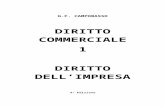diritto navigaziomnr
-
Upload
giovanni-di-gennaro -
Category
Documents
-
view
48 -
download
0
description
Transcript of diritto navigaziomnr

1

CAP. 1 – DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
1. Definizione ed oggettoIl diritto della navigazione è quella parte dell’ordinamento giuridico che si riferisce al fenomeno della navigazione per mare, per acque interne (laghi, fiumi, canali) e per aria.Quindi esso ha ad oggetto la materia della navigazione, che comprende il complesso dei rapporti attinenti alla navigazione, i quali costituiscono una categoria unitaria distinta dagli altri rapporti della vita economica e sociale.La navigazione, come trasporto, va intesa in due sensi:- in senso stretto o COMMERCIALE, riguardante il trasferimento di persone o cose da un luogo ad un altro;- in senso lato o TECNICO, riguarda sia il trasporto commerciale che ogni altro movimento per acqua o per aria di un qualunque mezzo galleggiante o volante adibito a svolgere una qualsiasi attività (es. pesca, rimorchio, scuola di pilotaggio…).
Questa nozione della navigazione è stata perfezionata, quindi è stato sostituito anche l’oggetto del diritto della navigazione. Prima era considerato oggetto il trasporto, ora invece oggetto del diritto nav. è considerato l’ESERCIZIO – ovvero, l’attività inerente all’impiego della nave e dell’aeromobile rivolta al soddisfacimento di un bisogno proprio dell’esercente ed accompagnata dall’incidenza del rischio.Quindi oggetto del diritto nav. è la materia relativa all’esercizio, a cui si aggiungono gli aspetti che ne costituiscono il presupposto o che vi sono connessi (proprietà e regime amministrativo della nave e dell’aeromobile, contratto di locazione…).
Non rientra nell’ambito del diritto della navigazione, quella militare. Tuttavia, in alcuni casi, il codice nav. stabilisce che alcune particolari norme si applicano in via eccezionale alle navi da guerra o agli aeromobili militari. Inoltre, rientrano nell’ambito del diritto della navigazione i rapporti giuridici che si riferiscono da un lato alla navigazione mercantile e dall’altro alla navigazione militare.Non è oggetto del diritto della nav. nemmeno la navigazione nello spazio extra atmosferico, mediante satelliti artificiali e veicoli spaziali.
- I caratteri del diritto della navigazione sono la specialità, l’autonomia (legislativa, didattica e scientifica), l’autonomia giuridica e l’unitarietà.
2. SpecialitàEssa è uno dei criteri per risolvere le antinomie. Una norma è speciale rispetto ad un’altra generale, quando la fattispecie che essa regola, compresa nella fattispecie generale, ha un contenuto più ristretto, essendo priva di alcuni suoi elementi.
2

Non deve essere confusa con la c. d. norma eccezionale. Infatti, questi due tipi di norme si differenziano soprattutto con riguardo agli effetti – ovvero la norma speciale costituisce una specificazione della norma generale, della quale contiene i principi, mentre la norma eccezionale costituisce un’eccezione della norma generale, costituendo un rapporto di contrarietà.Quindi il diritto della navigazione è un DIRITTO SPECIALE rispetto al diritto generale o comune, in quanto la materia della navigazione è disciplinata attraverso un complesso di norme (ordinamento della nav.) che si colloca in posizione speciale rispetto alla disciplina comune o generale.
3. Autonomia legislativa, scientifica e didatticaL’autonomia del diritto della navigazione è contemporaneamente legislative, scientifica, didattica e giuridica.- L’autonomia LEGISLATIVA trova piena espressione nel CODICE DELLA NAVIGAZIONE, approvato con r. d. il 30 marzo del 1942, il quale costituisce la fonte della disciplina particolare del diritto della nav.- l’autonomia SCIENTIFICA è connessa allo studio specifico dei problemi che derivano dai fatti della navigazione.- ha autonomia DIDATTICA, in quanto forma oggetto di specifico insegnamento universitario.Infatti, la materia costituisce oggi un autonomo settore scientifico – disciplinare ed è stata inserita fra le attività formative del corso di laurea magistrale in giurisprudenza.(Antonio Scialoja è stato il primo docente universitario a cui è stata assegnata la cattedra di diritto della navigazione a Roma nel 1942).
4. Autonomia giuridicaVi è autonomia GIURIDICA solo quando nell’ordinamento giuridico vi è una particolare ed organica disciplina, per una categoria di rapporti, dotata di principi speciali propri, come avviene per il diritto della navigazione. L’autonomia giuridica del diritto della navigazione dà luogo ad una disciplina specifica di fatti e rapporti che si riferiscono alla navigazione, tanto che questi fatti e rapporti hanno fonti diverse da quelle che regolano gli altri fatti e rapporti. L’ART. 1 del cod. nav. stabilisce che, “in materia di navigazione, si applicano il codice della navigazione, le leggi, i regolamenti, le norme corporative (abrogate) e gli usi ad essa relativi. In caso queste fonti non siano suscettibili di applicazione diretta o analogica, si applica il diritto generale”.Quindi, viene dato valore preminente alle fonti proprie della materia, condizionando l’operatività del diritto generale al preventivo ricorso a tutte le fonti speciali, anche di grado gerarchico inferiore. In questo modo il diritto generale viene ad assumere posizione subordinata rispetto alla disciplina propria della materia.
3

Questa graduazione delle fonti è espressione dell’autonomia giuridica del diritto nav. rispetto al diritto generale. Tuttavia, il principio espresso dall’Art. 1 c. nav. soffre di alcune eccezioni, in quanto non si estende alle leggi costituzionali, comunitarie ed internazionali, le quali hanno, quindi, una posizione gerarchica superiore rispetto all’Art. 1 c. nav.Importante è il COD. della NAUTICA di DIPORTO. Infatti, l’Art. 1 del medesimo cod. dispone che “il codice di nautica da diporto, le leggi, i regolamenti e gli usi in materia di navigazione da diporto prevalgono sull’applicazione del cod. nav. Quindi, i fatti ed i rapporti inerenti alla navigazione da diporto sono dotati di fonti proprie che si distinguono dalle fonti del diritto della nav. E’ da sottolineare, tuttavia, che la navigazione da diporto ha acquistato autonomia giuridica solo rispetto al diritto della navigazione e non all’ordinamento generale. Quindi, si tratta di un sub sistema interno al diritto della navigazione, dotato di un’autonomia speciale – ovvero autonomia di secondo grado rispetto all’autonomia di cui il diritto della navigazione è dotato rispetto all’ordinamento generale.
5. UnitarietàIl diritto della navigazione è caratterizzato dall’unitaria visione, disciplina ed elaborazione di un fenomeno economico e sociale, nella sua esplicazione per mare, per acque interne e per aria.Il fondamento della disciplina unitaria della navigazione marittima ed aerea va ricercato nella somiglianza di esigenze di carattere giuridico proprie degli spazi in cui si svolge l’attività e agiscono i mezzi impiegati per realizzarla, per cui le navi e gli aerei vengono considerati BENI MOBILI REGISTARTI, vengono assoggettati allo stesso regime di pubblicità, …
- IL CODICE DELLA NAVIGAZIONE
11. Il Codice della NavigazioneIl passaggio dalla legislazione frammentaria alla disciplina del codice della navigazione ha come precedente il programma formulato da Antonio Scialoja esposto all’Università di Napoli nel 1928, che trovò svolgimento nel Sistema del diritto della navigazione e venne redatto anche nella Rivista del diritto della navigazione, fondata dallo stesso Scialoja. Nel suo programma, Scialoja, manifestò il suo intento di dare unitarietà e autonomia al diritto della navigazione.Quindi ad Antonio Scialoja si deve la realizzazione del Codice della Navigazione. Nel 1924 fu nominata una commissione, presieduta dal senatore Perla, che aveva redatto il c. d. Progetto di codice marittimo. Tuttavia, questo progetto si presentava imperfetto, in quanto separava gli istituti pubblicistici da quelli privatistici e trascurava la navigazione aerea e quella interna.
4

Nel 1939 la revisione della legislazione in materia di navigazione fu affidata ad un consiglio, presieduto da Scialoja, il quale predispose il progetto ministeriale del codice della navigazione (comprensivo della navigazione marittima, aerea ed interna). Il progetto venne, poi, esaminato dalla sottocommissione delle assemblee legislative ed approvato con r. d. nel 1941.Successivamente fu approvato un nuovo testo del codice della navigazione, coordinato con il codice civile, con r.d. il 30 marzo 1942. Nel 1975 con d. m. è stata costituita una commissione per la riforma del codice della navigazione, presieduto da Gabriele Pescatore, i cui lavori si sono conclusi nella redazione di uno schema di disegno di legge delega per un nuovo codice della navigazione, che tuttavia non ha avuto seguito.È stata apportata una modifica della sola parte aeronautica nel 2005 e poi nel 2006.Nel 2005, con d. lgs. È stato approvato il Codice della Nautica di Diporto. In realtà, non si tratta di un vero e proprio codice, in quanto la nautica di diporto costituisce un sub sistema del diritto della navigazione.
13 .Regolamenti per l’esecuzione del Codice della NavigazioneSubito dopo l’emanazione del Codice, iniziarono i lavori per l’elaborazione del regolamento per il completamento e l’esecuzione del Codice stesso.È stato emanato il regolamento per la navigazione interna (approvato con d.p.r. nel 1949) e per la navigazione marittima (approvato con d.p.r. nel 1952). Questi due regolamenti cesseranno di avere effetto con l’entrata in vigore del REGOLAMENTO INTERGALE per l’esecuzione del Codice della Navigazione, quindi comprensivo anche della navigazione aerea.Infatti, allo stato attuale la legislazione comprende solo la navigazione marittima e quella interna; mentre all’elaborazione di un testo unitario riguardante la navigazione aerea si è rinunciato, preferendo adottare le disposizioni tecniche concernenti la materia oggetto degli annessi alla CONVENZIONE di CHICAGO del 1944. Con d.p.r. nel 1985 sono stati individuati i principi generali contenuti negli annessi e il cod. nav. demanda alla pubblica amministrazione il recepimento degli annessi stessi.In attesa dell’adozione di tutti gli annessi, la carenza di una normativa regolamentare per l’aviazione civile induce l’interprete a verificare se possa essere ancora applicato il regolamento per la navigazione aerea (approvato con r.d. nel 1925), in quanto sembra che esso sia stato abrogato espressamente dall’Art. 1329 c. nav.Tuttavia, l’Art. 1329 subordina la propria efficacia abrogativa all’entrata in vigore delle norme del cod. nav. Quindi l’Art. 1329 abroga il regolamento del 1925, però fino a quando le norme del c. nav. non entrano in vigore il regolamento del 1925 non può considerarsi abrogato.
5

- LE FONTI E L’INTERPRETAZIONE
18. Fonti del diritto della navigazioneL’Art. 1 c. nav. , comma 1, enumera le fonti del diritto della navigazione – “In materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative (abrogate) e gli usi ad essa relativi.”Tuttavia, l’Art. 1 non determina la gerarchia tra le fonti, la quale va desunta dal sistema delle disposizioni sulla legge in generale.Inoltre, a queste fonti devono essere aggiunte le CONVENZIONI INTERNAZIONALI. Esse non sono indicate, perché vengono rese esecutive con legge ordinaria, quindi esse rientrano nelle leggi o nei regolamenti. Occorre, però, sottolineare che, in virtù del 1 comma dell’Art. 117 cost., gli atti normativi di origine internazionale occupano una posizione gerarchica superiore rispetto alle fonti del diritto interno. Sono da aggiungere anche le fonti di grado costituzionale, le fonti di origine comunitaria, le leggi e i regolamenti regionali. Solo nei confronti delle prime due non trova applicazione l’autonomia del diritto della navigazione.
19. Le fonti di origine internazionaleLa disciplina della navigazione, particolarmente nel campo della navigazione marittima ed aerea, tende all’uniformità. Questo per l’esigenza di evitare che i vari rapporti ricevano una regolamentazione differente nei vari Stati in relazione alle diverse leggi statali.Quindi, i vari governi hanno favorito la redazione e la conclusione di CONVENZIONI INTERNAZIONALI di DIRITTO UNIFORME, miranti a realizzare una regolamentazione uniforme dei vari rapporti in materia di navigazione. Queste convenzioni sono rese vigenti in Italia mediante il c. d. ORDINE di ESECUZIONE seguito dalla ratifica o adesione. L’ordine di esecuzione è quasi sempre contenuto in una legge. Essa assume, sotto il profilo gerarchico, una forza superiore a quella della legge ordinaria, in virtù del 1 comma dell’Art. 117 cost., il quale dispone che la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni è vincolata al rispetto degli obblighi internazionali. (quindi la legge ordinaria è subordinata alle leggi di esecuzione delle convenzioni internazionali). Per rendere esecutive eventuali modifiche alle convenzioni si ricorre, invece, ad un procedimento più snello – ovvero attraverso la c.d. accettazione tacita. Gli emendamenti adottati dall’International Maritime Organization (IMO), entrano in vigore in una data stabilita, se entro quella data nessuno Stato aderente alla convenzione si oppone. Generalmente, le convenzioni di diritto uniforme contengono una norma strumentale, che determina l’ambito di applicazione della normativa convenzionale, limitando a determinati rapporti.
6

Le norme convenzionali sono denominate anche norme di applicazione necessaria, in quanto per la loro applicabilità è sufficiente che il caso da regolare corrisponda alla fattispecie prevista dalla norma strumentale. Naturalmente, l’obiettivo dell’uniformità della disciplina può essere conseguito soltanto se le relative norme ricevano un’interpretazione uniforme nei vari Stati aderenti. L’esigenza di uniformità è assecondata talora mediante la redazione di regole uniformi adottabili volontariamente da parte delle categorie interessate. (es. regole di York e Anversa sulle avarie comuni).
20. Convenzioni internazionali per la NAVIGAZIONE MARITTIMANel 1897 a Bruxelles è stato istituito il Comité maritime International (CMI) – ovvero un’organizzazione di carattere privato, costituita da operatori giuridici, economici e tecnici, raggruppati in associazioni internazionali, con lo scopo di predisporre progetti di convenzioni internazionali di diritto uniforme da sottoporre ad una conferenza diplomatica per l’approvazione. Le convenzioni adottate a Bruxelles sotto l’impulso del CMI riguardano:- l’urto (1910)- assistenza e salvataggio marittimi (1910 – non più in vigore perché sostituita)- polizza di carico (modificata nel 1989)- limitazione della responsabilità dei proprietari di navi (1924)- privilegi e ipoteche marittimi (1926)- sequestro conservativo delle navi (1952)- competenza penale in materia di urto e di altri eventuali eventi di navigazione- passeggeri clandestini (non ancora in vigore)- trasporto marittimi dei passeggeri- responsabilità degli esercenti di navi nucleari- iscrizione dei diritti relativi alle navi in costruzione- trasporto marittimo dei bagagli.Il CMI è stato sostituito da organizzazioni intergovernative, tra le quali la più importante ed influente è l’IMO (International Meritime Oragnization) costituita nel 1948. Si tratta di un organismo specializzato della Nazioni Unite con l’obiettivo di sviluppare la cooperazione internazionale, in particolare per quanto riguarda la sicurezza della vita umana in mare.Le convenzioni di maggior rilievo promosse dalle organizzazioni intergovernative riguardano:- protezione dei cavi sottomarini- regime internazionale dei porti marittimi- trattamento delle malattie veneree dei marittimi- intervento in alto mare in caso di inquinamento da idrocarburi (estesa successivamente anche alle sostanze diverse dagli idrocarburi)- responsabilità civile per danni da inquinamento di idrocarburi- requisiti di spazi delle navi passeggeri per traffici speciali
7

- responsabilità civile nell’ambito di trasporto marittimo di sostanze nucleari- istituzione di un Fondo internazionale per il risarcimento dei danni di inquinamento di idrocarburi- prevenzione dell’inquinamento causato dallo scarico di materiale e sostanze nocivi da parte di navi ed aeromobili- regole per prevenire gli abbordi in mare- prevenzione dall’inquinamento marino di provenienza terrestre- salvaguardia della vita umana in mare- protezione dell’ambiente marino e del litorale del mar Mediterraneo- standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi- condizioni d’immatricolazione delle navi- repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima e delle piattaforme situate sulla piattaforma continentale- soccorso in mare- sequestro di navi- controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi- rimozione dei relitti - controllo e gestione dell’acqua e dei sedimenti di zavorra delle navi.Altro organismo specializzato delle Nazioni Unite è l’ILO (International Labour Organization), costituito nel 1919.Tra le convenzioni promosse dall’ILO quelle che hanno trovato esecuzione in Italia riguardano:- indennità di disoccupazione in caso di perdita per naufragio- contratto di arruolamento dei marittimi- minimo di capacità professionale dei capitani ed ufficiali della marina mercantile- obblighi dell’armatore in caso di malattia, infortunio o morte della gente di mare- diploma di capacità professionale dei cuochi sulle navi- alloggio dell’equipaggio a bordo- contratto di arruolamento dei pescatori- carte di identità nazionali della gente di mare- alimentazione e servizio di tavolo a bordo di navi- sicurezza ed igiene del lavoro nelle operazioni portuali- prevenzione degli incidenti di lavoro della gente di mare- congedi annuali pagati della gente di mare.In materia di pesca le maggiori convenzioni in vigore in Italia riguardano:- conservazione dei tonnidi dell’Atlantico- esercizio della pesca nell’Atlantico del Nord- conservazione delle risorse biologiche dell’Atlantico- sicurezza delle navi da pesca- standards di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per il personale delle navi da pesca.
21. Convenzioni internazionali per la NAVIGAZIONE INTERNA
8

Nessuna di esse è in vigore in Italia – esse riguardano:- contratto di trasporto di merce per navigazione interna- immatricolazione delle navi da navigazione interna- limitazioni della responsabilità dei proprietari di navi per la navigazione interna- contratto di trasporto internazionale di passeggeri e di bagagli per navigazione interna- responsabilità per danni causati durante il trasporto di merce pericolosa per strada, ferrovia e navi da navigazione interna- protezione ambientale dei fiumi e dei laghi
22. Convenzioni internazionali per la NAVIGAZIONE AEREADurante la Convenzione di Parigi del 1919 fu istituita la Commission internationale de navigation aérienne (CINA), alla quale è stato demandato il compito di adeguare, con le opportune modifiche, le norme della Convenzione medesima al continuo sviluppo dell’aeronautica.Nel 1925 fu costituito il Comité International technique d’experts juridiques aériens (CITEJA), il quale ha promosso 4 importanti convenzioni internazionali riguardanti il trasporto aereo internazionale, il sequestro conservativo degli aeromobili, i danni causati a terzi in superficie da aeromobili stranieri e l’assistenza ed il salvataggio di aeromobili o da parte di aeromobili in mare.La Convenzione di Chicago ha istituito l’International Civil Aviation Otganization (ICAO), con sede a Montreal. Esso è un istituto specializzato delle Nazioni Unite dotato di personalità giuridica internazionale e ad esso aderiscono quasi tutti i Paesi del mondo.Tra le funzioni di maggior rilievo svolte dall’ICAO vi è l’adozione degli standards internazionali e delle pratiche raccomandate (denominati annessi alla Convenzione di Chicago). Essi contengono una normativa regolamentare dettagliata, periodicamente aggiornata, diretta a disciplinare gli aspetti tecnici della navigazione aerea in modo da assicurarne l’esercizio in condizioni uniformi di sicurezza e di efficienza. Gli Stati aderenti non sono obbligati a conformare il loro ordinamento agli annessi, ma sono soltanto tenuti a collaborare per assicurare il più alto grado possibile di uniformità. Altre convenzioni internazionali – riguardano:- transito dei servizi aerei internazionale- riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili- danni causati a terzi in superficie da aeromobili stranieri- diritti commerciali dei servizi aerei non di linea in Europa- certificati di navigabilità degli aeromobili importati- trasporto aereo effettuato da persona diversa dal vettore contrattuale- infrazioni e altri atti commessi a bordo degli aeromobili- salvataggio e ritorno degli astronauti e la restituzione degli oggetti inviati nello spazio extra atmosferico- responsabilità internazionale per i danni causati ad oggetti spaziali
9

- procedure per la determinazione delle tariffe dei servizi aerei regolari intra-europei- garanzie internazionali sui beni mobili con specifico riferimento agli aeromobili.
23. Norme comunitarieIn base al Trattato di Roma del 1957, la Comunità ha il potere di emanare, nelle materie che rientrano nelle attribuzioni comunitarie, norme direttamente applicabili nell’ordinamento di ogni Stato membro (regolamenti e decisioni) e norme che richiedono per la loro attuazione specifici provvedimenti degli Stati membri (direttive). Inoltre, la Comunità ha anche una competenza esterna, che si concretizza nella facoltà di stipulare accordi internazionali con Stati terzi.Con riguardo alla materia della navigazione, l’Art. 80 del Trattato CE stabilisce che le disposizioni sui trasporti si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili; mentre spetta al Consiglio la competenza di decidere riguardo alla navigazione marittima ed aerea.La Corte di Giustizia delle Comunità, tuttavia, ha posto dei limiti all’operatività di questo principio, affermando che l’Art. 80 CE sottrae il settore dei trasporti marittimi ed aerei alle disposizioni specifiche del titolo relativo ai trasporti, ma non ai principi generali del Trattato. Quindi, gli Stati membri sono tenuti ad osservare, nel settore della navigazione marittima ed aerea, le norme relative alla libera circolazione dei lavoratori e quelle a tutela della concorrenza, indipendentemente da interventi specifici degli organi comunitari.
- LE FONTI DI ORIGINE NAZIONALE
24. Leggi statali e regionaliFonti primarie sono le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato.Distinte da esse, sotto il profilo della competenza, sono le leggi regionali.In base all’Art. 117 cost., le Regioni hanno potestà legislativa esclusiva in tutte le materie non espressamente riservate allo Stato; hanno, invece, potestà legislativa concorrente in una serie di materie specificatamente individuate. Nelle materie di legislazione concorrente, è riservata allo Stato la determinazione dei principi fondamentali. Infine, l’art. 118 cost. attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative e consente che queste funzioni siano conferite in deroga allo Stato, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, quando vi è l’esigenza di assicurarne l’esercizio unitario.La materia della navigazione non è riservata allo Stato. Quindi, sono le REGIONI che hanno, in tale materia, potestà legislativa esclusiva. Solo con riguardo alla disciplina dei porti, degli aeroporti civili, delle grandi reti di trasporto e di navigazione le Regioni hanno potestà legislativa concorrente.È riservata allo STATO la disciplina dei rapporti privati e quella dei profili che, pur rientrando nella materia della navigazione, rientrano in settori
10

più generali di competenza statale (es. rapporti internazionali, tutela dell’ambiente, ordine pubblico e sicurezza…). Inoltre, è demandata allo Stato la disciplina legislativa di quegli aspetti della materia della navigazione, le cui funzioni amministrative sono ad esso attribuite in deroga, in base all’Art. 118 cost.
25. Regolamenti, norme corporative, usi Subordinati alle leggi in materia di navigazione sono i REGOLAMENTI in materia di navigazione. Essi sono espressione di un potere normativo attribuito dalla legge alla pubblica amministrazione.Le norme regolamentari sono emanate dal Governo, mediante decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato. Vengono, inoltre, emanate, quando autorizzati dalla legge, dai ministri (decreti ministeriali e interministeriali). Competenza regolamentare è attribuita anche alle Regioni ed a Enti pubblici territoriali (Comuni e Provincie) e non territoriali (es. Ente nazionale per l’aviazione civile).Riguardo le NORME CORPORATIVE, abrogate nel 1944, esse, in materia di navigazione, erano subordinate alle disposizioni di carattere imperativo delle leggi e dei regolamenti in materia di navigazione e prevalevano sulle disposizioni di carattere dispositivo. Dopo l’abrogazione delle norme corporative (nel 1944), la sfera di efficacia normativa è rimasta con riguardo ai contratti collettivi di lavoro previsti dall’art. 39 cost. Tuttavia, l’Art. 39 non ha ricevuto attuazione, quindi gli attuali contratti collettivi sono atti di autonomia privata, i quali non hanno efficacia per tutti gli appartenenti alla categoria interessata, ma solo per gli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti. Pertanto, questi contratti acquistano efficacia erga omnes solo quando la legislazione in materia di lavoro marittimo o di lavoro in generale rinvii ad essi.Per quanto riguardo l’USO, esso ha efficacia indipendentemente da qualsiasi richiamo solo nelle materie non regolate da leggi o regolamenti (quindi uso praeter legem); mentre, nelle materie regolate dalla legge o da regolamenti, l’uso ha efficacia solo se da essi richiamato (quindi uso secundum legem). Il Codice della nav. richiama frequentemente l’uso e, in alcuni casi, esso prevale su disposizioni del Codice della nav. dispositive o anche imperative (però solo se richiamato). È da sottolineare che l’uso, in materia di navigazione, ha una sfera di applicabilità più ampia di quella che gli è normalmente riservata, sia in virtù dell’autonomia del diritto della navigazione, sia perché in un caso (contratti di utilizzazione delle navi addette alla navigazione interna) gli è attribuita la prevalenza su norme di legge imperative dello stesso diritto speciale.
26. Analogia
11

L’analogia legis è un’operazione logica che consente di individuare la norma applicabile ad un caso concreto non direttamente regolato. Ovvero, si fa ricorso all’applicazione di una norma che regola una fattispecie simile, la cui ratio comprenda anche il caso non regolato. In altri termini, mediante il procedimento analogico si opera un’astrazione che dalla norma particolare consente di risalire ad un principio, il quale fissa una regola più ampia di quella espressa, comprensiva anche della fattispecie non regolata.Il procedimento analogico opera sia nell’ambito della navigazione marittima che in quello della navigazione aerea (es. applicabilità per analogia della disciplina sugli aeromobili ai veicoli spaziali), sia, reciprocamente, rispetto ad istituti di navigazione marittima ed aerea (es. rimorchio in via d’aria in base alla disciplina di quello per acqua). Il ricorso all’analogia deve essere preceduto dall’interpretazione estensiva, diretta a stabilire se l’intenzione del legislatore sia che la norma, espressamente formulata per la navigazione marittima, sia applicabile anche alle stesse fattispecie ricorrenti nella navigazione interna.L’analogia delle norme di diritto della navigazione è detta analogia prioritaria, perché il ricorso ad essa ha la precedenza nei riguardi dell’applicazione diretta del diritto generale, dato che la norma di diritto speciale , che deve prevalere su quelle di diritto generale.
27. Diritto civile , il diritto generale.Quando le lacune non possono essere colmate mediante l’analogia, deve farsi ricorso al diritto civile.In questo caso, però, l’espressione diritto civile designa il complesso dei principi e delle norme di diritto amministrativo, processuale, privato, internazionale e penale. (ovvero la normativa generale nella quale si inquadra la disciplina speciale del diritto della navigazione). Vi sono delle norme, dette qualificative, che pongono una delimitazione alla sfera di operatività della disciplina posta dal codice civile, dichiarandola inapplicabile alla materia della navigazione.Mentre, altre norme dispongono l’applicazione delle disposizioni del codice civile anche alla materia della navigazione. In questo modo la disciplina civilistica prevale sulle altre fonti speciali diverse dalla legge. È da sottolineare che il richiamo alle norme del codice civile qualifica la norma richiamata come “norma in materia di navigazione”, ossia come norma di diritto speciale. Quindi, la norma così qualificata, assume la stessa validità e gli stessi effetti delle norme del Codice nav. – ovvero si pone nella stessa posizione che l’Art. 1 c. nav. attribuisce al codice stesso, rispetto alle altre fonti del diritto speciale.
28. Caratteri dell’ordinamento delle fonti e criteri di interpretazione
12

I regolamenti, gli usi e l’applicazione analogica delle norme stabilite in materia di navigazione prevalgono sulle fonti, anche gerarchicamente sovraordinate, del diritto generale.La prevalenza di tutte le fonti del diritto della navigazione su quelle del diritto generale si spiega con la necessità di regolare la materia della navigazione con le speciali fonti proprie. Allo stesso modo si spiega il ricorso all’interpretazione analogica prima dell’interpretazione diretta delle norme di diritto generale. Si può dire, in definitiva, che il particolare carattere dell’ordinamento delle fonti del diritto della navigazione fa sì che, nella soluzione delle antinomie, il criterio di specialità prevale sul criterio gerarchico. Questo principio non vale rispetto alle fonti superiori alla legge ordinaria, ovvero le fonti costituzionali, internazionali e comunitarie. Queste si applicano alla materia della navigazione con prevalenza rispetto a tutte le altre fonti, anche quando non regolano la materia stessa.Con riguardo all’interpretazione, la posizione di diritto speciale consente l’impiego dei metodi normali di interpretazione, con l’accentuazione di quelli di carattere storico e comparativo.I metodi di carattere STORICO si riferiscono soprattutto agli istituiti marittimistici e servono a descrivere le origini e l’evoluzione degli istituiti stessi.Mentre, i metodi COMPARATIVI consentono, attraverso la valutazione dell’assetto degli istituti nei diversi ordinamenti, di acquisire utili elementi per valutarne l’oggetto e il significato. La comparazione esplica una funzione particolare, soprattutto rispetto alla normativa convenzionale internazionale di diritto uniforme – ovvero, se in una convenzione internazionale è stato recepito un istituito di un altro ordinamento, occorre risalire al significato che l’istituto assume in quell’ordinamento.
CAPITOLO QUARTOI BENI PUBBLICI DESTINATI ALLA NAVIGAZIONE
1. I beni demanialiPer beni pubblici destinati alla navigazione si intendono quei beni - o meglio quegli spazi - sui quali possono esercitarsi i poteri pubblici in materia di navigazione.Tali beni sono, quindi, beni demaniali (di proprietà pubblica) appartenenti allo Stato e agli Enti Locali.
Titolo IIL MARE E LO SPAZIO AEREO
2. Il mareIl mare (così come lo spazio aereo) non rientra nel novero dei beni demaniali di uno Stato; esso pertanto non può essere di proprietà di alcuno Stato ma su determinate zone di mare lo Stato costiero può
13

esercitare poteri limitativi della libertà altrui al fine di controllare la navigazione marittima e le altre attività che si svolgono nel mare adiacente.I poteri dello stato costiero si affievoliscono man mano che ci si allontana dalla costa per scomparire del tutto nella zona di alto mare, laddove trionfa la libertà dei mari ed il diritto alla libera navigazione da parte di chiunque.Le zone in qualche modo sottoposte alla sovranità dello stato costiero sono nella parte interna delimitate dalla costa ovvero dalla linea di base, ossia dalle rene che congiungono le sporgenze della costa ed i punti foranei delle baie che siano distanti non più di 24 miglia marine nonché le isole che si trovano di fronte alle coste; le acque che vengono a trovarsi tra la linea di base e la costa vera e propria, ivi comprese le insenature, le baie ed i golfi, si considerano pertanto acque interne e sono sottoposte al relativo regime.Relativamente a tali zone si distinguono:
1. Il mare territoriale , che (come stabilito dalla Convenzione di Montengo Bay del 1982), si estende fino al 12 miglia marine dalla linea di base. La sovranità degli Stati sul mare territoriale si estende allo Spazio Aereo a esso sovrastante ed al Suolo e Sottosuolo Marino a esso sottostante, con il conseguente diritto di esplorazione e di sfruttamento delle risorse economiche naturali ivi esistenti.
2. La zona contigua , che si estende, se istituita, fino a 24 miglia marine dalla linea di base, entro la quale esercitare il controllo necessario al fine di prevenire e reprimere le infrazioni alle proprie leggi doganali, fiscali, sanitarie e dell’immigrazione.
3. La zona economica , esclusiva, ove istituita, che si estende fino a 200 miglia marine dalla linea di base. In essa lo Stato costiero ha diritti esclusivi di esplorazione e sfruttamento, di conservazione e gestione delle risorse naturali: ha inoltre giurisdizione con riguardo a isole e impianti artificiali, ricerca scientifica, protezione dell’ambiente marino.
L’art. 303 consente anche l’istituzione di una cosiddetta zona archeologica, di pari estensione, al fine di controllare il recupero e il commercio di oggetti di natura archeologica e storica. L’Italia non ha istituito tali zone.
4. la piattaforma continentale, ove istituita, che corrisponde al naturale prolungamento della terra emersa che si estende in graduale declivio sul fondo marino ad un profondità non superiore ai 200 metri e, comunque, non oltre le 350 miglia marine dalla linea di base. In tale zona, i diritti esclusivi dello Stato costiero riguardano il solo sfruttamento del sottosuolo marino e non anche della massa d’acqua sovrastante e
14

dello spazio aereo che perciò rimangono acque e spazio aereo internazionale e, in quanto tali, liberamente utilizzabili da ogni Stato per qualsiasi attività.
5. Oltre tali zone inizia il cosiddetto alto mare dove prevale il principi della libertà dei mari.
6. Nell’ambito delle zone di mare di propria pertinenza gli stati costieri possono istituire aree marine protette, per fini biologici, culturali, scientifici o altri. Sono comunque vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area, come la pesca, l'asportazione di minerali e reperti archeologici, la navigazione a motore, la discarica di rifiuti, ecc. La gestione delle riserve può essere affidata alle capitanerie di porto competenti oppure può essere delegata a enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute, con apposita convenzione stipulata dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
In tali zone lo stato costiero può porre limiti all'altrui libertà di navigazione. Nella zona di mare territoriale, in particolare, lo stato costiero esercita la sua sovranità ed i poteri di polizia doganale, fiscale, sanitaria e di immigrazione cui restano assoggettate le navi straniere che vi transitano; è infatti ammesso nelle acque territoriali il:
● Diritto di Passaggio Inoffensivo : tale diritto è consentito anche alle navi da guerra, purché rapido e continuo e tale da non far presupporre pregiudizio per lo Stato costiero.
● Diritto di Passaggio in Transito : tale diritto sussiste quando la zona di mare territoriale, come per gli stretti, mette in comunicazione 2 zone di mare di libera navigazione; è ammesso purché sia continuo e rapido e non minacci la sovranità degli Stati rivieraschi. Tale diritto si differenzia dal Passaggio Inoffensivo perché comprende anche il sorvolo e non può essere sospeso.
In linea di principio le azioni di polizia si possono svolgere solo nelle acque territoriali, ma la nave dello stato costiero può inseguire la nave straniera, che abbia commesso una qualche infrazione, anche al di fuori di tali acque e fino alle acque territoriali di un altro stato, purché l'inseguimento sia condotto senza interruzione. La nave dello stato costiero può altresì effettuare azioni di polizia verso navi che, pur trovandosi al di fuori delle acque territoriali, hanno una presenza cosiddetta "costruttiva", e cioè hanno un collegamento di fatto con la costa, magari medianteimbarcazioni di minori dimensioni che fanno la spola.La convenzione di Montego bay disciplina inoltre il diritto di inseguimento, affinché esso sia considerato lecito esso deve essere intrapreso nel mare territoriale o nella zona contigua dello stesso stato
15

che ha intrapreso l’inseguimento in virtù di una violazione posta in essere dalla stessa nave.
3. Lo spazio aereoLo spazio aereo soggetto alla sovranità dello Stato è quello sovrastante sia il suo territorio che le sue acque territoriali (art.3 c. nav.). In Italia la navigazione nello Spazio Aereo nazionale è consentita ad aeromobili di altri paesi alle seguenti condizioni:
1. Aerei militari, doganali e di polizia non possono sorvolare il territorio dello Stato se:
● non sono muniti di speciale autorizzazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, d’intesa al Ministro della Difesa;
● se appartengono a paesi che non offrono uguali condizioni ai velivoli italiani (Condizione di reciprocità)
2. Aeromobili di linea impiegati in servizi registrati per sorvolare il territorio di altri Stati contraenti hanno bisogno di una particolare autorizzazione (Chicago 1944).
3. Aeromobili non impegnati in servizi registrati: il sorvolo e la sosta per scopi non commerciali di questi aeromobili sul territorio degli altri Stati contraenti possono effettuarsi senza la necessità di un permesso preventivo, salvo il diritto dello Stato sorvolato di richiederne l'atterraggio per fini doganali o altre ispezioni; tali aeromobili, se impiegati per scopi commerciali, potranno anche avere il privilegio di imbarcare o sbarcare passeggeri, merce o posta, ma alle condizioni che lo Stato, in cui tale imbarco o sbarco abbia luogo, ritenga desiderabili.
L’Ente nazionale aviazione civile può vietare il sorvolo di alcune zone del territorio o di tutto il territorio della repubblica ,per motivi di sicurezza o per motivi di interesse pubblico.Allo scopo di istituire un regime di maggiore liberalizzazione, per gli Stati che la volessero, il 7 dicembre 1944, a Chicago, oltre alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale, sono stati approvati due altri accordi alternativi fra loro: l'Accordo sul transito dei servizi aerei internazionali e l'Accordo sui trasporti aerei internazi onali .Col primo Accordo vengono sancite le prime due cosiddette libertà dell'aria:
1. il diritto degli aeromobili immatricolati in un altro Stato contraente di attraversare il proprio territorio senza atterrarvi;
2. il diritto di atterrarvi per scopi non commerciali (per esempio, per rifornimento di carburante, riparazioni tecniche, ecc.).
Col secondo Accordo le libertà dell'aria sono cinque: oltre alle due già menzionate, sono garantiti da ciascuno Stato contraente:
3. il diritto dì sbarcare nel proprio territorio passeggeri, posta e merci imbarcati sul territorio dello Stato di immatricolazione dell'aeromobile;
16

4. il diritto di imbarcare nel proprio territorio passeggeri, posta e merci con destinazione nel territorio dello Stato di immatricolazione dell'aeromobile;
5. il diritto di imbarcare o sbarcare nel proprio territorio passeggeri, posta e merci con destinazione nel territorio di ogni altro Stato contraente, diverso dallo Stato di immatricolazione dell'aeromobile, o provenienti dallo stesso.
L'Italia ha aderito al primo dei due accordi dettando poi disposizioni di attuazione inerenti ai temi del secondo accordo.
Cap. 5 – ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA NEI BENI PUBBLICI DESTINATI ALLA NAVIGAZIONE
- I PORTI
Sez. 1 – L’organizzazione dei porti
84. Autorità marittimaIl PORTO è considerato innanzitutto un bene demaniale, al quale si applica la relativa disciplina, ed è inoltre considerato un centro di attuazione di servizi pubblici e privati concernenti in genere la movimentazione delle navi e le attività complementari al trasporto marittimo (es. operazioni di carico e di scarico). Le attività complementari vengono esercitate dalle autorità portuali e dalle autorità marittima, secondo le rispettive competenze.Nei PORTI a MINORE volume di traffico, dove non sono istituite le autorità portuali, l’autorità marittima è titolare esclusiva delle funzioni di amministrazione e di vigilanza sulle attività che vengono svolte nei porti. Queste attività sono regolate dal COMANDANTE di PORTO. Le ordinanze del comandante del porto sono atti di formazione secondaria, mediante i quali vengono fissate le regole di condotta cui devono attenersi i soggetti che volgono attività all’interno del porto.Mentre, nei PORTI MAGGIORI, nei quali sono istituite le autorità portuali, l’autorità marittima ha tutte le competenze che non spettano alle autorità portuali. (es. funzioni di polizia e di sicurezza, disciplina ed organizzazione dei servizi tecnici-nautici di pilotaggio, rimorchio…).
Quindi: - PORTI MINORI autorità marittima (comandante del porto)- PORTI MAGGIORI autorità portuali
85. Autorità portualeMediante la l. 84/1994 sono state istituite, nei maggiori porti, le autorità portuali. Esse sono ENTI, con personalità giuridica di diritto pubblico; sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dei trasporti e svolgono attività sostitutiva, integrativa e sussidiaria dello Stato, perseguendo la
17

finalità di amministrare i porti e di consentire la gestione con la partecipazione delle strutture pubbliche e private interessate. Esse hanno compito di INDIRIZZO, PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO, PROMOZIONE e CONTROLLO delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione ed ordinanza.Hanno, inoltre, il compito di affidare in concessione, mediante gare pubbliche, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni del porto.Esse non possono esercitare, né direttamente né attraverso la partecipazione a società, operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse. Questo principio, detto di separazione, delimita il ruolo delle autorità portuali rispetto alle altre attività che si svolgono in ambito portuale, che vengono svolte da soggetti diversi. Esse possono solo costituire o partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai loro compiti.Le autorità portuali sono desinate a soddisfare essenzialmente bisogni di interesse generale; per questo motivo sono qualificate ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI.
Sez. 2 – Il lavoro portuale
86. GeneralitàIl tema del lavoro portuale è molto complesso in quanto vi concorrono elementi economici, giuridici, sociali e politici. Nella disciplina del lavoro portuale vi è un ampio intervento di elementi pubblicistici, connessi con la natura demaniale del bene in cui si svolge l’attività e con l’esigenza di tutelare le finalità pubbliche cui l’uso del porto è destinato.La l. 84/1994 ha profondamente modificato la disciplina preesistente del lavoro portuale, soprattutto in seguito ad una sentenza della Corte di Giustizia europea, la quale aveva giudicato contrario alla normativa comunitaria l’allora sistema monopolistico di somministrazione del lavoro da parte delle compagnie portuali per l’esecuzione delle operazioni portuali. La nuova disciplina si caratterizza, quindi, per essere diretta a favorire la presenza di una concorrenza nell’esecuzione di tali operazioni all’interno di uno stesso porto. Secondo la l. alle autorità portuali o, se non istituite, alle autorità marittime competono le funzioni relative alla disciplina e alla vigilanza sia delle operazioni portuali che dei servizi portuali che hanno per oggetto prestazioni specialistiche complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali.(Le operazioni portuali sono il carico, lo scarico, il trasporto, il deposito, il movimento in genere della merce e di ogni altro materiale, svolti nell’ambito portuale e non a bordo della nave.)I servizi portuali che hanno per oggetto le attività specialistiche complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali sono
18

individuati e regolati dalle autorità portuali e, se previste, dalle autorità marittime.
87. Imprese portuali e terminalisteL’esercizio delle operazioni portuali e dei servizi portuali specialistici complementari ed accessori è svolto da IMPRESE PORTUALI in base ad autorizzazione rilasciata dall’autorità portuale (o, in mancanza, dall’autorità marittima).Le imprese portuali, quindi, provvedono alla movimentazione della merce in ambito portuale – ovvero carico e scarico della merce, con annessi obblighi di custodia preventiva e successiva.Le imprese portuali devono essere in un numero tale, in ciascun porto, da assicurare il massimo della concorrenza nel settore. Il contratto che l’utente stipula con l’impresa portuale, detto contratto di imbarco e sbarco, è qualificato come appalto di servizi.L’incessante sviluppo tecnologico dei trasporti marittimi ha comportato l’esigenza di una sempre maggiore celerità nelle operazioni di caricazione e scaricazione della merce e, di conseguenza, la necessità di aree particolarmente attrezzate ed organizzate (terminals), che si pongono in posizione intermedia tra la nave ed il veicolo terrestre o ferroviario che conduce la merce da o verso l’interno del territorio. In queste aree la merce viene raccolta, depositata e smistata secondo la destinazione.In questa prospettiva, alcune imprese portuali che possiedono adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, possono ottenere dall’autorità portuali la concessione di aree demaniali e banchine nell’ambito portuale per l’espletamento delle operazioni portuali. Queste IMPRESE, definite TERMINALISTE, svolgono la loro attività nell’ambito portuale insieme alle altre imprese non concessionarie. Per le iniziative di maggiore rilevanza, in sostituzione del provvedimento di concessione, l’autorità portuale può stipulare con le imprese terminaliste accordi sostitutivi.La responsabilità dell’impresa terminalista nei confronti dell’utente, per servizi prestati in relazione a merce coinvolta in viaggi internazionali, è regolata dalla Convezione di Vienna del 1991, non ancora in vigore.
88. Fornitura di lavoro portuale temporaneoIl personale delle imprese portuali autorizzate potrebbe non essere sufficiente per far fronte alle esigenze operative del porto in caso di variazioni imprevedibili di domanda di mano d’opera.Allo scopo di fronteggiare tale eventualità, la l. 84/1994 dispone che l’autorità portuale (o l’autorità marittima) può autorizzare un’impresa a fornire lavoro temporaneo a tutte le imprese portuali che ne facciano richiesta, con osservanza della parità di trattamento.La fornitura di lavoro temporaneo deve costituire l’attività esclusiva dell’impresa autorizzata, la quale non può essere scelta fra quelle che svolgono già operazioni portuali o altri servizi nel porto.
19

Nel caso in cui non vi sia un’impresa disponibile, la fornitura di lavoro temporaneo viene erogata da una c.d. AGENZIA, la quale viene istituita dall’autorità portuale (o autorità marittima) e su cui ne esercita il controllo. Essa viene gestita da un organo direttivo a cui partecipano i rappresentanti di tutte le imprese abilitate a svolgere operazioni portuali altri servizi nel porto.
89. AutoproduzioneIn conformità alla normativa comunitaria è previsto il diritto di autoproduzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali specialistici complementari ed accessori – ovvero l’autorità portuale (o autorità marittima) può autorizzare all’esercizio delle operazioni portuali anche gli stessi utenti, purché le loro navi siano dotate di propri mezzi meccanici e di personale adeguato alle operazioni da svolgere. Per l’autorizzazione può essere richiesto un corrispettivo e il deposito di una cauzione.L’utente autorizzato può avvalersi anche della collaborazione di ausiliari dotati di un’adeguata struttura operativa, purché l’attività a loro affidata consista nel concorso all’organizzazione delle operazioni portuali e non nell’autonomo esercizio delle stesse.
Sez. 3 – I servizi tecnico-nautici
90. GeneralitàI servizi di PILOTAGGIO, di RIMORCHIO, di ORMEGGIO e di BATTELLAGGIO sono servizi pubblici, denominati servizi portuali tecnico-nautici di interesse generale, diretti a garantire la sicurezza della navigazione e dell’approdo nei porti.La disciplina e l’organizzazione dei servizi sono stabilite dall’autorità marittima o, nei porti in cui ha sede l’autorità portuale, d’accordo con quest’ultima.Il servizio di pilotaggio è, di norma, facoltativo; tuttavia, può essere reso obbligatorio con decreto del Ministero dei trasporti. Può, inoltre, essere reso obbligatorio dal direttore marittimo, ma solo in via temporanea e per particolari esigenze.I servizi di rimorchio, ormeggio e battellaggio possono essere resi obbligatori dall’autorità marittima, tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate. Le tariffe dei servizi sono fissate dalla CORPORAZIONE dei PILOTI per il pilotaggio e dal CAPO del COMPARTIMENTO per gli altri servizi, secondo i criteri stabiliti dal Ministero dei trasporti.
91. Servizio di PILOTAGGIOIl servizio di pilotaggio svolge la funzione di assistere il comandante della nave in località di approdo o di transito, fornendo i suggerimenti di un esperto (il pilota) riguardo alla rotta da seguire e dalle manovre necessarie per assicurare l’approdo o il transito senza danni.
20

Il servizio è affidato alle corporazioni di piloti; mentre, nelle località in cui questa non sia istituita, il comandante del porto può affidare il servizio a marittimi abilitati al pilotaggio (c.d. piloti pratici locali).Nelle località in cui il pilotaggio è obbligatorio, il pilota è tenuto a prestare la sua opera in tutta la zona in cui vige l’obbligo; mentre, dove il pilotaggio è facoltativo, deve prestare la sua opera fino a quando sia richiesto.Il pilota fa parte dell’equipaggio durante il periodo in cui presta servizio a bordo e nella gerarchia dell’organizzazione sulla nave, è equiparato al primo ufficiale.Nella navigazione interna, il pilotaggio, di regola facoltativo, è esercitato da piloti autorizzati dagli uffici regionali competenti. Può essere dichiarato temporaneamente obbligatorio per determinate località.Il pilota, durante il periodo in cui presta servizio a bordo, è equiparato al capo timoniere.
92. Corporazione di pilotiViene istituita con decreto del Presidente della Repubblica ed è sottoposta alla vigilanza del comandante del porto.Essa ha personalità giuridica, in particolare persona giuridica pubblica, che attua un fine di pubblico interesse – ovvero quello della sicurezza della navigazione. L’autorità marittima esercita sull’istituto larghi poteri di controllo, in particolare riguardo la costituzione ed il funzionamento dell’ente.Essa è un’impresa commerciale, avente ad oggetto un’attività ausiliaria a quella di trasporto per acqua. Le tariffe per la prestazione del servizio di pilotaggio sono determinate dalla corporazione, la quale deve conformarsi ai criteri stabiliti dal Ministero dei trasporti.I PILOTI sono membri della corporazione, alla quale accedono mediante concorso pubblico, riservato al personale marittimo particolarmente qualificato, in seguito al quale gli viene rilasciata licenza e vengono iscritti in uno speciale registro. Tutti i membri sono legati alla corporazione da un rapporto organico, non di lavoro subordinato.Organi della corporazione sono il CAPO PILOTA ed il SOTTOCAPO PILOTA, che lo sostituisce in caso di bisogno; essi vengono nominati dal capo del compartimento. Altri organi sono i PILOTI SINGOLI ed il COMMISSARIO STRAORDINARIO, nominato dal ministro dei trasporti in caso di gravi irregolarità nel funzionamento della corporazione.La corporazione ha un proprio patrimonio costituito dal diritto di uso delle navi che servono per l’esplicazione del servizio, dai proventi del servizio di pilotaggio, dai contributi dello Stato e da beni di varia natura. Ed è inoltre dotata di autonomia patrimoniale rispetto al patrimonio de singoli piloti.Le navi sono di comproprietà di ciascun pilota, che le concedono in uso alla corporazione. Essa, quindi, ne assume l’esercizio e provvede alle relative spese.
21

Quando il pilota cessa di far parte della corporazione, il valore della sua quota di comproprietà gli viene restituita.
93. Servizio di RIMORCHIOEsso consiste nella trazione o nella spinta di una nave, di un galleggiante o di altro mobile nei luoghi di approdo o di transito delle navi addette alla navigazione marittima. Esso concerne ogni operazione diretta ad imprimere (spingere) o rallentare o arrestare il movimento degli elementi rimorchiati.Esso è effettuato da apposite imprese in base a concessioni del capo del compartimento, nella quale sono determinati anche il numero e le caratteristiche dei mezzi tecnici. Effetti della concessione sono la legittimazione al servizio nella località stabilita, l’obbligo del concessionario di attuare il servizio secondo le norme di un apposito regolamento locale approvato dal ministro dei trasporti, l’obbligo a contrarre in ogni caso di richiesta ed in base alle tariffe stabilite dal capo del compartimento.
94. Ormeggiatori, battellieri, palombari e sommozzatoriGli ORMEGGIATORI provvedono ad ormeggiare le navi in arrivo, a vigilare sull’ormeggio durante la sosta della nave in porto e a disormeggiare la nave in partenza. Prestano la loro opera, per le navi in arrivo, quando la nave raggiunge il punto di ormeggio; per le navi in partenza, la loro prestazione termina quando la nave ha salpato le ancore e ha messo in moto.Il comandante del porto disciplina il servizio e determina il numero e le caratteristiche delle imbarcazioni di cui devono essere provvisti gli ormeggiatori.I BATTELLIERI, detti anche barcaioli, sono adibiti ai servizi attinenti al traffico, trasportando persone e beni necessari alla normale attività delle navi ferme in rada. Il comandante del porto disciplina il servizio e determina le tariffe.I PALOMBARI in servizio locale e i SOMMOZZATORI in servizio locale esercitano la loro attività nell’ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze. Possono anche prestare servizio in altri porti, ma solo con autorizzazione del porto a cui cono iscritti.Le imbarcazioni usate dai palombari e le pompe d’aria, di cui devono essere munite, devono possedere un certificato d’idoneità rilasciata dal Registro Italiano Navale.
- GLI AEROPORTI
Sez. 1 – L’organizzazione degli aeroporti
98. Gestione aeroportualeL’aeroporto è considerato innanzitutto un bene demaniale, a cui si applica la relativa disciplina; è, inoltre, considerato come ambito spaziale
22

in cui si esplicano attività imprenditoriali e come centro di attuazione di servizi pubblici e privati concernenti la movimentazione degli aeromobili e le attività complementari al trasporto aereo. Diversamente dal porto, gli aeroporti sono dati in concessione totale a soggetti che governano e gestiscono allo stesso tempo; quindi la gestione aeroportuale concreta un SERVIZIO PUBBLICO di IMPRESA.All’affidamento si provvede con decreto del ministro dei trasporti, in concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari, con il ministro della difesa.La concessione può avere una durata massima di 40 anni.L’affidamento in gestione è subordinato alla stipulazione di una convenzione e di un contratto di programma. Il GESTORE AEROPORTUALE è colui che ha il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e senza discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell’aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. Da questo emerge che la concessione di gestione è un nuovo modello di concessione speciale, che ha per oggetto non solo beni e servizi, ma una complessa attività sia di governo sia di gestione imprenditoriale.Il cod. nav. elenca i compiti e le funzioni del gestore aeroportuale:- organizza l’attività imprenditoriale- paga il canone di concessione- assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, fornendoli direttamente o coordinando lì attività dei fornitori- propone all’ENAC (Ente Nazionale dell’Aviazione Civile) l’applicazione delle misure sanzionatorie previste per l’inosservanza delle condizioni d’uso degli aeroporti e delle disposizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi- redige la Carta dei servizi e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualità dei servizi offerti all’utenza- assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, nonché la gestione degli oggetti smarriti- provvede alla liquidazione e riscossione dei diritti di uso degli aeroporti.
È evidente la differenza tra gestori aeroportuali e autorità portuali:- autorità portuali sono enti pubblici non economici, cui sono attribuiti compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo, ma non possono svolgere attività di impresa- gestori aeroportuali sono enti, anche privati, che, oltre ad amministrare, possono svolgere anche attività imprenditoriali, fornendo agli utenti servizi aeroportuali.
99. Polizia degli aeroportiLe funzioni di polizia negli aeroporti sono assicurate dall’ENAC, il quale vigila sui soggetti privati che esercitano un’attività all’interno degli
23

aeroporti, vigila sulla fornitura dei servizi di assistenza al volo, coordina e controlla il gestore aeroportuale. Il cod. nav. disciplina alcuni specifici poteri assegnati all’ENAC come quello di ordinare la messa a disposizione degli aeromobili in caso di urgente necessità, di provvedere al soccorso in caso di sinistro aeronautico, di ordinare la rimozione di relitti di aeromobili. L’ENAC, inoltre, disciplina la circolazione nelle strade aperte all’uso pubblico e provvede all’abbattimento del rumore aeroportuale.
Sez. 2 – I servizi aeroportuali
100. Assistenza a terraL’assistenza a terra (handing) comprende attività complementari e strumentali alla prestazione di trasporto del vettore aereo, che si svolgono in ambito aeroportuale. Si tratta di servizi di vario genere, tra cui: - assistenza ai passeggeri: controllo biglietti, registrazione bagagli, trasporto tra l’aerostazione e l’aeromobile…- assistenza ai bagagli: smistamento, caricamento sui sistemi trasportatori, caricazione e scaricazione…- assistenza a merce e posta: movimentazione, trattamento dei documenti, formalità doganali, caricazione e scaricazione…- assistenza all’aeromobile: parcheggio e spostamento, pulizia interna ed esterna, climatizzazione, rifornimento carburante, manutenzione…Non rientrano nell’assistenza a terra le altre attività che, pur svolgendosi nell’ambito aeroportuale, non riguardano la prestazione di trasporto del vettore aereo, ma sono offerto al solo scopo di migliorare la funzionalità e l’efficienza dell’aerostazione (es. servizio per la ristorazione a bordo).I servizi di assistenza a terra sono di solito esercitati in esclusiva ed affidati o al gestore aeroportuale oppure ad un altro soggetto in regime di concessione.Negli aeroporti con traffico annuale superiore a 2 milioni di passeggeri o a 50.000 tonnellate di merce, il servizio è stato liberalizzato; quindi, è riconosciuto il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra ai prestatori di servizi dotati di certi requisiti finanziari ed organizzativi.In tutti gli aeroporti è consentita l’autoproduzione, ovvero l’effettuazione dei servizi da parte del vettore per conto proprio.Negli aeroporti che servono regioni periferiche o in via di sviluppo, il ministro dei trasporti può disporre obblighi di servizio pubblico; ovvero l’obbligo di provvedere sovvenzioni, previa gara pubblica, a soggetti che altrimenti non avrebbero interesse economico a fornire il servizio.L’assistenza a terra è fornita ai vettori in base ad un contratto di appalto, che si basa su un formulario predisposto dalla IATA (International Air Transport Association).Le tariffe sono libere negli aeroporti in cui il servizio è prestato da almeno due fornitori. Mentre, negli aeroporti in cui il servizio è prestato da un solo fornitore, le tariffe sono stabilite da quest’ultimo e devono essere
24

comunicate al ministro dei trasporti. Se entro 45 giorni il ministro non esprima un motivato rifiuto, le tariffe si considerano approvate.
101. Controlli di sicurezzaI servizi di controllo di sicurezza in ambito aeroportuale, per il cui espletamento non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà, sono assicurati dal gestore aeroportuale. I servizi consistenti nei controlli dei passeggeri in partenza ed in transito, dei bagagli al seguito dei passeggeri, dei bagagli da stive e della merce possono essere svolti o dal gestore aeroportuale, previa concessione, oppure da altre imprese in possesso di requisiti tecnico-professionali, cui siano stati appaltati dal concessionario oppure direttamente dall’amministrazione. Questi servizi sono svolti sotto la vigilanza della Polizia di Stato.Altri servizi di controllo di sicurezza (es. controllo documentale dei passeggeri, vigilanza e custodia dei bagagli…) sono svolti dai vettori o da altri operatori aeroportuali, direttamente oppure tramite il gestore aeroportuale o imprese di sicurezza.Infine, il gestore aeroportuale svolge, direttamente oppure tramite un’impresa di sicurezza, i servizi di vigilanza dei beni aeroportuali di proprietà o in concessione.
102. Servizio antincendioL’ENAC determina le condizioni di applicabilità, attuazione e regolarità dei servizi antincendio in ambito aeroportuale.Il servizio antincendio nei più importanti aeroporti ed in quelli militari, è espletato dal Ministero dell’Interno, che vi provvede con personale, mezzi e materiale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.I locali necessari per il servizio antincendio, i relativi impianti tecnologici e le attrezzature ed infrastrutture per l’addestramento del personale sono apprestati dal Ministero dell’Interno, negli aeroporti a gestione statale e dal gestore, negli aeroporti affidati in concessione.Negli aeroporti minori e negli eliporti (piccoli aeroporti utilizzabili solo dagli elicotteri) il servizio è assicurato, a propria cura e spese, o dai titolari di licenza per servizi di trasporto non di linea, lavoro aereo o scuole di pilotaggio oppure dai gestori, con personale in possesso di apposita abilitazione.
Cap. 6 – ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA DELLA NAVIGAZIONE IN SENSO STRETTO- SERVIZI DI NAVIGAZIONE
Sez. 1 – I servizi marittimi e di navigazione interna
118. Servizi marittimi liberi e conferenziatiI traffici marittimi, compresi quelli di linea, sono, in via di principio, liberi, con la sola riserva del traffico di cabotaggio. Questo corrisponde al
25

principio consuetudinario della libertà di commercio marittimo, in base al quale gli Stati riconoscono alle navi di altri Stati la libertà di caricare e scaricare merce nei propri porti. Questo principio ha indotto le imprese di navigazione esercenti servizi di linea, a ricorrere a strumenti privatistici per acquisire un sicuro flusso di traffico, regolando la concorrenza.Così sono nate intese, dette conferenze marittime, che hanno il carattere di cartelli fra imprese che forniscono lo stesso servizio sulla stessa linea di navigazione, allo scopo di eliminare la reciproca concorrenza, ripartendo equamente il traffico tra le imprese conferenziate e fissando tassi di nolo uniformi, e allo scopo di difendersi dalla concorrenza originata da imprese esterne alla conferenza inducendo l’utenza a servirsi esclusivamente dei servizi conferenziati. Sono nate altre intese, dette consorzi, che hanno per oggetto accordi tecnici finalizzati a razionalizzare il servizio.Il sistema delle conferenze è stato regolato dalla Convezione di Ginevra del 1974, mediante il Codice di comportamento per le conferenze marittime. Secondo il Codice di comportamento, le compagnie marittime nazionali dei due Stati capilinea si ripartiscono l’80% del traffico conferenziato (rispettivamente il 40% ognuno), lasciando alle compagnie di Stati terzi il restante 20%.
119. Disciplina comunitaria dei servizi marittimiLa Comunità europea ha ritenuto opportuno intervenire allo scopo, da un lato, di disciplinare la partecipazione degli Stati membri al Codice di comportamento; da un altro, di applicare ai trasporti marittimi il principio della libera prestazione dei servizi e le regole di concorrenza comunitarie, nonché di tutelarsi dalle pratiche tariffarie sleali poste in essere da parte di Stati terzi e delle imprese loro appartenenti.In un primo momento, con il regolamento del 1979 sono stati liberalizzati, all’interno della Comunità e degli Stati membri dell’OCSE (Organizzazione di Cooperazione e Sviluppo Economico – a cui appartengono, oltre gli Stati membri della Comunità, anche l’Australia, gli Stati Uniti, la Norvegia, il Giappone, il Canada e la Nuova Zelanda), i traffici conferenziati regolati dal Codice di comportamento, escludendo l’applicazione delle disposizioni che regolano la partecipazione nel traffico. In questo modo, gli Stati membri della Comunità, ed eventualmente quelli appartenenti all’OCSE, si sono posti, nei confronti degli altri Stati aderenti al Codice, come un unico Stati contraente.In un secondo momento, nel 1986, sono stati emanati 4 regolamenti:1 – regola i trasporti non disciplinati dal reg. del 1979. Quindi i trasporti non conferenziati ed i trasporti conferenziati fra Stati che non sono parti del Codice di comportamento.2 – (abrogato) determinava le modalità di applicazione delle regole di concorrenza comunitarie ai trasporti marittimi internazionali di linea, esentando le conferenze marittime ed i consorzi.
26

3 – mira a scoraggiare le pratiche tariffarie sleali da parte di compagnie di linea di Stati terzi. Contro le pratiche sleali è prevista l’adozione di dazi compensativi.4 – mira a scongiurare il ricorso a misure protezionistiche da parte di Stati terzi, atte a limitare il libero accesso delle società di navigazione degli Stati membri ad un qualsiasi trasporto marittimo. In caso questo accada, è disposto il riscorso ad un’azione coordinata, consistente in rimostranza diplomatiche nei confronti dei Paesi terzi, seguite da contromisure dirette alle imprese di navigazione di tali Paesi, consistenti nell’imposizione di un’autorizzazione per il carico, il trasporto o lo scarico della merce, nell’imposizione di un contingente e di oneri finanziari.Successivamente, la Comunità non ha più riconosciuto utile il sistema delle conferenze marittime ed ha applicato anche ai servizi marittimi le regole generali sulla concorrenza (abrogato il 2 regolamento del 1986). Rimangono, però, consentiti gli accordi consortili, dai quali sono esclusi gli accordi sui prezzi, fino alla scadenza del regolamento che li prevede (prevista per il 2010).
120. Cabotaggio marittimo e servizi dei portiIl cod. nav. riserva agli armatori comunitari, che impiegano navi registrate in uno Stato membro e che battono bandiera del medesimo Stato, il cabotaggio fra i porti italiani ed il servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge, a condizione che tali navi siano ammesse agli stessi servizi in detto Stato membro.Gli armatori comunitari sono i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o le compagnie di navigazione da essi controllate.Non possono esercitare il cabotaggio fra porti italiani:- le navi registrate in uno Stato non comunitario- le navi in regime di sospensione iscritte nei registri delle navi locate- le navi esercitate da armatori non comunitari- le navi registrate in Italia ma di proprietà di cittadini non comunitari- le navi iscritte nel registro internazionale di un altro Stato membro quando non siano abilitate ad esercitare il cabotaggio fra i porti dello Stato a cui appartengono.Il cod. nav. non definisce il concetto di cabotaggio, ma è desumibile dal regolamento comunitario, il quale considera il cabotaggio un servizio di trasporto via mare di passeggeri o merce dietro compenso fra porti di un medesimo Stato. Quindi, il cabotaggio non concerne la navigazione in senso stretto, ma il traffico. Pertanto, le navi non comunitarie sono libere di navigare lungo le coste italiane e di toccarne i poti, ma non possono esercitare il traffico – ovvero il trasporto remunerato di cose o di persone da un porto ad un altro porto dello Stato.È importante sottolineare che non costituisce cabotaggio la navigazione di scalo, che consiste nel viaggio di una nave da due o più porti dello stesso Stato, allo scopo di sbarcare il carico proveniente dall’estero.
27

Possono considerarsi servizi di porto i servizi portuali attuati con navi; quindi il servizio di pilotaggio, rimorchio e soccorso.
121. Servizi marittimi sovvenzionatiIn passato, lo Stato italiano usava dare sovvenzioni a certe compagnie di navigazione, per assecondare l’interesse pubblico allo svolgimento di determinati servizi di linea, per merce e passeggeri, prevalentemente di cabotaggio.Questo sistema è cessato in seguito alla necessità di adeguarsi ai principi di diritto comunitario, che hanno liberalizzato il traffico di cabotaggio nella Comunità europea e che vietano gli aiuti di Stato.Secondo la disciplina comunitaria, quando lo Stato consideri lo svolgimento del servizio di cabotaggio di particolare interesse pubblico, può imporre i c. d. obblighi di servizio pubblico – ovvero obblighi che nessun armatore assumerebbe spontaneamente a quelle determinate condizioni.Questi tipi di servizi vengono sovvenzionati dallo Stato e possono formare oggetto di contratti di servizio pubblico, stipulati tra l’amministrazione e la compagnia di navigazione. Inoltre, devono essere offerti a tutti gli armatori comunitari senza discriminazione e devono essere aggiudicati mediante gara pubblica.
122. Servizi della navigazione internaI servizi della navigazione interna, di competenza delle Regioni, si distinguono in:1 – servizi pubblici di linea per trasporto di persone o cose, servizi pubblici di rimorchio e servizi pubblici di traino con mezzi meccanici (sono esercitati per concessione regionale, ad eccezione dei trasporti pubblici di linea di interesse regionale e locale, i quali sono affidati mediante contratto di servizio)2 – servizi di trasporto e di rimorchio per conto di terzi e servizi di traino con mezzi meccanici (sono sottoposti all’autorizzazione dell’autorità amministrativa regionale competente)3 – servizi di taxi e servizi di noleggio con conducente (sono assoggettati a licenza ed autorizzazione rilasciate dall’autorità comunale)4 – trasporto e rimorchio per conto proprio con navi di cui si è armatore (sono liberi).Per quanto riguarda gli interventi della Comunità europea, essi concernono:-divieto di accordi tra le imprese suscettibili di pregiudicare il gioco della concorrenza, tranne quelli che abbiano per oggetto l’applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica;- divieto di sfruttamento abusivo di posizione dominante- disciplina degli obblighi di servizio pubblico (consistono negli obblighi di esercizio del servizio di trasporto e obblighi tariffari che l’impresa di trasporto non avrebbe altrimenti assunto)
28

- liberalizzazione del cabotaggio (qualsiasi vettore di merce o di persone di uno Stato membro è ammesso ad effettuare trasporti per conto di terzi in un diverso Stato membro)- disciplina dell’accesso alla professione di trasportatore di merce per conto di terzi (può essere esercitata solo da chi è in possesso di uno specifico attestato rilasciato dagli uffici provinciali della motorizzazione civile di Milano e Venezia)- è stata sancita la libera prestazione di servizi per i vettori di merce o di persone per vie navigabili.
Sez. 2 – I servizi aerei
123. GeneralitàLa Convenzione di Chicago del 1944 sull’aviazione civile distingue:- servizi aerei registrati – quindi di linea – non possono essere esercitati senza uno speciale permesso o autorizzazione dello Stato, il cui territorio è destinato ad essere sorvolato- servizi aerei non registrati – quindi non di linea – se svolti con finalità commerciale, sono soggetti a tutte le norme, condizioni o limitazioni che lo Stato ritenga desiderabili. La differenza fra le due disposizioni è che l’intervento dell’amministrazione si attua verso i primi per consentirli , verso i secondi per vietarli. Per regolare i reciproci diritti di traffico, gli Stati ricorrono a trattative bilaterali, le quali sono di venute lo strumento fondamentale di organizzazione del traffico aereo nel mondo.Gli accordi unilaterali disciplinano prevalentemente la determinazione degli scali, la tipologia degli aeromobili, la designazione dei vettori…I servizi aerei che si svolgono nell’ambito territoriale della Comunità europea, compresi quelli che si esauriscono all’interno di uno stesso Stato, sono disciplinati dai regolamenti comunitari ed, in Italia, da qualche disposizione del cod. nav.Mentre, i servizi aerei che si svolgono fra Stati extracomunitari o fra uno Stato comunitario ed uno extracomunitario sono regolati, a livello internazionale, dal sistema degli accordi bilaterali e, per l’Italia, dal cod. nav.
124. Servizi di linea extra comunitariI servizi aerei di linea esercitati fra uno Stato membro della Comunità ed uno Stato terzo sono regolati dagli accordi bilaterali. Al riguardo, la Comunità europea ha affermato la propria competenza esclusiva per la disciplina delle tariffe e dei sistemi telematici di prenotazione.In Italia gli accordi possono farsi solo con Stati dotati di un sistema regolamentare di certificazione e di sorveglianza tecnica per lo svolgimento dei servizi di trasporto aereo, atto a garantire un livello di sicurezza conforme a quello previsto dalla Convenzione di Chicago.I vettori di parte italiana vengono designati dall’ENAC. Devono essere vettori muniti di licenza italiana o comunitaria, provvisti di mezzi
29

finanziari, tecnici ed assicurativi sufficienti da garantire il regolare svolgimento dei collegamenti in condizioni di sicurezza. I rapporti fra l’ENAC ed i vettori sono regolati da una convenzione, nella quale sono stabilite le condizioni di esercizio del servizio e gli obblighi dei vettori.I vettori designati decadono dal servizio in alcuni casi:- quando cedono il servizio assunto senza preventiva autorizzazione dell’ENAC- quando non iniziano l’esercizio nel giorno indicato dalla convenzione, a meno che il ritardo non derivi da causa a loro non imputabile- in seguito a provvedimento dell’ENAC assunto per gravi motivi di pubblico interesse.I diritti di traffico ai vettori sono attribuiti dall’ENAC, nel rispetto dei principi della libera concorrenza e secondo criteri trasparenti e non discriminatori.
125. Servizi di linea infra comunitariNell’ambito della Comunità europea i servizi di linea internazionali e nazionali sono stati ampiamente liberalizzati. L’accesso al traffico è garantito a tutti i vettori che abbiano ottenuto una licenza di esercizio e, preventivamente, un certificato di operatore aereo.Il certificato di operatore aereo è rilasciato dall’ENAC ed attesta che l’operatore possiede la capacità professionale e l’organizzazione aziendale necessarie ad assicurare l’esercizio dei propri aeromobili in condizioni di sicurezza; esso non è cedibile.La licenza d’esercizio è un’abilitazione che consente al vettore di effettuare a titolo oneroso i servizi di trasporto che intende svolgere. In Italia, la licenza è rilasciata dall’ENAC ad imprese stabilite in Italia, il cui controllo effettivo è esercitato da cittadini comunitari e la cui attività principale consiste nel trasporto aereo. Il richiedente deve dimostrare il possesso di requisiti amministrativi, finanziari ed assicurativi; deve dimostrare, inoltre, di disporre di uno o più aeromobili in proprietà o in base ad un contratto di utilizzazione, approvato dall’ENAC.Mentre il certificato di operatore aereo ha natura di attestazione, che dà la certezza giuridica tipica dell’atto pubblico, facendo prova fino a querela di falso, la licenza è un provvedimento abilitativo frutto di discrezionalità tecnica, ovvero non implica valutazioni di interesse pubblico generale.Una volta in possesso della licenza di esercizio, il vettore può esercitare i diritti di traffico su qualsiasi rotta all’interno della Comunità europea, compreso il traffico di cabotaggio.
Se uno Stato ritenga opportuno l’istituzioni di servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo, può imporre i c.d. oneri di servizio pubblico, i quali comportano che uno o più vettori selezionati mediante appalto pubblico, dietro compenso dello Stato, devono garantire la prestazione di servizi
30

che soddisfino determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione (sono criteri cui nessun vettore acconsentirebbe se tenesse conto del suo interesse commerciale).I vettori aerei comunitari fissano liberamente le tariffe per il trasporto di passeggeri e merce. Tuttavia, ogni Stato membro può disporre di ritirare una tariffa che sia ritenuta eccessivamente elevata per gli utenti oppure di bloccare riduzioni di tariffe che comportino perdite generalizzate per tutti i vettori aerei (la libertà tariffaria è esclusa per gli oneri di servizio pubblico).
L’efficacia della liberalizzazione dei diritti di traffico trova un ostacolo nella limitata disponibilità delle bande orarie (slots), ovvero degli orari programmati di atterraggio e di decollo di ogni aeromobile in un aeroporto in un dato giorno, durante i quali sia possibile utilizzare le infrastrutture aeroportuali. Per evitare una ingiusta distribuzione delle bande orarie è disposto che, negli aeroporti c.d. a orari facilitati (nei quali esiste un rischio di congestione) e in quelli c.d. coordinati (la cui capacità è insufficiente a consentire l’attività aeronautica richiesta) siano nominati rispettivamente un FACILITATORE ed un COORDINATORE, che sono responsabili dell’assegnazione delle bande orarie e devono operare in modo imparziale, non discriminatorio e trasparente. Il coordinatore è assistito da un comitato di coordinamento con funzioni consultive, cui partecipano i vettori aerei, le autorità aeroportuali ed i controllori del traffico aereo.
La Comunità europea ha, inoltre, esteso ai servizi infra comunitari le regole di concorrenza. In particolare, sono consentite alcune categorie di accordi, espressamente indicati, i quali abbiano per unico oggetto od effetto il raggiungimento di miglioramenti e l’instaurazione di una cooperazione sul piano tecnico.Sono consentiti, inoltre, gli accordi che, in relazione a servizi aerei fra aeroporti della Comunità o fra aeroporti di Stati terzi, abbiano per finalità consultazione per l’assegnazione delle bande orarie e coordinamento degli orari dei voli; consultazioni tariffarie per il trasporto di passeggeri e relativi bagagli sui servizi aerei di linea.
126. Servizi non di linea, servizi di lavoro aereo, scuole di pilotaggioLa disciplina dell’esercizio dei servizi aerei diversi da quelli di linea è lasciata all’iniziativa unilaterale di ogni singolo Stato.Con riguardo al trasporto aereo non di linea, per le rotte all’interno della Comunità, non si fa distinzione rispetto ai voli di linea, quindi vale la stessa normativa.Per i servizi aerei non di linea extracomunitari, si va affermando, come per i servizi di linea, la prassi del bilateralismo.
31

In ogni caso, questi servizi sono consentiti ai vettori titolari di licenza comunitaria ed ai vettori dello Stato in cui si svolge il traffico. In particolare, il vettore extracomunitario, per svolgere voli non di linea in partenza o in arrivo sul territorio italiano, deve preventivamente ottenere un accreditamento presso l’ENAC da parte delle autorità aeroportuali del proprio Stato e poi ottenere l’autorizzazione dell’ENAC.Per quanto riguarda, invece, i servizi di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio, la materia è disciplinata dal regolamento comunitario (approvato con d.m. nel 1981).
- SERVIZI DI LAVORO AEREOEsso comprende l’esecuzione, contro remunerazione:- di voli pubblicitari- di voli diretti ad effettuare riprese cinematografiche, fotografiche e televisive- di voli per spargimento di sostanze- tutti i voli per altre attività economiche o commerciali diverse dal trasporto di passeggeri e merci.Questo servizio rientra nelle attività sottoposte a licenza – quindi le perone, enti o società che intendono esercitare uno di questi servizi devono presentare al Ministero dei trasporti domanda per il rilascio della licenza, previa verifica dei requisiti tecnici e finanziari richiesti dal cod. nav.Inoltre, le imprese titolari di licenza dovranno sottoscrivere polizze di assicurazione per danni a terzi sulla superficie ai sensi del cod. nav.Infine, gli aeromobili utilizzati devono essere in proprietà oppure in disponibilità esclusiva per effetto di contratti di locazione
- SCUOLE DI PILOTAGGIOEsse provvedono, attraverso idonea organizzazione, ad impartire l’istruzione teorico-pratica per il conseguimento dei brevetti, delle abilitazioni e degli altri titoli previsti dalla legge.Esse comprendono le seguenti attività:- corsi di istruzione per il conseguimento dei brevetti di pilotaggio di volo a motore- corsi di istruzione per il conseguimento dell’abilitazione al volo strumentale su velivoli e elicotteri- corsi di istruzione per il conseguimento del brevetto di pilota di aliante veleggiatore- corsi di istruzione per il conseguimento del brevetto di pilotaggio di aerostati (dirigibile e pallone)127. Cabotaggio aereoLa Convenzione di Chicago riserva ad ogni Stato contraente il diritto di rifiutare agli aeromobili di altri Stati contraenti il permesso di imbarcare nel proprio territorio passeggeri, posta e merce, trasportati dietro compenso o dietro noleggio e destinati ad un altro punto del proprio territorio.
32

Sono esclusi dalla nozione di cabotaggio i trasporti non remunerati, quelli effettuati per diporto o per conto proprio o quelli gratuiti anche se effettuati da un’impresa di trasporti aerei. Il cod. nav. riserva alle imprese munite di licenza comunitaria i servizi di trasporto aereo, di linea e non di linea, fra aeroporti nazionali. Per quanto riguarda, invece, i servizi di trasporto aereo fra aeroporti nazionali da o per aeroporti extracomunitari, il principio di riserva alle imprese comunitarie può essere derogato da accordi internazionali.Nell’ambito della Comunità europea il cabotaggio è aperto a tutti i vettori comunitari.
Sez. 3 – I servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale
128. GeneralitàLe funzioni e i compiti amministrativi in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati, sono stati conferiti, nel 1997, alle Regioni a statuto ordinario ed agli enti locali.Si tratta di servizi di trasporto di linea di persone e merce, che operano nell’ambito di un territorio regionale o infra regionale (collegamenti aerei all’interno di una stessa regione, servizi elicotteristici, trasporti di navigazione interna…).L’esercizio di questi servizi è affidato mediante contratti di servizio, che possono anche comportare obblighi di servizio pubblico. I contrati di servizio non devono superare i 9 anni di durata.Attraverso gli obblighi di servizio pubblico, le Regioni assicurano la mobilità dei cittadini su tratte non remunerative, prevedendo nel contratto di servizio adeguate compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi.Alle regioni è, anche, affidata la gestione del rifornimento idrico delle isole minori, mediante apposite convenzioni con enti pubblici o privati di durata non superiore ai 2 anni per l’attuazione del servizio di provvista e trasporto dell’acqua.
CAPITOLO OTTAVOIL REGIME AMMINISTRATIVO DELLA NAVE E DELL’AEROMOBILE
Navi ed aeromobili devono avere una loro qualificazione e classificazione ai fini della determinazione della disciplina applicabile.
TITOLO IDEFINIZIONI E DISTINZIONI
1. Concetto, definizione e distinzione di nave e galleggiante►Nave:
33

Si qualifica Nave ogni mezzo galleggiante e mobile idoneo al Trasporto di persone e cose per acque marittime o interne avente anche scopo di rimorchio , di pesca, di diporto o altro scopo.(art.136 c. nav). Dunque requisito essenziale per la qualificazione di nave è la “destinazione al trasporto”. Per questo non sono da considerare nave i veicoli che sono privi all’attitudine a navigare (per i quali non si configura la destinazione al trasporto), quali:
I veicoli in costruzione I relitti oppure le navi destinati alla ristorazione od alberghi, ecc….
Le navi si distinguono in:a) Maggiori e minori.
Maggiori sono quelle che in virtù alle caratteristiche alle dotazioni e all’equipaggio sono utilizzate per la navigazione in alto mare;
Minori sono le navi costiere , sono atte soltanto alla navigazione costiera non oltrepassando le 20 miglia ovvero quelle che svolgono servizi di cabotaggio di collegamento con le isole.
b) Navi da guerra e navi civili Alle prime non si applica l’ordinaria disciplina del codice della
navigazione. Sono navi da guerra da un lato quelle comandate ed equipaggiate da personale militare o militarizzato , iscritte nelle liste del naviglio da guerra e che legittimano la propria qualità mediante appositi segni distintivi , il cui comandante appartiene al personale militare ed il cui equipaggio è soggetto alle regole e alla disciplina militare.
Le seconde sono le navi passeggeri e le navi mercantili private.
►Galleggiante:Per galleggiante si intende qualsiasi costruzione galleggiante mobile che non abbia l’anzidetta “destinazione al trasporto” e sia invece adibita a qualsivoglia altro servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne come ad es. dighe, chiatte ecc.. A questi si applica la disciplina del codice della navigazione.Sono considerate come appartenenti a categoria autonoma le piattaforme galleggianti per l'estrazione di prodotti dal fondo marino (off-shore), le quali quindi sono soggette ad un regime autonomo.
2. Concetto, definizione e distinzione di aeromobiliPer aeromobili si intendono quelle apparecchiature idonee al trasporto per aria di persone e cose da un luogo all'altro e, pertanto, non si considerano aeromobili i palloni aerostatici e simili. Gli aeromobili si distinguono in:
a) aerostati a sostentamento prevalentemente statico (mongolfiere), eventualmente muniti di un mezzo propulsore (dirigibili); cioè ogni aeromobile che si sostiene nell’area staticamente.
34

b) le aerodine, apparecchiature a sostentamento dinamico, per lo più muniti di un mezzo propulsore. Se muniti di motore comprendono aeroplani elicotteri idrovolanti ecc. se manca il motore costituiscono gli alianti .
Gli aeromobili si distinguono poi in:a) aeromobili di stato sono quelli militari, di polizia, della guardia di
finanza, del corpo dei vigili del fuoco, ecc., nonché quelli appartenenti allo stato. Sono soggetti ad una speciale disciplina ma solo in ambito nazionale; in ambito internazionale, infatti, anche gli aerei di stato non militari sono soggetti alla disciplina valida per gli aeromobili privati. “Convenzione di Chicago”
b) aeromobili privati, essi si distinguono in: aeromobili adibiti al trasporto di persone e cose; aeromobili destinati ad usi commerciali; aeromobili da turismo o sportivi.
TITOLO IIL’ISCRIZIONE DELLA NAVE E DELL’AEROMOBILE NEL REGIME AMMINISTRATIVO
3. Individuazione, nazionalità, iscrizione, abilitazione e cancellazione della naveElementi di Individuazione delle navi sono:
a) La stazza: indica la capacità interna della nave e si misura in “tonnellate di stazza” ognuna delle quali equivale a 2,83 metri cubi. Essa si distingue in:
Stazza lorda: indica l’intera capacità della nave Stazza netta: Indica l’effettiva capacità di carico.
b) il nome che deve essere diverso e non confondibile obbligatorio per le navi maggiori; ed il numero per le navi minori ed i galleggianti;
c) la sede di iscrizione, che è la sede dell'ufficio presso il quale viene effettuata l'iscrizione;
d) la nazionalità, costituisce una qualificazione giuridica del bene e comporta la soggezione dello stesso alla sovranità dello stato. Esso designa quindi un criterio di collegamento della nave inteso come bene con l’ordinamento giuridico di un determinato stato.
Collegata alla nazionalità del proprietario ovvero, nel caso di più proprietari, alla nazionalità dei detentori di almeno 12 dei 24 carati in cui si suddivide la proprietà della nave.
La Convenzione di Montego Bay del 1982 ha imposto il cosiddetto “Genuine Link”, che è il requisito in base al quale viene registrata la
35

nazionalità della nave. Tale requisito è quello della effettiva proprietà della nave ovvero della proprietà del maggior numero di carati della stessa, in quanto la nazionalità di iscrizione della nave deve essere quella degli effettivi proprietari e non di proprietari minoritari o di comodo. Il principio del genuine link è finalizzato ad evitare la registrazione delle navi presso paesi come il Panama e la Liberia che hanno regole molto meno rigide, specialmente in materia di sicurezza e di trattamento dei lavoratori di bordo, e quindi è finalizzato ad evitare registrazioni di comodo effettuate al solo scopo di eludere le regole. La nave, infatti, è considerata territorio fluttuante dello stato del quale essa porta la bandiera e quindi a bordo di essa si applicano le relative norme. La regola del genuine link, come tutte le regole internazionali di natura convenzionale, se da un lato pone un principio dell'altro non può essere imposta ad alcuno. La nave può anche portare temporaneamente un nazionalità diversa da quella del proprietario, se questa viene presa a nolo da un soggetto avente un’altra nazionalità, secondo il sistema del “Bareboat Charter Registration” (Registrazione di Scafo nudo a noleggio). Questo è un sistema di registrazione della nave o dell'aeromobile con la nazionalità dell’utilizzatore anziché del proprietario ed è, in buona sostanza, l'unico caso in cui la nave o l'aeromobile reca una doppia nazionalità: una di immatricolazione e l'altra di utilizzo. Questa doppia registrazione non determina la cancellazione della nave dai registri di immatricolazione ma la sola temporanea sospensione di tale sua registrazione. La nazionalità cambia, ovviamente, col trasferimento della proprietà della nave.
Affinché la nave possa essere ammessa alla navigazione occorrono l'iscrizione in pubblici registri e l'abilitazione alla navigazione.Per quanto riguarda l’iscrizione in pubblici registri:
a) Le navi maggiori sono iscritte in registri denominati matricole, tenuti dalle direzioni marittime (art, 146 e. nav.).
b) Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registro apposito tenuto dagli uffici compartimentali e circondariali e dagli uffici locali marittimi nonché dalle delegazioni di spiaggia, qualora ne sia riconosciuta la necessità dal direttore marittimo.
Successivamente alla loro iscrizione, le navi sono abilitate alla navigazione;
a) le navi maggiori sono abilitate dall'atto di nazionalità. L'atto di nazionalità è rilasciato dal direttore marittimo competente per luogo di immatricolazione; per le navi immatricolate all'estero, dal console che ha ricevuto l'iscrizione. Esso indica il nome, il tipo e le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave, nonché il nome del proprietario e l'ufficio di immatricolazione (art. 150 e. nav.).
36

b) Le navi minori e i galleggianti sono abilitati dalla licenza (art. 149 e. nav.). La licenza è rilasciata dall'ufficio presso il quale la nave o il galleggiante sono iscritti; essa deve indicare il numero, il tipo e le caratteristiche principali della nave, la stazza, il nome del proprietario, l'ufficio di iscrizione e il nome eventualmente dato al veicolo.
Il rilascio dell'atto di nazionalità e della licenza da diritto a inalberare la bandiera italianaL'atto di nazionalità e la licenza possono essere provvisoriamente sostituiti rispettivamente dal passavanti provvisorio e dalla licenza provvisoria. Questi vengono rilasciati:
a) in caso di urgenza alle navi di nuova costruzione o provenienti da un registro straniero. Per queste ultime occorre una dichiarazione dell'autorità marittima o consolare straniera che il venditore ha avanzato la richiesta di cancellazione della nave dai registri stranieri e che l'atto di nazionalità è stato preso in consegna.
b) alle navi il cui atto di nazionalità, o altro documento equivalente, sia andato smarrito o distrutto.
La Cancellazione della nave dal registro d’iscrizione è l’atto formale col quale si pone termine all’iscrizione. Ha effetti meramente amministrativi e non influisce sui diritti reali o di garanzia gravanti sul bene.I fatti giuridici che danno luogo alla cancellazione sono elencati dall’art. 163 c. nav e sono:
a) la perdita effettiva: si ha quando il bene viene a trovarsi in condizioni tali da non essere più idoneo alla navigazione (in caso di affondamento o distruzione);
b) la perdita presunta: si ha quando non si abbiano notizie per un certo lasso di tempo(4/8 mesi);
c) la demolizione: indica la distruzione della nave attuata volontariamente dal proprietario o coattivamente dall’autorità amministrativa.
d) la perdita dei requisiti di nazionalità in seguito ad autorizzazione alla dismissione della bandiera: si ha quando:
l’iscrizione della nave venga trasferito in un registro straniero non comunitario, salvo il caso in cui risulti in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo (Bareboat Charter Registration).
la nave venga acquistata da stranieri non comunitari.La cancellazione della nave ha luogo anche nel caso di passaggio di registro ovvero dal passaggio di qualifica da nave maggiore a nave minore.La perdita della nave si ha quando il bene non può più essere considerato tale, perché ha perso irreversibilmente la sua attitudine alla
37

navigazione oppure perché è stato destinato ad attività diversa dal trasporto.
4. Individuazione, nazionalità, iscrizione, abilitazione e cancellazione dell’aeromobile.Elementi di individuazione dell’aeromobile sono:
a) La Marca di Nazionalità: nel caso di aeromobili iscritti nel registro aeronautico nazionale è costituita dalla lettera maiuscola “I”.
b) La Marca di Immatricolazione: costituita da 4 lettere, deve essere diversa per ogni aeromobile. Per gli Alianti Libratori è previsto invece il Numero di Immatricolazione
c) La Nazionalità: criterio di collegamento del bene con l’ordinamento giuridico di un determinato stato , che comporta la soggezione dello stesso alla sovranità di tale stato . Essa è attribuita:
agli aerei civili appartenenti allo stato italiano ed agli enti pubblici italiani
agli aerei appartenenti a società che abbiano il presidente, il direttore generale e la maggioranza degli amministratori di nazionalità italiana o comunitaria.
Allo Stato , alle regioni , alle province , ai comuni ed a ogni altro ente pubblico o privato italiano o di altro stato membro dell’ unione europea.
Dunque in generale la nazionalità dell’aeromobile è quella del “proprietario” ma, come avviene per le navi, essa può essere temporaneamente sostituita con quella dell’”utilizzatore” secondo il sistema del Bareboat Charter Registration, senza che ciò determini la cancellazione dell’aeromobile dagli appositi registri.
Per quanto riguarda l’iscrizione: Per essere ammessi alla navigazione , gli aeromobili devono essere immatricolati , mediante l’iscrizione nel registro aeronautico nazionale ed abilitati alla navigazione .
a) Gli aeromobili, che rispondono ai prescritti requisiti di individuazione e di nazionalità, sono immatricolati nel registro aeronautico nazionale, tenuto dall'amministrazione aeronautica ENAC;
b) gli alianti libratori sono iscritti nel registro matricolare tenuto dall'Acro Club d'Italia (art.758 e. nav.).
L'iscrizione deve essere richiesta dal proprietario entro otto giorni dal rilascio del certificato di navigabilità o, per gli alianti libratori, del certificato di collaudo (art. 754).
38

L'iscrizione degli aeromobili ha la stessa natura giuridica dell'iscrizione della nave.Per quanto riguarda l’abilitazione:
a) Gli aeromobili sono abilitati alla navigazione dal certificato d'immatricolazione, che è rilasciato dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti dopo l'iscrizione dell'aeromobile nel registro.
b) Gli alianti libratori sono abilitati alla navigazione dall'attestazione dell'avvenuta immatricolazione fatta dall'Acro Club d'Italia, mediante annotazione sul certificato di collaudo.
L'aeromobile è cancellato dal registro di iscrizione, su richiesta del proprietario o d'ufficio, quando:
a) è perito o si presume perito; (qualora siano trascorsi almeno 3 mesi dalle ultime notizie )
b) è stato demolito;c) ha perduto i requisiti di nazionalità;d) è stato iscritto in un registro di altro Stato;e) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel
registro di altro Stato comunitario;f) è stato riconsegnato al proprietario, in caso di iscrizione effettuata
in base a un titolo diverso dalla proprietà.
7. I documenti di bordo della naveLe navi debbono essere provviste di particolari documenti, che sono:
a) le carte di bordo: l'atto dì nazionalità e il ruolo di equipaggio, per le navi maggiori; la licenza, che sostituisce entrambi questi documenti, per le navi minori e per i galleggianti;
b) le certificazioni inerenti alla sicurezza : il certificato di stazza, il certificato di classe o di navigabilità, i certificati dì bordo libero e di galleggiabilità, i certificati di visita, tutti gli altri documenti comprovanti l'adempimento delle prescrizioni relative alla sicurezza della vita umana in mare;
c) i documenti doganali e sanitari ;d) i libri di bordo: il giornale nautico, il giornale di macchina, il
giornale radiotelegrafico. Per le navi minori e per i galleggianti superiori a una determinata stazza, nonché per le navi addette alla navigazione interna è prescritto il solo inventario di bordo. I libri di bordo hanno fondamentalmente una funzione di carattere pubblicistico; tuttavia taluni di essi esplicano anche funzione di documenti probatori dell'attività commerciale della nave.
Il giornale nautico è il libro che adempie a una più complessa e incisiva finalità in relazione alla navigazione. Esso è composto dei seguenti libri:
inventario di bordo; giornale generale e di contabilità;
39

giornale di navigazione; giornale di carico o di pesca, se la nave è destinata alla pesca.
Il giornale nautico è da considerare il libro di bordo che documenta i momenti tecnici, amministrativi e le attività essenziali della navigazione e della vita di bordo.
8. I documenti di bordo dell’aeromobileGli aeromobili devono avere a bordo durante il volo:
a) il certificato di immatricolazione;b) il certificato di navigabilità;c) i documenti doganali e sanitari;d) il giornale di bordo;e) il certificato acustico;f) gli altri documenti prescritti da leggi e regolamenti.
Gli aeromobili da turismo sono esenti dall'obbligo di tenere il giornale di bordo.Gli alianti devono avere a bordo durante il volo i certificati di immatricolazione e dì navigabilità, nonché gli altri documenti prescritti da leggi e regolamenti.Inoltre, gli aeromobili adibiti al trasporto di passeggeri e di merci devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile e del libretto dei motori e delle eliche
Tutte le annotazioni sui libri di bordo della nave e dell’aeromobile sono redatte dal comandante e hanno efficacia probatoria salvo querela di falso.
CAPITOLO IX
LA COMPROPRIETÀ
La proprietà della nave o dell'aeromobile, ove sia di più persone, è soggetta al regime civilistico sulla comunione dei beni, salve le poche regole IN materia previste dal codice della navigazione.La comproprietà della nave, in particolare, è divisa in 24 carati, frazionabili. La sua nazionalità è determinata in base alla nazionalità dei possessori di almeno 12 carati. I carati si presuppongono di uguale valore e le decisioni dei condomini vengono assunte con la maggioranza assoluta e con effetto vincolante per i dissenzienti minoritari. A differenza della disciplina civilistica, il comproprietario non può costituire ipoteca sulla sua quota senza il consenso della maggioranza dei condomini, ciò in quantol'ipoteca può determinare l'ingresso nella comunione di soggetti di nazionalità diversa da quella dei condomini ed in base alla quale è stata determinata la nazionalità della nave, mettendone così a rischio il mantenimento.
40

Le decisioni assunte a maggioranza, vincolanti per la minoranza, sono tutte quelle che riguardano l'interesse comune genericamente inteso e, quindi, praticamente tutte. Per le spese superiori alla metà del valore della nave è necessaria la maggioranza dei 2/3, ossia 16 carati, e sono in ogni caso ammesse solo se con esse non si alteri la destinazione della nave.Quando una deliberazione non può essere presa per difetto di maggioranza, il tribunale che, su richiesta di uno o più caratisti, provvede secondo l’interesse comune (art. 261 c. nav.). Per gli atti di alienazione della nave è necessario il consenso di tutti i partecipanti.
Per l'aeromobile valgono le stesse regole ma la sua comproprietà non è divisa in carati bensì in quote di valore non necessariamente uguale. In più, rispetto alle altre regole, vi è quella che vieta la vendita della quota ad unostraniero senza il consenso della maggioranza, per le stesse possibili ripercussioni sulla nazionalità del veicolo.Nel resto valgono le stesse normali regole del codice civile sulla comunione di beni, ivi compreso l'obbligo di sopportare le spese pro-quota, la facoltà di ognuno di chiedere lo scioglimento della comunione nonché la facoltà di altri di evitarlo mediante l'acquisto ad un prezzo equo della quota del condomino uscente.
Cap. 11 – L’ESERCZIO DELLA NAVE E DELL’AEROMOBILE
- L’ARMATORE E L’ESERCENTE
195. DefinizioneIl cod. nav. definisce l’armatore e l’esercente:- ARMATORE è chi assume l’esercizio della nave- ESERCENTE è chi assume l’esercizio di un aeromobileQuindi, la figura dell’esercente corrisponde, nella navigazione aerea, a quella dell’armatore nella navigazione per acqua.L’esercizio può definirsi come quell’attività organizzata , inerente all’impiego della nave o degli aeromobili , rivolta al conseguimento di un risultato economico connesso al soddisfacimento di un bisogno proprio dell’esercente. Il concetto di esercizio si fonda essenzialmente non tanto sull’aspetto formale ovvero la navigazione in quanto tale ma più sull’aspetto teleologico ovvero l’attività organizzativa.Il concetto di esercizio prescinde dalla proprietà del veicolo, perché può presupporre anche un diritto reale limitato (es. usufrutto) o anche un rapporto obbligatorio (es. contratto di locazione).Il concetto di esercizio prescinde anche dall’armamento, ovvero la fornitura di tutto il necessario per la navigazione (attrezzature, equipaggiamento,…). Quindi un soggetto che provvede ad armare la nave non ne assume l’esercizio, ma questo viene assunto dall’armatore.
41

196. Esercizio ed impresaL’esercizio di una singola nave o di un singolo aeromobile configura l’impresa di navigazione.Il termine impresa usato nel cod. nav. ha un significato diverso di quello usato nel cod. civile.Il cod. civ. designa l’impresa l’esercizio professionale di un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.Infatti, non sempre nell’esercizio possono riconoscersi tutti gli elementi che sono il presupposto dell’attività commerciale. La nave e l’aeromobile, infatti, possono essere esercitati a scopo di diporto o per spedizione scientifiche oppure essere gestiti in via meramente occasionale – è evidente che in questi casi non è ipotizzabile l’impresa per la carenza della finalità produttiva o di scambio e del requisito della professionalitàPertanto, il diritto commerciale investe l’esercizio della navigazione quando questo configura un’impresa, ma non preclude l’applicazione della disciplina del cod. nav.Lo stesso può dirsi con riguardo all’esercizio di attività di pesca. Infatti, l’armatore è anche imprenditore ittico. (la disciplina dell’imprenditore ittico non si applica all’esercizio della pesca sportiva o della pesca-turismo).
Sommario:- l’esercizio di una singola nave o di un singolo aeromobile costituisce l’impresa di navigazione ed è regolato dal diritto della navigazione- nell’ipotesi di esercizio della navigazione sotto forma di impresa come definita dal cod. civile (ovvero esercizio professionale di un’attività economico-produttiva) la disciplina dell’impresa si aggiunge a quella del cod. nav.
197. Pubblicità dell’esercizioCon riguardo all’ARMATORE, prima di assumere l’esercizio della nave, deve fare dichiarazione di armatore all’ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante. La dichiarazione deve contenere: le generalità, la nazionalità, il domicilio o la residenza dell’armatore; gli elementi di individuazione della nave (nome o numero, stazza…).Quando l’esercizio è assunto da persona diversa dal proprietario, occorrono anche le generalità, nazionalità, domicilio o residenza del proprietario; l’indicazione del titolo che attribuisce l’uso della nave o del galleggiante.La dichiarazione viene trascritta nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante e, per le navi maggiori, annotata sull’atto di nazionalità.
42

Con riguardo, invece, all’ESERCENTE, prima di assumere l’esercizio dell’aeromobile, deve farne dichiarazione all’ENAC. La dichiarazione deve essere fatta nelle stesse forme e con le stesse modalità della dichiarazione di armatore e viene trascritta nel registro aeronautico nazionale ed annotata sul certificato di immatricolazione.
Se vi è discordanza tra la trascrizione nel registro e le annotazioni sui documenti di bordo, prevalgono le risultanze del registro.In mancanza di dichiarazione, armatore ed esercente si presume il proprietario fino a prova contraria.A tutela degli interessi del proprietario non armatore o esercente, il cod. nav. dispone che, qualora l’armatore o l’esercente non provveda alla dichiarazione, questa può essere effettuata dal proprietario della nave o dell’aeromobile.
Per quanto riguarda l’efficacia dichiarativa della pubblicità la dottrina ritiene che, da un lato, la dichiarazione dovrebbe avere l’effetto positivo dell’opponibilità ai terzi in buona fede del fatto trascritto, dall’altro l’effetto negativo dell’inopponibilità ai terzi in buona fede del fatto non trascritto.Tuttavia, altra parte della dottrina ritiene che si tratti di pubblicità-notizia (serve a dare semplice notizia di determinati fatti, ma la sua omissione non influisce né sulla validità né sull’efficacia e costituisce un obbligo). Il suo effetto è quello di rendere a tutti gli interessati la conoscenza dei fatti iscritti; tuttavia, non è preclusa la prova che i fatti iscritti non corrispondano alla realtà oppure che, in assenza di dichiarazione, che l’esercizio sia stato assunto da persona diversa da quella del proprietario.L’adempimento della dichiarazione, nell’ipotesi dell’armatore che sia anche proprietario, costituisce una semplice facoltà, in quanto il proprietario si presume armatore.Nell’ipotesi, invece, di armatore che non sia proprietario, esso costituisce un onere per la dottrina che attribuisce efficacia dichiarativa alla dichiarazione. Mentre, ritenendo che si tratti di pubblicità-notizia o di un mezzo di prova precostituito, esso costituisce una facoltà, in quanto l’interessato ha facoltà di scegliere se provvedere alla dichiarazione oppure fornire successivamente la prova del fatto non trascritto.
La dichiarazione di armatore non è richiesta quando i comproprietari della nave si siano costituiti in società di armamento, perché la pubblicità dell’atto costitutivo sostituisce la dichiarazione.Non è nemmeno richiesta per l’esercizio di navi straniere prese in locazione ed iscritte nel registro speciale delle navi locate. Inoltre, non è richiesta per le navi addette alla navigazione interna.
43

La dichiarazione di esercente non è richiesta per l’esercizio di aeromobili presi in locazione per più di 6 mesi, perché è sostituita dalla pubblicità del contratto di locazione.
198. Conferenze e consorzi marittimiGli armatori che esercitano servizi di trasporto nell’ambito di una stessa linea usano associarsi in cartelli, detti conferenze marittime, allo scopo di regolare la concorrenza fra di loro e di limitare o, se è possibile, di eliminare la concorrenza di armatori non partecipanti alla conferenza.L’accordo conferenziale comporta, da un lato, l’uniformazione delle tariffe e delle condizioni di trasporto, la ripartizione delle percorrenze e, a volte, mediante appositi pools, la messa in comune dei carichi e dei noli. D’altra parte, sono attuate pratiche dirette a vincolare gli utenti con accordi di fedeltà che prevedono sconti di vario genere sulle tariffe.La Comunità europea ha dichiarato l’illegittimità delle conferenze marittime, in quanto contrastanti con le regole comunitarie che presiedono alla concorrenza.
I consorzi marittimi sono forme di cooperazione finalizzate a razionalizzare le operazioni di trasporto marittimo svolte in comune tramite accordi tecnici o commerciali (con esclusione della determinazione dei prezzi), fino a realizzare un vero e proprio servizio congiunto fra le imprese stesse.Fra le intese che integrano gli accordi di consorzio, la più significativa consiste nella messa in comune delle capacità di carico, attraverso lo scambio reciproco, da parte degli armatori, di quote di stive delle proprie navi. Questo determina la necessità di ulteriori accordi di carattere tecnico, quali l’uso in comune di terminali portuali e servizi annessi, l’uniformità delle procedure informatiche e della documentazione relativa… Con il regolamento CE del 2000 tali attività sono state esentate, a certe condizioni, dal rispetto delle regole sulla concorrenza.
199. Accordi di collaborazione fra compagnie aereeLa liberalizzazione dei servizi aerei ed il conseguente incremento della competitività fra compagnie aeree, hanno determinato lo sviluppo di accordi di collaborazione tendenti a ridurre la concorrenza ed a razionalizzare i servizi, con effetti benefici sui costi di gestione. Si tratta di contratti atipici, fra i quali i più importanti sono il code sharing, il franchising, il wet lease e l’interchange agreements.
1 – CODE SHARING è l’accordo più diffuso. Tramite esso una compagnia aerea, che esercita voli di linea col proprio codice di designazione (denominata vettore operativo), consente ad un’altra compagnia (denominato vettore commerciale) di aggiungere il proprio diverso codice sullo stesso volo e di vendere i relativi biglietti di trasporto con tale codice a proprio nome.
44

La finalità dell’accordo è quella di ottimizzare l’efficienza operativa delle due compagnie, evitando duplicazioni di voli e razionalizzando la capacità degli aeromobili.Gli accordi di code sharing sono spesso inseriti in più ampi accordi di collaborazione, che possono prevedere la programmazione degli orari, la suddivisione dei ricavi, la qualità dei servizi offerti, l’assistenza a terra…I vettori sono tenuti a rispettare le regole di concorrenza e i requisiti di sicurezza prescritti. Inoltre, quando il trasporto aereo è effettuato da un vettore di verso da quello indicato nel biglietto, i passeggeri devono essere informati.
2 – FRANCHISING (o contratto do affiliazione commerciale)Con esso un’impresa affiliante concede ad un’altra impresa affiliata il diritto di utilizzare la denominazione commerciale dell’affiliante, vendendo prodotti o prestando servizi a nome di questa. La compagnia aerea affiliata utilizza segni distintivi e codice di volo dell’affiliante ed emette i biglietti di passaggio in nome di quest’ultimo; le bande orarie sono dell’affiliata, ma le linee servite rientrano nella rete dell’affiliante. Il corrispettivo è generalmente costituito da una percentuale del volume di affari.
3 – WET LEASE è un contratto mediante il quale una compagnia aerea esercente si obbliga nei confronti di un’altra compagnia a mettere a disposizione uno o più aeromobili con il proprio equipaggio oppure a compiere un certo numero di viaggi su linee servite da quest’ultima e utilizzando il codice di designazione di quest’ultima. L’obbiettivo che si cerca di realizzare può essere quello di assolvere ai propri doveri di servizio in temporanea carenza di aeromobili o di personale.
4 – AIRCRAFT INTERCHANGE AGREEMENTS servono per consentire ad una compagnia aerea di trasportare passeggeri o merce per un viaggio che solo per una prima parte può essere da lei effettuato in base ai propri diritti di traffico, perché per una seconda parte tali diritti spettano ad un’altra compagnia aerea. Quindi, in base all’accordo fra le due compagnia, l’aeromobile di cui la prima compagnia ha l’esercizio effettua l’intero viaggio, ma per la seconda parte l’esercizio si trasferisce alla seconda compagnia, la quale sostituisce con il proprio equipaggio quello della prima. Il rapporto fra le due compagnie si qualifica come locazione di aeromobile e solo la prima compagnia figura come vettore contrattuale per tutto il percorso.
- LA RESPONSABILITA’ DELL’ARMATORE E DELL’ESERCENTE E LA RELATIVA LOMITAZIONE
200. Disciplina della responsabilitàLa disciplina della responsabilità dell’armatore e dell’esercente si inquadra nei principi stabiliti in materia di responsabilità del codice civile.
45

Il cod. nav. dispone solo che l’armatore e l’esercente sono responsabili dei fatti commessi dall’equipaggio (compreso il comandante) in virtù del rapporto di preposizione.Inoltre, il comandante ha la rappresentanza dell’armatore e dell’esercente; quindi, costoro, per quanto riguarda la nave, l’aeromobile e la spedizione, sono direttamente impegnati dall’attività negoziale del comandante che agisce in nome e per conto loro.L’armatore e l’esercente non sono responsabili per l’adempimento di obblighi pubblicistici, che la legge impone al comandante, in quanto il soggetto è tenuto personalmente e direttamente.Il codice della navigazione stabilisce il criterio generale d’imputazione di tutti i fatti del comandante e dell’equipaggio imputandoli all’esercente o all’ armatore.È imputabile all’armatore ed all’esercente la responsabilità per tutte le obbligazioni, sia che esse derivino da contratti stipulati dal comandante in nome e per conto loro, sia che derivino da fatti illeciti del comandante o di altro membro dell’equipaggio.
Importante è l’Art. 143 c. nav. il quale consente l’iscrizione nei registri italiani di navi appartenenti a persone non comunitarie, purché queste assumano direttamente l’esercizio della nave attraverso un’organizzazione sul territorio italiano con gestione demandata a persona comunitaria, che assuma la responsabilità dell’esercizio facendone dichiarazione presso l’ufficio di iscrizione.Quindi, la responsabilità viene attribuite al rappresentante, in deroga ai principi in tema di mandato con rappresentanza.
La disciplina del cod. nav., disponendo solo i criteri di imputazione, ricorre all’integrazione normativa del cod. civ., in assenza di una disciplina speciale.Ad es. con riferimento alla responsabilità extracontrattuale si ritiene che gli artt. del cod. nav. devono essere considerati speciali rispetto all’Art. 2049 c. civ., il quale detta il criterio di imputazione per padroni e committenti; quindi non riceve applicazione in tema di responsabilità dell’armatore e dell’esercente. Mentre, si ritengono applicabili in materia di navigazione gli artt. del cod. civ. sulla responsabilità per l’esercizio di attività pericolosa e per danni cagionati da cose in custodia – responsabilità oggettiva).
L’Art. 879 c. nav. regola la responsabilità dell’ESERCENTE nel caso di uso dell’aeromobile senza il suo consenso; in questo caso l’esercente risponde, in solido con l’utente abusivo, solo se non abbia rispettato la dovuta diligenza al fine di evitare tale uso. Inoltre, il cod. nav. dispone che, in caso di responsabilità derivante dell’utilizzazione dell’aeromobile da parte di chi abbia acquistato il diritto di utilizzarla per non più di 14 giorni, l’esercente risponde in solido con l’utilizzatore.
46

(Queste norme sono applicabili per analogia alla navigazione marittima.)
Per quanto riguarda l’unità da diporto la responsabilità verso terzi derivante dalla loro circolazione è regolata dal c.c. ovvero il conducente è presunto responsabile e può liberarsi solo provando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.(il diritto al risarcimento dei danni si prescrive in 2 anni).
Le convenzioni internazionali prevedono speciali regimi di responsabilità, con riferimento ai danni a terzi provocati dal trasporto marittimo di idrocarburi, di sostanze nucleari, di sostanze pericolose e nocive.Con riguardo ai danni provocati dal trasporto di idrocarburi e sostanze nucleari, le norme internazionali non imputano la responsabilità all’armatore, ma al proprietario della nave ed all’esercente dell’impianto nucleare.Mentre, con riguardo ai danni provocati dal trasporto di sostanze pericolose e nocive, dispone la Convenzione di Londra del 1996, il quale non è ancora in vigore.
201. Limitazione della responsabilità dell’ARMATOREÈ tradizionale alla navigazione marittima l’istituto della limitazione della responsabilità dell’armatore. Secondo il cod. nav. la limitazione della responsabilità dell’armatore si riferisce a tutte le obbligazioni che vincolano l’armatore in occasione e per bisogni di un viaggio e a quelle sorte da fatti o atti compiuti durante il viaggio stesso, ad eccezione delle obbligazioni derivanti da dolo o colpa grave dello stesso armatore.
Per viaggio deve intendersi la navigazione dal porto di partenza fino al porto di approdo, comprese le operazioni preparatorie, strumentali o complementari, anteriori alla partenza e successive all’approdo.L’elemento patrimoniale, al quale si riferisce la limitazione, è costituito da una somma, pari al valore della nave ed all’ammontare lordo del nolo e di ogni altro provente del viaggio.Il valore della nave, che si assume per stabilire la somma limite, è determinato con riferimento al momento in cui la limitazione è richiesta e non oltre la fine del viaggio. Ma se il valore della nave, al momento della richiesta, è inferiore ad 1/5 del valore della nave all’inizio del viaggio, la somma limite è data da questo quinto; se invece il valore della nave al momento della richiesta è superiore ai 2/5, la somma limite è data da questi 2/5.Il valore della nave all’inizio del viaggio è dato dalla polizza di assicurazione come valore di stima. In mancanza, si fa ricorso al valore commerciale stabilito dagli accertamenti svolti dal registro di classificazione.
47

Per nolo deve intendersi i corrispettivo del contratto di noleggio o di trasporto di cose o persone, in relazione al viaggio al quale si riferisce la limitazione, integrato da alcune retribuzioni accessorie.
La limitazione non opere ex lege, ma è frutto dell’esercizio di un diritto potestativo dell’armatore, che si esperisce con ricorso all’autorità giudiziaria competente, la quale dichiara, con sentenza, aperto il procedimento di limitazione.
202. Natura della limitazioneÈ discusso se il sistema di limitazione della responsabilità configuri una limitazione del debito o della responsabilità. Per limitazione del debito consiste nella riduzione del corrispondente credito entro i limiti complessivi di una determinata somma dovuta dal debitore, di questa somma il debitore ne risponde con tutto il suo patrimonio . Per limitazione di responsabilità avviene secondo la separazione dal complesso del patrimonio del debitore di alcuni beni ; solo su questi i creditori possono farsi valere, per coloro che siano rimasti inadempienti è possibile azione di regresso.È stato disposto che il sistema attuato dal cod. nav. concrea una limitazione della responsabilità e non del debito dell’armatore.
Il cod. nav. dispone che, dalla data di pubblicazione della sentenza di apertura del procedimento di limitazione, i CREDITORI soggetti alla limitazione non possono promuovere l’esecuzione forzata sui beni dell’armatore per le obbligazioni soggette alla limitazione. Inoltre, l’armatore è tenuto a depositare una somma limite sulla quale concorrono i creditori soggetti a limitazione, secondo l’ordine delle rispettive cause di prelazione. In questo modo si attua una separazione dal patrimonio dell’armatore della somma limite. (Questo dimostra che non si tratta di una limitazione del debito, perché se così fosse i creditori potrebbero esperire l’azione esecutiva sui beni dell’armatore.)
203. Disciplina internazionaleA livello internazionale esistono 3 Convenzioni, nessuna delle quali è stata ratificata in Italia.1 – Convenzione sulla limitazione della responsabilità dei proprietari di nave, redatta a Bruxelles nel 19242 – Convezione sulle limitazione di responsabilità dei proprietari di nave, redatta a Bruxelles nel 19573 – Convenzione di Londra del 1976 sulla limitazione di responsabilità per crediti marittimi.La Convenzione di Londra ha modificato in modo sostanziale l’istituto della limitazione. Infatti, è stato esteso il beneficio della limitazione anche al noleggiatore, al soccorritore ed all’assicuratore della responsabilità. Tuttavia, i crediti nei confronti dei quali il beneficio è ammesso sono inferiori, non essendovi compresi quelli per compenso di
48

soccorso o per contributo di avaria comune, quelli per inquinamento e danno nucleare. La composizione della somma limite è commisurata alle tonnellate di stazza lorda della nave e varia, a seconda della stazza, per i danni alle cose e per i danni alle persone.
204. Limitazione della responsabilità dell’ESERCENTELa responsabilità dell’esercente non è limitata globalmente, ma sussistono diverse e specifiche limitazione per varie cause di responsabilità. Ad es. per il risarcimento di danni da urto il cod. nav. dispone che il risarcimento complessivo dovuto dall’esercente è limitato alle somme previste dalla normativa comunitaria come copertura assicurativa minima della responsabilità verso i terzi per incidente.
La disciplina della limitazione dell’esercente differisce da quelle dell’armatore in alcuni punti:- la limitazione opera ex lege, non essendo necessaria una dichiarazione dell’esercente- la somma limite, anziché al valore del veicolo, è fissata in base a coefficienti predeterminati o a somme prestabilite- la limitazione non ha luogo per viaggio, ma per incidente- si tratta, in ogni caso, di limitazione del debito, non della responsabilità.
205. Responsabilità per inquinamento del mare causato da naviÈ stata sviluppata, di recente, un’intensa attività normativa, soprattutto a livello internazionale, al fine di prevenire incidenti che determinano il versamento in mare di ingenti quantità di idrocarburi e quindi di diminuire gli effetti dannosi ed al fine di istituire un regime di responsabilità idoneo a compensare i soggetti danneggiati.È stata approvata la Convenzione di Bruxelles nel 1969 sulla responsabilità civile per danni da inquinamento da idrocarburi (detta CLC) integrata dalla Convenzione di Bruxelles del 1971 sulla creazione di un Fondo internazionale per il risarcimento dei danni da inquinamento da idrocarburi (detta IFC).La Convenzione CLC si applica ai danni da inquinamento da idrocarburi fuoriusciti o scaricati da navi (escluse navi da guerra e le navi di Stato utilizzate per un servizio non commerciale), in conseguenza ad un incidente, purché tali danni si verifichino nel territorio o nel mare territoriale o nella zona economica esclusiva di uno Stato contraente.La responsabilità è imputata al proprietario della nave; costui può liberarsi solo provando che il danno:- è derivato da un atto di guerra, ostilità, guerra civile, insurrezione, o da un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile ed irresistibile;- è stato interamente causato dall’atto od omissione di un terzo compiuto con l’intenzione di provocare il danno;
49

- è stato interamente causato da colpa dell’autorità addetta alla manutenzione dei fari o di altri aiuti alla navigazione, nell’esercizio di tale funzione,- è derivato, in tutto o in parte, dall’atto od omissione della persona che ha subito il danno (in questo caso il proprietario è liberato, in tutto o in parte, dalla sua responsabilità verso tale persona.Si può dunque parlare di RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, però, non assoluta, perché il fatto dannoso prescinde dalla considerazione dei fatti che l’abbiano provocato e tanto meno dalla condotta di un soggetto o del suo atteggiamento psicologico; è sufficiente il verificarsi dell’evento dannoso per determinare il sorgere dell’obbligazione risarcitoria.Oltre all’autore del danno e della sua condotta, è irrilevante anche il nesso di casualità. Occorre tener presente inoltre che la responsabilità del proprietario viene mento quando non è lui l’armeggiatore in quanto il criterio d’imputazione risulta totalmente estrinseco all’attività produttrice del fatto dannoso.Si tratta di una RESPONSABILITA’ CANALIZZATA, poiché la Convenzione esclude che i danneggiati possano agire nei confronti di tutti gli altri soggetti diversi dal proprietario della nave, potenzialmente responsabili (es. equipaggio, pilota, armatore…), a meno che il danno non sia derivato da dolo o da condotta consapevole di costoro.Invece, con riguardo al proprietario, la Convenzione gli consente l’azione di rivalsa verso i terzi responsabili.
A questo severo regime di responsabilità, si aggiunge la previsione dell’obbligo, a carico dei proprietari di navi cisterna di portata superiore alle 2.000 tonnellate, di contrarre un’assicurazione o altra garanzia finanziaria. In questo caso, il danneggiato ha azione diretta contro l’assicuratore.
Il proprietario ha il diritto di limitare la sua responsabilità per ogni sinistro, ad una certa somma per ogni tonnellata di stazza della nave, fino ad un massimo di 89.770.000 diritti speciali di prelievo. Tuttavia, il proprietario non può avvalersi di questa limitazione se il sinistro è stato causato da dolo o condotta consapevole a lui imputabili.
Nel caso in cui il danno non sia risarcibile ai sensi della Convenzione, oppure se l’entità dei danni superi il limite massimo consentito, oppure se l’assicurazione o altra garanzia finanziaria non sia sufficiente, la Convenzione IFC prevede l’intervento del Fondo internazionale, dotato di personalità giuridica, finanziati con i contributi degli interessati ai carichi di idrocarburi, che è obbligato fino al limite complessivo di 230 milioni di diritti speciali di prelievo oppure di 300.740.000 diritti speciali di prelievo se l’incidente avviene in periodi di elevata contribuzione finanziaria.Il Fondo non è obbligato quando dimostri che il danno è derivato da un atto di guerra, ostilità, guerra civile, insurrezioni, oppure quando si tratta
50

di nave di Stato utilizzata per un servizio non commerciale, o ancora quando è derivato dall’atto od omissione colposo o doloso della persona che ha subito il danno.
Il diritto al risarcimento è assoggettato ad un doppio termine di estinzione – ovvero:- termine di 3 anni decorrente dal verificarsi del danno- termine di 6 anni decorrente dalla data del sinistro.
Fuori dall’ambito di applicazione della Convenzione CLC, la responsabilità per danni da inquinamento in Italia è regolata dalla l. 979/1982.Questa legge vieta le immissioni nel mare territoriale italiano di idrocarburi e di altre sostanze nocive. Per le navi italiane il divieto è esteso anche al di fuori delle acque territoriali.In caso di immissioni sono previste sanzioni penali a carico del comandante, del proprietario della nave o dell’armatore in caso di concorso in reato.È disposta la responsabilità solidale del comandante col proprietario o con l’armatore della nave per le spese sostenute dallo Stato per la pulizia delle acque e degli arenili e per i danni causati alle risorse marine.Questa RESPONSABILITA’ è ASSOLUTA, perché non prevede nessuna prova liberatoria e anche perché essa sussiste, oltre che in caso di scarico doloso o colposo, anche nei casi in cui la discarica sia stata effettuata per la sicurezza della nave o di altra nave; l’immissione sia stata causata da un’avaria o da una perdita inevitabile. Nei casi diversi da questi (es. quando la discarica sia stata effettuata per la necessità di salvare vite umane) la legge non si applica ed al soggetto responsabile vengono applicate le norme di diritto comune (es. in caso di scarico per salvare vite umane, si potrà ricorrere a una delle cause di giustificazione – ovvero alla stato di necessità).
206. Responsabilità per il trasporto di sostanze nucleariÈ presente, a livello internazionale, una normativa speciale della responsabilità civile per danni conseguenti ad incidenti nucleari.È stata approvata la Convenzioni di Parigi nel 1960 sulla responsabilità nel campo dell’energia nucleare, completata dalla Convenzione complementare di Bruxelles del 1963.Entrambe le convenzioni sono state ratificate in Italia.
La normativa interna italiana, contenuta nella l. 1860/1962, si è adeguata a quella internazionale.Nel trasporto di sostanze nucleari, effettuato con qualunque mezzo di trasporto, in caso di incidente causato dalle proprietà radioattive delle materie trasportate, la responsabilità per i danni è canalizzata sull’esercente dell’impianto nucleare, con esclusione di qualsiasi altro soggetto.
51

La responsabilità è assoluta e rimane esclusa solo in caso di conflitto armato, ostilità, guerra civile, insurrezioni, cataclismi naturali di carattere eccezionale. La responsabilità dell’esercente dell’impianto è limitata a 3.870.000 euro.Per i danni eccedenti tale cifra risponde lo Stato fino a 22.590.000 euro.Se i danni provocati superano tali somme, ne rispondono le parti contraenti della Convenzione fino a 38.730.000 euro.L’esercente è obbligato a stipulare un’assicurazione o altra garanzia finanziaria per l’ammontare che gli spetta.
Allo scopo di evitare possibili interferenze con altre convenzioni in materia di trasporto, è stata approvata la Convenzione di Bruxelles nel 1971. Questa convenzione esclude la responsabilità di qualsiasi soggetto che potrebbe essere responsabile in virtù di una qualche convenzione in materia di trasporto, sancendo in questo modo la specialità della normativa in materia nucleare su quella in materia di trasporto.
CAPITOLO DODICESIMOGLI AUSILIARI DELL’ARMATORE E DELL’ESERCENTE
1. GeneralitàPer la realizzazione della finalità di impiego della nave e dell'aeromobile, l'armatore e l'esercente si avvalgono della collaborazione di diverse persone, a terra e a bordo, che con la loro opera concorrono alla realizzazione delle dette finalità.
a) Il personale di terra svolge la sua attività per l'imprenditore e, quindi, per il proprietario o l'armatore della nave, o per l'esercente dell'aeromobile; esso quindi, non svolge la sua attività con riferimento al singolo viaggio.
b) Il personale di bordo è costituito dal comandante e dall'equipaggio dallo stesso reclutato; esso, quindi, può svolgere la sua attività anche con riferimento al singolo viaggio.
Un ‘ulteriore figura di ausiliare che si è sviluppata recentemente è il manager, legato all’armatore da un contratto di ship management al quale è affidata la conduzione tecnico aziendale dell’impresa aziendale.
TITOLO IIL PERSONALE A BORDO
2. L’equipaggioL’equipaggio ha una sua gerarchia:
a) L’equipaggio della nave è costituito: Dal comandante; Dagli ufficiali; Da tutte le altre persone arruolate;
52

Dal pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo.Quello per la navigazione interna è costituito:
Dal comandante; Dagli ufficiali; Dagli iscritti nei “registri del personale navigante” imbarcato
su quella nave.b) L’equipaggio dell’aeromobile è costituito:
Dal comandante; Dalle altre persone addette al servizio di volo.
La composizione e la “forza minima” dell’equipaggio, cioè il personale quantitativamente e qualitativamente indispensabile ai fini della sicurezza e regolarità della navigazione e dei turni di lavoro, è stabilita da norme di legge e dalla contrattazione collettiva; il rispetto di tali norme è accertato dal comandante del porto al momento del rilascio dell'autorizzazione alla partenza (ossia delle spedizioni).La composizione dell'equipaggio dell'aeromobile è stabilita dall'esercente in relazione alle caratteristiche ed all’impiego del veicolo, ma per gli aerei adibiti al trasporto di persone essa deve essere approvata dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.I componenti dell’equipaggio rivestono particolari gradi e sono legati fra loro da un rapporto di gerarchia che trova la più alta carica nel comandante.Quest’ultimo detta istruzioni per il servizio e la disciplina di bordo, alle quali l’equipaggio deve prestare obbedienza.Dunque, l’ordinamento gerarchico dell’equipaggio assicura il raggiungimento di fini di interesse pubblico relativi alla sicurezza della navigazione e alle discipline di bordo.
Per quanto riguarda la nazionalità, l'equipaggio delle navi armate nei porti italiani e quello degli aeromobili di nazionalità italiana deve essere italiano o comunitario; alcune limitate regole sono previste da convenzioni internazionali. Infatti:
Per le navi adibite alla pesca marittima, il personale di bordo può essere composto anche da cittadini extracomunitari, tranne che per la qualifica di comandante;
È consentito in caso di necessità, l’assunzione di personale extracomunitario all’estero.
Il personale di bordo di bassa forza può essere composto anche da cittadini non appartenenti all’unione europea, fino alla meta dell’intero equipaggio.
L’equipaggio di aeromobili nazionali deve essere formato interamente da iscritti nell’albo o nel registro del personale di volo.
I membri dell’equipaggio, oltre a obblighi di natura privatistica, che derivano loro dal rapporto di lavoro in base al quale sono imbarcati,
53

hanno doveri di natura pubblicistica, che scaturiscono dalla loro partecipazione all’organizzazione di bordo.Fra questi:
cooperare per la salvezza della nave o dell'aeromobile e delle persone a bordo fino a quando sia dato l'ordine di abbandono;
recuperare i relitti, in caso di naufragio; prestare soccorso ad altre navi o aeromobili in difficoltà; eseguire gli ordini di arresto a bordo; cooperare ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori a bordo.
Dobbiamo dire che l’equipaggio costituisce la comunità di lavoro a bordo ma come tale non ha una sua autonoma rilevanza giuridica, in quanto ogni membro dell'equipaggio mantiene la sua individualità, insieme però inquadrano il complesso delle prestazioni necessarie al raggiungimento dei fini del viaggio . I componenti dell’equipaggio fanno parte di quel organizzazione che s’incentra sulla nave e nel aeromobile che è diretta al raggiungimento di un risultato d’ordine tecnico produttivo. Purché venga fatta domanda :- 1/3 dell’equipaggio ha diritto di chiedere all’autorità marittima o
consolare ispezioni e visite straordinarie della nave.- 1/5 dell’equipaggio può rivolgersi alle stesse autorità per chiedere
l’accertamento della qualità e quantità delle razioni di viveri.
3. Il comandanteLa massima autorità a bordo sia della nave che dell’aeromobile è il comandante. E’ il capo dell’equipaggiamento , il quale si trova al vertice dell’organizzazione. I suoi principali compiti sono:
a) la direzione delle operazioni di manovra, anche quando a bordo vi sia un pilota, e della navigazione nel suo complesso;
b) l'accertamento dell'idoneità del mezzo alla navigazione;c) la tenuta dei libri e della documentazione di bordo.
Il comandante è reclutato direttamente dall'armatore, o dall'esercente, col quale instaura un rapporto di impiego. Allo stesso modo l'armatore, o l'esercente, possono rimuovere dall'incarico il comandante in qualsiasi momento, salvi i diritti derivanti dal rapporto di lavoro. Nel caso di impedimento, assenza o morte, il comandante viene sostituito dal soggetto a lui immediatamente sottoposto secondo l'organizzazione gerarchica dibordo, fino a quando l'armatore o l'esercente non abbiano designato un nuovo comandante o, comunque, fino all'arrivo in porto o nell'aeroporto, laddove alla temporanea nomina del comandante provvede l'autorità marittima, o consolare, o il direttore dell'aeroporto.
Il comandante rappresenta l’armatore e l’esercente.Si tratta di rappresentanza legale, in quanto deriva dalla legge.
54

Egli esercita i poteri attribuitigli dalla legge e gode della più ampia autonomia d’azione per portare a compimento il viaggio.In particolare:
a) Provvede all’approvvigionamento giornaliero;b) Provvede all’assunzione di personale;c) In circostanze straordinarie di necessità può procurarsi some di
denaro attraverso: La vendita di attrezzature di bordo non necessarie per la
sicurezza della navigazione; La vendita o il pegno della merce trasportata; ma gli aventi
diritto al carico possono opporsi, scaricando la merce a proprie spese e pagando il nolo relativo;
La contrazione di debiti.I poteri di rappresentanza sono quindi commisurati alla necessità e cessano nei casi in cui l'armatore o l'esercente intervengano direttamente ma restano validamente esercitati anche quando questi, presenti in loco, non lo facciano.
Il comandante è fornito dei poteri di rappresentanza processuale dell’armatore, nelle località in cui questi non sia presente o nelle quali non sia domiciliato un suo rappresentante munito dei necessari poteri (art.309 c. nav.).In particolare il comandante è convenuto in giudizio per i fatti dell'equipaggio, delquale è direttamente responsabile, ed ha poteri di rappresentanza processuale passiva dell’armatore, nell'interesse del quale egli è chiamato a contraddire quando quest'ultimo non sia presente in loco. La rappresentanza processuale attiva si riferisce alle cause relative alla nave ed alla spedizione ed ha come presupposto l’urgenza di provvedere. La rappresentanza processuale è esclusa quando siano coinvolti interessi personali con responsabilità penali (ossia nel caso di conflitto di interessi).
Il comandante della nave ha altresì la rappresentanza del vettore, ossia del soggetto che assume l’obbligo di trasportare le cose caricate sulla nave.In luogo del vettore, il comandante emette le polizze di carico, ossia i documenti di carico della merce trasportata.Anche al comandante dell’aeromobile sono stati riconosciuti gli anzidetti poteri nei confronti del vettore, eccettuata l’emissione della lettera di trasporto aereo.Quando il vettore è lo stesso armatore, il comandante rappresenta la stessa persona a duplice titolo.
55

Ulteriori poteri in rappresentanza il comandante della nave può esercitarli, in via del tutto eccezionale, previa autorizzazione del giudice ovvero, all'estero, dell'autorità consolare, quando ve ne sia la necessità, uno dei casi eccezionali può essere la vendita della nave che versi in condizioni di non navigabilitàQui il comandante agisce come rappresentante del proprietario o dei titolari di altri diritti reali sulla nave (usufruttuario ecc.) e che pertanto sono obbligatorie 3 condizioni :
1. Durante il viaggio si verifica un caso di estrema urgenza 2. La nave si trova in stato di assoluta innavigabilità3. Intervenga l’autorizzazione della competente autorità giudiziale
locale che abbia accertato la sussistenza dell’assoluta innavigabilità e prescritto le modalità della vendita.
In rappresentanza dei proprietari il comandante può altresì costituire ipoteca sulla quota di quei comproprietari che, pur avendo acconsentito alla costituzione della società di armamento, non vogliano contribuire alle spese della spedizione, così ottenendo in prestito il denaro necessario.Il comandante dell’aeromobile, invece, non può mai vendere né ipotecare l’aeromobile senza mandato speciale del proprietario.
Relativamente al carico il comandante agisce in rappresentanza del vettore ma non può ignorare le istruzioni eventualmente impartitegli dai soggetti interessati al carico. Egli in ogni caso, e ancor più in assenza di istruzioni, deve agire al meglio per salvezza, nell'ordine, delle persone a bordo, della nave, del carico, e per il completamento del viaggio e come capo della spedizione può adottare qualsiasi misura si renda a tal fine necessaria ivi compreso il getto del carico, cominciando da quello di minor valore ed il razionamento dei viveri.Inoltre, per conto degli interessati al carico, il comandante può concludere contratti di soccorso.Al comandante dell’aeromobile non spettano gli indicati poteri in ordine alla gestione degli interessi degli aventi diritto al carico.
Il comandante, come capo della spedizione, è investito di poteri diretti ad assicurare il successo della stessa nell'interesse dei partecipanti, nell'interesse superiore dello Stato alla sicurezza della navigazione, nonché nel complesso degli interessi privati e pubblici che si collegano alla spedizione. Nell'esercizio di queste attribuzioni il comandante non agisce nella qualità di rappresentante dell’armatore o dell’esercente dato che la legge gli attribuisce già la prevalenza della sua volontà.Dunque, come capo della spedizione il comandante ha l'obbligo di eseguire, in via ordinaria, una serie di adempimenti quali:
a) l'accertamento delle condizioni di sicurezza per la nave e per i lavoratori a bordo e della salute di quest’ultimi, l’obbligo di
56

accertarsi personalmente che la nave o l’aeromobile siano idonee a intraprendere il viaggio;
b) la custodia dei documenti e dei libri di bordo e di curare tutta la documentazione relativa alla nave , all’aeromobile, ai passeggeri, all’equipaggio e al carico;
c) la presentazione, all'arrivo, della prescritta documentazione e delle relazioni sugli eventi eccezionali;
d) l'impiego del pilota laddove obbligatorio; ecc.e) la cura e il rifornimento con ogni possibile mezzo delle provviste di
bordo o di altra cosa indispensabile alla regolare e sicura navigazione , qualora vengano a mancare in corso di navigazione il comandante deve richiederne ad altre navi incontrate sulla rotta o approdare nel luogo più vicino.
f) Il divieto di ordinare l’abbandono nave in pericolo se non dopo l’esperimento senza risultato dei mezzi suggeriti dall’ arte nautica per salvarla sentito il parere degli ufficiali di coperta … il comandante deve abbandonare la nave per ultimo provvedendo , in quanto possibile, a salvare le carte e i libri di bordo e gli oggetti di valore affidati alla sua custodia.
Inoltre il comandante deve assicurare la sicurezza della spedizione che si trovi in pericolo nel corso del viaggio con tutti i mezzi che sono a sua immediata disposizione , inoltre il comandante può esercitare poteri eccezionali per la salvezza, nell'ordine, delle persone imbarcate, della nave, della spedizione e del carico. Per la salvezza delle persone a bordo od anche della spedizione il comandante può anche ordinare il getto in mare delle cose trasportate, iniziando da quelle di minor valore e salvo risarcimento a carico di tutti i partecipanti alla spedizione, secondo l'istituto dell'avaria comune. Per il prosieguo della spedizione, nel caso di avarie, il comandante può vendere la merce imbarcala o parti della nave che non ne pregiudichino la navigabilità.
Il comandante in virtù della sua posizione a bordo è, inoltre, un esercente privato di pubbliche funzioni, in quanto abilitato all’esercizio di:
a) Poteri disciplinari : esercitati nei confronti di tutte le persone a bordo. In base ad essi il comandante della nave può applicare sanzioni sia all’equipaggio, sia ai passeggeri. Il comandante dell’aeromobile può applicarle solo ai passeggeri, dato che nei confronti dell’equipaggio il potere disciplinare è esercitato dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, e all’estero dall’autorità consolare (art.1250 c. nav.)
b) Poteri di polizia di sicurezza : il comandante della nave e dell’aeromobile esercita tali poteri;
Sia in materia sanitaria, vietando l’imbarco di passeggeri affetti da malattie gravi, o l’imbarco di merci pericolose;
57

Sia in materia di soccorso obbligatorio a favore di mezzi in difficoltà l’inadempimento è sanzionato penalmente .
c) Poteri come capo della comunità viaggiante , che vanno dall'esercizio delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, abilitato a disporre misure restrittive di pubblica sicurezza, a quelle di ufficiale di stato civile e di notaio, abilitato a celebrare matrimoni in extremis e a ricevere testamenti nonché, per il solo comandante di nave, a redigere atti nascita e di morte e dichiarazioni di scomparsa.
TITOLO IIIL PERSONALE A TERRA
4. Il raccomandatario e il caposcaloL’impresa di navigazione si avvale, altresì, dell'opera di personale a terra che ne curi gli interessi commerciali, stipulando contratti per suo conto, ed eseguendo determinati adempimenti burocratici.
La figura tipica è il raccomandatario, detto anche agente marittimo, il cui rapporto con l’armatore o anche col vettore è quello del mandato.I suoi compiti sono:
a) Assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi;
b) Ricezione o consegna delle merci;c) Operazioni di imbarco o sbarco di passeggeri;d) Acquisizione dei noli;e) Conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con
rilascio dei relativi documenti, ecc.Il raccomandatario, per l'esercizio della professione, deve essere provvisto di specifica abilitazione ed è iscritto nei registri della camera di commercio.Il raccomandatario è normalmente un lavoratore autonomo ma non è esclusa lacostituzione di un rapporto di lavoro dipendente con l'armatore. Previa espressa procura, il raccomandatario può anche avere la rappresentanza processuale dell'armatore per conio del quale agisceL'atto che conferisce i poteri rappresentativi (procura), munito della sottoscrizione autenticata del preponente, le successive modifiche e la revoca devono essere depositati presso l'ufficio di porto, ove il raccomandatario risiede, per la pubblicazione nel registro a tal fine tenuto. Il comandante del porto dà comunicazione dell'avvenuta pubblicazione alla camera di commercio.Qualora non sia adempiuta la pubblicità, la rappresentanza del raccomandatario sì reputa generale e non sono opponibili ai terzi le limitazioni, le modifiche o la revoca della procura, a meno che il
58

preponente provi che i terzi ne erano a conoscenza al momento in cui fu concluso l'affare (art.289 c. nav.)
Per le imprese di navigazione aerea l'equivalente del raccomandatario è il Caposcalo, il quale normalmente è un dipendente dell'esercente. Anche per questo è prevista la pubblicità della procura, che lo abilita ad agire per conto dell'esercente, mediante annotazione della stessa in apposito registro. Il caposcalo ha rappresentanza legale dell’esercente per tutto ciò che concerne l’esercizio dell’impresa . Il Caposcalo, inoltre, esercita altre mansioni esemplificate nell’art, 882:
a) compila i documenti doganali e sanitari, l'elenco dei passeggeri e gli altri documenti indicati nel regolamento;
b) tiene i libri dell'aeromobile, ad esclusione del giornale di bordo; c) con comunicazione scritta, ordina al comandante la sospensione
della partenza dell'aeromobile; d) in caso di sovraccarico, stabilisce quali siano i passeggeri e le cose
che devono escludersi dall'imbarco, secondo le istruzioni dell'esercente.
Cap. 14 – I CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE E DELL’AEROMOBILE
267. I contratti di utilizzazione (CONTRATTI CONSENSUALI)I contratti di utilizzazione come categoria giuridicaII codice della navigazione disciplina i cosiddetti contratti di utilizzazione della nave e dell'aeromobile riguardanti, in particolare, la locazione del veicolo, il noleggio dello stesso completo di equipaggio, ed il trasporto di persone e cose con l'utilizzo del medesimo veicolo.Tale raggruppamento risponde ad un'esigenza pratica di ricondurre sotto un' unica categoria tutti i contratti aventi in comune l'utilizzo della nave o dell'aeromobile ma senza voler costituire una categoria specifica di negozi giuridici (categoria giuridica).Proprio perché essi non costituiscono una categoria giuridica, si considerano contratti di utilizzazione anche tutti gli altri contratti che in un modo o nell’altro prevedono l’utilizzazione della nave e dell’aeromobile.Dunque, i principali contratti di utilizzazione della nave o dell'aeromobile sono: la locazione, il noleggio, il trasporto.
- Nella LOCAZIONE di nave o aeromobile, il veicolo costituisce l’oggetto della prestazione di dare del locatore (locatio rei).- Nel NOLEGGIO, il veicolo è oggetto della prestazione, però, a differenza della locazione, la prestazione del noleggiante consiste in un facere.- Nel TRASPORTO il veicolo assume una funzione strumentale, perché costituisce il mezzo necessario per l’esecuzione dell’obbligazione principale di trasferimento delle persone o delle cose.
59

268. Sistematica del Codice della NavigazioneLa locazione, il noleggio ed il trasporto relativi alle navi addette alla navigazione interna sono regolati dalle norme del cod. nav. per i corrispondenti contratti relativi alle navi addette alla navigazione marittima, salvo che gli usi speciali non dispongano diversamente. Pertanto, per la disciplina dei contratti di utilizzazione della navigazione interna si ha una prevalenza degli USI rispetto alle norme del cod. nav.
- La LOCAZIONE della nave o dell’aeromobile è caratterizzata dal passaggio della detenzione della nave o dell’aeromobile dal locatore al conduttore (che generalmente assume la veste di armatore o esercente).
- Il NOLEGGIO si caratterizza per il compimento, da parte del noleggiante, di viaggi, che possono essere prestabiliti (noleggio a viaggio) oppure ordinati dal noleggiatore entro il periodo di tempo stabilito (noleggio a tempo). Armatore o esercente è il noleggiante che conserva la detenzione del veicolo e ha alle proprie dipendenze il comandante e l’equipaggio.
- Il contratto di TRASPORTO è contraddistinto dall’obbligazione del vettore di trasferire da un luogo ad un altro persone o cose, con assunzione della relativa protezione e custodia.
TITOLO ILA LOCAZIONE
2. Definizione e caratteriAi sensi dell’art.376 c. nav., si ha la locazione di nave o di aeromobile quando una delle parti (locatore) si obbliga a far godere all’altra (conduttore), per un dato tempo, la nave o l’aeromobile verso un determinato corrispettivo (canone).La locazione si distingue dagli altri “contratti di utilizzazione”, in quanto la prestazione del locatore non consiste in un facere, ma consiste in un complesso di obbligazioni dirette a consentire il godimento del conduttore, fra le quali la consegna della res (nave o aeromobile) oggetto del contratto, con correlativo passaggio della detenzione.È da notare che il locatore può anche non essere titolare di un diritto reale sulla nave o sull’aeromobile che concede in locazione, essendo sufficiente che sia in condizione di attribuire la detenzione dei medesimi.In seguito all’assunzione del possesso, il conduttore assume la qualità di armatore o di esercente, con la conseguenza che l’equipaggio si trova alle sue dipendenze.
3. Locazione di nave. Forma e pubblicitàLa locazione di nave può essere di 2 tipi:
a) Locazione a scafo nudo ;
60

b) Locazione di nave armata , completa, cioè, di tutto quanto necessario per il viaggio, ivi compreso l'equipaggio.
Nella pratica il contratto di locazione ricorrente è quello a scafo nudo, in quanto il conduttore preferisce, in genere, provvedere in proprio all'armamento della nave. Nel caso di locazione di nave armata, i contratti di lavoro stipulati con l'equipaggio sono automaticamente trasferiti dal locatore al conduttore ex lege e l'equipaggiopassa alle dipendenze del locatore-armatore; non si tratta, quindi, di cessione del contratto bensì di trasferimento automatico ex lege in quanto l'equipaggio deve essere alle dipendenze dell'armatore (art.347 c. nav.).
Per i contratti, di utilizzazione della nave non v'è l'obbligo della forma scritta ma taleforma è necessaria ai fini probatori. Il contratto concluso in forma non scritta è perciòvalido a tutti gli effetti ma la prova dello stesso diventa più difficile.Per le navi minori e per i galleggianti la forma scritta non è prevista neanche per la prova.Nella pratica la redazione del contratto avviene mediante l’adozione di un formulario denominato Barecon 2001.
4. Locazione di aeromobile. Forma e pubblicitàLe disposizioni del codice della navigazione in tema di locazione si applicano anche alla locazione di aeromobile (art. 939 c. nav.).L’unica differenza è che il contratto di locazione di aeromobile deve essere sempre in forma scritta, e se di durata non inferiore a 6 mesi deve essere reso pubblico.Quest’ultima disposizione è stata prevista dalla Convenzione di Ginevra del 1948 “sul riconoscimento internazionale dei diritti su aeromobili”, la quale dispone che l'iscrizione della predetta locazione nel registro di immatricolazione dell'aeromobile costituisce condizione necessaria per il riconoscimento da parte degli altri Stati contraenti di tale diritto di utilizzazione dell'aeromobile.Una particolare forma di locazione di aeromobili e quella denominata aircraft interchange agreement, col quale una compagnia cede ad un'altra il suo aeromobile, senza equipaggio, per consentire il completamento del viaggio su una linea i cui diritti di traffico appartengano alla seconda.
5. Obblighi del locatore e del conduttoreObblighi del locatore sono (art. 379 c. nav. e 1575 c.c.):
a) consegnare la nave o l'aeromobile, con le relative pertinenze, in stato di navigabilità e in buono stato di manutenzione;
b) munire la nave o l'aeromobile dei documenti necessari per la navigazione;
61

c) mantenere la nave e l'aeromobile in stato tale da servire all'uso convenuto e provvedere a tutte le riparazioni dovute a forza maggiore o a logorio per uso normale, secondo l'impiego convenuto;
d) garantire il pacifico godimento durante la locazione;e) garantire il conduttore dalle molestie di terzi che pretendono di
avere diritti sulla nave o sull'aeromobile (art.1585 c.c.).Il locatore non è responsabile di eventuali vizi emersi dopo la consegna quando riesce a provare che si tratta di vizi occulti non rilevabili con la normale diligenzaGli obblighi assunti dal conduttore consistono:
a) nel pagamento del canone; b) nella corretta tenuta della nave;c) nella manutenzione della stessa durante l'utilizzo;d) nella sua restituzione nel termine stabilito e nel luogo della
consegna alle condizioni in cui gli è stata data. Nel caso di mancata consegna nei termini, il conduttore è tenuto al pagamento dell'ulteriore canone rapportato al periodo eccedente, salvo il maggior danno; se tale periodo eccede il decimo della durata originaria, il canone è per disposizione di legge dovuto al doppio, alla stregua di penale.
e) Il conduttore è tenuto ad effettuare e far effettuare tutte le riparazioni necessarie alla conservazione del bene e non può effettuare innovazioni che diminuiscano il valore della nave. Le riparazioni urgenti possono essere dallo stesso effettuate direttamente, salvo rimborso, dandone avviso al proprietario.
6. Sublocazione e Cessione della locazioneCol consenso del locatore il contratto può essere ceduto o esteso ad un terzo con la sublocazione;
a) Nel primo caso si ha la cessione del contratto, sicché il terzo subentra al conduttore nel suo rapporto con il locatore;
b) nell'altro caso si ha, invece, una sublocazione ed il conduttore originario diventa locatore (sublocatore) del nuovo conduttore (sub conduttore).
7. Scadenza del contratto e PrescrizioneIl contratto di locazione di nave ed aeromobile, scade allo spirare del termine stabilito dalle parti.Esso non può rinnovarsi tacitamente alla scadenza del termine pattuito, salva diversa intesa tra le parti.Alla scadenza, il conduttore deve riconsegnare il bene al locatore nel medesimo luogo e stato in cui l’ha ricevuto.
I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col decorso di un anno dalla scadenza o dalla ritardata consegna del bene o ancora, nel caso di perimento della nave, dalla sua cancellazione dai registri.
62

8. Locazione finanziaria e ComodatoDella più ampia categoria dei contratti di locazione fanno parte i contratti di locazione finanziaria (leasing) ed i contratti di comodato gratuito.
a) Col contratto di leasing tra il proprietario del bene (fornitore) e quello che intende acquisirne il godimento (conduttore) si intromette un terzo (concedente) il quale acquista il bene dal fornitore e lo da in godimento all’utilizzatore verso un canone periodico comprensivo del valore di ammortamento del bene, relative spese ed interessi; alla scadenza del contratto il locatore ha sostanzialmente pagato una parte del bene e, quindi, potrà acquisirne la proprietà pagando la restante parte. Il leasing può riguardare sia la costruzione della nave che l'utilizzo di una nave già in esercizio.
b) Col comodato d'uso gratuito il veicolo viene dal proprietario dato in uso all’utilizzatore, senza alcun compenso; tale contratto si perfeziona con la materiale consegna del bene.
TITOLO IIIL NOLEGGIO
9. Definizioni e caratteriIl Noleggio è il contratto per il quale il noleggiante (armatore o esercente) in corrispettivo del nolo (canone) pattuito, si obbliga a compiere con una nave determinata uno o più viaggi prestabiliti, ovvero, entro un periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi ( art.384 c. nav.).Dunque, il contratto di noleggio, si distingue in 2 sottospecie:
a) Noleggio a viaggio : con esso l’armatore si obbliga ad effettuare una serie di viaggi per conto del vettore, esauriti i quali il contratto cessa i suoi effetti.
b) Noleggio a tempo : con esso l’armatore si obbliga a mettere a disposizione del vettore nave ed equipaggio per un determinato lasso di tempo, a prescindere dal numero di viaggi che questo intende effettuare.
Col contratto di noleggio la nave resta in esercizio all’armatore e mentre nel contratto di locazione la figura dell’armatore viene a coincidere con quella dell' utilizzatore, col contratto di noleggio l'utilizzatore assume la veste del vettore e la figura dell'armatore resta invariata.Inoltre, mentre nella locazione la nave è l'oggetto del contratto, giacché la causa del contratto è il godimento del bene, nel noleggio la nave è lo strumento necessario per la realizzazione di un determinato utile, e siccome la nave è un mezzo di trasporto ed il suo noleggio è per lo più finalizzato al trasporto di persone e cose, il contratto di noleggio presenta molti punti in comune col contratto di trasporto, il quale ultimo
63

avrebbe in più solo l'obbligo della custodia e della consegna della merce trasportata ovvero della cura e sicurezza delle persone trasportate.Ma la sostanziale differenza tra il contratto di noleggio e quello di traspone sta nellapersona del vettore:
nel primo caso, infatti, il noleggiatore prende a nolo la nave per effettuare un trasporrò di persone o cose e se lo effettua a fini commerciali egli andrà poi a stipulare contratti di trasporto con passeggeri o con caricatori (mittenti) di merci o cose;
nell'altro caso è l'armatore che effettua in proprio il trasporto di persone e cose e, quindi, stipula direttamente il contratto di trasporto con quelli che ne fruiscono.
Per i contratti di noleggio si usano in genere dei formulari prestabiliti detti charter party, distinti in voyage charter e time charter a seconda che il nolo sia a viaggio o a tempo. Tali formulari sono costantemente aggiornati ad opera di organizzazioni e soggetti interessati, se non predisposti della stesse compagnie di navigazione, e specialmente per i noli a viaggio i formulali sono di vario tipo, in quanto predisposti in funzione delle caratteristiche del viaggio, delle nave, della merce, ecc.
Per la disciplina del noleggio di aeromobile, l’art.939 c. nav., rinvia, come già per la locazione, agli articoli del codice della navigazione sul noleggio di nave.
10. Forma del contrattoIl contratto di noleggio delle navi deve essere in forma scritta ai soli finiprobatori sicché è valido anche se concluso in forma non scritta; per le navi minori ed i galleggianti la forma scritta non è richiesta neanche ai fini probatori.Il contratto di noleggio di aeromobile deve essere sempre in forma scritta.Il contratto deve riportare:
a) gli elementi identificativi della nave, la sua nazionalità e la portata;b) il nome del noleggiante (armatore) e del noleggiatore (vettore);c) il nome del comandante;d) l'ammontare del nolo;e) i viaggi da effettuare ovvero la durata del nolo.
Il contratto è talvolta sottoscritto oltre che dalle parti anche dal broker, ossia dall’intermediario dell'affare, benché sprovvisto di una qualsiasi delega o mandato.
11. Messa a disposizione della nave: Clausola di cancello
64

La nave deve essere posta a disposizione del noleggiatore nel porto indicato nel contratto, o che il noleggiatore si sia riservato di indicare successivamente, e nel termine convenuto.Il contratto di noleggio prevede 2 termini:
a) Termine iniziale : entro tale termine il noleggiante deve mettere la nave a disposizione del noleggiatore e pronta all'uso. Il contratto avrà inizio dopo un breve lasso di tempo dal momento in cui il noleggiante avrà dato al noleggiatore l’avviso di prontezza.
b) Termine finale (o di Cancello) : la clausola di cancello è una clausola di risoluzione espressa del contratto di noleggio; essa prevede un termine entro il quale l'armatore deve mettere a disposizione del vettore la nave ed il suo equipaggio. Decorso tale termine il vettore può risolvere il contratto od anche attendere che l'armatore esegua il suo adempimento. Trattandosi di clausola di risoluzione espressa, se il vettore se ne avvale non può chiedere il risarcimento del danno; se, invece, il vettore non se ne avvale e attende l'adempimento dell'armatore, può poi reclamare il danno.
12. Obblighi e Responsabilità del noleggianteObbligo del noleggiante è quello di mettere a disposizione del noleggiatore la nave e l’equipaggio nel luogo e tempo stabiliti ed in condizioni di navigabilità.Ove la nave risulti affetta da vizi, il noleggiatore può liberarsi da responsabilità provando che si tratta di vizi occulti non rilevabili con la normale diligenza. Non essendovi un regime specifico in materia, ulteriori responsabilità possono essere di volta in volta convenute dalle para, di tal che la responsabilità del noleggiante può estendersi alla colpa dei dipendenti, alla custodia del carico, ecc.Altri obblighi a carico del noleggiante sono quelli di normale collaborazione, affinchè l’altra parte contraente sia messa nelle condizioni di eseguire le sue obbligazioni.
13. Obblighi e Responsabilità del noleggiatoreObbligo del noleggiatore è il pagamento del canone, che in genere è a rate mensili anticipate, con facoltà, per l'armatore, di interrompere il servizio immediatamente e senza preavviso nel caso di mancato pagamento.Il noleggiatore, nel caso in cui la nave sia costretta ad una sosta forzata per cause a lui non imputabili e comunque diverse dalla riparazione, non è tenuto a corrispondere il canone.Se la sosta forzata è dovuta alla necessità di effettuare riparazioni, il canone (nolo) è dovuto al netto delle spese risparmiate dal noleggiante per la tenuta in esercizio della nave.Durante il nolo le spese a carico del noleggiante sono quelle inerenti alla tenuta in esercizio della nave (spese fisse) mentre sono a carico del
65

noleggiatore quelle relative alla realizzazione del viaggio (spese variabili), specie quando il nolo e a tempo per cui le spese di viaggio non sono preventivamente conosciute. Il noleggiante non è tenuto ad effettuare viaggi pericolosi nè illeciti ed il noleggiatore, dal canto suo, deve garantire la sicurezza dei porti verso i quali indirizza la nave. Il concetto di sicurezza nei porti comprende condizioni metereologi che, fisiche, politiche.
14. Employment e Indemnity. Emissione delle Polizze di carico.Una clausola tipica del contratto di noleggio è quella dell’Employment (Impiego) per effetto della quale il comandante della nave, pur restando dipendente dall'armatore, deve eseguire gli ordini del vettore, restandone esonerato solo nel caso in cui tali ordini presuppongano lo svolgimento di attività pregiudizievoli per la conservazione della nave o per la salute delle persone impiegate nella spedizione. In pratica col contratto di noleggio l'armatore si obbliga a mettere a disposizione del vettore nave ed equipaggio, sicché il comandante della nave, nell’eseguire le disposizioni del vettore, non adempie ad una sua personale obbligazione nei confronti del vettore bensì all’obbligazione assunta dall'armatore. Il comandante è in tal caso il tramite attraverso il quale l'armatore esegue la sua obbligazione.Le attività che il comandante deve svolgere in esecuzione di tale clausola si possono dividere in 2 gruppi:
a) Il primo gruppo riguarda le attività relative all’impiego contrattuale della nave, che costituiscono concreta esplicazione della prestazione del noleggiante, la quale, in mancanza delle istruzioni del noleggiatore, non potrebbe avere materiale esecuzione.
b) Il secondo gruppo è costituito dalle attività che il noleggiatore dovrebbe e potrebbe svolgere direttamente e che per fini pratici vengono invece affidate al comandante, come, principalmente, l'emissione delle polizze di carico. Quest'ultima circostanza espone l'armatore, dal quale il comandante dipende, all'azione dei terzi nel caso di inadempimenti del vettore; ad essa è perciò riferita la clausola contrattuale della cosiddetta indemnity (indennità), secondo la quale il noleggiante può poi rivalersi sul noleggiatore, sempre che non sia anche quest’ultimo ad agire nei suoi confronti.
La massima espressione dell’adempimento del comandante nell’interesse del noleggiatore è l’emissione delle polizze di carico.La polizza di carico è un documento comprovante l'avvenuto carico della merce trasportata. Sulla polizza di carico devono essere indicati tutti i dati identificati della nave, della spedizione e della merce.
66

La polizza di carico costituisce valido titolo per il ritiro della merce da parte di chi ne sia legalmente in possesso.Nel caso di inadempimento del noleggiatore il caricatore agisce direttamente nei confronti di questo e non del comandante col quale ha stipulato la polizza, salvo che questi abbia stipulato le polizze a nome dell'armatore; in tale ultima ipotesi sarà il noleggiante a rispondere dell'inadempimento ma con diritto di rivalersi sul noleggiatore.
15. Subnoleggio e Cessione del noleggioIl noleggiatore può subnoleggiare la nave o cedere totalmente o parzialmente i dirittiderivanti dal contratto di noleggio, rimanendo responsabile verso il noleggiante delle obbligazioni assunte col contratto di noleggio.
a) Il subnoleggio si ha quando il noleggiatore (subnoleggiante) stipula con un terzo subnoleggiatore un altro contratto di noleggio. Naturalmente il subnoleggiante, poiché non essendo armatore deve necessariamente servirsi del noleggiante per adempiere alle prestazioni cui si è obbligato verso il subnoleggiatore, risponde verso quest'ultimo anche dei fatti del noleggiante e dell'equipaggio, che figurano come suoi ausiliari.
b) La cessione, dei diritti derivanti dal noleggio si ha quando il noleggiatore sostituisce a sé un terzo nella parte attiva del contratto, rimanendo però personalmente vincolato verso il noleggiante in relazione agli obblighi derivanti dal contratto stesso. A differenza della normale disciplina secondo la quale la Cessione del contratto libera il cedente, nella Cessione di noleggio il cedente non è liberato, salvo contraria dichiarazione del ceduto.
16. Cessazione e Prescrizione del noleggioIl noleggio a tempo cessa con lo spirare del termine convenuto, se però prima della scadenza il noleggiatore ordina un viaggio che si concluderà dopo la detta scadenza, esso deve essere eseguito. Quando l'ultimo viaggio eccede la durata del contratto per tatto del noleggiatore, questi per il periodo eccedente deve un compenso doppio rispetto a quello stabilito per la normale durata del contratto.Tale clausola è in genere derogata nei formulari prevedendo l'applicazione dei prezzi di mercato se più elevati.Il contratto di noleggio si estingue poi per le cause generali di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive, fra le quali s'inquadra anche l'impedimento definitivo.Una particolare forma di risoluzione è prevista dai formulari nel caso di entrata in guerra dello Stato, di cui la nave noleggiata batta bandiera.
I diritti del contratto di noleggio si prescrivono in un anno dalla scadenza o dall'ultimazione dell'ultimo viaggio, se eccedente la durata del contratto, ovvero dal verificarsi dell'evento che abbia impedito l'esecuzione del contratto.
67

In caso di perdita presunta della nave, il termine di prescrizione decorre dalla data della sua cancellazione dai registri di iscrizione.
17. Noleggio non contrattuale: “Noleggio obbligatorio” e “Requisizione in uso”.Fino ad ora abbiamo trattato del noleggio contrattuale, cioè frutto della libera iniziativa delle parti.Ma il noleggio può essere anche non contrattuale, e ciò avviene in 2 casi particolari:
a) Noleggio obbligatorio : esso non nasce da un reciproco consenso, ma è imposto dalla autorità marittima. All’armatore verrà corrisposto un canone secondo le tariffe imposte dalle stesse autorità.
b) Requisizione in uso : questa è regolata dalla legge 1154/1989 e consiste in una forma di utilizzo simile al Noleggio obbligatorio. È disposta dalla competente autorità, e in conseguenza della stessa, all’armatore spetta un’indennità.
IL TRASPORTO
297. Specie di trasporto e disciplina del Codice della NavigazioneIl cod. nav. distingue due specie di TRASPORTO PER ACQUA: trasporto di persone (e bagagli) e trasporto di cose. Quest’ultimo, a sua volta, si divide in trasporto di carico totale o parziale e trasporto di cosa determinata.Il TRASPORTO PER ARIA, invece, si distingue in trasporto di persone e bagagli e trasporto di cose.
La normativa del trasporto marittimo si applica direttamente al trasporto per acque interne, salvo che gli usi non dispongano diversamente. La normativa del trasporto marittimo di cose si applica direttamente al trasporto aereo, con esclusione delle norme sulla responsabilità del vettore, e al trasporto di carico totale o parziale.
298. Fonti interne e internazionaliI contratti di trasporto della navigazione rientrano nella figura generale del contratto di trasporto, in base al quale il vettore si obbliga, verso un corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro e di proteggerle o custodirle.- Le disposizioni generali del COD. CIV. sul trasporto sono applicabili ai trasporti per via d’acqua o per via d’aria, se non derogate dal cod. nav. e dalle leggi speciali.- Una parte importante della normativa sui trasporti della navigazione è contenuta in testi di diritto uniforme prodotte da CONVENZIONI internazionali.
68

Per quanto riguarda la responsabilità del vettore marittimo di passeggeri e di bagagli dispone la Convenzione di Atene del 1974; essa non è in vigore in Italia, quindi è il cod. nav. a regolare tutti i trasporti marittimi di persone e bagagli.In tema di trasporto marittimo di cose, gli aspetti inerenti alla documentazione ed alla responsabilità del vettore sono regolati dalla Convenzione di Bruxelles del 1924 sulla polizza di carico.Mentre, in materia di trasporto aereo di persone e di cose, la Convenzione di Varsavia del 1929 regolava gli aspetti inerenti alla documentazione ed alla responsabilità del vettore per infortuni al passeggero, per perdita o avaria della merce o bagagli e per ritardo.Questa convenzione è stata poi sostituita dalla Convenzione di Montreal del 1999, la quale si applica ai trasporti internazionali i cui punti di partenza e di arrivo siano situati sul territorio di due Stati contraenti oppure sul territorio di un unico Stato contraente purché sia previsto uno scalo in un altro Stato anche non contraente; si applica anche ai trasporti gratuiti, solo se effettuati da un’impresa di trasporti aerei, ed ai trasporti eseguiti non dal vettore contraente ma dal c.d. vettore operativo. La normativa comunitaria ha esteso l’applicabilità delle norme della Convenzione di Montreal alla responsabilità di tutti i vettori aerei muniti di licenza comunitaria anche nei trasporti effettuati in un unico Stato membro. Le convenzioni in vigore sono di applicazione necessaria nel senso che si applicano indipendentemente dall’essere o meno il rapporto regolato dalla legge italiana in base alle norme di diritto internazionale.
Sez. 1 – TRASPORTO di PERSONE (aereo e nave)
299. Obbligazioni tipicheIl contratto di trasporto di persone (denominato CONTRATTO di PASSAGGIO) è un contratto consensuale, contraddistinto dall’obbligo del vettore di trasferire una persona da un luogo ad un altro.Esso si differenzia dal trasporto di cose per la diversità dell’oggetto trasportato. Questa diversità mantiene inalterata la natura del contratto, ma configura diversamente l’attività di esecuzione dello stesso e, quindi, gli obblighi delle parti. Infatti, in ogni contratto di trasporto, alla prestazione principale di trasferimento da un luogo ad un altro, si aggiunge quella di vigilanza sull’oggetto trasportato e che si configura diversamente a seconda della diversità dell’oggetto.Nel trasporto di cose vi è la consegna dell’oggetto al vettore e la sua detenzione da parte dello stesso; mentre, nel trasporto di persone il vettore si limita a fornire al passeggero un idoneo spazio a bordo, di uso
69

esclusivo o comune agli altri passeggeri. Questo comporta che sul passeggero gravano anche oneri di collaborazione.La dottrina comprende l’obbligo del vettore di vigilare sull’incolumità del passeggero nell’ambito degli obblighi di protezione.(non è ammesso un contratto di sub trasporto nel contesto del trasporto di persone)Fra gli elementi costitutivi dell’obbligo di trasferimento è da comprendere la durata del trasferimento stesso, che deve essere ragionevole in relazione al mezzo di trasporto e all’interesse del creditore.Le imprese di trasporto della navigazione interna, concessionarie di servizi di linea, ai sensi del cod. civ. sono obbligate a contrarre; ovvero devono accettare le richieste di trasporto ed eseguirle secondo l’ordine delle richieste stesse.
300. Forma del contrattoIl contratto di trasporto di persone per ACQUA deve essere provato per iscritto, tranne che si tratti di navi inferiori ad una certa stazza. Tuttavia, l’assenza della forma scritta non pregiudica la validità del contratto, ma ne rende più difficile la prova (quindi forma scritta ad probationem).Nel TRASPORTO AEREO, invece, la forma scritta non è richiesta nemmeno ai fini della prova. È solo disposto l’obbligo del vettore di informare per iscritto il passeggero che la propria responsabilità è regolata e può essere limitata dalla Convenzione di Montreal. La normativa comunitaria, inoltre, prevede l’obbligo per il vettore di informare, presso i punti vendita, i passeggeri circa il regime di responsabilità.In caso di mancata informazione il contratto rimane valido, ma è prevista dal cod. nav. una grave sanzione amministrativa che consiste nel divieto al vettore di atterraggio e decollo nel territorio nazionale.
In deroga alla disposizione del cod. civ. secondo la quale la scrittura privata fa piena prova solo se sottoscritta da colui contro il quale è prodotta, il biglietto del contratto di passaggio rilasciato al passeggero fa prova della conclusione del contratto anche se non sottoscritto dalle parti. La conclusione del contratto è preceduta da una PRENOTAZIONE, che è qualificata come contratto preliminare o patto di opzione.Nel trasporto aereo si stanno diffondendo le c.d. ASTE ON-LINE, mediante le quali i passeggeri si aggiudicano da un banditore virtuale trasferimenti aerei offerti all’incanto. Si tratta di un’offerta revocabile a prezzo indeterminato da convenire, che non è una vera e propria offerta al pubblico, in quanto la proposta contrattuale viene dal passeggero ed il contratto si conclude con l’aggiudicazione telematica al miglior offerente.
301. Biglietto di passaggio
70

Nel TRASPORTO MARITTIMO il biglietto di passaggio deve indicare il luogo e la data di emissione, il luogo di partenza e di destinazione (indicazioni essenziali), la classe ed il prezzo del passaggio, il nome ed il domicilio del vettore (indicazioni essenziali). Nel TRASPORTO AEREO il biglietto deve contenere l’indicazione dei punti di partenza e di destinazione; se i punti di partenza e di destinazione sono situati sul territorio di uno stesso Stato, ma sono previsti degli scali sul territorio di un altro Stato, il biglietto deve contenere l’indicazione di almeno uno di tali scali. Inoltre, al passeggero deve essere consegnato un avviso scritto nel quale sia specificato che la responsabilità del vettore è soggetta alla Convenzione di Montreal.- Il passeggero è legittimato a ricevere la prestazione con la semplice presentazione del documento (solo in caso di biglietto nominativo anche la prova dell’identità) senza dover ulteriormente provare la titolarità del diritto ed il vettore è liberato eseguendo il trasporto in favore di chi esibisce il biglietto.Il vettore aereo può emettere anche un titolo di trasporto COLLETTIVO, ovvero per una pluralità di passeggeri. La lista nominativa dei passeggeri è fornita a parte al vettore dall’organizzatore di viaggi. - Nei trasporti aerei può accadere che il nome del vettore indicato nel biglietto non corrisponda la vettore che effettuerà il trasporto. In questo caso vige l’obbligo di informare il passeggero della circostanza prima dell’emissione del biglietto oppure, in caso di prenotazione, al momento della conferma. In caso di mancata informazione il passeggero può richiedere la risoluzione del contratto, il rimborso del biglietto e il risarcimento di eventuali danni. - Il biglietto di passaggio normalmente è rilasciato con lo status di OK, che significa che il posto sul volo è prenotato. Se, invece, lo status è RQ, significa che il posto è stato prenotato ma non confermato oppure è in lista di attesa. In questo caso l’obbligazione di trasferimento è sottoposta alla condizione che un certo numero di passeggeri con biglietto confermato non si presenti all’imbarco.
302. Cessione del bigliettoIl diritto al trasporto può essere ceduto solo con il consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero abbia già iniziato il viaggio.Nel trasporto aereo il consenso può essere anche tacito.Riguardo la natura della cessione del diritto al trasporto si è dubitato che si tratti di una vera e propria cessione. Tuttavia, è stata avanzata la tesi che ricorra una risoluzione del contratto con contestuale stipulazione di un nuovo contratto, avente lo stesso oggetto. Questa tesi è confermata dal fatto che il nuovo passeggero non paga il biglietto al precedente passeggero, ma direttamente al vettore. Sarà poi quest’ultimo a rimborsare, in tutto o in parte, il biglietto al c.d. cedente.
71

303. Obblighi accessori del vettoreOltre alla prestazione principale di trasferimento da un luogo ad un altro e a quella di protezione dell’incolumità del passeggero, il vettore di persone è tenuto ad un complesso di prestazioni accessorie.- Il vettore è tenuto a mettere a disposizione del passeggero la nave o l’aeromobile in stato di navigabilità e provvisti dei requisiti necessari per il trasporto, nel giorno indicato e per l’esecuzione del viaggio stabilito, osservati gli adempimenti in materia di polizia sanitaria e di carattere amministrativo generale.- La prestazione del vettore comprende anche il trasporto del bagaglio.- Altra prestazione accessoria è la fornitura del vitto e la messa a disposizione di uno spazio a bordo, che può essere di uso esclusivo (cabina, cuccetta,…) oppure comune ad altri passeggeri (saloni, bar,..).- Altra prestazione è l’eventuale espletamento delle operazioni di imbarco e sbarco, alle quali, in assenza di apposito servizio portuale, il vettore è tenuto a provvedere, con diritto al rimborso da parte del passeggero, se non è compreso nel prezzo di passaggio.
Anche se queste operazioni sono caratteristiche del trasporto marittimo, si ritiene che possano essere imposte anche nel trasporto aereo, fra cui l’espletamento del trasporto in superficie dal centro urbano all’aeroporto.
304. Impedimenti o ritardi della nave o dell’aeromobileIl cod. nav. disciplina gli impedimenti all’esecuzione del contratto distinguendo quelli che incidono sul vettore e quelli che incidono sul passeggero.
- Impedimenti o ritardi della NAVESe la partenza della nave è impedita per causa non imputabile al vettore, il contratto è risolto di diritto ed il vettore deve restituire il prezzo al passeggero.
Se, invece, è il vettore che sopprime la partenza, si distinguono: - il caso in cui il viaggio non può più essere effettuato con altra nave dello stesso vettore che parta successivamente – in questo caso il contratto si risolve di diritto- il caso in cui vi siano partenze successive di altre navi dello stesso vettore – in questo caso il passeggero ha la facoltà di utilizzare la successiva partenza oppure di risolvere il contratto. Il passeggero ha sempre diritto al risarcimento dei danni, ma se la soppressione è stata determinata da giustificato motivo, il risarcimento non può eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio.
72

Se il vettore muta l’itinerario in modo da recare pregiudizio al passeggero, quest’ultimo ha la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto oppure intraprendere l’itinerario modificato. Anche in questo caso il passeggero ha diritto al risarcimento dei danni, ma se il mutamento dell’itinerario è dovuto ad un giustificato motivo, il risarcimento non può superare il doppio del prezzo netto di passaggio.
Se la partenza della nave è ritardata, il passeggero ha diritto, durante il periodo di ritardo, all’alloggio ed al vitto, solo se compreso nel prezzo di passaggio. Se si tratta di viaggio di durata inferiore alle 24 ore, dopo 12 ore di ritardo il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto.Se si tratta di viaggi di durata superiore alle 24 ore, il passeggero può chiedere la risoluzione dopo 24 ore di ritardo, nei viaggi fra porti del Mediterraneo, oppure dopo 48 ore, nei viaggi che abbiano inizio o fine fuori d’Europa o dei Paesi bagnati dal Mediterraneo. Se non si avvale di tale facoltà, dallo scadere dei termini, il passeggero non ha diritto a ricevere l’alloggio ed il vitto a spese del vettore.Se il ritardo è dovuto da causa imputabile al vettore, il passeggero ha diritto al risarcimento dei danni.
Se il viaggio è interrotto per causa di forza maggiore, il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione al tratto utilmente percorso; tuttavia, il vettore ha diritto all’intero prezzo se procura al passeggero, a proprie spese, la prosecuzione del viaggio su nave con caratteristiche analoghe, fornendogli, nell’intervallo, l’alloggio ed il vitto, solo se compresi nel prezzo di passaggio. La disciplina anzidetta è suscettibile di deroghe.
- Impedimenti o ritardo dell’AEREONel trasporto aereo il regime degli impedimenti del vettore è regolato dalla normativa comunitaria contenuta nel regolamento del 2004. Questo regolamento disciplina le fattispecie del c.d. negato imbarco, della cancellazione del volo e del ritardo prolungato della partenza, quando il volo è in partenza da un aeroporto comunitario oppure da un aeroporto extracomunitario, ma il vettore è comunitario.Il negato imbarco si ha quando il vettore rifiuta il trasporto ad uno specifico passeggero in possesso di biglietto valido e di prenotazione confermata. (overbooking)La cancellazione del volo incide, invece, su tutti i passeggeri prenotati sullo stesso volo.Il ritardo si considera prolungato quando si protrae per più di 2, 3 o 4 ore, secondo la lunghezza del viaggio.In questi casi, il passeggero può scegliere fra la risoluzione del contratto (in caso di ritardo prolungato solo dopo 5 ore) oppure la partenza con un volo successivo.Al passeggero è dovuta un’assistenza consistente in vitto, alloggio, trasferimento dall’aeroporto all’albergo, telefonate.
73

In caso di negato imbarco e di cancellazione di volo è, inoltre, dovuto al passeggero un compenso (detto compensazione pecuniaria), salvo il diritto di richiedere il maggior danno. Il compenso costituisce un acconto anticipato forfettario, di natura indennitaria, per i danni subiti dal passeggero.
305. Obblighi del passeggeroLa più importante prestazione del passeggero consiste nel pagamento del prezzo del trasporto, salvo che la prestazione del vettore sia a titolo gratuito o amichevole.Il prezzo corrisposto dal passeggero comprende una quota che si riferisce al trasporto puro e semplice (prezzo netto) ed un’altra quota che si riferisce al vitto o ad altre prestazioni accessorie. Il prezzo comprende anche normalmente l’importo delle operazioni di imbarco e sbarco se, mancando il servizio, il vettore le esegue direttamente. (se il prezzo di tali operazioni non è compreso nel prezzo, il passeggero deve pagare una quota supplementare.)Il vettore, a garanzia dei crediti verso il passeggero, ha diritto di pegno legale sul bagaglio.Il passeggero che si imbarca senza biglietto deve darne immediato avviso al comandante o al commissario di bordo. In mancanza, il passeggero è tenuto a pagare il doppio del prezzo di passaggio, salvo il risarcimento dei danni.Il passeggero è tenuto all’osservanza dei regolamenti di bordo ed è soggetto all’autorità del comandante della nave o dell’aeromobile, la quale si manifesta nel potere di infliggere pene disciplinari e di adottare misure coercitive nei confronti dei passeggeri ai quali sono imputabili determinate infrazioni commesse a bordo di aeromobili.
306. impedimenti del passeggeroIl passeggero deve cooperare con il vettore. A tal fine deve presentarsi tempestivamente a bordo per l’esecuzione del viaggio.La mancata presentazione del passeggero non si può configurare come mora del creditore, perché questa presuppone che, nel momento in cui si determina, la prestazione del debitore sia ancora possibile; in questo caso, invece, la prestazione del vettore diventa definitivamente impossibile e si estingue a norma del c.c.
Se prima della partenza si verifica la morte del passeggero oppure un impedimento a viaggiare per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto di diritto ed è dovuto il quarto del prezzo di passaggio. (anche nel caso di morte o impedimento di congiunti)In ogni caso, al vettore deve essere data notizia dell’impedimento prima della partenza. In mancanza, è dovuto l’intero prezzo di passaggio netto.
74

Nel trasporto AEREO, in caso di impedimento alla partenza del passeggero per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto ed il vettore deve restituire tutto il prezzo di passaggio.In caso di mancata notizia prima della partenza, il vettore deve dimostrare di aver subito un danno ed il passeggero è responsabile di tale danno entro il massimo dell’ammontare del prezzo di biglietto.
Se il passeggero non si presenta a bordo nel tempo stabilito e la nave parte deve il prezzo di passaggio. Tuttavia, il prezzo non è dovuto quando il biglietto, nel quale sono indicati il nome del passeggero ed il diritto al trasporto, è trasferito ad altri, su domanda del passeggero e con il consenso del vettore.In questo caso, spetta al vettore una provvigione sul prezzo, in misura non superiore al 10 %.La disciplina del trasporto AEREO è analoga con la differenza che al vettore non spetta nessuna provvigione e non è necessario che il sostituto sia scelto dal passeggero.
In alcuni casi, le disposizioni generali sul trasporto marittimo, consentono al passeggero di recedere dal contratto, attribuendo al vettore il diritto ad un percentuale del prezzo del biglietto, di ammontare variabile a seconda dell’anticipo con cui il recesso viene comunicato.Il corrispettivo del recesso, non avendo natura risarcitoria è stato definito multa penitenziale.- Se il passeggero è costretto ad interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio è dovuto in misura del tratto utilmente percorso. Se, invece, l’interruzione avviene per fatto del passeggero, quest’ultimo deve il prezzo di passaggio netto.
307. Trasporto del bagaglioIl prezzo del passaggio comprende il corrispettivo del trasporto del bagaglio del passeggero, nei limiti di peso e di volume prestabiliti dal vettore. (bagaglio non registrato)Il bagaglio deve contenere esclusivamente oggetti personali del passeggero; se vi si includono oggetti di altra natura è dovuto il doppio del prezzo di tariffa per il trasporto delle cose stesse, oltre il risarcimento dei danni.Per i bagagli eccedenti i limiti di peso e volume, su richiesta del passeggero il vettore è tenuto a compilare in duplice esemplare un bollettino con l’indicazione del luogo e della data di emissione, del luogo di partenza e di quello di arrivo, del domicilio, del numero e del peso dei colli, dell’eventuale valore dichiarato e del prezzo di trasporto. (bagaglio registrato) Un esemplare del bollettino firmato del vettore è consegnato al passeggero.
La distinzione tra bagaglio registrato e non registrato non deve essere confusa con bagaglio consegnato e bagaglio non consegnato.
75

Il bagaglio consegnato implica l’affidamento al vettore, che ne assume la custodia. In linea di fatto, il bagaglio consegnato è anche registrato. Il bagaglio a mano non è mai registrato. La Convenzione di Montreal prescrive il rilascio di uno SCONTRINO IDENTIFICATIVO per ogni bagaglio registrato; di solito la matrice dello scontrino è apposta sul bagaglio, mentre la figlia è applicata sul biglietto del passeggero.
Quando per il bagaglio consegnato è rilasciato il bollettino (o lo scontrino) questo può funzionare da documento di legittimazione o da titolo improprio, secondo che sia o meno integrato nel biglietto nominativo. In ogni caso attribuisce la legittimazione al ritiro del bagaglio e consente al vettore di liberarsi consegnando il bagaglio a chi lo presenta.Il trasporto del bagaglio non pone in essere un autonomo rapporto giuridico, in quanto è una prestazione accessoria a quella del trasporto del passeggero. Tuttavia, con riguardo al trasferimento del bagaglio consegnato si ritiene che si tratti di un contratto autonomo di trasporto di cose.
Il passeggero deve ritirare il bagaglio nel luogo convenuto nel contratto di trasporto. Se non lo ritira, il vettore può depositarlo. Nel trasporto aereo, se il passeggero è irreperibile o rifiuta di ricevere i bagagli, il vettore ha la facoltà di consegnarli ad un’impresa di sbarco autorizzata, la quale diviene responsabile verso il destinatario. Il vettore, che si avvale di questa facoltà è tenuto a darne avviso al passeggero, se conosciuto, o all’indicato nella polizza.
308. PrescrizioneI diritti derivanti dal contratto di trasporto marittimo di persone e di bagagli non registrati si prescrivono con il decorso di 6 MESI dall’arrivo a destinazione o, in caso di mancato arrivo, dal giorno in cui il passeggero sarebbe dovuto arrivare.I diritti derivanti dal contratto di trasporto di bagagli registrati si prescrivono con il decorso di 1 ANNO dalla riconsegna o, in caso di perdita, dal giorno in cui sarebbero dovuti essere riconsegnati.Questi termini sono elevati ad 1 ANNO per i trasporti che hanno inizio o fine fuori d’Europa o dei Paesi bagnati dal Mediterraneo.Per quanto riguarda i TRASPORTI AEREI è previsto il termine di decadenza di 2 ANNI dall’arrivo a destinazione dell’aeromobile o dal giorno in cui l’aeromobile sarebbe dovuto arrivare o dall’interruzione del trasporto. (non si applicano le norme sulla prescrizione).
Sez. 2 – Responsabilità del vettore nel trasporto di persone
309. Responsabilità del VETTORE MARITTIMO
76

Nel trasporto marittimo il vettore risponde dei danni derivati al passeggero da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, se non prova che l’evento è derivato da causa a lui non imputabile. Risponde, anche per i sinistri che colpiscono il passeggero dipendenti da fatti verificatisi dall’inizio dell’imbarco al termine dello sbarco, se non prova che l’evento è derivato da causa a lui non imputabile.In entrambi i casi, si tratta di una responsabilità PRESUNTA.
La disposizione relativa alla responsabilità in caso di ritardo o mancata esecuzione del trasporto è derogabile a favore del vettore, mentre quella relativa ai sinistri del passeggero non derogabile a favore del vettore. Nei limiti del diritto comune che tutela il consumatore.
- ONERE della PROVANel caso in cui il passeggero contesti la mancata esecuzione del trasporto o il ritardo, egli ha l’onere di provare l’esistenza del diritto ad ottenere la prestazione (quindi il contratto di trasporto) e, in caso di ritardo, deve provare il diritto di ottenere la prestazione in un certo tempo; deve, inoltre, provare l’esistenza del danno. Data questa prova il vettore si presume responsabile. Egli può liberarsi dando la prova di aver adempiuto oppure dimostrando che la causa della mancata o del ritardo nell’esecuzione non è a lui imputabile.Nel caso di infortunio del passeggero, l’obbligo di cui si contesta l’adempimento è quello di vigilanza o protezione; l’infortunio implica la presunzione di violazione di questo obbligo.Quindi, spetta al passeggero provare l’esistenza del contratto di trasporto, l’esistenza del danno (infortunio) e che questo si sia verificato dall’inizio dell’imbarco al termine dello sbarco. Il vettore ha l’onere di provare di aver adempiuto (ovvero che l’infortunio si è verificato nonostante egli abbia osservato l’obbligo di custodia) oppure che non ha adempiuto (e quindi l’infortunio si è verificato a causa di un fatto a sé non imputabile che abbia reso impossibile l’adeguata protezione del passeggero.- Per quanto riguarda il danno da causa ignota il vettore è sempre responsabile.
310. Responsabilità del VETTORE AEREO per mancata esecuzione del trasporto e ritardoIl cod. nav. dispone che ai trasporti aerei di persone si applicano le regole della responsabilità previste dalla Convenzione di Montreal del 1999.Con riguardo alla responsabilità per danni da ritardo il vettore è responsabile a meno che non provi che lui stesso ed i suoi dipendenti e preposti abbiano preso tutte le misure che si sarebbero potute ragionevolmente richiedere per evitare il danno o che sarebbe stato loro possibile prenderle.
77

Mentre, ai danni per mancata esecuzione del trasporto, la Convenzione non si applica. Tuttavia, il cod. nav. adotta lo stesso regime di responsabilità previsto dalla Convenzione per la responsabilità per ritardo. Quindi, il vettore è responsabile dei danni derivanti dalla mancata esecuzione a meno che provi che lui stesso e i suoi dipendenti e preposti abbiano preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
- ONERE della PROVAAnche con riguardo il vettore aereo, l’inadempimento si presume (quindi responsabilità PRESUNTA) ed il passeggero ha l’onere di provare l’esistenza del suo diritto all’esecuzione oppure all’esecuzione tempestiva e l’esistenza del danno. Diversa, invece, è la prova del fatto impeditivo a carico del vettore. Infatti, il vettore, se non riesce a dimostrare di aver adempiuto, ha l’onere di provare di aver preso, o di non aver potuto prendere, le misure ragionevoli (o secondo la normale diligenza) per evitare il danno.A differenza del trasporto marittimo, nel trasporto aereo la causa dell’inadempimento o del danno non viene presa in considerazione, in quanto la prova liberatoria si esplica sul piano degli effetti, non della causa. Infatti, la prova ha per oggetto fatti che non si riferiscono all’evento produttivo del danno, ma alla sua conseguenza (ovvero al danno stesso). Ciò significa che le misura da provare devono essere quelle dirette all’eliminazione delle conseguenze dannose dell’evento al fine di dimostrare l’INEVITABILITA’ del DANNNO.Quindi, se la causa del danno non è individuata, il vettore non deve provare la non imputabilità della stessa, ma deve dimostrare che il danno non poteva essere evitato in altro modo, non sussistendo o avendo adottato invano misure idonee ad evitarlo.- Nel caso in cui la causa del danno sia ignota il vettore non è ritenuto responsabile se riesce a provare l’inevitabilità del danno e a dimostrare di aver adottato le misure ragionevoli (o necessarie e possibili secondo la normale diligenza) in relazione ad ogni possibile evento dannoso.
- Diversa è la disciplina in caso di mancata esecuzione del trasporto da parte di VETTORI COMUNITARI o da parte di vettori EXTRACOMUNITARI in partenza da un aeroporto comunitario. In questo caso, è previsto un particolare regime di compensazione finanziaria.Infatti, il regolamento del 2004 disciplina la fattispecie del negato imbarco e della cancellazione del volo.In questi due casi, il passeggero può scegliere fra la risoluzione del contratto e la partenza con un volo successivo. In entrambi i casi, il passeggero ha diritto ad una liquidazione forfettaria del danno subito, che va da 250 a 600 euro, a seconda della lunghezza del viaggio. Questo risarcimento è ridotto a metà se il vettore offre un volo alternativo la cui
78

ora di arrivo non ecceda troppo rispetto quella programmata per il volo inizialmente prenotato.
311. Responsabilità del vettore aereo per MORTE o LESIONE PERSONALEIl cod. nav. rende applicabile a tutti i trasporti aerei la Convenzione di Montreal del 1999. La Convenzione non parla di lesioni personali, ma lesioni corporali, escludendo quindi dal proprio ambito di applicazione le lesioni di carattere psichico (es. lesione mentale causata dal turbamento emotivo provocato da un atterraggio di fortuna). Tuttavia, il cod. nav. estende l’applicabilità della Convenzione a tutte le lesioni personali, colmando così la lacuna della Convenzione.
Il vettore è responsabile quando l’evento che ha provocato il danno si è verificato a bordo dell’aeromobile o nel corso delle operazioni di imbarco e sbarco.La responsabilità del vettore inizia dal momento in cui il passeggero entra nella sfera di influenza e controllo del vettore (questo normalmente coincide con il ritiro della carta di imbarco). Il termine delle operazioni di sbarco coincide con l’uscita del passeggero dalla sfera di controllo del vettore, ovvero con l’ingresso nell’aerostazione.
Sistema del doppio livello adottato dalla convenzione di Montreal :
PRIMO LIVELLO
Per quanto riguarda i vettori COMUNITARI, ad essi viene imposta una responsabilità PRESUNTA ed ILLIMITATA, accompagnata da una prestazione di carattere indennitario entro un certo importo pecuniario.La Convenzione dispone che, fino a concorrenza di una somma pari a 100.000 diritti speciali di prelievo, il vettore non può liberarsi della responsabilità. Solo per evitare un risarcimento in misura maggiore di 100.000, il vettore può fornire la prova liberatoria, consistente nel dimostrare che il danno non è derivato da colpa propria o dei propri ausiliari oppure che il danno è derivato esclusivamente da colpa di un terzo. In ogni caso, se la negligenza del passeggero danneggiato ha contribuito o ha causato il danno, il vettore può essere, totalmente o parzialmente, esonerato dalla responsabilità.
79

SECONDO LIVELLO
- ONERE della PROVAIl passeggero deve provare solo l’infortunio (che implica la presunzione di inadempimento del vettore dell’obbligo di protezione) e deve dimostrare che il danno si è verificato nell’ambito temporale richiesto dalla Convenzione; non ha, invece, l’onere di provare la causa del danno.Per quanto riguarda la prova liberatoria del vettore che vuole evitare un risarcimento superiore a 100.000 diritti speciali di prelievo, essa è uguale a quella prevista per il trasporto marittimo.Ovvero, la causa del danno deve essere individuata dal vettore, per poi dimostrare la mancanza di colpa propria o dei propri ausiliari oppure la colpa di un terzo connessa a quella causa.Non si tratta di responsabilità canalizzata nemmeno entro il limite di 100.000 diritti speciali di prelievo, poiché non è esclusa né l’azione di rivalsa del vettore, né la possibilità di imputazione della responsabilità su altri soggetti (es. i preposti).
- Il legislatore ha provveduto per migliorare il livello di protezione dei passeggeri coinvolti in incidenti aerei, garantendo, in ogni caso, al passeggero la reintegrazione del suo patrimonio fino a un certo ammontare. Questa reintegrazione, a carico del vettore, che ha funzione surrogatoria del risarcimento, non ha natura sanzionatoria, ma indennitaria, perché tutela la posizione del passeggero contro il fatto oggettivo della sua pregiudizievole alterazione prescindendo dall’imputabilità dell’inadempimento del vettore. - Inoltre, è previsto un sistema di anticipi di pagamento, che il vettore deve offrire ai passeggeri per far fronte a loro immediate necessità economiche. Il regolamento comunitario, inoltre, stabilisce che in caso di morte l’anticipo non può essere inferiore a 16.000 diritti speciali di prelievo.- Nel caso in cui venga esperita un’azione extracontrattuale nei confronti degli ausiliari del vettore, costoro possono far valere le condizioni ed i limiti di responsabilità previsti per il vettore.- Per i danni non regolati dalla Convenzione(es. danni psichici, quelli esterni alla sfera spazio-temporale coperta dalla Convenzione,..) si applica il diritto nazionale individuato dalle norme di diritto internazionale privato.- La disciplina della responsabilità contenuta nella Convenzione di Montreal è inderogabile a favore de vettore.
312. Responsabilità nel trasporto aereo eseguito da vettori successivi e da soggetto diverso dal vettore contraenteLa Convenzione di Montreal disciplina la fattispecie del trasporto eseguito da vettori successivi e quello eseguito da soggetto diverso da quello che ha stipulato il contratto di trasporto.
80

Nel caso di TRASPORTO SUCCESSIVO di persone, caratterizzato dal fatto che il passeggero intrattiene rapporti contrattuali con tutti i vettori successivi, il passeggero può agire soltanto contro il vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale si è verificato l’incidente o il ritardo, salvo i casi in cui, per accordo espresso, il primo vettore si sia assunto la responsabilità dell’intero viaggio.Vettore è colui che si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro; l’assunzione di questo obbligo, mediante un contratto, è sufficiente all’assunzione della qualità di vettore, non essendo necessario che egli stesso esegua il trasferimento. Infatti, questo può essere fatto eseguire, in tutto o in parte, da un terzo. In questo caso il rapporto fra vettore e terzo può consistere in un contratto di noleggio (o nel trasporto di cose in un sub trasporto), mentre fra terzo e passeggero non vi è alcun rapporto contrattuale, in quanto il terzo si presenta come ausiliare del vettore.La Convenzione denomina vettore contraente il soggetto che stipula il contratto di trasporto, mentre vettore operativo il soggetto che effettivamente esegue il trasferimento.Per quanto riguarda la responsabilità, la Convenzione prevede la solidarietà dei due vettori nei confronti dei passeggeri, salvo reciproca rivalsa. Ovviamente, il vettore contraente risponde per l’intero viaggio, mentre il vettore operativo risponde solo per il percorso da lui eseguito.
313. Limitazione del debito del vettore aereoNel trasporto di persone, è prevista la limitazione risarcitoria del vettore solo con riguardo alla responsabilità per ritardo.Infatti, per la mancata esecuzione del trasporto, per morte o lesioni del passeggero il cod. nav. non pone alcun limite risarcitorio alla responsabilità del vettore.Mentre, con riguardo alla responsabilità per ritardo, la Convenzione di Montreal prevede il limite risarcitorio pari a 4.150 diritti speciali di prelievo per ogni passeggero.Tuttavia, la Convenzione dispone che il vettore decade dal beneficio della limitazione se il passeggero prova che il danno è derivato da un atto o omissione del vettore o dei suoi ausiliari con l’intenzione di provocare un danno oppure con la coscienza che ne sarebbe derivato un danno.
314. Responsabilità relative al bagaglioIl regime della responsabilità per perdita o avaria del bagaglio differisce a seconda che si tratti di bagaglio consegnato o non consegnato.Nel TRASPORTO MARITTIMO il vettore è responsabile della perdita e delle avarie al bagaglio che gli è stato consegnato chiuso, se non prova che il danno è derivato da causa a lui non imputabile. Il debito del vettore è limitato a 6,19 euro per kg, salvo dichiarazione di maggior valore da parte del passeggero.
81

La perdita o le avarie, se apparenti, devono essere fatte constatare, a pena di decadenza, al momento della riconsegna. Mentre, se le avarie non sono apparenti, devono essere denunciate entro 3 giorni.Per i bagagli e gli oggetti non consegnati, si ha un’inversione dell’onere della prova, in quanto il vettore è responsabile solo se il passeggero riesce a provare che la perdita o l’avaria sia stata determinata da causa imputabile al vettore. Inoltre, il limite risarcitorio e la decadenza stabiliti per il bagaglio consegnato, non si applicano alla responsabilità per il bagaglio non consegnato.Questo regime di responsabilità è dichiarato dal cod. nav. inderogabile a favore del vettore.Nel TRASPORTO AEREO il regime della responsabilità è regolato dalla Convenzione di Montreal. Per quanto riguarda il bagaglio consegnato, il vettore può liberarsi soltanto provando che il danno deriva da vizio proprio del bagaglio stesso.Per i danni da ritardo nel trasporto di bagagli, il vettore è responsabile a meno che non provi che lui stesso ed i suoi dipendenti e preposti abbiano preso tutte le misure che si sarebbero potute ragionevolmente richiedere per evitare il danno e che sarebbe stato loro impossibile prendere.Per i danni al bagaglio non consegnato, il vettore risponde se il danneggiato provi che il danno è derivato da colpa del vettore o dei suoi ausiliari.Sia per il bagaglio consegnato che per quello non consegnato, la responsabilità per perdita, avaria o ritardo è limitata a 1.000 diritti speciali di prelievo per ogni passeggero. Per evitare l’applicazione del limite, il passeggero deve provare che il danno è derivato da dolo o condotta consapevole del vettore o dei suoi dipendenti o preposti, oppure può fare una dichiarazione speciale di interesse alla riconsegna, pagando un supplemento di tariffa. In questo caso, il vettore deve risarcire il danno fino alla somma dichiarata, a meno che non provi che è più elevata dell’effettivo interesse alla riconsegna.
315. Responsabilità nel trasporto gratuito e amichevoleIl regime di responsabilità del vettore marittimo e aereo nel trasporto di persone e di bagagli vale anche nelle ipotesi di TRASPORTO GRATUITO.Il trasporto gratuito trae origine da un rapporto contrattuale. Tuttavia, non si tratta di una sottospecie di contratto di trasporto, in quanto il contratto di trasporto è essenzialmente oneroso. Nonostante questo, la disciplina della responsabilità nel contratto di trasporto oneroso può applicarsi per analogia al trasporto gratuito di cose, salvo i casi e nei limiti in cui non si ritenga che la gratuità debba comportare una valutazione con minor rigore della diligenza del vettore nell’adempimento dei suoi obblighi.Il contratto gratuito si distingue dal CONTRATTO AMICHEVOLE o di CORTESIA, in quanto il primo è caratterizzato da un interesse del trasportatore ad eseguire la prestazione gratuitamente; mentre, il
82

secondo presuppone la mancanza di tale interesse ed è effettuato in assenza di un obbligo del vettore, fondandosi su relazioni umane di cortesia, amicizia, convivenza…Non si tratta, quindi, di un rapporto contrattuale ed obbligatorio, ma esso è fonte di responsabilità extracontrattuale.Nel trasporto amichevole di persone o bagagli per ACQUA la responsabilità del vettore sussiste solo nel caso in cui il danneggiato provi il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti o preposti.Il trasporto amichevole per ARIA non è espressamente regolato, quindi si ritiene applicabile la disposizione in tema di trasporto amichevole per acqua.
Sez. 3 – CONTRATTI di TURISMO ORGANIZZATO
316. Tipologie contrattualiLe figure contrattuali connesse a trasporti a scopo turistico si articolano in diversi profili tipologici. Essi sono stati ricompresi in una figura generale, chiamata contratto di turismo organizzato, che si caratterizza per la finalità turistico - ricreativa cui sono dirette le prestazioni che vi sono contenute.Nell’ambito di questa figura sono compresi 4 sottotipi: contratto di crociera turistica, contratto di organizzazione di viaggio turistico, contratto di organizzazione turistica e contratto di trasferimento turistico.Questi contratti hanno in comune, oltre alla finalità turistico – ricreativa, la presenza di una pluralità di prestazioni, che vengono fornite da diversi soggetti, ma che sono comunque dirette al perseguimento di un risultato unitario, cui è obbligato l’organizzatore (tour operator).- Nel contratto di organizzazione di viaggio turistico sono sempre presenti le prestazioni di trasporto e di soggiorno- Nel contratto di organizzazione turistica sono presenti l’alloggio e altre prestazioni, ma non il trasporto- Nel contratto di trasferimento turistico sono presenti il trasporto ed altre prestazioni, ma non l’alloggio.Ad essi si aggiunge il contratto di intermediazione turistica, concluso da un’agenzia di viaggi, che può comprendere tutti e quattro i tipi.
317. Crociera turisticaNel contratto di crociera turistica l’organizzatore della crociera, con una nave da lui esercitata no noleggiata, si obbliga a trasportare i passeggeri per un viaggio di piacere solitamente circolare (ovvero con ritorno al punto di partenza) ed a fornire altre prestazioni a bordo (cabina, vitto,…). Nel contratto di crociera turistica all’obbligazione di trasporto si affiancano altre prestazioni avente oggetto diverso ; le diverse prestazioni sono fra loro complementari e concorrono insieme al conseguimento al conseguimento della funzione turistica.
83

La crociera è considerata un contratto misto, al quale si applicano le discipline legali dei contratti corrispondenti alle singole prestazioni (trasporto, albergo, ristorazione,…).
318. Contratti di viaggio turisticoLe altre tipologie contrattuali diverse dalla crociera sono chiamate contratti di viaggio. Per esse è prevista una tipizzazione legale dalla Convenzione di Bruxelles del 1970 sul contratto di viaggio (CCV) e dal d.lgs. del 1995, poi trasfuso nel codice del consumo.La CCV si applica ai contratti, stipulati da un organizzatore o da un intermediario (agenzia di viaggi) stabiliti in uno Stato, che debbono essere eseguiti, totalmente o parzialmente, in uno Stato diverso da quello in cui il contratto è stato concluso o da dove il viaggiatore è partito.La CCV distingue 2 figure contrattuali: contratto di organizzazione di viaggio e contratto di intermediario.- Con il contratto di organizzazione di viaggio l’organizzatore si obbliga nei confronti del viaggiatore a fornire un insieme di prestazioni combinate comprendenti il trasporto ed il soggiorno, più altri eventuali servizi, verso il corrispettivo di un prezzo globale (si tratta del contratto di organizzazione di viaggio turistico). In questo caso l’organizzatore si obbliga verso il viaggiatore anche riguardo le prestazioni di servizio fornite da soggetti diversi (albergatore, vettore,…), i quali non entrano in rapporto con viaggiatore, ma solo con l’organizzatore. In tal caso si inquadra un contratto di appalto, poiché l’organizzatore si obbliga a fornire un prodotto complesso ma unitario , attraverso la propria attività organizzativa. - Il contratto di intermediazione di viaggio è quello mediante il quale l’intermediario si obbliga a procurare al viaggiatore un contratto di organizzazione di viaggio, il quale viene organizzato da latri soggetti.Il COD. del CONSUMO usa l’espressione pacchetto turistico, il quale è realizzato da un organizzatore e procurato da un intermediario. Il pacchetto ha ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla combinazione di almeno 2 dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (visite, escursioni…). I servizi devono essere venduti ad un prezzo forfettario e devono essere di durata superiore alle 24 ore oppure di almeno una notte.Il COD. del CONSUMO prevede anche un contratto di intermediazione, dove l’intermediario (chiamato venditore) vende o si obbliga a procurare, al viaggiatore pacchetti turistici realizzati da organizzatori, verso un corrispettivo forfettario.- I contratti di viaggio sono da inquadrare nell’appalto, in quanto l’organizzatore si obbliga a fornire un prodotto complessa, ma unitario.- Il contratto di intermediazione è qualificato come mandato fra il viaggiatore (mandante) e l’intermediario (mandatario).
84

319. Responsabilità dell’organizzatore e dell’intermediario secondo la legge nazionaleSecondo il Cod. di Consumo la responsabilità dell’organizzatore e dell’intermediario è distinta in relazione a due diverse fattispecie.- La prima riguarda l’inadempimento o la mancata esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, fornite dallo stesso organizzatore o venditore oppure da altri soggetti (vettore, albergatore…) ai quali l’organizzatore ne abbia affidato l’esecuzione. In questa ipotesi, l’organizzatore ed il venditore (a scelta del viaggiatore) sono responsabili a meno che non provino che la mancata o inesatta esecuzione sia imputabile al viaggiatore o sia dipesa da un terzo oppure da caso fortuito o di forza maggiore.L’organizzatore o il venditore che abbiano risarcito il viaggiatore sono surrogati in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso il terzo responsabile. Il viaggiatore può agire direttamente contro il prestatore del servizio.- La seconda fattispecie riguarda il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni personali dell’organizzatore e del venditore, diverse dalle prestazioni che formano oggetto del pacchetto (es. per l’organizzatore: alloggio diverso da quello pattuito). In questo caso, l’organizzatore ed il venditore sono responsabili parziariamente, ovvero ciascuno secondo le rispettive responsabilità, a meno che non provino che il mancato adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.L’organizzatore o il venditore possono, poi, rivalersi nei confronti degli ausiliari, ai quali è stato demandato l’adempimento delle obbligazioni.È ammesso anche il risarcimento dei danni morali.
- Per i danni alla persona la responsabilità è illimitata ed è nullo ogni accordo che ponga limiti di risarcimento per tali danni.Il viaggiatore deve contestare la mancanza o inesatta esecuzione del contratto IN LOCO oppure entro 10 GIORNI dal rientro. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in 3 ANNI dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza (nel caso di trasporto stradale il termine è di 12 MESI).Per gli altri danni, il termine di prescrizione è di 1 ANNO.- L’organizzatore ed il venditore devono essere coperti da un’assicurazione per la responsabilità civile verso il viaggiatore per il risarcimento dei danni relativi alla prima fattispecie (mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico).Inoltre, è istituito presso la Presidenza del Consiglio un fondo nazionale di garanzia, per garantire al viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e del venditore.
85

320. Responsabilità dell’organizzatore e dell’intermediario secondo la CCV
Anche la Convenzione di Bruxelles del 1970 distingue la responsabilità dell’ORGANIZZATORE per la mancata esecuzione dei suoi obbligo personali dalla responsabilità del medesimo per l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.- Nel primo caso, l’organizzatore è responsabile verso il viaggiatore a meno che non provi di essersi comportato da organizzatore diligente. Il risarcimento è limitato, per ogni viaggiatore, a 50.000 franchi oro per danni corporali, a 2.000 franchi oro per danni materiali ed a 5.000 franchi oro per ogni altro danno.(Il FRANCO ORO è il c.d. franco Germinal, corrispondente a dieci trentunesimi d’oro al titolo di 900 millesimi. Il 1 agosto 2007 1 franco Germinal equivaleva a 4,54 euro).- Nel secondo caso, se è l’organizzatore che effettua le prestazioni oggetto del pacchetto, risponde dei danni causati al viaggiatore.Mentre, se le prestazioni sono eseguite da terzi, si fa un’ulteriore distinzione. Per i danni causati al viaggiatore da mancata esecuzione della prestazione, l’organizzatore risponde secondo le disposizioni che regolano la prestazione. Per i danni causati al viaggiatore in occasione dell’esecuzione della prestazione, l’organizzatore risponde, a meno che non provi la propria diligenza nella scelta del terzo che ha eseguito la prestazione. L’organizzatore che abbia risarcito il viaggiatore è surrogato nei diritti di questo verso il terzo responsabile ed il viaggiatore può scegliere di agire direttamente contro il terzo responsabile.- La CCV disciplina anche la responsabilità dell’INTERMEDIARIO nel contratto di intermediazione.L’intermediario risponde verso il viaggiatore solo della colpa nell’esecuzione dei suoi obblighi personali di assistenza, entro il limite di 10.000 franchi oro per viaggiatore. Mentre, non è responsabile dell’inesecuzione dei viaggi, soggiorni o altre prestazioni oggetto del contratto.Sia l’organizzatore che l’intermediario non possono avvalersi delle limitazioni se il viaggiatore dimostra il dolo o la colpa loro o degli ausiliari.Le disposizioni della Convenzione sono derogabili solo a favore del viaggiatore.Le azioni del viaggiatore fondate su sinistri alla persona si prescrivono in 2 ANNI, mentre le altre azioni in 1 ANNO.
Sez. 4 – TRASPORTO di COSE (aereo e nave)
321. Natura
86

Il contratto di trasporto di cosa è un contratto consensuale, con cui il vettore si obbliga a trasferire cose da un luogo ad un altro. Si caratterizza rispetto al trasporto di persone, per la diversità dell’oggetto. Il vettore, assumendo la detenzione delle cose ed obbligandosi a riconsegnarle a destinazione, è anche tenuto a custodirle. Inoltre, la diversità dell’oggetto introduce nella struttura soggettiva del contratto, oltre ai contraenti, che sono il vettore ed il mittente (caricatore), un terzo soggetto, ovvero il destinatario.
322. TipiIl trasporto marittimo di cose può avere esecuzione in 2 diverse modalità, chiamate dal cod. nav. trasporto di carico totale o parziale e trasporto di cose determinate.Del trasporto aereo, invece, è prevista solo la modalità del trasporto di cose determinata alla quale si applicano le norme relative al trasporto marittimo.Il trasporto di carico corrisponde al contratto documentato nella pratica da un formulario di voyage charter, adottato nei traffici non di linea.Il trasporto di cosa determinata corrisponde al contratto documentato da una polizza di carico o da una sea waybill ed è tipico dei traffici di linea. La differenza giuridica fra questi 2 contratti sta : nel trasferimento di cose determinate l’interesse del caricatore si esaurisce nel trasferimento di un certo quantitativo di merce ; nel trasporto di carico si riscontra inoltre una particolare attenzione nei riguardi della nave e del suo viaggio.Altre modalità di TRASPORTO MARITTIMO di cose, non previste dal cod. nav. sono:- Lo SLOT CHARTER, nel quale il vettore mette a disposizione del caricatore un certo numero di spazi (slots) della nave destinati a ricevere container, di solito per viaggi di linea. Il nolo è stabilito a viaggio, ma il contratto può essere stipulato non solo per uno o più viaggi, ma anche per un certo periodo di tempo.- Il TRIP CHARTER è un ibrido fra time e voyage charter. Il nolo è fissato a tempo, però il viaggio o i viaggi che la nave deve compiere sono prefissati nel contratto.- Il CHARTER per VIAGGI CONSECUTIVI è un trasporto di carico con il quale il vettore si obbliga ad effettuare un numero determinati di viaggi consecutivi oppure tanti viaggi consecutivi quanti la nave potrà effettuare entro un determinato periodo di tempo.- CONTRACT OF AFFREIGHTMENT, mediante il quale vettore si obbliga ad effettuare, entro un certo periodo di tempo relativamente lungo, una pluralità indeterminata d viaggi secondo un programma prestabilito, per il trasporto di elevata quantità di merce. La nave non è determinata, ma può cambiare per ogni viaggio. Il contratto può essere documentato mediante un formulario di voyage charter oppure mediante un contratto quadro che disciplina l’operazione complessiva, rinviando ad un
87

determinato voyage charter o ad una polizza di carico la disciplina dell’esecuzione dei singoli viaggi.
323. Forma del contrattoIl contratto di trasporto di cose per acqua o aria deve essere provato per iscritto, tranne per il trasporto su navi minori inferiori a una certa stazza. Tuttavia, l’assenza di forma scritta non pregiudica la validità del contratto, ma rende più difficile la prova dello stesso.Per il trasporto di carico si provvede alla sottoscrizione o al richiamo espresso di formulari di voyage charter. La prova della conclusione del contratto di trasporto di COSE DETERMINATE può risultare, in mancanza di scrittura, dalla polizza di carico o dalla booking note, ovvero un documento a stampa, sottoscritto dal vettore e dal caricatore, contenente gli estremi del contratto di trasporto concluso verbalmente ed avente piena efficacia probatoria.- documento probatorio del contratto di TRASPORTO AEREO di cose è la lettera di trasporto aereo. La convenzione di Montreal 1999 dispone che nella lettera di trasporto aereo la sottoscrizione può risultare a stampa o sostituita da un timbro senza che ciò pregiudichi l’efficacia probatoria del documento. La scrittura privata fa piena prova solo se sia stata sottoscritta da colui contro il quale è prodotta.
324. Acquisto dei diritti da parte del DESTINATARIOQuando il contratto non è documentato da un titolo di credito rappresentativo delle cose trasportate (polizza di carico), mittente e destinatario possono essere soggetti diversi, specialmente nel caso di contratto di compravendita.In questo caso, si pone il problema di specificare i rapporti che caricatore e destinatario intrattengono con il vettore.Il destinatario acquista i diritti nascenti dal contratto verso il vettore dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine entro il quale sarebbero dovute arrivare, ne richiede la consegna, purché abbia pagato al vettore i crediti derivanti dal trasporto e gli assegni da cui le cose trasportate siano gravate.Mentre, il mittente si libera dall’obbligo della consegna all’acquirente rimettendo le cose al vettore.Il mittente-venditore, tuttavia, non perde la disponibilità della cosa con la rimessione della stessa al vettore. Infatti, egli, fino a quando la merce non giunge a destinazione, ha il c.d. diritto di contrordine, ovvero può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose oppure ordinare la consegna ad un destinatario diverso, salvo l’obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine.
325. Obbligo del caricatore di pagare il NOLOL’obbligazione principale del caricatore è quella di pagare il nolo. Quest’ultimo può essere calcolato per lump sum, ovvero in una somma
88

fissa prestabilita oppure in funzione della quantità o del volume del carico.Le parti possono trasferire l’obbligazione di pagamento del nolo dal caricatore al destinatario, mediante la clausola del nolo pagabile a destino o mediante la cesser clause, che prevede la cessazione di ogni obbligo del caricatore verso il vettore quando la merce sia stata caricata.Questa clausola è accompagnata dal riconoscimento al vettore di un lien sul carico, ovvero una sorta di diritto di ritenzione a garanzia del pagamento del nolo e degli altri crediti. È, inoltre, stabilito che il caricatore rimane obbligato se il vettore non sia riuscito a soddisfare i suoi crediti dopo l’esercizio del lien.Il cod. nav. garantisce i crediti del vettore facendoli assistere da un privilegio sulle cose caricate e consentendo al comandante, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria del luogo di scaricazione, di depositare o vendere tanta parte delle cose quanta ne occorra per coprire il nolo ed i compensi di controstallia, a meno che il destinatario non provveda al deposito di una somma pari all’ammontare del credito del vettore.
326. Obblighi del caricatore prima della partenzaIl caricatore deve opporre marche di contrassegno sulla merce consegnata al vettore o sugli imballaggi, in modo che possano risultare visibili fino al termine del viaggio.Deve, inoltre, indicare su ciascun collo o oggetto, il rispettivo peso lordo quando sia di 1000 kg o più. Le marche di contrassegno e l’indicazione del peso non sono applicabili sulla merce caricata alla rinfusa, in quanto essa non è imballata o avvolta con involucro esterno.Il caricatore deve, inoltre, all’atto dell’imbarco, consegnare al vettore le bollette doganali. Al riguardo, il vettore non è tenuto a verificare la completezza dei documenti.- Il caricatore è responsabile dei danni al vettore derivati dall’imperfetta apposizione delle marche, della mancata o errata indicazione del peso e dell’omessa consegna delle bollette doganali.
- Se il caricatore intende imbarcare merce pericolosa o inquinante, deve trasmettere una dichiarazione al comandante o al raccomandatario, il quale la notifica all’autorità marittima al fine di ottenere il rilascio delle spedizioni.Se omette di dichiarare o se indica falsamente il carico, il comandante può far scaricare la merce nel luogo di imbarco oppure esigere il nolo al tasso massimo corrente nel luogo di caricazione, oltre al risarcimento dei danni.- Con particolare riguardo alla merce pericolosa, le Regole dell’Aia-Visby dispongono che essa può essere sbarcata in ogni momento prima della scaricazione oppure può essere distrutta o resa inoffensiva dal vettore. Il caricatore è responsabile per ogni danno derivante dalla merce.
89

- Il caricatore deve consegnare le cose da imbarcare nella quantità convenuta. Se ne consegna quantità minore è tenuto a corrispondere il nolo intero, detratte le spese che il vettore ha risparmiato per la mancata caricazione, ed il nolo eventualmente acquisito dal vettore per altre merci che avrebbe caricato. Se il caricatore consegna l’esatto quantitativo della merce e, ciò nonostante, la caricazione è incompleta per un successivo fatto addebitabile ad altro soggetto (es. impresa di imbarco) al caricatore può essere chiesto solo il nolo della merce caricata.
327. Recesso del caricatoreIl caricatore ha la facoltà di recedere dal contratto prima della partenza, pagando la metà del nolo convenuto e le spese sostenute per la caricazione e scaricazione, se tali spese non sono comprese nel nolo, più le eventuali controstallie.Il caricatore può liberarsi, in tutto o in parte, da tale obbligo se prova che il vettore non abbia subito danni oppure abbia subito un danno minore.- Nel trasporto di cose determinate e nel trasporto aereo il recesso del caricatore prima della partenza subisce un temperamento, in quanto, quando la merce è stata già caricata, il caricatore può recedere solo quando lo dichiari entro il termine di uso per la partenza della nave e se la scaricazione non cagioni alla partenza stessa.- Il caricatore può recedere anche durante il viaggio, ritirando le cose caricate. In questo caso, deve corrispondere al vettore il nolo intero e rimborsargli le spese straordinarie per la scaricazione. Il comandante non è tenuto alla scaricazione quando questa importi ritardo eccessivo o modificazione dell’itinerario oppure comporti scalo in un porto intermedio non contemplato nel contratto.La facoltà di recesso del caricatore è qualificata come diritto di contrordine.
328. Impedimenti e rischio del noloGli impedimenti che incidono sull’esecuzione del contratto sono disciplinati dal cod. nav.- Se la partenza della nave è impedita (impedimento definitivo) per causa di forza maggiore, il contratto si risolve di diritto. Se, invece, la partenza è ritardata, è facoltà del caricatore se risolvere il contratto. In entrambi i casi se la risoluzione avviene dopo l’imbarco, gravano sul caricatore le spese di scaricazione.- Se la partenza della nave o la prosecuzione del viaggio sono temporaneamente impediti per causa non imputabile al vettore, il contratto resta in vigore. Tuttavia, il caricatore ha la facoltà di far scaricare la merce a proprie spese, con l’obbligo di ricaricarla o, in alternativa, di risarcire i danni.In ogni caso, il vettore non può richiedere più del nolo pattuito. Ed, in caso di impedimento durante il viaggio, il nolo è dovuto solo per il tratto utilmente percorso.
90

- Se il viaggio è interrotto per la necessità da fare riparazioni per causa di forza maggiore, il contratto rimane in vigore ed il caricatore è tenuto a pagare il nolo intero. Tuttavia, se le riparazioni non possono effettuarsi o sussista altro impedimento, che interrompa il viaggio definitivamente, il nolo è dovuto solo per il tratto utilmente percorso, purché il comandante abbia fatto il possibile per provvedere all’inoltro della merce al luogo di destinazione con altra nave.- Se l’approdo è impedito o ritardato per causa di forza maggiore, il comandante deve provvedere all’approdo in un altro porto vicino o ritornando al porto di partenza. Anche in questo caso è dovuto il nolo del solo tratto utilmente percorso.Al riguardo, i contratti contengono la c.d. near clause, che dà al comandante la facoltà di approdare in un luogo diverso da quello pattuito, in caso di impedimenti.
Se la merce non giunge a destinazione il nolo non è dovuto, a meno che il mancato arrivo non sia dovuto ad un fatto del caricatore o alla nature della merce.Contro l’eventualità di perdere, in tutto o in parte, il nolo, il vettore può inserire nel contratto la clausola “nolo acquisito ad ogni evento”.
329. PrescrizioneI diritti derivanti dal contratto di TRASPORTO MARITTIMO di cose si prescrivono con il decorso di 6 MESI. Tale termine decorre, nel trasporto di carico, dalla riconsegna delle cose e, in caso di perdita totale, dal giorno in cui le cose sarebbero dovute arrivare; mentre, nel trasporto di cose determinate, dalla riconsegna e, in caso di perdita, dal giorno in cui la perdita è stata riconosciuta dal vettore oppure dopo 7 giorni dal termine in cui la merce sarebbe dovuta arrivare a destinazione.- Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori d’Europa o dei Paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione si compie con il decorso di 1 ANNO.- Nei trasporti MISTI di cose per mare e per terra il termine di prescrizione è previsto dal cod. civ. I diritti derivanti dal contrato si prescrivono in 1 ANNO. Il termine decorre dal giorno in cui sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa. Se il trasporto ha inizio o fine fuori d’Europa, il termine si compie in 18 MESI.- I diritti derivanti dal contratto di TRASPORTO AEREO di cose sono assoggettati al termine di decadenza di 2 ANNI (uguale al trasporto di persone).
Sez. 5 – TRASPORTO di CARICO totale o parziale (Traffici non di linea – nave)
330. Nozione
91

Il trasporto di carico totale o parziale si esplica nel contesto dei traffici non di linea . si contraddistingue per il particolare interesse del caricatore non soltanto all’arrivo della merce a destinazione, ma anche alle caratteristiche della nave ed alle modalità di esecuzione di esecuzione del viaggio. Il caricatore utilizza tutti o gran parte degli spazi disponibili della nave.
331. Determinazione e messa a disposizione della naveLa designazione della nave è un elemento importante nel contratto, in quanto il trasporto di carico è in funzione della CAPACITA’ del veicolo.La nave designata non può essere sostituita in mancanza di accordo delle parti.- Fra le caratteristiche della nave, la PORTATA è la più importante. Essa è il peso totale che la nave può portare al massimo della sua immersione. Essa si distingue in lorda e netta; solo quest’ultima rileva ai fini commerciali perché si identifica con il carico utilmente trasportabile.- Il vettore deve mettere la nave a disposizione del caricatore nel tempo e nel luogo convenuti.Il TEMPO è regolato nei voyage charter come per il noleggio e culmina nel termine di cancello.Il LUOGO di caricazione può essere indicato nel contratto o, successivamente, dal caricatore.Dal porto di caricazione va distinto il PUNTO di ANCORAGGIO o di ORMEGGIO. Se il contratto non indica questo punto, deve essere deciso dal caricatore. Se quest’ultimo non designa in tempo il luogo, la nave viene condotta nel luogo abituale oppure in altro luogo scelto dal comandante, tenendo conto degli interessi del caricatore.
332. Spese e rischi di caricazione e scaricazioneIn mancanza di diverso patto o uso locale, il vettore riceve e riconsegna la merce SOTTO PARANCO, ovvero sotto il bordo della nave. È prevista la CLAUSOLA c.d. SOTTO PARANCO, che ripartisce fra vettore e caricatore o ricevitore l’effettuazione delle attività di caricazione e scaricazione, con le relative spese e rischi. Ovvero:- al VETTORE spetta caricare e scaricare la merce sotto il bordo della nave- sul CARICATORE gravano i rischi e le spese fino al bordo della nave- sul RICEVITORE quelli a partire dal bordo.
Spesse viene stipulata la CLAUSOLA FIO dispone che le operazioni di caricazione e scaricazione debbano essere effettuate rispettivamente dal caricatore e dal ricevitore.Quindi il vettore prende in consegna la merce quando è già caricata e la riconsegna ancora nella stiva.
92

Per quanto riguarda lo STIVAGGIO sussiste una responsabilità del comandante, il quale è tenuto ad assicurarsi che la nave sia correttamente caricata e stivata.- Per il carico non possono essere utilizzati gli spazi interni (nei quali non è materialmente possibile collocare la merce es. locali delle macchine) e gli spazi riservati agli alloggi dell’equipaggio, salvo autorizzazione del vettore.
333. STALLIECostituiscono un periodo di tempo, determinato nel contratto, entro il quale si presume abbiano termine le operazioni di caricazione o scaricazione.Il TEMPO di stallia ha inizio quando, arrivata la nave nel porto o nel luogo di ormeggio, il caricatore o il ricevitore riceve il c.d. avviso di prontezza dal comandante.Ai fini dell’inizio del tempo di stallia, la nave deve essere pronta anche sotto l’aspetto amministrativo, ovvero deve disporre di tutte le documentazioni e permessi necessari all’operazione.- E’ frequente l’adozione della clausola “whether in berth or not”, mediante la quale l’avviso di prontezza può essere dato anche prima che la nave giunga il porto o il luogo di ormeggio, trasferendo così al caricatore il rischio dell’impossibilità di raggiungere il porto o il luogo. La durata della stallia è prevista nel contratto ed è stabilita a giorni o a ore.Il tempo di stallia si computa in giorni lavorativi.- Nella pratica viene pattuito il c.d. PREMI di ACCELERAMENTO, in base al quale al caricatore è concesso un premio se termina le operazioni prima che scada il tempo di stallia.- Oltre a prevedere due termini di stallia (caricazione e scaricazione) può essere stabilito un unico termine per completare entrambe le operazioni (in questo caso si parla di STALLIE REVERSIBILI).
334. CONTROSTALLIENel caso in cui il tempo di stallia è decorso senza che le operazioni di caricazione o scaricazione siano terminate per causa non imputabile al caricatore o ricevitore, il vettore è tenuto ad un periodo ulteriore di attesa, detto tempo di controstallia, per il quale ha diritto ad un compenso.Salvo diverso patto o uso locale, il tempo di controstallia è di tanti giorni lavorativi quanti sono stati quelli di stallia.- Se il termine di caricazione sia decorso senza che sia stata caricata tutta la merce per causa non imputabile al caricatore, il comandante ha la facoltà di partire senza attendere altro tempo, a meno che non gli venga fornita idonea garanzia.Il COMPENSO è computato in ragione di ore o giorni e deve essere versato giorno per giorno. Il tasso di controstallie è fissato nel contratto ,
93

in mancanza è determinato proporzionalmente alla portata della nave. Gli impedimenti fortuiti non interrompono il decorso della controstallie. Se invece il tempo di controstallie è decorso per causa non imputabile al caricatore o al destinatario è dovuto un compenso minore.Spirato il termine di controstallie il comandante ha facoltà di partire senza attenderla caricazione, o il suo completamento.- Se il tempo di controstallia è decorso ed il comandante non si sia avvalso della facoltà di partire, è dovuto un ulteriore compenso (equivale al compenso della controstallia più la metà). In questo caso si parla di CONTROSTALLIE STRAORDINARIE.Tenuto al pagamento è il caricatore. Tuttavia, l’obbligo può essere trasferito al ricevitore mediante la cesser clause.
335. Natura giuridica del compenso di controstalliaVi sono 2 orientamenti della dottrina:- che abbia natura risarcitoria, ravvisando nel ritardo attribuibile al caricatore o al ricevitore una mora del creditore. In sostanza il caricatore o il ricevitore , creditore del trasporto , ritardando il compimento della propria prestazione di caricazione o scaricazione , impedirebbe la vettore debitore alla sua obbligazione di trasferimento. Il compenso pertanto consisterebbe in una liquidazione preventiva delle spese e dei danni causati.- che abbia natura retributiva ed è configurabile come supplemento del nolo. Esso consisterebbe in uno speciale corrispettivo dovuto per la particolare prestazione aggiuntiva del vettore avente per oggetto l’ulteriore attesa. (prevale questo orientamento)
336. Impedimenti alla riconsegnaSe al momento dell’arrivo della nave il destinatario sia irreperibile, rifiuti di ricevere il carico, si presentino più destinatari oppure vi sia opposizione da parte dei creditori privilegiati, il vettore deve immediatamente chiedere istruzioni al caricatore. Quest’ultimo può esercitare il diritto di contrordine.- Se non è possibile chiedere istruzioni al caricatore, il vettore può DEPOSITARE le cose in luogo di pubblico deposito oppure, se le cose sono soggette a rapido deterioramento, può VENDERLE, dopo aver informato il caricatore.(Nel caso di deposito il contratto non si estingue con la consegna al depositario ma vi è una modificazione del soggetto in quanto gli obblighi assunti dal vettore passano in capo al depositario. il vettore non è liberato in quanto si usa lo schema della delegazione).
Sez. 6 – TRASPORTO di COSE DETERMINATE (Traffici di linea - aereo e nave)
94

337. Sostituibilità del veicoloIl trasporto di cose è eseguito, normalmente, da navi di linea ed è documentato dalla polizza di carico.Si distingue dal trasporto di carico perché in esso non vi è l’interesse del caricatore in relazione alla nave destinata ad eseguire il trasporto. Infatti, il cod. nav. dispone che, in mancanza di divieto, il vettore può sostituire il veicolo designato con un altro. Sia per quanto riguarda la nave che l’aeromobile.La Convenzione di Montreal, invece, prevede direttamente la facoltà del vettore a sostituire il veicolo.
338. Trasbordo e trasporto con pluralità di vettoriLa CLAUSOLA di TRASBORDO permette al vettore di trasbordare il carico da una nave ad un’altra per il compimento del viaggio fino a destinazione. Il documento concernente l’intero viaggio è detto polizza di carico diretta.Quando la nave sulla quale il carico viene trasbordato appartiene ad un altro vettore oppure, più in generale, quando i vettori coinvolti nel trasporto sono 2 o più, si pone il problema di determinare chi assume la qualità di vettore nei confronti dell’interessato al carico.Il problema si risolve diversamente a seconda di quale contratto con pluralità di vettori si tratta.Essi sono:1 – TRASPORTO CON RISPEDIZIONE, mediante il quale il vettore si obbliga verso il caricatore a trasferire la merce per un solo tratto del percorso. Mentre, per gli altri tratti stipula contratti di trasporto con altri vettori IN NOME PROPRIO ma PER CONTO del CARICATORE. Quindi, assume la qualità di vettore per il proprio tratto e la qualità di spedizioniere per gli altri tratti (mandatario senza rappresentanza).In caso di inadempimento di un vettore che effettua i tratti successivi, se il destinatario ha acquistato i diritti derivanti dal contratto (quando richiede la riconsegna) egli ha azione contro il vettore inadempiente. Mentre, se il caricatore è titolare dei diritti è lo spedizioniere che ha l’onere di agire contro il vettore inadempiente. In mancanza risponde verso il caricatore, in forza del mandato, per non aver tutelato il suo interesse.
2 – TRASPORTO con SUBTRASPORTO, mediante il quale il vettore assume nei confronti del caricatore l’obbligo di trasporto per l’intero percorso, curandone l’esecuzione mediante l’opera di vettori successivi (sub vettori) coi quali stipula IN NOME e PER CONTO PROPRIO i relativi contratti di trasporto.Quindi, il vettore risponde dell’intero percorso, potendo rivalersi sui sub vettori per i fatti accaduti nei tratti di loro pertinenza.Se il destinatario non ha acquistato i diritti derivanti dal contratto, il mittente ha azione contro il vettore principale, mentre contro i sub vettori può esperire solo l’azione extracontrattuale.
95

3 – TRASPORTO CUMULATIVOIn esso esiste un unico vincolo fra caricatore e tutti i vettori successivi, in quanto questi ultimi hanno assunto il trasporto con atto unitario.In questo caso, vi è la RESPONSABILITA’ SOLIDALE di tutti i vettori, salvo patto contrario.Tuttavia, il vettore chiamato a rispondere per un fatto di un altro vettore, può agire in regresso contro il vettore durante il cui percorso si è verificato il fatto dannoso.Se non è possibile stabilire in quale tratto si è verificato il danno, i vettori rispondono in proporzione dei propri percorsi (esclusi i vettori che dimostri che il danno non si è verificato nel proprio tratto).
Le 3 figure di trasporto con pluralità di vettori ricorrono anche nei trasporti c.d. combinati o multimodali, effettuati con veicoli a diverse modalità di trasporto (es. nave autoveicolo, nave-terno,…).In questi casi la giurisprudenza ritiene applicabili le norme sul trasporto in generale previste dal codice civile.
Per quanto riguarda il TRASPORTO AEREO, la Convenzione di Montreal prevede:- nel trasporto eseguito da vettori successivi il mittente può agire contri il primo vettore, mentre il destinatario contro l’ultimo vettore. Entrambi possono agire contro il vettore che abbia eseguito il percorso durante il quale si sia verificato il danno.- nel trasporto eseguito da un vettore diverso da quello contraente si applica la disciplina del trasporto di persone (paragrafo 312).
339. Caricazione e scaricazione Nel trasporto di cose determinate non sussistono le stallie di caricazione e scaricazione. Appena la nave è pronta a ricevere il carico, il caricatore deve presentare la merce per l’imbarco nei termini d’uso e la caricazione deve essere effettuata dal vettore nei termini d’uso. Decorso il termine per la consegna della merce , il comandante ha facoltà di partire senza attendere il carico, qualora aspetti il comandante ha diritto al pagamento del intero prezzo del trasporto. Anche nel trasporto di cose determinate può essere convenuta la clausola FIO , che attribuisce al caricatore ed al ricevitore rispettivamente l’effettuazione delle operazioni di caricazione e scaricazione, con i relativi spese e rischi. Detta clausola non esonera la responsabilità del vettore ma delimita i confini nella quale essa si configura ovvero dal momento che le merci sono caricate sulla nave fino alla loro scaricazione.
SBARCO D’UFFICIO Quando la nave o l’aeromobile siano giunti al luogo di destinazione e siano in condizioni di scaricare, se il destinatario è irreperibile o rifiuta di ricevere la merce , il vettore ha la facoltà di consegnarla ad un’impresa
96

di sbarco autorizzata , la quale diviene responsabile verso il destinatario come depositaria delle cose per il periodo successivo alla consegna.
Quando si presentino più destinatari o vi sia opposizione alla riconsegna si attua il deposito ( già precedentemente esaminato ).
La polizze di carico spesso contengono una clausola , mediante la quale , nel caso che il destinatario non si presenti a ritirare la merce , il vettore può sbarcare e depositare la merce e esonerandosi da responsabilità per danni al carico successivo alla scaricazione.
SBARCO D’AMMINISTRAZIONE FACOLTATIVO quando il destinatario è presente e la scaricazione
avviene a mezzo di impresa nell’interesse della nave per esigenze tecnico-economiche.
OBBLIGATORIO quando il destinatario è presente e la scaricazione avviene a mezzo di impresa per regolamento od ordine dell’autorità portuale nell’interesse pubblico di un maggior ordine di speditezza delle operazioni portuali.
Le spese relative sono a carico del vettore. L’impresa in questione assume le vesti di ausiliare del vettore ,ossia di un soggetto che il vettore si serve al fine di perfezionare i suoi obblighi di custodia e riconsegna , sicché il vettore sarà liberato soltanto quando il destinatario riceve la merce.
Viene assimilata a detta disciplina sopra dettata nell’ipotesi di trasporto aereo ,quando la consegna della merce avviene per opera dell’operatore di assistenza a terra. Anche in questo caso il vettore è responsabile fino alla consegna della cosa al destinatario.
Mancata riscossione del nolo o degli assegni. Il destinatario acquista i diritti derivanti dal contratto verso il vettore dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione (o anche scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare) ne richiede la riconsegna al vettore. Tale acquisto è soggetto a condizione che il destinatario paghi anticipatamente al vettore oltre i crediti derivanti dal trasporto, anche gli assegni che andranno eventualmente a gravare sulle cose trasportate. Qualora il vettore consegnasse la merce al destinatario e non riscuotesse i propri crediti, sarà responsabile verso il mittente dell’importo degli assegni dovuti allo stesso e non potrà rivolgersi a quest’ultimo per il pagamento dei propri cediti, salva l’azione verso il destinatario.
Obblighi del vettore.In primis l’obbligazione principale del vettore è quella di trasferire le cose da un luogo ad un altro, trasferimento che deve essere accompagnato
97

anche dalla custodia della cosa trasportata. Il tutto monitorato dalla responsabilità sia par la mancata esecuzione sia per il ritardo nel trasporto stesso; responsabilità che entra in gioco anche nell’ipotesi di perdita o avaria della cosa. Nell’ipotesi di inadempimento di tali obblighi, verranno applicate le norme previste dalla convenzione dell’Aia-Visiby in materia, a condizione che l’inadempimento abbia provocato danni configurabili come perdita o avaria della merce. Differentemente, il cod. nav. non contiene una specifica disciplina delle fattispecie nella parte marittima. Nell’ambito della custodia del carico, le regole stabiliscono che il vettore deve procedere, adeguatamente e con cura della caricazione, manutenzione, stivaggio, trasporto,custodia, cura e scaricazione della merce trasportata, sancendo che il vettore sarà responsabile in caso di inadempimento di tutti suddetti obblighi. Ovvio che il vettore è chiamato ad effettuare la sua prestazione con diligenza garantendo la messa in navigabilità della nave stessa, dunque sarà chiamato ad armarla, equipaggiarla e approvvigionarla in modo appropriato rendendo idonee le stive, le camere fredde e frigorifere e tutte le altre parti della nave destinate a ricevere la merce. Dunque la navigabilità concerne sia l’aspetto nautico sia quello commerciale, in sintesi la nave deve essere idonea sia alla navigabilità sia al trasporto.In ultimo, non per importanza, la responsabilità del vettore non è derogabile, cioè significa che risponderà anche per la mancata diligenza dei suoi ausiliari.
Fatti costitutivi della responsabilità del vettore marittimo. La responsabilità PRESUNTA del vettore marittimo è connessa all’esistenza del diritto del caricatore riguardo sia all’esecuzione della prestazione di trasferimento e sia al tempo impiegato oltre che all’obbligo di custodire le cose trasportate. Pertanto il caricatore in virtù di detti diritti non deve provare il danno ma soltanto l’inadempimento del trasporto o del ritardo attraverso il contratto di trasporto. Per determinare l’entità del danno , si calcola il prezzo corrente della merce nel luogo e nel tempo della riconsegna . Disciplina diversamente le regole dell’Aia-visby secondo cui il valore della merce è stabilito in base ai listini di borsa o secondo il loro valore usuale.
Fatti impeditivi della responsabilità del vettore marittimo.
Uno volta che l’interessato del carico abbia dato prova della responsabilità presunta del vettore ,quest’ultimo ha l’onere, per liberarsi da tale presunzione, di provare un fatto impeditivo della propria responsabilità . Secondo le regole dell’Aia il vettore non è responsabile dei danni derivati dallo stato di innavigabilità della nave , purché fornisca la prova di aver agito con diligenza.
98

Il vettore non è responsabile dei danni derivanti dai cd pericoli eccettuati previsti nelle Regole dell’Aia-Visiby. Dunque il vettore deve provare che il danno è stato causato da uno dei seguenti pericoli eccettuati: pericoli di mare; atto di Dio, questo concetto diciamo che è quasi identico al concetto di
forza maggiore; atti o colpe del comandante, di marinai, del pilota o dei preposti del
vettore nella navigazione o nell’amministrazione della nave la cosiddetta colpa nautica ;
incendio non provocato da fatto o colpa del vettore ; fatti di guerra; fatto di nemici pubblici; provvedimento di pubblica autorità o sequestro giudiziario; restrizione per quarantena; atto di omissione del caricatore o del
proprietario della merce o di un loro agente o rappresentante; scioperi, serrate, arresti o impedimenti frapposti al lavoro, per
qualsiasi causa, totale o parziale; rivolte o sommosse civili; salvataggio o tentativo di salvataggio di vite o beni in mare; calo di volume o di peso o altra perdita o danno derivante da vizio
occulto, natura speciale o vizio proprio della merce; insufficienza di imballaggio; insufficienza o imperfezione di marche; vizi occulti che sfuggono ad una ragionevole diligenza; ogni altra causa che non dipende da fatto o da colpa del vettore o dei
suoi sottoposti.Nell’ultimo punto esiste una ulteriore prova che è quella per cui il vettore ed i suoi ausiliari devono provare che il fatto non è stato provocato né da lui e né dai suoi ausiliari.
Il cod. nav. all’art. 422 stabilisce che il vettore deve provare che la causa del danno (o danni da ritardo, la causa del ritardo) non è stata determinata da colpa propria o da colpa commerciale dei propri ausiliari, dunque per fornire la prova della non imputabilità della causa del danno, il vettore dovrà, altresì, individuare la causa del danno. Qualora il vettore non riuscisse a provare il danno per colpa ovvero si avvalesse dei casi eccettuati sopra indicati , l’avente diritto alla riconsegna potrà comunque provare che la causa del danno o del ritardo è stata determinata da colpa del vettore o da colpa commerciale dei suoi ausiliari ( controprova ). Da ricordare è che il vettore assume i rischi dei danni derivati da una causa che rimanga ignota. I danni determinati per cause ignote ha particolare rilievo nei trasporti attraverso container, perché la causa dei danni alla merce in esso contenuta appuri all’arrivo non facilmente individuabili. il trasporto a condizioni FCL\FCL full container load , il container, riempito dal caricatore, è consegnato al vettore già chiuso e sigillato. La prova liberatoria del vettore consiste soltanto nel dimostrare l’integrità dei sigilli e l’assenza di manomissioni.
99

Sorgono dei dubbi però quando la polizza di carico descrive le merci in esso contenuti poiché la prova liberatoria potrà fatta valere solo se vi siano delle garanzie o delle riserve nella polizza di carico altrimenti la responsabilità ricade sul vettore.
Colpa nautica ed incendio.La colpa nautica dei dipendenti e preposti del vettore e l’incendio provocato dai dipendenti e preposti del vettore, sono due pericoli eccettuati che esonerano il vettore malgrado si tratti di fatti colposi.La colpa nautica non è definita nel cod. nav., nel quale viene solo distinta la cd “colpa commerciale”, colpa di cui il vettore risponde . La colpa commerciale rappresenta ogni colpa degli ausiliari del vettore non qualificabile come colpa nautica; dunque della colpa nautica risponde solo l’armatore (noleggiante) titolare dell’impresa di navigazione e della colpa commerciale solo il vettore, titolare dell’impresa di trasporto. Secondo che tipo di attività che si svolge, la nozione di colpa nautica si distingue in: colpa dans la navigation, la quale concerne comportamenti inerenti
all’attività nautica propriamente detta (errore di manovra, difetto di ancoraggio, inavvertenza dei segnali meteorologici, ecc);
colpa dans l’administration du navire, la quale concerne la manutenzione della nave con attenzione a quelle che sono le parti che attengono alla sua utilizzazione commerciale (stive, impianti di raffreddamento e congelamento, paranchi, ecc). Questo rientra nel concetto di colpa commerciale.
L’incendio, come pericolo eccettuato è controversa perché è qualificato dalla legge in base all’assenza di colpa del vettore: “incendio non provocato da colpa del vettore”. Il fatto impeditivi della responsabilità del vettore non è l’incendio, ma l’incendio non provocato da colpa del vettore, considerato come fatto dannoso esonerante. Spetta al vettore provare che il danno è stato causato da un pericolo eccettuato, lo dovrà provane nel suo insieme unitario, cioè l’incendio non provocato da propria colpa. Responsabilità extracontrattuale. Le regole dell’Aia –Visby hanno parificato le azioni contro il vettore sia sul piano contrattuale che extracontrattuale. L’azione extracontrattuale può essere proposta sia contro il vettore che contro l’armatore (il quale non deve essere anche vettore contraente, dunque noleggiante, subvettore, o vettore operativo). Le Regole all’art. 4 parifica la responsabilità dell’armatore e quella del vettore sotto ogni aspetto, quindi il vettore contraente ed armatore hanno lo stesso trattamento. Malgrado quello appena detto si può esperire tale azione anche contro l’armatore che non sia vettore, la quale produrrà, una volta esperita, gli stessi effetti dell’azione contrattuale. Le azioni contro i
100

dipendenti o mandatari del vettore, possono essere sottoposti all’azione extracontrattuale ma con le limitazioni e difese previste dalla Convenzione (salvo il caso nel quale abbiano tenuto un comportamento doloso o temerario e consapevole). Fra i contraenti indipendenti hanno particolare rilievo le imprese portuali, allorquando operino per conto del vettore; l’interessato al carico non ha azione contrattuale contro di loro, poiché le imprese intrattengono rapporti contrattuali sono con il vettore e non con il caricatore. Qualora il danno fosse provocato dall’impresa portuale, il caricatore potrà agire contrattualmente solo contro il vettore, il quale poi potrà rivalersi sull’impresa.Il caricatore può anche agire contro l’impresa portuale ma in via extracontrattuale. Mentre nel caso in cui l’impresa operi per conto dell’interessato al carico (soprattutto in presenza della clausola FIO) l’azione contro la stessa impresa è di tipo contrattuale (fondandosi però sul contratto di appalto).A tutela dei contraenti indipendenti vi è La clausola HIMALAYA è chiamata a tutela dei contraenti indipendenti, e quindi a tutti gli ausiliari del vettore, la cui clausola giustifica la sua disposizione con il fatto che il vettore agisce per conto di tali ausiliari in qualità di agente e per questo sono da ritenersi parti del contratto di trasporto.
Limitazione del debito del vettore marittimo.Il debito di risarcimento del vettore riconosciuto responsabile è sottoposto a limitazione per legge. Il cod. nav. fissa il limite a 103,29 euro per ciascuna unità di carico (la nave può essere caricata o in colli, alla rinfusa o in pezzi non imballati.)L’unità di carico consiste sia in colli che in cosa specifica individuata nella sua entità fisica (che può essere non rinchiusa in un imballaggio) . l’unità di carico può anche essere alla rinfusa (peso e volume) indicata nel documento di trasporto corrispondente che nella maggior parte dei casi è uguale all’unità di base alla quale è stato commisurato il nolo. Mentre la convenzione Aia-Visiby prevede un limite per collo o unità pari a 666,67 euro diritti speciali di prelievo o un altro limite di 2 diritti speciali di prelievo per kg di merce perduta o danneggiata. È prevista una particolare disciplina per i container, disciplina che considera collo o unità, indicato nella polizza di carico come contenuto nel container stesso, in mancanza di enumerazione sarà il container ad essere considerato come collo o unità.I limiti indicati non si applicano allorquando il caricatore dichiari, anteriormente all’imbarco, il maggior valore della merce. Le parti hanno la facoltà di derogare quanto stabilito dalla convenzione, manifestando entrambe le parti la loro volontà di derogarle, dunque potranno stabilire noli ad valorem proporzionali ai limiti di risarcimento maggiori di quelli previsti per legge. Beneficio che non entra in applicazione nel momento in cui sia provato che il danno è derivato da un atto o omissione del vettore compiuto o
101

con l’intenzione di provocare il danno (dolo) o temerariamente e con la coscienza che un danno ne sarebbe con probabilità derivato. La condotta temeraria e consapevole è più grave della cd “colpa grave”.
Responsabilità del vettore aereo per mancata esecuzione del trasporto e ritardo. In materia viene applicata la convenzione di Montreal.I danni da ritardo sono regolati dalla convenzione in modo identico per le persone, i bagagli e le merci. Il vettore è responsabile a meno che non provi che lui stesso ed i suoi dipendenti e preposti abbiano preso tutte le misure che si sarebbero potute ragionevolmente prendere per evitare il danno o che sarebbe stato per loro impossibile prenderle. La convenzione come per il trasporto di persone non si applica per i danni cagionati in caso di mancata esecuzione del trasporto, e nel traporto di cose è limitata. Il danno da ritardo della merce deve essere oggetto di reclamo entro 21 giorni dalla sua messa a disposizione. In mancanza di esso non può esservi alcuna responsabilità del vettore.
Responsabilità del vettore aereo per perdita o avaria delle cose.La convenzione di Montreal per i danni da perdita o da avaria della merce, prevedere regole decisamente severe verso il vettore. Esso è dichiarato responsabile per il solo fatto che l’evento che ha causato il danno si è prodotto nel periodo in cui la merce si trovava sotto la sua custodia. La custodia è intesa in senso giuridico perché strettamente connessa all’attività di consegna e di riconsegna. Il vettore può liberarsi dalla responsabilità solo provando che il danno sia derivato da uno dei quattro eventi seguenti:1. natura o vizio proprio della merce;2. difetto di imballaggio non effettuato dal vettore o dai suoi ausiliari;3. fatto di guerra o conflitto armato;4. atto di pubblica autorità inerente all’entrata, uscita o transito della
merce.È esonerato altresì allorquando provi che il danneggiato ha contribuito fortemente nella produzione del danno. Il vettore risponderà del danno alla merce anche in caso di negligenza nell’adempimento dell’obbligo di custodia, infatti garantendo la custodia esso garantisce, altresì, la riconsegna della merce nello stato in cui l’ha ricevuta. Il reclamo di danneggiamento della merce deve essere fatto dall’avente diritto entro 14 giorni dal suo ricevimento.
Limitazione del debito del vettore aereo.La convenzione di Montreal 1999 stabilisce 17 diritti speciali di prelievo per kg di merce perduta, danneggiata o giunta in ritardo. Il caricatore può evitare l’applicazione del limite, facendo al momento della riconsegna della merce al vettore, una dichiarazione speciale d’interesse alla riconsegna, indicando il valore effettivo delle cose trasportate. Questa dichiarazione è un atto unilaterale ed il vettore non può chiedere in cambio un supplemento di prezzo.
102

In caso di perdita o avaria della merce il limite non è superabile, salvo che sia stato provato il dolo del vettore, salva la possibilità di formulare la dichiarazione speciale d’interesse alla riconsegna. Solo nel caso di danni da ritardo l’interessato al carico può evitare l’applicazione del limite provando il dolo o la condotta temeraria e consapevole del vettore o dei suoi dipendenti o dei suoi preposti.
Derogabilità della normativa.Sia la responsabilità del vettore di cose sia il sistema della sua limitazione, è derogabile a favore del caricatore. Deroghe che sono ammesse solo laddove espressamente previste per legge. Nel trasporto marittimo sono ammesse le deroghe in favore del vettore non solo quando queste sono ammesse dalla disciplina internazionale uniforme, ma anche in tutti i casi in cui tale disciplina non riceve applicazione. Secondo il codice civile la deroga è ammessa nei seguenti casi: per periodi di tempo anteriore alla caricazione e posteriore alla
scaricazione, derogabilità che è ammessa anche allorquando si applicano le Regole;
nei trasporti di merce caricata sopra coperta e di animali vivi; nei trasporti nazionali; per i danni da ritardo; qualora non sia emessa una polizza di carico, né altro documento
negoziabili, ipotesi che riguarda soprattutto i charterparties, i quali contengono spesso clausole ampiamente esoneratici.
Per i trasporti in container sopra coperta, può essere effettuato solo previo consenso del caricatore, diversamente il vettore è responsabile in caso di danno alla merce; il consenso rende adempiente il vettore per il tipo di caricazione, ma non ne esclude la responsabilità per altri fatti. A questa responsabilità, si applicano le Regole nel momento in cui la dichiarazione sopra coperta non sia dichiarata nel contratto. Il codice civile all’art. 1229 sancisce la nullità di ogni patto che escluda o limiti preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave, ma ammette le clausole di esonero al debitore per i fatti dolosi o colposi dei suoi ausiliari. Saranno, altresì, nulli qualsiasi patto che esoneri il debitore ed i suoi ausiliari, patti che contravverrebbero agli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico. In fine da ricordare che le clausole sono assoggettate al controllo di vessatorietà (previsto dal codice del consumo, ovviamente allorquando il caricatore possa essere qualificato come consumatore).
La documentazione del trasporto di cose. Formazione ed emissione.
103

Il documento del trasporto di carico è il cd charterparties. La documentazione del contratto di trasporto di cose determinate è prevista dagli artt. 457 e 458 del cod. nav.
Art. 457 - Dichiarazione d'imbarco1. Il caricatore presenta al vettore una dichiarazione d'imbarco, nella quale sonoindicati la natura, la qualità e quantità delle cose da trasportare, nonchè il numerodei colli e le marche che li contrassegnano.2. Il caricatore è responsabile verso il vettore dei danni che possono a questoderivare da omissioni o inesattezze nelle indicazioni contenute nella dichiarazioned'imbarco.Art. 458 - Documenti rilasciati dal vettore all'assunzione del trasporto, alla consegnae all'imbarco delle merci1. Assunto il trasporto, il vettore, o in suo luogo il raccomandatario, è tenuto arilasciare al caricatore un ordinativo d'imbarco per le merci da trasportare, ovveroall'atto della consegna, quando sia stato convenuto, una polizza ricevuto perl'imbarco.2. Dopo l'imbarco, ed entro ventiquattr'ore dallo stesso, il comandante della nave ètenuto a rilasciare al caricatore una ricevuta di bordo per le merci imbarcate, a menoche gli rilasci direttamente, in nome del vettore, la polizza di carico.3. Qualora non vi abbia provveduto il comandante della nave, il vettore o in suoluogo il raccomandatario, su presentazione della ricevuta di bordo, è tenuto arilasciare la polizza di carico, ovvero ad apporre la menzione dell'avvenuto imbarco,con le indicazioni di cui alle lettere g) ed h) dell'articolo 460, sulla polizza ricevutoper l'imbarco precedentemente rilasciata.
Come proposta contrattuale il caricatore presenta al vettore la cd “dichiarazione di imbarco”, nella quale vengono indicate la natura, la qualità, e la quantità delle cose trasportate, il numero dei colli e le marche che li contrassegnano. Il caricatore è responsabile verso il vettore dei danni che a questo possono derivare (infrazioni doganali, ecc) da omissioni o inesattezze nelle indicazioni contenute nella dichiarazione di imbarco.Formato il consenso e si conclude il contratto di trasporto, il vettore o il suo raccomandatario, è tenuto a rilasciare un cd “ordinativo d’imbarco” per la merce da trasportare o, all’atto della consegna della merce allorquando sia stato convenuto, è tenuto a rilasciare la polizza ricevuto per l’imbarco, che fa prova dell’avvenuta riconsegna della merce al vettore. Dopo l’imbarco, il comandante della nave è tenuto a rilasciare al caricatore una ricevuta di bordo per la merce imbarcata; questa ricevuta e la polizza di carico provano anche l’avvenuta caricazione. La polizza ricevuta per l’imbarco e la polizza di carico sono emesse in due originali. L’originale rilasciato al caricatore è titolo rappresentativo della merce.
Nel trasporto aereo, secondo la convenzione di Montreal del 1999, è emessa in tre originali una lettera di trasporto aereo. Rispettivamente le 3 lettere originali vanno al vettore , al destinatario e al mittente.
104

Natura giuridica della polizza di carico.La polizza di carico è disciplinata dal codice della navigazione, essa prova l’avvenuta caricazione e l’entità e le caratteristiche del carico in essa descritti. La polizza ha una duplice funzione: documento probatorio; titolo di credito rappresentativo della merce.Essa integra i termini del contratto, soprattutto specificando le caratteristiche del carico e attestando l’avvenuta caricazione, nel caso di discordanza fra le clausole charterparties e clausole della polizza, sono le prime a prevalere. La polizza è valida solo fra caricatore e vettore (non opera nei confronti del terzo destinatario); In quanto titolo di credito rappresentativo la polizza di carico è costitutiva di un diritto cartolare ed attribuisce al suo possessore:1. il diritto alla riconsegna della merce;2. il possesso della stessa;3. il diritto di disporne attraverso disposizione del titolo.
In quanto titolo di credito, la polizza è disciplinata dal codice civile , pertanto la legittimazione alla riconsegna della merce si acquista in base alle forme di circolazione del titolo e il vettore riconsegni la merce al possessore del titolo. Il vettore può opporre al terzo possessore del titolo soltanto le eccezioni personali, di forma, ovvero quelle sul contesto letterale del titolo da cui deriva la falsità della propria firma , difetto di capacità o rappresentanza.Il carattere della letteralità impedisce al vettore di eccepire fatti che non risultano dal contesto letterale del titolo.Il carattere di autonomia preclude al vettore l’opponibilità di eccezioni relative ai vizi del rapporto sottostante o a fatti o rapporti personali ai precedenti possessori del titolo. Il carattere di causalità emerge dalla circostanza che essa non solo incorpora la sua causa ,in quanto contiene le clausole del contratto di trasporto .In quanto titolo rappresentativo, la polizza di carico attribuisce al suo possessore il possesso della merce in essa indicata, possesso che può essere trasferito ad altri mediante trasferimento del titolo.
Natura giuridica della lettera di trasporto aereo.La lettera di trasporto aereo è sempre emessa non negoziabile, essa e la ricevuta del carico non sono titoli di credito, ma semplici documenti probatori ed il destinatario acquista il diritto alla riconsegna quando, all’arrivo della merce a destinazione, ne richiede la riconsegna al vettore. Fino a prima del momento di ricezione il mittente ha diritto di contrordine , disponendo della merce sia ritirandola presso l’aeroporto di partenza o destinazione , sia facendola riconsegnare a persona diversa dal destinatario indicato nel documento, sia chiedendone il ritorno all’aeroporto di partenza. L’esercizio di suddetto diritto è condizionato
105

alla presentazione al vettore del documento originale rilasciato al mittente stesso.
Circolazione.La copia originale della polizza di carico, costituente il titolo di credito, può essere: al portatore ; in questo caso è trasferita con la consegna del titolo. Il
possessore del titolo è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo stesso;
all’ordine ; in questo caso il trasferimento avviene attraverso girata, scritta sul titolo e sottoscritta dal girante (è valida anche se non contiene il titolo del giratario). La girata al portatore vale come la girata in bianco, e la girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo. La polizza all’ordine può essere girata “per procura”, “per sbarco” o “per l’incasso”, allo scopo di consentire al giratario (solitamente è lo spedizioniere), di ritirare la merce quale mandatario del girante. Il giratario acquista tutti i diritti inerenti al titolo, ma non può girarlo se non per procura. La polizza all’ordine può essere girata anche “per garanzia” costituendo un pegno sul quale ci si potrà rifare in caso di inadempimento;
nominativo ; in questo caso il trasferimento si concretizza attraverso l’annotazione del nome dell’acquirente sul titolo o con il rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare, o attraverso girata autenticata da un notaio o da un agente di cambio. La girata della polizza nominativa può essere fatta “in garanzia” o una simile, con il fine di costituire in pegno il titolo. Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura.
Legittimazione alla riconsegna.il possessore dell’originale polizza di carico trasferibile è legittimato all’esercizio del diritto, in base alla presentazione del titolo stesso o in base ad una serie continua di girate o per effetto dell’intestazione a suo favore. Il diritto alla riconsegna comprende, altresì, di agire contro il vettore per ottenere il risarcimento dei danni in caso di perdita o avaria della merce. Il vettore prima di procedere alla riconsegna ha l’obbligo di identificare il possessore dello stesso titolo. Il vettore che adempie alla prestazione è liberato anche se il possessore del titolo non sia il titolare del diritto. Il possessore del titolo che riceve la merce deve restituire al vettore il titolo. Può accadere che il ricevitore al momento dell’arrivo della merce non abbia ancora la polizza di carico, in tal caso egli potrà lasciare al vettore una lettera di garanzia munita di fideiussione bancaria con la quale lo ritiene indenne dai danni che
106

potrebbero derivargli dall’aver consegnato la merce a persona non munita di titolo.
Indicazioni.La polizza ricevuto per l’imbarco e la polizza di carico devono essere datate e sottoscritte da chi le rilascia.La polizza ricevuto per l’imbarco e la polizza di carico devono indicare: il nome ed il domicilio del vettore; il nome ed il domicilio del caricatore; il luogo di destinazione, qualora la polizza fosse nominativa, anche il
nome ed il domicilio del destinatario; la natura, la qualità e la quantità delle cose trasportate, ed anche il
numero dei colli e le marche che li contrassegnano; lo stato apparente della merce o degli imballaggi; il luogo e la data di consegna.Inoltre la polizza di carico deve contenere altre indicazioni:1. il nome o il numero, l’ufficio di iscrizione e la nazionalità della nave;2. il luogo della data di caricazione.
Le Regole dall’Aia-visiby richiedono che siano indicati anche: le marche di contrassegno; il numero dei colli e dei pezzi o la quantità o il peso, secondo i casi; lo stato ed il condizionamento apparente della merce.
La convenzione di Montreal del 1999 prevede che la lettera di trasporto aereo o la ricevuta del carico devono contenere: i luoghi di partenza e di destinazione; se questi luoghi si trovano nel medesimo Stato contraente, almeno un
altro scalo previsto nel territorio di un altro Stato; il peso della merce.
Le parti hanno facoltà di inserire nei titoli altre indicazioni, oltre a quelle previste per legge.
Identificazione del vettore.
Molto spesso nella polizza di carico non compare il nome del vettore in quanto essa è sottoscritta dal comandante o dal raccomandatario. Tale ipotesi è possibile nel momento in cui è possibile individuare il vettore grazie ad altri documenti sottostanti alla polizza di carico. Quando però il titolo rappresentativo è posseduto da un terzo, l’identificazione del vettore si deve evincere unicamente dal titolo stesso, altrimenti in virtù delle indicazioni riportate sulla polizza di carico relative al nome della nave si può risalire al comandante e all’armatore.
Valore delle indicazioni relative alla merce.
107

Nella polizza di carico sono inserite le caratteristiche della merce e degli imballaggi su indicazione del caricatore ed il vettore le fa proprie sottoscrivendo la polizza stessa. Poiché il vettore è obbligato a riconsegnare la stessa merce descritta nella polizza e nelle stesse condizioni ,è suo onere verificare , all’atto della presa in consegna o dell’imbarco , l’esattezza delle indicazioni presenti nel titolo . Qualora, dopo una verifica alle condizioni della merce si dovessero riscontrare delle difformità fra le condizioni reali della merce e quelle indicate nella polizza, il vettore può far scaricare la merce o annotare nel titolo le effettive condizioni della merce o degli imballaggi da lui verificate, attraverso l’apposizione di riserve specifiche, col la loro presenza la polizza di dice che “non è netta”. Nei trasporti aerei la convenzione di Montreal dispone una distinzione fra le indicazioni presenti nella lettera di trasporto aereo. Infatti occorre distinguere fra indicazioni facilmente verificabili ( numero, peso, dimensioni dei colli, stato degli imballaggi e stato apparente della merce) che fanno fede fino a prova contraria , da altre indicazioni meno facilmente controllabili ( natura, qualità, quantità, volume, e stato della merce) le quali non fanno prova contro il vettore a meno che non siano da lui verificate .
Riserve generiche.Esistono casi in cui il vettore marittimo (o chi per suo conto) si trova nella ragionevole impossibilità di eseguire la verifica di tutte o di parte delle indicazioni inerenti alle merci ed imballaggi forniti dal caricatore. In tale situazione il vettore ha la facoltà di non menzionare nella polizza di carico il dato non verificabile oppure può menzionarlo inserendo riserve generiche. Tipici esempi di riserve generiche sono: “dice essere”, “ignoro peso” e “dice contenere”. In relazione alle concrete condizioni delle merci e alle modalità e mezzi tecnici con cui si svolgono le operazioni d’imbarco è possibile assoggettare le riserve generiche.Infatti non sono valide le riserve che si riferiscono allo stato apparente degli imballaggi (poiché sempre controllabile) né sono valide quelle riserve prestampate sul documento perché la loro apposizione prescinde dall’impossibilità del controllo. Pertanto al vettore resta fermo il suo obbligo di adempimento al trasporto ma si esclude , limita il valore del carico nei confronti dell’interessato al carico, quindi l’inserimento delle riserve incide soprattutto sul regime della responsabilità del vettore.In definitiva le riserve rendono più difficile, a vantaggio però del vettore, la prova dell’esistenza e dell’entità del danno.
La lettere di garanzia.Il caricatore può indurre il vettore ad emettere una polizza netta (cioè senza riserve), rilasciandogli in cambio una lettere di garanzia , mediante la quale si impegna a tenerlo indenne dalle conseguenze di eventuali
108

reclami o pregiudizi che esso vettore debba subire per il fatto che la merce non sia conforme a quanto indicato nella polizza.Questa lettera di garanzia non è opponibile a terzi, ma genera solo un’obbligazione di garanzia fra il vettore e caricatore. Sarà nulla per illiceità di causa o del motivo della lettera di garanzia emessa nella comune consapevolezza dell’inesattezza delle indicazioni di polizza.
Ordini di consegna.Gli ordini di consegna propri sono titoli rappresentativi mediante i quali il vettore o il raccomandatario, una volta emessa la polizza di carico, da ordine al comandante della nave di consegnare al possessore dell’ordine di consegna la merce in esso specificata, costituente singole partite della merce rappresentata dalla polizza.L’emissione del titolo è obbligatoria, allorquando è convenuto nel contratto di trasporto. Una volta emesso l’ordine di consegna, il vettore indicherà sull’originale trasferibile della polizza, l’indicazione circa la natura, la qualità e quantità della merce specificata in ciascun ordine con l’apposizione della propria firma. Essendo gli ordini di consegna titoli rappresentativi della merce, possono essere: all’ordine, nominativi ed al portatore; tali titolo attribuiscono al legittimo proprietario il diritto alla consegna della merce che vie è specificata, il possesso della stessa merce ed il diritto di disporne mediante disposizione del titolo. Gli ordini di consegna sono disciplinati secondo le norme che disciplinano la polizza di carico. Esistono anche ordini di consegna “impropri”, essi sono emessi dal possessore della polizza di carico direttamente sul comandante o sul raccomandatario e non recano la firma del vettore o del suo rappresentante. Il possessore della polizza non perde la disponibilità della merce, ed ha quindi la possibilità di modificare la designazione della persona indicata nell’ordine di consegna improprio. L’ordine di consegna improprio non è un titolo rappresentativo della merce ma è atto a designare la persona alla quale deve essere eseguita la prestazione, cioè la consegna della merce.
Lettera di trasporto marittimo (Sea waybills).
Nei traffici marittimi è prevista, in diversi casi, l’emissione di un titolo di credito rappresentativo, esempio: quando la merce è venduta in corso di viaggio; quando la merce è oggetto di una vendita su documenti; quando il prezzo della merce è anticipato da una banca; in caso di finanziamento garantito da pegno sulla merce imbarcata.
109

In altri casi, allorquando mittente e destinatario si identificano o si tratti di società collegate, si usa emettere documenti (al posto della polizza di carico si emette una lettera di trasporto marittimo) chiamati sea waybills, documenti che contengono sempre il nome del destinatario e sono espressamente dichiarati non negoziabili.Non sono titoli di credito e non legittimano il destinatario alla riconsegna (quest’ultimo non ha la disponibilità del documento, il quale è consegnato dal vettore solo all’atto della riconsegna della merce). I sea waybills hanno solo efficacia probatoria ed il destinatario indicato nel documento acquista il diritto alla riconsegna in base a quanto stabilito nel codice civile all’art. 1689, cioè solo quando, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, ne chiede la riconsegna al vettore. Il mittente conserva il diritto di contrordine, dal quale deriva la disponibilità delle cose trasportate, finché è in possesso del documento di trasporto. Nel trasporto marittimo oltre agli strumenti del sea waybills, sono stati sperimentati altri sistemi come ad esempio l’emissione del documento a destinazione, con comunicazione elettronica o telefax, e così via.
CAPITOLO XV IL CONTRATTO DI RIMORCHIO E PILOTAGGIO
Contratto di pilotaggioIl contratto di pilotaggio che si conclude fra l’armatore della nave, rappresentato dal comandante, e la corporazione di piloti (o in mancanza pilota locale) è un contratto in base al quale, verso corrispettivo, il pilota si obbliga a suggerire la rotta e assistere il comandante nell’ esecuzione delle manovre necessarie per eseguirla. E’ paragonato questo contratto a quello di arruolamento grazie all’ inserimento del pilota nell’ equipaggio in veste di primo ufficiale. Dal momento che manca un vincolo di subordinazione tra pilota e armatore (essenziale nel rapporto di arruolamento)possiamo inquadrare il contratto di pilotaggio nella categoria del contratto d’ opera. La corporazione dei piloti è obbligata a contrarre e si trova in condizioni di permanente offerta al pubblico. Il contratto si perfeziona nel momento in cui il pilota di turno percepisce il segnale di chiamata, con il quale il comandante esprime la sua dichiarazione di accettazione dei servizi della corporazione ;inoltre l’ avviso che la nave deve dare alla nave da pilotare non costituisce accettazione ma conferma dell’ inizio dell0 esecuzione del contratto. La situazione non cambia quando la chiamata del pilota non è fatta dal comandante ma dal raccomandatario. Ricordiamo che il pilota esercita una semplice attività d’ assistenza tecnica fornendo al comandante le indicazioni relative alla rotta e la manovra anche se la determinazione della prima e l’ attuazione delle manovre necessarie per eseguirla competono al comandante. Nell‘ipotesi di danni causati alla nave da manovra errata è responsabile il comandante che è tenuto a dirigere personalmente la manovra anche se è assistito da un pilota. Il
110

comandante può liberarsi dalla responsabilità solo se dimostra che l’ errore di manovra e derivato da inesatte informazione date dal pilota. Di conseguenza la responsabilità cade su quest’ ultimo. L’ inadempimento del pilota non si presume ma deve essere dimostrato, per cui la responsabilità del pilota assume carattere assoluto e non ammette prova liberatoria(nei casi in cui l’inadempimento contrattuale non produca danni alla nave pilotata il pilota è soggetto ai principi comuni).La corporazione dei piloti risponde invece solitamente con il pilota dei danni di cui quest’ultimo è responsabile derivati da inadempimento contrattuale ed extra contrattuale dei danni verso terzi provocati dalla nave pilotata risponde l’ armatore salvo l’ ipotesi d’ inadempimento del pilota.
Contratto di rimorchioRimorchio è l ‘operazione che determina lo spostamento per acqua di una nave, di un galleggiante o altro mobile mediante spinta da parte di un’ altra nave, comprendente ogni operazione volta a rallentare o arrestare il movimento degli elementi rimorchiati. Il cod. navigazione art.101- 106 prevede il rimorchio per via acqua applicando le seguenti norme per analogia anche al rimorchio per via d’ aria mentre non sono applicabili nel caso in cui il rimorchiatore agisca per terra. Si opera una distinzione fra rimorchio portuale e d’ altura a seconda se le operazioni si svolgano o meno in ambito portuale. Il primo si differenzia dal secondo in quanto realizza pubblici interessi, essendo influenzato quindi da interventi pubblici che caratterizzano il servizio .Questa distinzione corrisponde a quella adottata dalla dottrina tra rimorchio manovra e trasporto. L’ elemento distintivo è dato dalla consegna degli elementi rimorchiati all’ armatore del rimorchiatore presente in quello di trasporto e non in quello di manovra. Questa differenza comporta il fatto che l’ armatore del rimorchiatore assume obblighi supplementari, ulteriori rispetto a quelli previsti per il rimorchio senza consegna. Il contratto di rimorchio è considerato una sottospecie del contratto d’ appalto, configurazione messa in dubbio per il fatto che il rimorchiatore non garantisce un risultato di lavoro ma semplicemente compie delle attività necessarie al suo conseguimento. La responsabilità del contratto di rimorchio è fondata su una presunzione reciproca( art.104.) L’armatore del rimorchiatore è responsabile dei danni sofferti dagli elementi rimorchiati e l’ armatore degli elementi rimorchiati è responsabile dei danni sofferti dal rimorchiatore a meno che’ si dimostri che i danni non derivino da cause a se imputabili. Nell’ ipotesi di rimorchio trasporto, cioè quando è fatta consegna degli elementi rimorchiati all’ armatore del rimorchiatore, gli obblighi e le responsabilità delle parti sono disciplinate non solo dall’ art.104 ma anche da disposizioni sul contratto di trasporto marittimo di cose. Per i danni sofferti dai terzi durante il rimorchio invece sono solitamente responsabili gli armatori degli elementi rimorchiati e l’ armatore del rimorchiatore, i quali possono esonerarsi da questa responsabilità provando che i danni non derivino da cause a loro
111

imputabili. Il rimorchiatore, che durante l’ esecuzione di un contratto di rimorchio, al fine di assistere o salvare la nave rimorchiata, presta un’ opera eccedente a quella normale di rimorchio, ha diritto al compenso stabilito per assistenza e salvataggio. Diverso è il caso in cui questa prestazione si effettui quando il contratto non sia in fase di esecuzione ma è stato concluso durante la fase di pericolo.
La responsabilità per l’urto di navi ed aeromobili.
Il codice della navigazione prende in considerazione: Urto di navi; Urto fra aeromobili; Urto misto.Le disposizione codicistiche regolano solamente i rapporti extracontrattuali e non si applicano, di conseguenza, ai rapporti di responsabilità che in seguito all’urto intercorrono fra soggetti vincolati da contratto di lavoro, di trasporto o da altro contratto, e non si applica, altresì, alle unità da diporto che sono sottoposte alla normativa del codice civile. Dunque la disciplina speciale si occupa di:1. urto fra navi, galleggianti ed aeromobili in movimento ma non si
applica ad una nave o aeromobile in movimento con un oggetto considerato fermo, cioè non in movimento (per movimento si intende dall’inizio delle manovre fino all’approdo).
La normativa speciale distingue anche altri tre tipi di urto:1. urto fortuito; se ciò è avvenuto per causa di forza maggiore e per
caso fortuito, i danni restano a carico di coloro che li hanno sofferti;2. urto per colpa unilaterale; il risarcimento è a carico del veicolo in
colpa ed essendo una responsabilità extracontrattuale l’onere della prova della colpa incombe al danneggiato;
3. urto per colpa comune; se la colpa è di più veicoli, ciascuno di essi risponde della propria colpa e dell’ammontare delle relative conseguenze.
Queste fattispecie sono completate da due tipi di presunzione: PRESUNZIONE DELLA NON IMPUTABILITA’ DELLA CAUSA, si parifica
l’urto per causa dubbia all’urto fortuito, e dunque si stabilisce che i
112

danni restano a carico di coloro che li hanno sofferti anche quando non è possibile accertare al causa dell’urto;
PRESUNZIONE DI UGUAGLIANZA DELLA COLPA, in caso di colpa comune a più veicoli, laddove non fosse possibile individuare la proporzionalità della gravità della colpa e l’entità delle relative conseguenze, i danni derivati dall’urto sono a carico dei veicoli in colpa in parti uguali.
Nella fattispecie di urto causato da colpa comune, la responsabilità verso i terzi dei veicoli in colpa è solidale soltanto per i danni derivanti da morte o da lesioni personali.I criteri di risarcimento sono stabiliti nella loro procedura dalla Convenzione di Lisbona del 1987. Circa la limitazione del debito nell’urto fra aeromobili e nell’urto misto è previsto uno speciale sistema nella limitazione del debito dell’esercente ritenuto responsabile; il regime di limitazione è quello previsto per la limitazione dei danni a terzi sulla superficie. Circa i danni a terzi sulla superficie in seguito ad urto fra aeromobili, nei confronti dei terzi danneggiati rispondono in solido gli esercenti degli aeromobili che si sono urtati vicendevolmente. La PRESCRIZIONE.Il diritto al risarcimento dei danni causati da urto (navi, aeromobili o misto) si prescrive in due anni dal giorno in cui il danno si è prodotto.Il diritto di rivalsa spettante al responsabile solidale (dunque uno dei veicoli coinvolti nella colpa comune dei danni derivanti da lesioni o morte) che abbia pagato l’intero risarcimento, può esperire l’azione con il decorso di un anno dal giorno del pagamento in toto del risarcimento. L’azione di regresso spettante all’aeromobile che abbia pagato l’intero risarcimento dovuto in solido dagli aeromobili, si prescrive con il decorso di un anno dal giorno del pagamento al danneggiato.
ASSISTENZA A SALVATAGGIOIl soccorso si concreta in presenza di una situazione di pericolo, tale soccorso è prestato a cose o persone o in ambiente acqueo (soccorso marittimo) o in ambiente aeromobile (soccorso aeronautico).La disciplina trova la fonte nelle convenzioni di Bruxelles del 1910 e 1938, le quali sono state completamente assorbite dal codice della navigazione. Oggi la Convenzione di Londra del 1989 si applica ad ogni ipotesi di soccorso in mare o in altre acque, effettuato con o senza mezzi nautici. La disciplina del cod. nav. concerne qualsiasi prestazione di soccorso compiuta da una nave o da un aeromobile o di cose o di persone che si trovano in una situazione di pericolo. Dunque i presupposti erano nella natura del soggetto che prestava il soccorso (nave o aereo) e la situazione (stato di pericolo). Con l’entrata in vigore della convenzione di Londra, tali presupposti sono validi solo per il soccorso aeronautico. Infatti oggi è irrilevante chi presta il soccorso ma è irrilevante anche il soggetto che lo presta, visto che le norme della convenzione si applicano anche al soccorso prestato senza mezzi nautici, e la stessa conv.
113

comprende anche il soccorso prestato da aeromobile, purché in ambiente acqueo. Dall’istituto del soccorso rimane escluso il soccorso prestato senza mezzi nautici in ambiente diverso da quello acqueo. Stato di pericolo. Il soggetto che riceve il soccorso deve trovarsi “in pericolo di perdersi”e tale pericolo deve sussistere nel momento in cui è prestato il soccorso. Nell’ambito della discriminazione del “ricupero” la prestazione del soccorso ha come peculiarità quello di essere finalizzata a scongiurare un pericolo in atto, mentre il ricupero ha lo scopo di mirare ad annullare le conseguenze dannose già verificatesi del pericolo. Assistenza e salvataggio. Oggi per quanto concerne il soccorso marittimo il soccorso comprende sia l’assistenza che il salvataggio; nel soccorso aeronautico il soccorso è distinto in: assistenza e salvataggio. Esistono diverse tipologie di posizioni giuridiche di assistenza e salvataggio:Assistenza e salvataggio obbligatori: generalmente allorquando sussiste un pericolo per le vite umane, l’opera di soccorso è obbligatoria. Tale obbligo trova la sua origine o da un’autorità amministrativa o nella legge. Nell’ipotesi di autorità amm. I diritti del soccorritore sono determinati e ripartiti secondo quanto stabilisce la Conv. di Londra e dal cod. nav., nell’ipotesi della legge l’obbligo è a carico del Comandante con espressa esclusione dell’armatore, soccorso che è dovuto ad ogni persona che si trova in pericolo di perdersi in mare, o in caso di urto fra navi il comandate di ciascuna di esse è tenuto a prestare soccorso alle altre, al loro equipaggio ed ai loro passeggeri. Nel soccorso aeronautico, l’obbligo di soccorso è stabilito in diversi casi, ad esempio un aeromobile caduto o atterrato in mezzo al deserto e vi siano persone a bordo; a favore di persone che siano in pericolo di perdersi a causa dell’atterraggio dell’aereo in zone desertiche; in caso di urto fra aeromobili che sono entrati in collisione da parte dei rispettivi comandanti.IMPl’obbligo è subordinato alla possibilità di prestare soccorso senza grave rischio della nave o dell’aeromobile che lo presta, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri.Assistenza e salvataggio contrattuali: senza obbligatorietà di legge o di autorità amministrativa, il soccorso può essere convenuto contrattualmente. Il contratto di soccorso prevede che il soccorritore si obbliga all’esecuzione di un complesso di atti diretti al conseguimento di quel determinato risultato utile, nel quale va determinato l’adempimento (esso è un contratto d’opera). Tale contratto può essere concluso o al di fuori dell’ambite dove deve essere prestato materialmente il soccorso o nell’ambiente stesso; soccorso che è concretato dal comandante della nave o dell’aeromobile.Assistenza e salvataggio spontaneo: si profila questa ipotesi di assistenza allorquando essa non è né obbligatoria né contrattuale. Ad esempio è il caso in cui il soccorso prestato contro la volontà del comandante della nave o dell’aeromobile che l’abbia ricevuto (questa ipotesi si identifica meglio con la gestione del negozio).
114

EFFETTI GIURIDICI. La convenzione di Londra trova applicazione con riferimento agli aspetti non regolati dagli accordi delle parti (art. 6). L.O.F., Lloyd’s Standard Form of Salvage Agreement, è un formulario (l’ultima edizione risale al 2000) contrattuale utilizzato nella prassi che contiene una disciplina modella sulla Convenzione di Londra e che, poiché tale contratto viene concluso mentre è in corso la situazione di pericolo, la Convenzione di Londra sancisce che può essere annullato o modificato quando: è stato concluso sotto influenza indebita o sotto influenza del pericolo
ed in suoi termini sono iniqui quanto l’importo è eccessivamente troppo alto o troppo basso.Il soccorritore ha diritto al compenso solo in caso di successo delle operazioni. Obblighi legali nell’assistenza e salvataggio di cose.Nel soccorso marittimo il soccorritore ha i seguenti obblighi:- eseguire le operazioni di soccorso con diligenza;- sollecitare l’assistenza di altri soccorritori ove necessario;- accettare l’assistenza di altri soccorritori;- cercare di non danneggiare l’ambiente.Anche i soggetti che ricevono il soccorso hanno degli obblighi da rispettare: cooperare pienamente con il soccorritore; esercitare la dovuta diligenza per agevolare le operazioni di soccorso;
ecc.Al soccorritore spetta un compenso, subordinato alla riuscita delle operazioni; per il compenso vanno presi in considerazione diversi elementi:a) il valore della nave e degli altri beni salvati;b) la misura del successo ottenuto e l’abilità e gli sforzi profusi;c) il tempo trascorso e la prontezza ed i servizi resi;d) i rischi corsi dal soccorritore e dalle sue attrezzature; ecc.Il compenso non può superare il valore dei beni salvati, tranne il caso di pericolo per l’ambiente ove si avrà il diritto a ricevere dal proprietario una safety net (special compensation o speciale indennità) corrispondente a tali spese, eventualmente aumentato del 30% o 100% mediante l’intervento dell’Autorità Giudiziaria ove abbia prevenuto o minimizzato il danno all’ambiente.Nel soccorso aeronautico gli obblighi del soccorritore sono praticamente i medesimi. Una vera differenza tra le due tipologie è il risarcimento dei danni subiti ad al rimborso delle spese che prescinde dal risultato conseguito. Ovviamente anche in questa tipologia di soccorso il compenso è commisurato ad una serie di elementi, pressoché come per il soccorso marittimo di cose. Nel soccorso spontaneo prestato a cose (marittimo o aeronautico) ogni diritto viene meno allorquando il soccorso sia stato effettuato nonostante il rifiuto espresso e ragionevole del comandante o del proprietario delle cose in pericolo.
115

Obblighi legali nell’assistenza e nel salvataggio di persone.Nel soccorso di persone (vale sempre il principio della gratuità) i diritti del soccorritore variano a seconda della situazione giuridica che fa capo al soggetto passivo.a) se le operazioni di soccorso sono coperte da assicurazione, il
soccorritore ha diritto a ricevere dall’assicuratore, nei limiti della copertura assicurativa ed in caso di risultato utile, un compenso determinato in relazione ai rischi corsi, agli sforzi operati ed al tempo impiegato. Nel soccorso aeronautico il soccorritore ha diritto, altresì, al risarcimento dei danni subiti ed alle spese sostenute;
b) qualora tali operazioni non fossero coperte da assicurazione e le operazioni di soccorso di persone è stato effettuato in occasione di operazioni di soccorso a navi o aeromobili o cose, il soccorritore ha diritto solo ad un compenso;
c) negli altri casi il soccorritore non ha alcun diritto.Il compenso per il soccorso deve essere ripartito tra: armatore, 1/3, ma può essere incrementata non oltre la metà del
compenso dovuto equipaggio, 2/3.Circa la prescrizione, i diritti del soccorritore si prescrivono in 2 anni dal giorni in cui le operazioni di soccorso sono terminate.
IL RICUPERO ED IL RITROVAMENTO DI RELITTIIl ricupero ha per oggetto relitti di nave o di aeromobile naufragati o altri relitti della navigazione. L’elemento che discrimina il ricupero dal soccorso consiste proprio nell’assenza del pericolo nel momento in cui le operazioni sono svolte, cioè il ricupero è finalizzato ad annullare, per quanto possibile, le conseguenze dannose prodotte dal pericolo già verificatosi. Esso può essere effettuato direttamente dal proprietario o da un altro soggetto (in questo caso il ricuperatore può operare o per contratto o agire per iniziativa spontanea).Riepilogando, si può avere: ricupero contrattuale; ricupero spontaneo ricupero d’ufficio dell’autorità marittima; ricupero di nave estera compiuto nelle acque italiane dall’autorità
consolare dello Stato battente bandiera. Ricupero marittimo e aereo.Tipologie che si distinguono, nel caso del ricupero marittimo questo avviene operando in mare o altre acque (con o senza mezzi nautici), mentre il ricupero aeronautico avviene in terraferma ad opera di aeromobile. Ricupero privato.Esso prevede tre fattispecie:1. ricupero effettuato dal proprietario: in questa ipotesi il proprietario del
relitto ha diritto di provvedere al ricupero direttamente (o tramite un ricuperatore da lui designato), tranne il caso in cui subito dopo il
116

verificarsi del naufragio, il comandante si costituisca immediatamente capo ricuperatore. L’autorità marittima può assumere il ricupero d’ufficio solo laddove il proprietario non intenda farlo direttamente;
2. ricupero contrattuale: tale contratto ha natura di contratto d’opera o d’appalto e la prestazione ha come oggetto un’obbligazione di risultato;
3. il ricupero spontaneo (con o senza mezzi nautici), si configura come l’istituto della gestione di negozio.
Obblighi e diritti del ricuperatore.Gli obblighi sono diversi e vado ad elencarli: non può sospendere o abbandonare le operazioni se non dietro
giustificato motivo e congruo preavviso; entro 10 gg dall’approdo della nave che ha compiuto il ricupero o
compimento delle operazioni deve riconsegnare le cose ricuperate al legittimo proprietario, o se questi è ignoto alla vicina autorità marittima preposta, la quale la prende in custodia.
In merito ai diritti, il ricuperatore ha diritto al risarcimento degli eventuali danni e spese sostenute (chiamate indennità), ed un compenso stabilito in merito al lavoro svolto, al tempo impiegato, ai rischi, ecc; comunque esso non potrà eccedere il valore delle cose ricuperate. Il diritto alle indennità ed al compenso si prescrivono in due anni dal compimento delle operazioni. Il compenso va ripartito tra coloro che hanno collaborato o partecipato alle operazioni di ricupero. Ripartizioni che distingue se tali operazioni siano avvenute: - con mezzi nautici: si fa rinvio alla ripartizione prevista per il contratto
di soccorso;- senza mezzi nautici: ripartiti in base alle fatiche ed ai rischi corsi
durante le operazioni.Il ricupero d’ufficio, avviene in due condizioni:- mancata assunzione o prosecuzione del proprietario nei termini fissati;- che dal ricupero sia prevedibile un risultato utile.In merito alle attribuzioni dell’amministrazione possiamo dire che l’autorità marittima può provvedere alla vendita delle cose ricuperate allorquando non sia possibile o utile la conservazione, o per coprire le spese di ricupero.Dunque l’autorità marittima vende per conto del proprietario che non ritira le cose ricuperate o è ignoto, entro una determinata data.
IL RITROVAMENTO DI RELITTIIl ritrovamento di relitti si diversifica dal ricupero, per il fatto che manca l’intenzione di trovare le cose naufragate, ma il tutto avviene assolutamente per caso fortuito. Vediamo due ipotesi: ritrovamento di relitti (da navigazione marittima o aerea) in mare o
rigettati nelle acque del demanio marittimo; ritrovamento di relitti della navigazione aerea caduti sulla terra.
117

L’obbligo principale del ritrovatore è quello di denunciare entro 3 gg dal ritrovamento o dall’approdo della nave se il ritrovamento è avvenuto in corso di navigazione, all’autorità marittima o aeronautica. È punita l’eventuale omissione. Altresì, avrà l’obbligo alla riconsegna delle cose ritrovate, consegna che andrà fatta direttamente al legittimo proprietario, o se ignoto all’autorità marittima.Il ritrovatore ha diritto ad un rimborso delle spese ed un premio; il premio verrà elargito, altresì, in caso di ritrovamento di un cetaceo arenato (il cetaceo è di proprietà dello Stato).Il diritto del ritrovatore al rimborso ed al premio si prescrivono in due anni dal ritrovamento. L’autorità che riceve la riconsegna, custodisce le cose e le rivende devolvendo le cose ricavate.
118










![Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo con ... … · Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo con riferimento al diritto dell'Unione europea [RIF. 1.1] Domanda 1.1](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5f5ba6fab6ec104a966811ae/diritto-costituzionale-e-diritto-amministrativo-con-diritto-costituzionale.jpg)

![[EBook ITA] - Diritto - Formulario Diritto Amministrativo](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/568bd9041a28ab2034a57be3/ebook-ita-diritto-formulario-diritto-amministrativo.jpg)