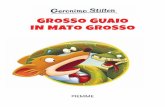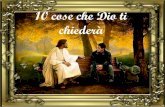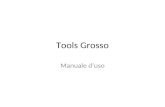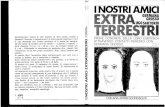DICEMBRE 2007 La valutazione dieci anni dopo SOMMARIO · Le riflessioni e le ricerche in materia di...
Transcript of DICEMBRE 2007 La valutazione dieci anni dopo SOMMARIO · Le riflessioni e le ricerche in materia di...

SOM
MAR
IODICEMBRE 2007ANNO XVIII - N. 1
INFORMAIRESSemestrale dell’Istituto diRicerche Economico-Socialidel Piemonte
n. 33, Dicembre 2007Direttore responsabileMarcello La RosaComitato di redazioneLuciano Abburrà, Maria TeresaAvato, Carlo Alberto Dondona,Vittorio Ferrero, Tommaso GarosciRedazione e direzione editoriale:IRES - Istituto di RicercheEconomico-Sociali del Piemontevia Nizza, 18 - 10125 TorinoTel. 011.666.64.11Telefax 011.669.60.12E-mail: [email protected] editoria IRESMaria Teresa Avato, Laura CarovignoE-mail: [email protected] del Tribunale diTorino n. 4034 del 10/03/1989.Poste Italiane, spedizione inabbonamento postale 70%.DCB Torino, n. 3/anno XVIIStampa: IGF - Industria Grafica Falciola
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE2006-2010
Angelo Pichierri, presidente;Brunello Mantelli, vicepresidente;Paolo Accusani di Retorto ePortanova, Antonio Buzzigoli,Maria Luigia Gioria, CarmeloInì, Roberto Ravello, MaurizioRavidà, Giovanni Salerno.
COLLEGIO DEI REVISORI
Emanuele Davide Ruffino, presi-dente; Fabrizio Allasia, MassimoMelone, membri effettivi; LilianaMaciariello, Mario Marino, mem-bri supplenti.
COMITATO SCIENTIFICOGiorgio Brosio, presidente;Giuseppe Berta, Cesare Emanuel,Adriana Luciano, Mario Montinaro,Nicola Negri, Giovanni Ossola.DIRETTORE: Marcello La Rosa.STAFF: Luciano Abburrà, StefanoAimone, Enrico Allasino,Loredana Annaloro, Maria TeresaAvato, Marco Bagliani, GiorgioBertolla, Antonino Bova, PaoloBuran, Laura Carovigno, RenatoCogno, Luciana Conforti, AlbertoCrescimanno, Alessandro Cun-solo, Elena Donati, Carlo AlbertoDondona, Fiorenzo Ferlaino,Vittorio Ferrero, Filomena Gallo,Tommaso Garosci, Maria Inglese,Simone Landini, Antonio La-rotonda, Eugenia Madonia,Maurizio Maggi, Maria CristinaMigliore, Giuseppe Mosso, CarlaNanni, Daniela Nepote, SylvieOccelli, Santino Piazza, StefanoPiperno, Sonia Pizzuto, ElenaPoggio, Lucrezia Scalzotto,Filomena Tallarico, GiuseppeVirelli.
La valutazione dieci anni dopo
Introduzione e quadro metodologico
La sfida della valutazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
La valutazione nelle pubbliche amministrazioni, dieci anni dopo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A ciascuno il suo. Cinque modi di intendere la valutazione in ambito pubblico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Le esperienze
La valutazione ex ante del PSR 2007 – 2013 della Regione Piemonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Valutare gli impatti ambientali delle infrastrutture . . . . . . . . . . . 27
La decisione nei processi di valutazione e selezione dei progetti: un’analisi delle procedure adottate dalla Regione Piemonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
La valutazione del personale. Rappresentazione teatrale in due atti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Valutare la performance dei Centri per l’Impiego . . . . . . . . . . . . 44
Il sistema sanitario regionale tra programmazione e monitoraggio. Quale ruolo per la valutazione? . . . . . . . . . . . . 50
Valutare le politiche per l’integrazione sociale degli immigrati: riflessioni a margine di un’esperienza di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Intesa Istituzionale di Programma e Accordi di Programma Quadro: analisi dei processi di implementazione . . . . . . . . . . . . 62
L’esperienza condotta con la valutazione del DOCUP 1994-1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Valutare il microcredito: l’analisi di un progetto condotto in Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
La valutazione di un intervento a sostegno della ricerca industriale in Piemonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
La valutazione di impatto delle politiche di aiuto alle imprese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:05 Pagina 1

Ricerche
Relazione sulla situazione economica, sociale e territoriale del Piemonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Osservatorio Istruzione Piemonte. Rapporto 2006 . . . . . . . . . . . 102
Immigrazione straniera in Piemonte. Rapporto 2006 . . . . . . . . . 107
Gli investimenti diretti all’estero delle imprese piemontesi.Tendenze, strategie e risultati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
PMI piemontesi e mercato mondiale. Flussi di approvvigionamento e di fornitura . . . . . . . . . . . . . . . . 117
ICT e distretti industriali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Commercio nei centri urbani. Il Centro Commerciale Naturale e il rapporto con il territorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Mappe di comunità: perché, quando e come . . . . . . . . . . . . . . . 130
La mobilità in Piemonte nei primi anni del 2000 . . . . . . . . . . . . 134
Convegni, seminari, dibattiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Pubblicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
SOM
MAR
IO
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:05 Pagina 2

Caravaggio
Ad accompagnare questo numero di “Informaires” sono state scelte alcune opere esposte nella mostra “DalDuecento a Caravaggio a Morandi”, collezione di Roberto Longhi, Fondazione Ferrero di Alba dal 13 ottobre2007 al 10 febbraio 2008.
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:05 Pagina 3

Lorenzo Lotto
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:05 Pagina 4

LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO
INTRODUZIONE E QUADRO
METODOLOGICO
LA SFIDA DELLA VALUTAZIONE
ANGELO PICHIERRI,Presidentedell’IRES Piemonte Nella cultura organizzativa caratteristica di buona parte del XX se-
colo, la valutazione dei risultati dell’azione delle organizzazioni,private o pubbliche, non è stata normalmente tematizzata come un
problema. A dire il vero, neanche l’attuazione degli obiettivi posti dal ver-tice dell’organizzazione veniva percepita concettualmente come tale. Loscientific management tayloristico come il tipo ideale weberiano di buro-crazia prevedevano che gli obiettivi posti da un consiglio d’amministrazio-ne come da un governo si sarebbero attuati nella maniera più efficace inpresenza di una divisione del lavoro disegnata secondo la one best way sta-bilita dalla scienza, e di una burocrazia rigorosamente aderente alla normae in grado di far procedere la “pratica” attraverso passaggi successivi stret-tamente programmati. Per dirla con le parole di De Gaulle, il politico pren-de le decisioni e l’intendance suivra.
Solo nella seconda metà del secolo studiosi di varia provenienza discipli-nare cominciarono a mettere in dubbio il rapporto univoco tra gli obiettivi ela loro attuazione, tra la strategia e la struttura. Un grande storico d’impresada poco scomparso, Alfred Chandler, contribuì fortemente a rendere di sen-so comune l’idea che non ci sono strutture valide per ogni strategia, e cheuna nuova strategia diventa efficace attraverso la trasformazione della strut-tura precedente. Nel caso dell’impresa, la svolta intellettuale fu appuntoquella del superamento dell’idea di one best way, la constatazione che il suc-cesso si ottiene adeguando e trasformando le strutture organizzative. Si po-teva peraltro pensare che il successo o l’insuccesso dell’impresa non avesse-ro bisogno di raffinate operazioni di valutazione, visto che la scelta di unastrategia, e l’adeguamento ad essa della struttura organizzativa, produconorisultati di cui è giudice il mercato. Tra le pochissime eccezioni a questo mo-do di vedere un classico degli studi organizzativi, J.D. Thompson, che nel1967 dedicò un capitolo del suo libro fondamentale alla “valutazione delleorganizzazioni” (organizzazioni appunto, non solo imprese) centrato sulrapporto tra le organizzazioni e il loro task environment. Thompson propo-neva qui una tipologia di assessment situations che non ha ancora esaurito ilsuo valore euristico, fondata sull’incrocio tra “credenze relative alla cono-scenza dei rapporti causa-effetto” e “standard di desiderabilità”.
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 P . 5 - 6
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:05 Pagina 5

Le riflessioni e le ricerche in materia di“implementazione” (termine che diventa dimoda a partire grosso modo dagli anni settan-ta) si svilupparono poi specialmente in riferi-mento alle organizzazioni pubbliche e nellanascente analisi delle politiche pubbliche. Trai concetti più importanti proposti dagli orga-nizzativisti c’è quello di “strutture di imple-mentazione”: l’attuazione delle politiche pub-bliche non è mai affare solo di una organizza-zione, ma di più organizzazioni, anzi di frazio-ni di organizzazioni reticolarmente collegate.Le ricerche sull’implementazione provano arispondere agli interrogativi relativi all’effica-cia delle azioni e delle politiche pubbliche,che va studiata senza disporre delle indicazio-ni e delle sanzioni che arrivano dal mercato.
È probabilmente la stessa esigenza che staalla base, quasi senza soluzione di continuità,del successivo crescente interesse per le atti-vità di valutazione, intesa come “attività tesaalla produzione sistematica di informazioniper dare giudizi su azioni pubbliche con l’in-tento di migliorarle” (Martini e Sisti in que-sto volume). Ed è soprattutto nel campo del-le politiche pubbliche che la valutazione haavuto negli ultimi anni uno sviluppo impe-tuoso, creando nuove professionalità, fissan-do nuovi standard, arrivando ad essere una
componente essenziale del processo di cuiuna politica pubblica si compone. Era facilesupporre che l’ondata avrebbe prima o poiinvestito l’IRES, istituto la cui missione centra-le è quella del supporto alle politiche pubbli-che. L’Istituto ha condotto negli ultimi annisperimentazioni interessanti, ad esempio inmateria di valutazione dei risultati delle poli-tiche industriali; ma le richieste che adesso glipervengono sono più ampie e sistematiche, esi inseriscono in un processo apprezzabile manon privo di rischi di istituzionalizzazionedella valutazione.
Il volume qui presentato offre un abbozzodi stato dell’arte, e una esemplificazione nonesaustiva del patrimonio di expertise che l’isti-tuto ha maturato in questo campo. Dà ancheun’idea dei problemi che in materia di valuta-zione restano aperti: ad esempio per quel cheriguarda i rapporti (in termini di modalità maanche di attori) tra valutazione ex ante ed expost, o tra valutazione e monitoraggio; o perquel che riguarda il coinvolgimento nella va-lutazione dei destinatari delle politiche. Que-sti e altri problemi costituiscono una sfidascientificamente difficile e politicamente im-pegnativa, destinata probabilmente a marcareuna fase nuova in un IRES che sta per compie-re i cinquant’anni.
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 76
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:05 Pagina 6

LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO
LA VALUTAZIONE NELLA PUBBLICAAMMINISTRAZIONE DIECI ANNI DOPO
RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA PIEMONTESE
STEFANO PIPERNO,IRES Piemonte
Perché questo numero?
La scelta di dedicare un numero di “InformaIres” alla valutazione derivada due motivazioni principali. La prima è riconducibile al fatto che dopoun periodo, nella seconda metà degli anni novanta, in cui il dibattito sullavalutazione nella Pubblica amministrazione – nelle sue numerose accezioni– aveva visto uno sviluppo rilevante, a partire dal nuovo secolo la tensioneinnovativa sembra essersi notevolmente affievolita. Si tratta di un periododenso anche di novità normative che hanno promosso l’introduzione distrumenti di valutazione nella Pubblica amministrazione statale e locale mamanca a livello nazionale e regionale una valutazione dell’impatto di questeinnovazioni. Da questo punto di vista, ci si ricollega idealmente al numerodi “Informaires” del dicembre 1998, dedicato anch’esso all’analisi e alla va-lutazione delle politiche pubbliche. Cosa è cambiato da allora? La “valuta-zione” si è davvero affermata nel modo di operare delle pubbliche ammini-strazioni piemontesi, come molti si aspettavano che accadesse? Attraversoquali esperienze? E cosa ancora resta da fare?
La seconda è invece legata a una ricorrenza. Nel 1997 – proprio in con-seguenza allo sviluppo del dibattito sulla valutazione in Italia – l’IRES insie-me alla Fondazione CRT, la Compagnia San Paolo, il CSIPiemonte e la Ca-mera di commercio di Torino promosse la costituzione di ASVAPP (Associa-zione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbli-che), un’associazione non profit che si poneva come missione principale lapromozione, l’elaborazione e la diffusione di metodi e tecniche analitiche asupporto del processo decisionale pubblico. In questi dieci anni ASVAPP hasvolto numerosi studi valutativi – spesso in collaborazione con l’IRES – e at-tività formativa per conto di amministrazioni pubbliche e soggetti non pro-fit, come le Fondazioni di origine bancaria sviluppando un’esperienza pro-babilmente unica in Italia.
Sarebbe anomalo per una istituzione di questo tipo, e, quindi, anche perl’IRES, non promuovere un dibattito sullo “stato dell’arte” della valutazione,che tracci un primo bilancio sulla sua diffusione nel nostro territorio in termi-ni di cultura, approcci, soluzioni organizzative e opportunità di formazione.
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 P . 7 - 1 2
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:05 Pagina 7

Per questi motivi abbiamo deciso di pre-sentare dei contributi prevalentemente basa-ti su concrete esperienze di valutazione ma-turate in questi anni in Piemonte, piuttostoche su riflessioni di tipo puramente metodo-logico, per le quali sono più congrue altredestinazioni come riviste scientifiche e testiuniversitari. In questa maniera è anche piùfacile fare un po’ di chiarezza rispetto a undibattito spesso ammantato da retorica, scar-sa chiarezza concettuale e limitata evidenzaempirica. Ugualmente, la segnalazione di ca-si di buone pratiche valutative, così come l’a-nalisi delle criticità incontrate, rappresenta-no il terreno migliore per offrire una onestarisposta alle critiche che giornalmente vengo-
no appuntate sull’inefficienza della Pubblicaamministrazione, sugli sprechi e sui “fannul-loni”, sui mille rivoli improduttivi di spesapubblica.
I vari modi di intendere la valutazione:alcuni casi concreti
Martini e Sisti, nel prossimo contributo, nellatradizione di chiarificazione concettuale e ri-gore metodologico portata avanti da Proget-toValutazione (Pro.Va) – il braccio operativodell’ASVAPP – individuano almeno cinque ac-cezioni di valutazione che si sono sviluppatein questo arco di tempo:
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 78
Che cos’è l’ASVAPP?
L’ASVAPP (Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche)è un’organizzazione non-profit nata nel dicembre del 1997 per iniziativa di cinque enti pub-blici e non-profit interessati a promuovere l’elaborazione e la diffusione di metodi e tecnicheanalitiche a supporto del processo decisionale pubblico. Attualmente, i soci dell’associazionesono la Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT, il CSI-Piemonte e l’IRES-Piemonte. Lo scopo dell’associazione consiste nell’aiutare la crescita di esperienze di eccellenza nel cam-po della valutazione delle politiche, offrendo a enti pubblici e non-profit un punto di riferi-mento metodologico. Nel perseguire questo scopo l’ASVAPP ha dato vita nel 1998 a Progetto-Valutazione (www.prova.org), la struttura operativa dell’associazione. Successivamente, nel2002, l’ASVAPP ha promosso la costituzione del progetto CAPIRe (www.capire.org), nato suiniziativa di quattro Consigli regionali – Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana –per dare maggiore efficacia alla funzione di controllo esercitata in seno alle assemblee legislati-ve. Dal 2006 progetto CAPIRe si è allargato all’intero territorio nazionale ed è passato sotto ildiretto patrocinio dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni edelle Province Autonome. Nel corso dell’ultimo anno, inoltre, l’associazione ha consolidato lesue collaborazioni istituzionali avviando due nuovi progetti. In collaborazione con sei fonda-zioni ex bancarie ha dato vita al progetto GIVER (Grantmaker interessati alla valutazione delleerogazioni) con lo scopo di elaborare strategie innovative per la valutazione degli interventipromossi dalle stesse fondazioni, partendo dallo studio dell’esperienza delle fondazioni filan-tropiche americane e adattandola al contesto italiano. In collaborazione con la Provincia di To-rino, la Provincia di Cuneo, la Fondazione CR Torino e la Fondazione CR Cuneo, l’ASVAPP hacreato il LIR (Laboratorio Ida Rossi per la valutazione dei servizi per l’impiego e delle politiche at-tive del lavoro), con lo scopo di applicare lo stato dell’arte della metodologia valutativa per ca-pire in che misura i servizi per il lavoro offerti ai disoccupati ne migliorino le prospettive occu-pazionali. Dal 2002, infine, l’associazione organizza una summer school sull’impiego di metodiquantitativi per la valutazione delle politiche, alla quale partecipano ricercatori provenienti daenti di ricerca, società di consulenza e università italiane.Nei suoi dieci anni di attività l’Associazione ha prodotto numerosi rapporti di ricerca e organiz-zato seminari sulle tematiche valutative.
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:05 Pagina 8

• valutare per scegliere tra alternative;• valutare per gestire organizzazioni;• valutare per rendere conto a soggetti esterni;• valutare per apprendere;• valutare per motivare.
Il lettore, soprattutto colui che è stato im-pegnato più o meno direttamente in attivitàvalutative, potrà facilmente individuare qualeaccezione risulti più vicina alla sua concretaesperienza.
Il contributo di Aimone e Spaziante si rife-risce all’esperienza di valutazione ex ante delPiano di sviluppo rurale 2007-2013 della Re-gione Piemonte. Essa rientra tra le pratichevalutative (insieme alla valutazione ambientalestrategica) introdotte dai regolamenti comuni-tari e ormai divenute in una certa misura rou-tinarie nelle amministrazioni regionali. Aspet-ti positivi si mischiano ad aspetti negativi: cer-tamente il passaggio di un processo valutativovissuto come adempimento formale a uno fi-nalizzato all’apprendimento e al conseguentemiglioramento dell’azione amministrativa èancora da completare.
Norese e Torta descrivono i principali ri-sultati di una interessante analisi svolta nel2003 per conto del Nucleo di valutazione eVerifica degli investimenti pubblici della Re-gione Piemonte relativamente alle politicheregionali i cui elementi costitutivi e caratteriz-zanti sono il fatto di finanziare interventi pub-blici mediante l’erogazione selettiva di finan-ziamenti a soggetti attuatori pubblici o privati.Si tratta di un profilo di analisi di grande rilie-vo perché la Regione è per sua natura un “en-te intermediatore”, che non eroga servizi fina-li ma, tendenzialmente, opera come distribu-tore di risorse pubbliche ad altri soggetti. Ciòspiega la presenza dominante dei trasferimen-ti tra le componenti di spesa dei bilanci regio-nali. Le conclusioni offrono numerosi spuntidi riflessione trasversale rispetto alle principa-li politiche regionali e alla valutazione ex ante.
Giaccaria presenta una valutazione (anchequesta ex ante) degli impatti ambientali dellarete dei grandi elettrodotti in Piemonte attra-verso una stima monetaria delle esternalitàambientali attraverso il metodo della valuta-zione contingente. Tale stima dimostra comesia possibile la definizione più puntuale delle
politiche regionali di localizzazione anche at-traverso la quantificazione delle possibili mi-sure compensative (indennizzi).
Con il contributo di Curzio passiamo allavalutazione intesa come strumento di gestionedi organizzazioni complesse. In particolare, ilcontributo affronta in maniera originale ilproblema della valutazione dei dirigenti se-gnalando i limiti di un approccio formale chenon tenga conto pienamente della complessitàdi gestione delle risorse umane in un’aziendadi servizi come la Pubblica amministrazione:un po’ di maggior attenzione ai modelli piùinnovativi in uso nel settore privato (si pensi aesperienze come quella di Google) non fareb-be male.
Il contributo di Battiloro e Mo Costabellaè importante per diversi motivi. In primo luo-go, perché valuta la performance dei serviziper l’impiego, che rappresentano uno deimaggiori ambiti di attività amministrativa tra-sferito alle amministrazioni provinciali nelquadro del processo di decentramento portatoavanti dalle leggi Bassanini. In secondo luogo,per l’approccio seguito che evita il rischio del-le valutazioni basate su batterie di indicatori,utili tutt’al più per il monitoraggio, utilizzan-do informazioni amministrative disponibili.Infine, i risultati dell’analisi consentono ditrarre una lezione importante. L’approccio ba-sato sulla performance presenta il rischio della“sindrome della graduatoria”, ovverosia delgiudizio che si viene a dare in termini compa-rati tra le diverse strutture, appunto, in termi-ni di performance. Il fatto stesso che si sia pre-ferito non dare i riferimenti dell’ente sul qualesi è svolta l’analisi la dice lunga sul gap cultu-rale ancora da superare per cogliere le oppor-tunità offerte dagli strumenti di valutazione.
Pier Vincenzo Bondonio affronta i proble-mi della valutazione all’interno del servizio sa-nitario regionale. Si tratta di un contributometodologico, che distingue tra attività diprogrammazione, monitoraggio e valutazione,anche se con riferimenti precisi al modello diservizio sanitario del Piemonte. In particolare,la valutazione può spaziare da un livello mi-cro, all’interno di uno specifico settore di atti-vità di un’azienda sanitaria o ospedaliera, perarrivare a livello regionale tenendo conto delruolo dei diversi livelli di governo.
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 9
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:05 Pagina 9

LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 710
Che cos’è il NUVAL?
Il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVAL) è una struttura dellaRegione Piemonte costituita nel 2001 in attuazione della l. n. 144 del 1999. La 144/99, nel-l’ambito di un più generale riassetto del quadro normativo della spesa, prevede che in ogniRegione i Nuclei agiscano come “strumenti” di razionalizzazione delle scelte per investimen-ti, promosse dalle Amministrazioni centrali e regionali, ai fini di un complessivo migliora-mento del processo di programmazione delle politiche di sviluppo. La principale funzione at-tribuita ai NUVAL è dunque di “garantire il supporto tecnico alle diverse fasi della program-mazione, della valutazione e verifica di piani, programmi e politiche promossi dalle varie Am-ministrazioni”. Attualmente il NUVAL del Piemonte è organizzato sulla base di due organi principali, che pro-gettano ed implementano le attività connesse alla sua missione: il Comitato di indirizzo e coor-dinamento, composto da dirigenti e funzionari afferenti alle diverse Direzioni regionali e loStaff di consulenza tecnica, composto a sua volta da un Gruppo di esperti esterni e da un teamdi analisti di politiche pubbliche. Negli ultimi anni il NUVAL ha svolto una funzione di stimo-lo intellettuale e di sostegno allo sviluppo della cultura della valutazione all’interno della stes-sa amministrazione regionale, in particolare attraverso l’assistenza metodologica e tecnico-or-ganizzativa rivolta alle singole Direzioni. Il NUVAL organizza le proprie attività secondo unprogramma biennale approvato dal Comitato di Indirizzo e Coordinamento, all’interno delquale sono previste attività riconducibili ai seguenti filoni di lavoro:• approfondimento sull’uso di metodi valutativi, trasversali ai diversi ambiti settoriali;• supporto alla realizzazione di progetti di analisi, monitoraggio e valutazione di singoli in-
terventi settoriali;• certificazione degli studi di fattibilità presentati dalle pubbliche amministrazioni;• organizzazione di seminari e momenti di formazione sul tema del monitoraggio e della va-
lutazione.
Allasino e Sisti si occupano di un tema dipolitica sociale, l’integrazione degli immigra-ti. Emerge un problema rilevante, quello del-la valutazione delle politiche attuate da piùlivelli di governo, tema cruciale per un entecome la Regione. Ciò risulta particolarmentecomplesso all’interno di politiche sociali ca-ratterizzate da multiformi obiettivi. L’espe-rienza in corso innova notevolmente i mecca-nismi di valutazione sinora seguiti attraversoil coinvolgimento di tutti gli attori in gioco alfine di identificare meglio le varie tipologiedi interventi e di fare emergere le buoneprassi.
Barella ripercorre l’esperienza di valuta-zione dell’Intesa Istituzionale di programmasvolta dall’IRES per il NUVAL mettendo in lu-ce i numerosi problemi incontrati. In parti-colare la difficoltà di effettuare vere valuta-zioni a causa della multiformità degli inter-venti attuati attraverso lo strumento degli
Accordi di programma quadro (APQ) e le cri-ticità dei meccanismi di monitoraggio ancorain parte vissuti come incombenze burocrati-che e non strumenti di miglioramento perl’azione amministrativa.
Nel contributo di Cogno viene riesamina-ta un’esperienza di valutazione dell’IRES sul-l’attuazione del Documento unico di pro-grammazione (DOCUP) 1994-99 che si è rite-nuta ancora molto attuale. La strategia valu-tativa seguita presenta aspetti originali siaper quanto concerne le domande valutativeche l’organizzazione del lavoro con i com-mittenti. Il risultato finale è positivo in ter-mini di apprendimento delle strutture regio-nali.
Anglois descrive i risultati di uno studio divalutazione sugli effetti del progetto Micro-credito sociale promosso dalla CompagniaSan Paolo in Italia. Si tratta quindi di un’espe-rienza in cui il committente non era un’ammi-
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:05 Pagina 10

LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 11
nistrazione pubblica ma una Istituzione nonprofit. L’indagine è ancora in corso ma i risul-tati sinora ottenuti hanno consentito l’intro-duzione di correttivi rispetto ai meccanismiintrodotti inizialmente.
Rocca e Strada affrontano un tema di gran-de attualità a livello regionale: la valutazionedegli interventi di sostegno alla ricerca indu-striale in Piemonte finanziati dalla RegionePiemonte attraverso bandi. Lo studio (tuttorain corso) è svolto da Progetto Valutazione perla Direzione Industria della Regione Piemon-te. Sono emerse alcune criticità (scarso utilizzodelle risorse, tempi troppo limitati per la pro-gettazione, ecc.), anche se in genere per lamaggior parte delle imprese l’agevolazionepubblica ha avuto un effetto incentivante. Lostudio ha soprattutto mostrato come la valuta-zione possa svolgere una funzione di appren-dimento che consente aggiustamenti successivialle politiche.
Anche il contenuto dell’ultimo contribu-to di Daniele Bondonio è riferito alle politi-che industriali. Lo studio, anche questo com-missionato dal NUVAL, affronta in maniera ri-gorosa il problema della valutazione dell’im-patto occupazionale dei contributi pubblicierogati alle imprese. Esso offre importantiindicazioni circa la scelta delle modalità di fi-nanziamento (finanziamenti agevolati vs. fi-nanziamenti a fondo perduto). In particola-re, i finanziamenti agevolati, a parità di spesadi denaro pubblico per i sussidi, determina-no nel complesso un maggiore impatto occu-pazionale rispetto ai contributi a fondo per-duto. Analisi di questo tipo potrebbero esse-re alla base di riflessioni più generali sugli in-terventi di politica industriale regionale co-me sostituzione degli incentivi con riduzionifiscali. Ciò però rientra in una possibile agen-da per il futuro.
Le prospettive
In conclusione, molto resta da fare ma qual-cosa è stato fatto. Forse dieci anni fa nessunosi sarebbe aspettato che nel nuovo Statuto re-gionale approvato nel 2005 sarebbe stata “co-stituzionalizzata” la valutazione: “Il consiglioregionale esercita il controllo sull’attuazionedelle leggi e predispone gli strumenti per va-lutare gli effetti delle politiche regionali al finedi verificare il raggiungimento dei risultatiprevisti” (art. 71).
In questo quadro, è difficile pensare chel’IRES non si occupi di valutazione nei prossimianni. Il suo ruolo, insieme a quello di ASVAPP,potrà essere definito alla luce delle politichedella Regione Piemonte, per quanto concerneil NUVAL, il sistema nazionale di valutazione, el’attuazione della pianificazione strategica re-gionale nel quadro degli interventi comunitarie in uno scenario di federalismo fiscale raffor-zato. Si tratta di un processo di “istituzionaliz-zazione” della valutazione che sarà approfon-dito nel prossimo numero di “InformaIres”.
Infine, un caveat. Come ricercatori abbia-mo sempre preso sul serio la valutazione, masempre con l’umiltà di chi è consapevole che“la democrazia si basa sull’assunto che nessunoè infallibile e nessuno possiede il segreto delbuon governo. Non esiste una scienza socialeesatta come le scienze fisiche. I fenomeni dellavita sociale sono infinitamente più complicatidi quelli del mondo fisico. (…) E infine le ipo-tesi avanzate per spiegare i fatti sociali non pos-sono essere verificate sperimentalmente comeaccade nelle scienze fisiche. Più la società si facomplessa, più difficile diventa prevedere il fu-turo e più incerta l’arte di governo”. Questeparole di Gaetano Salvemini scritte nel lontano1934 in esilio negli Stati Uniti e recentementepubblicate in Italia paiono quanto mai attuali.
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:05 Pagina 11

Lorenzo Lotto
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:05 Pagina 12

LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO
A CIASCUNO IL SUO
CINQUE MODI DI INTENDERE LA VALUTAZIONE IN AMBITO PUBBLICO
ALBERTO MARTINI,MARCO SISTI,ProgettoValutazione Èormai invalsa l’abitudine di invocare la valutazione come la panacea
in grado di rimediare alla scarsa “efficacia ed efficienza” dell’inter-vento pubblico. L’entusiasmo con il quale ci si rivolge a questa atti-
vità rischia tuttavia di non prendere in seria considerazione i limiti che si in-contrano nella pratica valutativa e conduce a sottostimare i diversi utilizzi acui essa può essere orientata.
Da qualche anno a questa parte è sempre più frequente leggere articolidi giornale nei quali si invoca la “valutazione” come strumento necessarioa migliorare la gestione della cosa pubblica. A volte tale invocazione nascespontanea nelle parole di un editorialista, dedito a commentare l’ennesi-mo spreco o scandalo italiano; altre volte la ritroviamo nell’appassionatodiscorso di un politico innovatore e lungimirante; altre ancora si nascon-de nelle dichiarazioni rilasciate da un moderno manager, responsabile diqualche azienda pubblica. Se dai quotidiani si passa poi a letture più im-pegnate, cioè a documenti prodotti dalla stessa Pubblica amministrazione– come testi di legge, delibere, declaratorie, accordi, atti di indirizzo o dicontrollo – la musica non cambia molto. Al contrario, aumenta di tono edi volume: le invocazioni e gli auspici diventano norme e prescrizioni el’aspirazione a valutare si trasforma in dovere istituzionale e obbligo am-ministrativo
Davvero difficile non dirsi contenti di questa tendenza generale. So-prattutto per chi ha scelto di occuparsi di valutazione per mestiere e tentada tempo di sostenerne il processo di consolidamento in seno agli enti pub-blici. Eppure, dopo un primo moto di soddisfazione, non possiamo non co-gliere in questo movimento di opinione una qualche preoccupante debo-lezza; non connessa soltanto alla distanza che separa le parole (molte) daifatti (molti meno).
La debolezza più insidiosa – quella che più ci preoccupa – è legata al-la constatazione che in molti casi, rapiti dall’entusiasmo o dalla retorica, siassegnano alla valutazione obiettivi e ambizioni che vanno molto al di làdella sua reale portata. Forse perché se ne deve legittimare l’impiego inun Paese che tradizionalmente ne ha fatto sempre poco uso; forse perché
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 P . 1 3 - 2 1
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:05 Pagina 13

parlandone – e scrivendone – molto si ha lasensazione di essere già a metà dell’opera;forse perché vi è poca consapevolezza di co-sa essa realmente sia: sta di fatto che troppospesso si scaricano sulla valutazione le fru-strazioni conoscitive più disparate, confidan-do nell’idea che esista, in qualche luogo miti-co, un’unica strumentazione metodologica,già pronta all’uso, adatta a dar loro soddisfa-zione.
Questo articolo nasce con l’intento di re-stituire alla valutazione un po’ di ragionevo-lezza e di modestia cognitiva, riconoscendo lepotenzialità d’uso, ma anche gli inevitabili li-miti analitici, dei vari metodi che vi fanno ri-ferimento. Si tratta di un’operazione di puli-zia concettuale necessaria, se non si vuol ri-schiare di alimentare aspettative che resteran-no poi deluse: la valutazione potrà dare uncontributo utile al miglioramento dei proces-si decisionali pubblici, soltanto se muoveràda domande realistiche e vi sarà piena co-scienza che il suo scopo non è produrre veritàassolute, incontrovertibili e salvifiche, masemplicemente argomentazioni più informatee, dunque, più solide. A questo scopo distin-guiamo tra cinque diversi modi di intenderela valutazione – cinque logiche ispiratrici –concentrando l’attenzione sui concreti biso-gni conoscitivi cui i diversi approcci alla valu-tazione dovrebbero dare risposta. A questotentativo di attribuzione si ispira anche il ti-tolo dato a questo articolo: a ciascun bisogno,il suo approccio.
Partiamo però affrontando una domandapreliminare: che cosa è la “valutazione”?
Cosa intendiamo per valutazione?
Non è nostra intenzione dilungarci troppo suquesto punto. In letteratura vi sono già nume-rose spiegazioni di cosa, in astratto, debba in-tendersi per valutazione e crediamo che il no-stro tentativo di mettere ordine tra le varie de-finizioni esistenti aggiungerebbe poco a quan-to già è stato scritto. Tuttavia, considerandol’estrema elasticità d’uso di questo termine,che assume significati diversi in contesti diffe-renti, un chiarimento è d’obbligo. Per valuta-zione intendiamo qui un’attività tesa alla pro-
duzione sistematica di informazioni per daregiudizi su azioni pubbliche con l’intento di mi-gliorarle.
Si tratta di una definizione poco restritti-va, che non compie nette scelte di campo tra idiversi approcci. Questa è la sua forza: ha ilnotevole pregio di adattarsi alle molte acce-zioni che vengono abitualmente attribuite atale termine in seno alla Pubblica amministra-zione.
Vediamo quali sono gli elementi distintivipiù importanti contenuti in questa definizione.
Innanzitutto, questa attività prevede l’u-so di strumenti d’analisi mutuati dall’espe-rienza delle scienze sociali. L’aggettivo siste-matica riferito a produzione di informazioniallude proprio al suo fondamento empirico eanalitico: essa deve basarsi sull’osservazionedella realtà, condotta attraverso metodi ripe-tibili e condivisi da una comunità scientificadi riferimento. In questo senso si distinguenettamente da un’attività di giudizio pura-mente personale e soggettivo – come adesempio avviene quando si giudica la bellez-za di un’opera d’arte o la squisitezza di unpiatto – che si fonda invece sull’esistenza dicanoni, gusti o interessi, che trascendono dal“metodo scientifico”.
In secondo luogo, la valutazione comportal’espressione di un giudizio che si fonda sullarealizzazione di un qualche tipo di confronto.Possiamo anzi affermare il principio che senzaconfronto non esiste valutazione. Il problemasta quindi nel chiarire qual è il termine di con-fronto utilizzato per formulare tale giudizio,perché è stato adottato proprio tale termine ecome si è giunti alla sua costruzione. A volte(raramente) il termine di confronto è facil-mente individuabile, in quanto dichiarato da-gli stessi decisori pubblici in qualche docu-mento ufficiale. Molto più spesso tale termineè implicito, ambiguo, difficilmente riconosci-bile, e neppure esprimibile attraverso un sem-plice numero. Sta all’abilità del valutatore in-dividuare, proporre e trovare le argomenta-zioni giuste per far accettare come credibileun determinato termine di confronto.
Infine, la valutazione incorpora un fonda-mentale intento migliorativo dell’attività pub-blica. L’essenza stessa della valutazione sta tut-ta nel suo essere orientata all’azione o, ancor
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 714
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:05 Pagina 14

meglio, alla decisione. La volontà di incideredirettamente sul processo decisionale pubbli-co costituisce la discriminante fondamentaledi tale attività analitica e la sua vera ragiond’essere: in sostanza, ogni valutazione nasceper produrre risultati analitici utilizzabili dachi decide. La missione di ogni valutatoreconsiste proprio nell’aiutare chi ha responsa-bilità decisionali in ambito pubblico ad assu-mere scelte più informate e consapevoli, inquanto fondate su evidenza empirica. Se que-sto è vero, la valutazione deve essere ritagliatasulle particolari esigenze conoscitive che alcu-ne persone ben individuate nutrono nei con-fronti di quel particolare intervento pubblico:di volta in volta il valutatore costruisce la suastrategia di analisi, partendo dalle domandeche, in quel contesto politico-amministrativo,alcune ben identificate persone (o gruppi dipersone) si pongono. Il valutatore deve perciòavere sempre ben chiaro in mente qual è l’uti-lizzo che essi possono fare delle risposte.
Alla ricerca delle domande valutative
Una delle prime sfide da affrontare quando siconcepisce una valutazione consiste nel defini-re a quali domande si vuol dare risposta peradottare quali decisioni. Per quanto possa ap-parire strano, non è sempre facile intendersiimmediatamente sulle attese che la committen-za ripone nella valutazione. Né sugli utilizziche intende farne. Molto spesso in ambitopubblico si ricorre alla valutazione per uncocktail di ragioni – imposizioni legislative, ri-chieste dei superiori, mode occasionali – che èassai complicato ricostruire ed esplicitare. Ladifficoltà nel definire “cosa si vuol sapere eperché” non dipende però soltanto da unascarsa chiarezza di idee della committenza.Talvolta anche il valutatore ci mette del suonell’intorbidire le acque, utilizzando magari ungergo specialistico ambiguo e a tratti astruso,oppure tentando di “piazzare” – sempre e co-munque – il metodo che padroneggia meglio.
Partire dalla formulazione di domandesemplici ed essere consapevoli che per rispon-dere a queste domande occorrono professio-nalità specifiche, di volta in volta diverse: que-sti dovrebbero essere i due principi da seguire
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 15
in ogni caso. Basandoci su queste regole ab-biamo costruito la classificazione che propo-niamo in queste pagine. Per ognuno dei cin-que modi di intendere la valutazione, abbia-mo individuato:• la particolare finalità conoscitiva e decisio-
nale che lo motiva;• la sfida cognitiva che essa sottintende;• le particolari strategie d’analisi utilizzabili
per affrontare tale sfida;• alcune possibili applicazioni pratiche.
Valutare per scegliere (tra alternative)
All’interno della Pubblica amministrazionenasce spesso l’esigenza di valutare al fine discegliere tra opzioni alternative. Di volta involta la scelta può riguardare come distribui-re le risorse disponibili tra una serie di pro-getti concorrenti; quali varianti possono es-sere apportate a un piano regolatore; a qualidipendenti affidare responsabilità maggiori oassegnare premi di produttività; a quali fami-glie erogare servizi di assistenza sociale; inquale area geografica collocare una discaricao un rigassificatore; e così via. Naturalmente,in ciascuno di questi casi la valutazione nasceda motivazioni diverse. Talvolta vi è la neces-sità di decidere quali sono i progetti che han-no maggior probabilità di essere portati atermine con successo. Altre volte si intendestimolare comportamenti di emulazione, pre-miando chi tiene un comportamento virtuo-so. In alcuni casi lo scopo consiste nel raffor-zare la convinzione che l’investimento pub-blico che si sta per compiere vada nella “di-rezione giusta”, confrontandolo con strategied’investimento alternative; in altri, è di con-centrare le risorse solo su chi si trova in unacondizione di reale svantaggio, e dunque dinon sprecarle attribuendo benefici a chi nonne ha bisogno. In altri ancora si tratta di in-dividuare la soluzione in grado di incontrareil maggior consenso possibile da parte di unacollettività.
Ciò che però accomuna tutti questi casi tan-to diversi è il fatto che attraverso la valutazionesi vuol produrre un giudizio comparativo: ovve-ro un giudizio non assoluto, ma relativo soltan-to agli oggetti (azioni, enti e individui) posti a
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:05 Pagina 15

confronto. Un giudizio che assume significatosolo in quanto legato a una precisa decisione al-locativa e che al di fuori di quella particolaredecisione può addirittura essere irrilevante. Lasfida cognitiva di questo tipo di valutazioneconsiste infatti nel costruire un sistema che per-metta di razionalizzare e, in ultima istanza, le-gittimare il processo decisionale, attraverso ilquale saranno riconosciuti meriti, opportunitàe bisogni e sarà operata la scelta prevista. In al-tri termini si tenta di rispondere alla domanda:“quale tra gli ‘n’ oggetti analizzati si adatta me-glio alle intenzioni dei decisori?”
Possono essere identificati tre passaggi checaratterizzano questo approccio.1) Dapprima si individuano i criteri sui quali
comparare gli “n” oggetti sottoposti a va-lutazione. Durante questo passaggio si ècostretti a esplicitare le “intenzioni dei de-cisori” e a tradurle in dimensioni osserva-bili. A volte occorre anche scegliere pesidiversi da assegnare ai criteri; il peso soli-tamente varia in ragione della (presunta)rilevanza del criterio individuato.
2) Successivamente si assegna uno specificovalore su ciascun criterio predefinito perogni oggetto analizzato. Il valore può deri-vare da una misurazione “oggettiva” (adesempio i costi legati a progetti alternatividi ristrutturazione di una piazza), oppuredall’espressione di un punto di vista “sog-gettivo” (ad esempio, il giudizio di cittadi-ni scelti, o di esperti, sul valore esteticodelle diverse ristrutturazioni proposte).
3) I valori così espressi vengono aggregati alfine di poter comparare gli oggetti. Di vol-ta in volta, questa procedura di aggrega-zione permetterà di premiare alcune op-zioni ed escluderne altre, oppure di co-struire graduatorie tra gli oggetti sulla basedei punteggi ottenuti.
Esistono diverse tecniche a cui si può ri-correre per realizzare questo tipo di compara-zioni. Le più conosciute sono l’analisi costi-be-nefici, che tenta di ricondurre il confronto trale varie opzioni a valori monetari, e l’analisimulticriteri, una famiglia di metodi che af-fronta la multidimensionalità di un problemadecisionale, senza tentare di riportare il tuttoal solo criterio monetario.
Valutare per gestire (organizzazioni)
Spesso una Pubblica amministrazione si trovanella situazione di voler migliorare il propriofunzionamento, o di voler migliorare il rendi-mento di enti o unità organizzative che da es-sa dipendono. Per conseguire questi obiettivi,si chiama in aiuto la valutazione. Ma di che ti-po di valutazione si tratta?
La domanda che motiva questa forma divalutazione è piuttosto semplice da formulare:“quanto bene una determinata organizzazionepubblica (o una parte di essa) sta svolgendo ilcompito che le è stato affidato?” Dare rispostaa questa domanda è invece molto più com-plesso.
In termini molto generali, possiamo direche per rispondervi occorre misurare ciò chel’organizzazione ha prodotto e confrontarlocon ciò che l’organizzazione avrebbe dovuto(o potuto) produrre. A tal proposito si puòparlare di valutazione della performance, in-tendendo con questo termine – performance– far riferimento all’insieme di tutte le caratte-ristiche che descrivono l’operato dell’organiz-zazione: i costi di produzione, i volumi di atti-vità, la qualità delle prestazioni.
Le fasi che caratterizzano questo tipo divalutazione sono essenzialmente cinque:• l’individuazione degli aspetti (dimensioni)
dell’agire dell’organizzazione che si ritieneutile tenere sotto controllo, sotto l’assuntoche siano suscettibili di miglioramento;
• la definizione delle variabili (indicatori)capaci di descrivere la performance del-l’organizzazione per ogni aspetto indivi-duato;
• la determinazione dei valori desiderati(standard) appropriati per ciascun indica-tore, cioè dei punti di riferimento che con-sentano di separare una performance buo-na da una meno buona;
• la raccolta dei dati per ricavare il valore diciascun indicatore e poi confrontarlo conil rispettivo valore desiderato;
• l’interpretazione delle deviazioni dellaperformance osservata dagli standard el’introduzione di un meccanismo di premie sanzioni per le organizzazioni che mo-strano performance sistematicamente so-pra o sotto gli standard.
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 716
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:05 Pagina 16

Numerosi approfondimenti sarebbero ne-cessari per superare l’impressione di superfi-cialità che probabilmente questa generica li-sta di passaggi ingenera nel lettore. Qui cipreme sottolineare come siano il terzo pas-saggio, l’individuazione degli standard, e ilquinto, l’interpretazione degli scostamenti, acostituire la vera sfida per chi si accinge adoperare questo tipo di valutazione. Una sfidanon sempre raccolta nella pratica e nella let-teratura valutativa in Italia, che generalmentetende a concentrarsi soltanto sul secondopassaggio, relativo alla definizione degli indi-catori.
Le modalità di costruzione dei valori de-siderati variano molto secondo il contesto. Aun estremo possono essere usati come terminidi confronto semplicemente i valori osservatiin passato sullo stesso indicatore per la stessaorganizzazione; il confronto permette così diapprezzare l’avvenuto miglioramento, o di ri-levare un peggioramento, nella performancedell’organizzazione stessa. L’osservazione del-l’esperienza passata in taluni casi può esserestrumentale alla costruzione di valori-obietti-vo (target) fissati dal management direzionaleper stimolare le diverse unità o parti dell’or-ganizzazione a raggiungere prestazioni mi-gliori. Nel far ciò la principale difficoltà con-siste nel calibrare la voglia di produrre un mi-glioramento con la necessità di non imporreobiettivi irraggiungibili. Altre volte per la co-struzione dei target possono essere utilizzati ivalori osservati per gli stessi indicatori pressoorganizzazioni simili, che servono dunque dabenchmark. Il problema in questo caso è riu-scire ad operare un confronto tra le diverseorganizzazioni che avvenga a parità di condi-zioni (ceteris paribus) rispetto alle caratteristi-che della popolazione servita, oppure al con-testo più generale nel quale l’organizzazioneopera. Infine, in casi molto particolari, i valo-ri obiettivo possono avere natura del tuttoesogena ed essere fissati, a livello centrale, daorganismi di natura professionale o da auto-rità pubbliche.
Esempi di concrete attività che si richia-mano a questo schema concettuale, pur nelleloro diversità sono il controllo di gestione, lacertificazione di qualità e alcune forme di ac-creditamento. Anche strumenti quali le inda-
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 17
gini di soddisfazione dell’utenza possono esse-re ricondotte a questa tipologia di valutazio-ne: in questo caso il confronto tra valori os-servati e valori desiderati è compiuto diretta-mente dall’utente, che confronta il servizio ri-cevuto con le proprie aspettative, che in que-sto particolare ambito applicativo fungono dastandard.
Valutare per rendere conto (a soggettiesterni)
Alla base della terza forma di valutazione vi èl’esigenza di descrivere le realizzazioni pro-dotte dalle amministrazioni pubbliche, al finedi poterne rendere conto agli stakeholders piùrilevanti (in primis a coloro che finanziano l’a-zione pubblica). La domanda rilevante in que-sto caso è: “ciò che è stato fatto dall’ammini-strazione riesce ad adempiere agli impegni as-sunti?”
L’idea è di fornire una rappresentazionedello sforzo compiuto da un’amministrazionenel portare avanti la sua missione. La differen-za più rilevante rispetto alla forma di valuta-zione precedente riguarda la ricaduta decisio-nale dei due tipi di valutazione. Se nel primocaso i risultati dell’analisi sono utilizzati perassumere decisioni di natura gestionale – e,quindi, per intervenire direttamente sullerealtà organizzative che mostrano performan-ce inadeguate – le informazioni prodotte dalsecondo tipo di valutazione hanno conseguen-ze decisionali più sfumate e assumono soprat-tutto una valenza “comunicativa”. Lo scopodi tali informazioni consiste nell’offrire a sog-getti esterni a un apparato organizzativo com-plessiva delle strategie d’intervento adottatedalle amministrazioni; delle motivazioni chestanno dietro a tali strategie; delle attività rea-lizzate e dei risultati conseguiti.
Il concetto che viene richiamato più spes-so per riferirsi a questo tipo di valutazione ètrasparenza. L’ente che rende conto cerca dilegittimare, attraverso questo atto di traspa-renza, il proprio ruolo, e le attività che ha rea-lizzato, agli occhi di un pubblico esterno.Esempi tipici di questa forma di “valutazione”sono il bilancio sociale, impiegato anche da al-cune amministrazioni locali per rendere conto
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:05 Pagina 17

ai loro cittadini della gestione delle risorse lo-ro affidate, e la maggior parte dell’apparatoinformativo legato alla valutazione dei FondiStrutturali Europei.
L’utilità di questi strumenti sta soprattuttonel raccontare in maniera sintetica – con ta-belle, grafici, o semplicemente a parole – aipropri finanziatori/contribuenti/clienti/elet-tori, cosa ne è stato delle risorse messe a di-sposizione dell’ente gestore. Senza la pretesa– come a volte capita di leggere – che questoracconto riesca a penetrare le criticità degli in-terventi e, tanto meno, a stimarne gli effetti.La vera sfida consiste piuttosto nel non far sci-volare questo racconto in un’apologia apriori-stica e poco argomentata delle scelte compiu-te e nel non limitarsi a un’arida elencazionedelle attività realizzate (come purtroppo spes-so accade).
Valutare per apprendere (l’utilità delle soluzioni adottate)
Esiste un tipo di valutazione che si ispira a unalogica del tutto diversa da quelle fin qui consi-derate: si tratta della valutazione che nasce perrispondere a un’esigenza di apprendimento.
A prima vista riconoscere alla funzione diapprendimento una categoria specifica diquesta classificazione può apparire una forza-tura. In tutti gli approcci valutativi fin qui esa-minati esiste una certa volontà di apprendere.Si analizzano e si confrontano azioni alternati-ve per apprendere quale sia la scelta più ade-guata da adottare in quel contesto. Si verificaa livello gestionale la performance di un’orga-nizzazione per apprendere come farla funzio-nare meglio. Si chiede conto del raggiungi-mento da parte di un ente degli impegni as-sunti per apprendere se le risorse da questo ge-stite sono state utilizzate correttamente. Il tipodi apprendimento che caratterizza l’approcciopresentato in questo paragrafo parte però daun presupposto del tutto diverso rispetto aiprecedenti: ciò che si vuol apprendere è l’ef-fettiva capacità di una politica pubblica, giàadottata dall’amministrazione, di risolvere undeterminato problema collettivo.
Questo approccio ha una forte valenza re-trospettiva, ovvero giudica decisioni e attività
del passato (il che lo differenzia nettamentedal primo approccio presentato: valutare perscegliere); non ha come oggetto specifico diosservazione l’organizzazione, ma una politicae quindi non ha scopi direttamente gestionali(come accade nel secondo approccio: valutareper gestire); non nasce per comunicare all’e-sterno se l’utilizzo fatto delle risorse è statocongruente con gli impegni assunti (che è pro-prio del terzo approccio: valutare per rendereconto). Ma ciò che davvero distingue questoapproccio è il suo scopo finale: esso è volto afar imparare qualcosa di nuovo sull’utilità de-gli interventi pubblici. Una conoscenza cheassume valore al di fuori dei ristretti ambitinei quali la valutazione è stata concepita. Tan-to che destinatari di tale conoscenza non sonosoltanto i finanziatori della politica, o i re-sponsabili della sua gestione, ma un insiememolto più ampio di soggetti accomunati dal-l’interesse di trovare soluzione a un certo pro-blema sociale.
Tale conoscenza può riguardare due aspet-ti delle politiche: i processi d’implementazio-ne e gli effetti.
L’analisi dei processi d’implementazioneLa domanda pertinente in questo caso è: “inche modo il disegno originario della politicasi è tradotto in azioni concrete?” Tale doman-da nasce dalla consapevolezza che i processiattuativi delle politiche pubbliche sono im-prevedibili e poco controllabili dall’alto.Ogni politica deve infatti passare dallo statodi dettato normativo a quello di pratica am-ministrativa. Nella fase d’attuazione le buoneintenzioni enunciate dai decisori devono tra-dursi in azioni: le risorse devono essere utiliz-zate e spese; i servizi devono essere erogati;gli obblighi e i divieti devono essere imposti.È in questo delicato passaggio – dalla faseprescrittiva a quella delle realizzazioni – chepesano gli atteggiamenti e i modi di pensaredei singoli attori coinvolti nella messa in ope-ra dell’intervento. Essi, decidendo di percor-rere alcuni sentieri attuativi e non altri, pos-sono anche giungere a stravolgere il sensodella politica progettata a livello centrale. Avolte tale stravolgimento potrà essere il risul-tato di un’azione consapevole, pianificata da-gli stessi attori; in altre situazioni sarà sempli-
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 718
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:05 Pagina 18

cemente l’esito inatteso di un’insieme di azio-ni tra loro non coordinate, realizzate da sog-getti diversi.
Lo scopo di questa forma di valutazione èdi apprendere come, perché, in quali contesti egrazie all’azione di quali attori alcuni meccani-smi implementativi sembrano agire nel mododesiderato e altri invece no. Anche in questocaso, come nei precedenti, il giudizio valutati-vo deriva da un confronto: si raffronta la de-scrizione di come le cose sono accadute e un’in-sieme di ipotesi di come le cose sarebbero do-vute accadere. La difficoltà principale di que-sto tipo di valutazione consiste nel costruireuna documentazione empirica credibile, chevada ad alimentare questo tipo di confronto. Imetodi di indagine impiegati sono perlopiù dinatura qualitativa e la produzione di cono-scenza deriva perlopiù dall’interazione direttacon gli attori della politica, che assumono ilruolo di testimoni delle decisioni assunte e deifatti accaduti.
L’analisi degli effettiUna volta stabilito che la politica è stata im-plementata nel modo previsto, resta da ri-spondere a una domanda fondamentale: “inche misura l’intervento pubblico ha prodottogli effetti desiderati (o non ne ha prodotto diindesiderati)?” La finalità conoscitiva di que-sta forma di valutazione consiste nel capire“cosa davvero funziona”, cioè quali sono lepolitiche capaci di determinare i cambiamentivoluti in fenomeni – inquinamento, disoccu-pazione, criminalità – che la collettività perce-pisce come problemi.
L’ambizione di fondo di chi si occupa diquesto tipo di analisi è di orientare il disegnodelle politiche future verso quelle forme di in-tervento risultate più efficaci nel passato. Auna così grande ambizione fa però da con-trappeso una difficoltà altrettanto grande:quella di isolare l’effetto delle politiche dallamiriade di altri fattori che influiscono sui fe-nomeni collettivi.
Per attribuire “meriti” (o demeriti) a unapolitica pubblica occorre infatti riuscire aidentificare quei cambiamenti che si sarebbe-ro prodotti comunque anche in assenza di in-tervento. Ad esempio, prima di attribuire ilmerito dell’aumento di occupazione a un cer-
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 19
to provvedimento legislativo (o di gridare alfallimento del medesimo provvedimento nelcaso in cui si osservi un calo dell’occupazio-ne), occorre capire cosa sarebbe successo al-l’occupazione in assenza di quello stesso prov-vedimento. Sarebbe aumentata comunque?Sarebbe invece diminuita?
Questo approccio pone perciò al centrodell’attenzione una formidabile sfida cogniti-va: per stabilire quale effetto abbia avuto unapolitica pubblica, occorre trovare dei metodiper ricostruire ciò che sarebbe successo a co-loro che sono stati oggetto di quella politica(disoccupati di lungo periodo, imprese, fami-glie, città, ecc.) se non lo fossero stati. Questa èuna situazione ipotetica che in gergo viene de-finita “controfattuale”.
L’impossibilità di osservare direttamente lasituazione controfattuale genera un dilemmache non riguarda solo la valutazione delle po-litiche, ma tutta quella parte delle scienze so-ciali che tenta di inferire rapporti di causalitàdall’osservazione di fenomeni. In linea diprincipio, questo è un dilemma senza soluzio-ne. Se l’effetto di una politica è definito comela differenza tra ciò che è successo dopo l’in-tervento pubblico e ciò che sarebbe successosenza l’intervento, esso non potrà mai esseredeterminato con certezza assoluta. Tuttavianon è la certezza assoluta che tenta di ottene-re questo tipo di analisi. Essa si accontenta diuna ragionevole approssimazione. Tale ap-prossimazione potrà essere ottenuta sostituen-do al valore controfattuale un valore che siaosservabile e allo stesso tempo si accosti, nelmodo più credibile possibile, a ciò che sareb-be successo ai soggetti esposti alla politica senon lo fossero stati.
Esistono diverse strategie d’analisi checonsentono di giungere a una stima quantita-tiva degli effetti. In alcuni casi si sfruttano leinformazioni disponibili sui soggetti espostialla politica prima che la politica fosse stataadottata. Si parla in questo caso di confrontopre-post per le unità trattate. In altri casi siestraggono informazioni da soggetti che nonsono stati esposti alla politica, ma che presen-tano caratteristiche simili agli esposti. L’e-spressione che può essere impiegata per defi-nire questa famiglia di metodi è confronto traunità trattate e non trattate.
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:05 Pagina 19

LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 720
Valutare per motivare (una collettività versouno scopo comune)
Concludiamo la nostra trattazione, facendoriferimento a un approccio “spurio” alla va-lutazione. Di cosa si tratta? Fino a questo mo-mento abbiamo considerato la valutazionecome un’attività che prevede l’impiego di unastrumentazione analitica da parte di una figu-ra tecnica (il valutatore) che opera sempre al-l’esterno della politica che sta valutando. Ilcompito di tale figura consiste nel trovare unmetodo per osservare un certo interventopubblico e giungere all’espressione di un giu-dizio su qualche aspetto relativo a tale inter-vento. Egli compie il suo lavoro con distaccoe non si lascia coinvolgere dalle dinamicheche operano all’interno di quella particolarepolitica.
Talvolta però al valutatore può essere chie-sto di agire in modo più incisivo rispetto a ciòche sta “valutando” e di fornire un contributosostanziale alla formazione e alla strutturazio-ne dello stesso intervento posto sotto osserva-zione. La domanda in questi casi diventa: “co-me è possibile motivare una certa collettivitàa far proprio l’intervento e a muoversi versouna comune direzione di cambiamento?”
In tali situazioni la valutazione non ha loscopo di produrre un puntuale risultato cono-scitivo – contenuto magari all’interno di unrapporto finale di ricerca – ma è inserito al-l’interno di un processo dialogico e di rifles-sione collettiva più ampio, che prevede nume-rose interazioni e scambi con la comunità diattori a vario titolo coinvolti dall’intervento.In questa prospettiva il valutatore stesso è unattore che prende parte attiva alla messa inopera dell’attività pubblica che sta analizzan-do, immergendovisi completamente.
Nei paesi anglosassoni la corrente dipensiero che sposa in modo più convintoquesto particolare approccio prende il nomedi empowerment evaluation. L’ambizione diquesto tipo di valutazione consiste nel susci-tare tra gli attori della politica un misto di“partecipazione e motivazione” derivante dauna maggiore conoscenza dei “fatti” e fina-lizzato al raggiungimento di una finalità con-divisa. Il processo ciclico di informazione eriflessione critica messo in moto dal valuta-
tore dovrebbe indurre i soggetti coinvoltidal programma a discutere periodicamen-te, non solo su quanto è stato fatto e quan-to ancora resta da fare per raggiungere de-terminati obiettivi, ma anche se queglistessi obiettivi mantengono la loro validità,o devono essere rivisti alla luce delle nuoveinformazioni acquisite. Si tratta di un tipodi attività che nelle finalità e nelle modalitàdi svolgimento confina con l’animazionesociale.
I metodi impiegati a questo fine fannoperlopiù riferimento alla cosiddetta Ricerca-Azione (Action-Research), ovvero un model-lo di ricerca qualitativa, elaborato nell’ambi-to della psicologia sociale. La sfida principa-le consiste nel far emergere le istanze e i bi-sogni, ma anche le capacità di informazionee di riflessione insite nei componenti dellacollettività, e utilizzare tale “materiale di la-voro” per individuare inesplorati percorsi ditrasformazione sociale.
La necessità di distinguere
Probabilmente la classificazione proposta inqueste pagine non esaurisce tutti i possibilimodi di intendere e fare valutazione. Cosicome è probabile che vi siano casi concretidi valutazione che non possono essere ricon-dotti soltanto a uno degli approcci qui sin-teticamente presentati. Del resto, non rien-trava tra gli scopi di questo contributo for-nire un quadro esaustivo di tutte le attivitàdi valutazione esistenti.
Il messaggio che intendevamo lanciareera molto più modesto: ribadire che nonesiste un modo univoco di concepire la va-lutazione. Soprattutto che non esiste unasola professionalità in grado di dare rispo-sta alle molteplici esigenze conoscitive chepossono nascondersi dietro la richiesta divalutare un intervento pubblico. Chi credeche esista un valutatore tuttofare, o una va-lutazione passpartout, semplicemente si il-lude. È dunque sempre necessario distin-guere e chiarire la valutazione di cui si habisogno sulla base delle domande alle qua-li si vuol dare risposta: questa dovrebbe es-sere la regola.
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:05 Pagina 20

I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 21
Giacomo Ceruti
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:05 Pagina 21

LA VALUTAZIONE EX ANTEDEL PSR 2007-2013
DELLA REGIONE PIEMONTE
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
STEFANO AIMONE, IRES PiemonteAGATA SPAZIANTE, Politecnico di Torino,DipartimentoInterateneoTerritorio
Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) è il documento che le Regioniredigono per attingere al Feasr, il Fondo comunitario destinato alle po-litiche strutturali agricole, agroalimentari e rurali. Il Psr costituisce il
principale strumento di intervento legato al cosiddetto Secondo Pilastrodella Politica agricola comunitaria (PAC), che mira a innalzare il livello dicompetitività del settore agricolo e agroindustriale, migliorando allo stessotempo il rapporto tra agricoltura e ambiente e lo sviluppo delle aree rura-li, in particolare quelle più svantaggiate. Un elemento innovativo e carat-terizzante della nuova PAC, infatti, è la valorizzazione della “multifunzio-nalità” dell’agricoltura promuovendo politiche orientate non solo a mi-gliorarne le prestazioni produttive ma anche a svilupparne la capacità dicontribuire alla rinaturalizzazione, al recupero del paesaggio, alla riqualifi-cazione ambientale, al “presidio” del territorio rurale.
Il PSR copre il periodo di programmazione 2007-2013 e si deve correla-re con il più ampio quadro dei Fondi comunitari Fesr e Fse, da un lato, econ l’ambito complessivo delle politiche regionali, dall’altro
L’oggetto della valutazione e il mandato
Come previsto dalla normativa comunitaria – nel caso specifico l’art. 85 delRegolamento (CE) n. 1698/2005 – la redazione del PSR deve essere accom-
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 P . 2 2 - 2 6
Attraverso il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) si cercadi promuovere sia lo sviluppo agricolo che i valori
ambientali e paesaggistici del territorio. Ciò richiede diintegrare i tradizionali strumenti di valutazione ex ante di
settore con la Valutazione ambientale strategica
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:05 Pagina 22

pagnata da una Valutazione ex ante che, a par-tire dall’attuale ciclo di programmazione, de-ve anche comprendere l’esecuzione della Va-lutazione ambientale strategica (VAS) ai sensidella direttiva 2001/42/CE, come strumentointegrato a piani e programmi per garantirnela continua attenzione alla sostenibilità, dallaloro definizione fino alla verifica dei risultatiottenuti.
L’Autorità di Gestione del PSR, che fa capoalla Direzione Programmazione dell’Assesso-rato all’Agricoltura della Regione Piemonte,ha quindi incaricato l’IRES Piemonte di svolge-re il ruolo di valutatore ex ante, mentre la VAS
è stata effettuata dal Dipartimento InterateneoTerritorio del Politecnico di Torino (DITER). Ilgruppo di lavoro dell’IRES, formato da StefanoAimone (coordinatore) e Giovanna Perino, èstato integrato dalle competenze esterne ap-portate da Claudia Cominotti (R&P), RobertoResegotti (R&P) e Roberto Cagliero (I.RUR).La VAS, a sua volta, deve fare riferimento a unRapporto Ambientale, la cui realizzazione èstata curata dall’Autorità Ambientale del PSR,individuata presso la Direzione Tutela e Risa-namento Ambientale – Programmazione Ge-stione Rifiuti della Regione Piemonte. Nel loroinsieme tali soggetti hanno predisposto unostaff, allo scopo di coordinare i diversi aspettidell’attività di valutazione e di interagire effi-cacemente con l’Autorità di Gestione.
Il PSR mette in gioco circa unmiliardo di euro di spesa
pubblica ed è un Programmamolto complesso, caratterizzatoda una molteplicità di misure e
azioni e dalla necessità didefinire in modo dettagliato le
singole scelte operative eprocedurali
La domanda di valutazione
La definizione dei contenuti della Valutazioneex ante del Programma di Sviluppo Rurale
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 23
2007-2013 assume caratteristiche peculiari ri-spetto a quanto avvenuto nella precedenteprogrammazione 2000-2006. La nuova valuta-zione ex ante segue ancora più strettamentel’iter procedurale della creazione del Pro-gramma ed è funzionale sia alla stesura dellostesso sia, e questo è elemento di novità, allesuccessive attività di valutazione. Nel nuovociclo di programmazione, inoltre, assume unparticolare rilievo la necessità di assicurare lamassima integrazione strategica e operativatra il PSR e le altre politiche comunitarie, na-zionali e regionali, in particolare con quelleche hanno un rilevante contenuto ambientale.
La definizione della domanda divalutazione è quindi complessa.In estrema sintesi, si ritiene dipoterla così formulare: “in che
misura l’impianto diprogrammazione, nella sua
costruzione e nei suoi obiettivi,si dimostra adeguato alla
situazione locale, in termini difabbisogni, possibilità e scenari
alternativi?”
Il processo di valutazione, pertanto, deveaffrontare una gamma molto articolata diaspetti che vanno dall’identificazione dei fab-bisogni e degli obiettivi da raggiungere allaquantificazione degli impatti, dalla conformitàrispetto alle priorità comunitarie al recepi-mento delle raccomandazioni di valutazioniprecedenti, per finire alla qualità delle proce-dure di attuazione, sorveglianza, valutazione egestione finanziaria.
Il metodo e l’articolazione della valutazione
Per quanto concerne gli aspetti metodologici,il processo valutativo si è basato sugli schemiproposti a livello comunitario mediante ilQuadro Comune di Monitoraggio e Valuta-zione (QCMV) appositamente definito dall’U-
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:05 Pagina 23

nione Europea per i programmi di svilupporurale, applicato anche tenendo conto delleindicazioni provenienti dal Regolamento (CE)n. 1698/2005.
Un aspetto di particolare rilievo è quellodella complessità tecnica del PSR, che deveanalizzare una grande quantità di elementi dicontesto e deve raggiungere un estremo livellodi dettaglio nelle indicazioni di tipo strategicoe operativo, superiore a quello degli altri Pro-grammi legati ai fondi comunitari, con eviden-ti riflessi sull’onerosità del processo valutativo.
La valutazione ex ante del PSRdeve prendere in esame una
pluralità di questioni di naturaassai diversa
Per quanto attiene alle fonti consultate, siè fatto ricorso per gli indicatori di baseline,alle informazioni opportunamente fornitedall’Unione Europea (European Union, Di-rectorate-General for Agriculture and RuralDevelopment (2006), Rural Development InThe European Union Statistical And Econo-mic Information Report 2006). Inoltre sonostate utilizzate informazioni di fonte ISTAT re-lative ai Censimenti (Agricoltura, Industria eServizi, Popolazione) e a indagini periodichee congiunturali specifiche del settore agricoloo di carattere generale (occupazione, contieconomici regionali). Per le tematiche am-bientali si è anche fatto ricorso alle fonti Co-rine Land Cover, APAT, ARPA, IRENA. Sonostati utilizzati inoltre studi specifici svolti dal-l’INEA. Utili indicazioni sono emerse dalla Va-lutazione Intermedia del PSR 2000-2006(PROVA, 2005) e dell’iniziativa Leader (IZI-APRI). Il trattamento dei dati e l’elaborazionedegli indicatori è avvenuto in collaborazionecon il CSI-Piemonte.
La Valutazione ex ante del PSR 2007-2013della Regione Piemonte ha verificato i seguen-ti aspetti legati sia ai contenuti del Program-ma che alle sue modalità di implementazione:• l’individuazione dei problemi e dei bisogni
da affrontare, in relazione ai contenuti e
alla completezza dell’analisi di contestoproposta dal PSR;
• la definizione degli obiettivi del Program-ma e l’analisi della coerenza interna (ri-spetto ai risultati dell’analisi di contesto)ed esterna rispetto al PSN (Piano Strategi-co Nazionale) e al quadro di riferimentocomunitario;
• la rispondenza logica delle misure propo-ste rispetto agli obiettivi e al piano finan-ziario, anche tenendo conto delle risultan-ze della passata programmazione e dellepossibili interazioni, positive e negative,tra le misure stesse;
• la stima delle ricadute possibili del pro-gramma, attraverso un’apposita batteria diindicatori, mettendo anche in evidenza ca-si di potenziale conflitto tra impatti diffe-renti;
• l’analisi del “valore aggiunto comunitario”espresso attraverso il grado di sussidiarietàe di proporzionalità del programma, lacomplementarietà e le sinergie con gli altriinterventi; il perseguimento delle Prioritàcomunitarie, in particolare quelle definitea Göteborg e Lisbona e le pari opportu-nità;
• la verifica dei meccanismi di monitoraggioe valutazione previsti dal Programma, del-la corretta individuazione delle autoritàcompetenti nel rispetto delle indicazionicomunitarie e delle garanzie di efficienzaed efficacia risultanti dall’organizzazionedella gestione;
• la verifica del rispetto dei meccanismi diconcertazione definiti dalla regolamenta-zione comunitaria, relativamente al coin-volgimento delle parti economiche e socia-li, degli organismi istituzionali e degli altrisoggetti rappresentativi ma anche del“pubblico”, così come definito dalla Di-rettiva 2001/42/CE.
La valutazione ambientale strategica
L’introduzione della Valutazione AmbientaleStrategica (VAS) nel processo di programma-zione dei fondi europei costituisce una dellenovità più rilevanti del nuovo ciclo di pro-grammazione. La VAS, che si giustifica già ai
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 724
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:05 Pagina 24

sensi dell’art. 3 della direttiva 2001/42/CEconcernente la valutazione degli effetti di de-terminati piani e programmi sull’ambiente, èulteriormente opportuna in un Programma diSviluppo Rurale sia per la natura dei suoi con-tenuti (prevede infatti interventi nel settoredell’agricoltura che si stima possano avere ef-fetti anche rilevanti sull’ambiente) sia per i ca-ratteri del territorio regionale piemontese, checomprende zone di grande interesse e sensibi-lità ambientale.
Avvalendosi del Rapporto Ambientale(RA), il valutatore ambientale ha provveduto aformulare un giudizio indipendente sugli effet-ti del PSR sull’ambiente, allo scopo di fornireall’Autorità di Gestione elementi di decisioneorientati a individuare e perseguire le prioritàambientali, ad assicurare la qualità e l’efficaciadel programma anche sotto il profilo della so-stenibilità ambientale, suggerendo i provvedi-menti idonei a migliorarne le prestazioni inquesta direzione e garantendo che le decisionifinali tengano conto dei risultati del processodi partecipazione. La VAS contiene inoltre lepremesse necessarie a consentire la successivae determinante valutazione in itinere ed ex po-st, che deve garantire l’efficacia dell’attuazionedel Programma e il tempestivo intervento, nelcorso del periodo di programmazione, conmodifiche qualora ciò si rendesse necessarioper meglio conseguire gli obiettivi prefissati.
Il valutatore ha fornito elementidi decisione per individuare e
perseguire le priorità ambientali,la qualità e l’efficacia del
programma anche sotto il profilodella sostenibilità ambientale,suggerendo i provvedimentiidonei e garantendo che le
decisioni finali tengano contodei risultati del processo di
partecipazione
Anche nel caso della VAS la procedura divalutazione ha assunto il carattere dell’accom-
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 25
pagnamento continuo al processo di definizio-ne del PSR mediante la collaborazione con Au-torità di gestione, Autorità Ambientale e Va-lutatore ex ante per:• assicurare la coerenza delle strategie e de-
gli obiettivi del PSR con quelli ambientaliespressi, ai diversi livelli, da piani e pro-grammi che interessano il territorio regio-nale;
• definire le modalità corrette con cui tenereconto degli effetti ambientali del Program-ma dell’ambiente;
• rendere efficace la partecipazione alle de-cisioni dei diversi soggetti portatori di in-teressi e del pubblico;
• garantire la correttezza delle modalità concui le considerazioni ambientali che ne so-no scaturite sono state integrate nel Pro-gramma.
Problematiche emerse e riflessioni
Prendendo atto della grande articolazione edella complessità del compito da affrontare, lostaff di valutazione ha richiesto di stabilirecon l’Autorità di Gestione un rapporto dispiccata collegialità, interpretando la valuta-zione come un supporto metodologico e criti-co lungo tutto il percorso di elaborazione delPSR. Questo approccio ha portato a un’intera-zione continua, concretizzata anche dalla par-tecipazione dei valutatori ai lavori del Comi-tato Tecnico di Concezione e dei vari gruppidi lavoro da questo attivati, così come ai mo-menti di confronto con il Tavolo Tecnico diConcertazione e ai passaggi di consultazionepubblica.
Tale approccio ha quindi permesso di in-tervenire negli innumerevoli passaggi del per-corso di programmazione, offrendo elementidi analisi del contesto, riflessioni sulle strate-gie, suggerimenti provenienti da altri processivalutativi e sollecitando azioni di comunica-zione e concertazione.
Il rapporto tra valutatori e Autorità di ge-stione, per quanto positivo, non sempre è statoagevole e fluido, soprattutto a causa della diffi-cile comunicazione tra le diverse “culture”proprie dei due soggetti. In particolare, ha pe-sato una conoscenza inizialmente approssima-
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:05 Pagina 25

tiva – ma successivamente affinatasi – delle im-plicazioni causate da meccanismi valutativi piùcomplessi rispetto al passato, tali da richiederemaggiore attenzione all’articolazione e allacoerenza del processo di programmazione.
La metodologie valutativedisegnano percorsi di analisi
lineari e razionali chefaticosamente si armonizzano
con i tempi e i modi dellapolitica. A ciò si aggiungono le
difficoltà di far dialogare culturee competenze specialistiche cheappartengono a mondi diversi
Secondo le metodologie comunitarie, taleprocesso dovrebbe seguire un percorso logicolineare, che prevede il rispetto di fasi e di tem-pi di elaborazione adeguati. Tutto ciò si con-fronta faticosamente con i tempi e i modi diprocedere della politica, per loro natura più
accelerati e ricorsivi: alcune sfasature nel pro-cesso di valutazione ne sono state la conse-guenza.
Le difficoltà sono state acuite dalla parti-colare ampiezza dei temi toccati dal PSR, cherichiede una gamma di competenze tecnichedel valutatore altrettanto estesa, da un lato, emoltiplica la complessità delle relazioni tra idiversi interventi attivabili dal Programma equindi le difficoltà di dialogo tra valutatore evalutato. Inoltre, si è verificato un continuomodificare, da parte dell’Unione Europea, delQCMV, il punto di riferimento metodologicofondamentale, consolidatosi solamente a pro-cesso ormai molto avanzato, causando incer-tezza.
D’altra parte, non sono mancati i riscontripositivi. La complessa interazione tra struttu-re regionali, soggetti esterni e valutatori hacreato una rete di relazioni e di conoscenze digrande valore, ha permesso di consolidaremetodologie di nuova introduzione e ha con-tribuito a rendere più trasparente e coerenteil processo di programmazione del PSR, met-tendo le basi per un più proficuo ed efficacerapporto tra valutazione e attuazione del Pro-gramma nel suo percorso di implementazione
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 726
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:05 Pagina 26

LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
VALUTARE GLI IMPATTIAMBIENTALI DELLEINFRASTRUTTURE:
LA RETE DEI GRANDIELETTRODOTTI IN
PIEMONTE
SERGIO GIACCARIA, Dipartimento diEconomia,Università diTorino
Lo studio che viene qui presentato valuta le esternalità ambientali derivantidalla rete di trasmissione dell’energia elettrica. L’indagine, commissionatadalla Regione Piemonte e svolta dal Dipartimento di Economia dell’Univer-
sità di Torino fa parte di un più ampio progetto di ricerca (“Implementazione diuno strumento per la valutazione economica delle esternalità ambientali correlatea infrastrutture campione, quale strumento di supporto a decisioni pubbliche”)svolto tra il 2005 e il 2007. Del gruppo che ha lavorato alla ricerca hanno fatto par-te Ugo Colombino, Silvana Dalmazzone, Vito Frontuto, Sergio Giaccaria. Tale in-dagine ha avuto come obiettivo la determinazione di stime monetarie delle ester-nalità ambientali: indicatori del danno percepito dalla popolazione residente inprossimità delle linee di elettrodotto. Sono state considerate le linee che servono altrasporto dell’energia su lunghe distanze, ad alta e altissima tensione (132, 220 e380 Kv). Di seguito viene introdotta la tecnica di valutazione utilizzata nello studio:il metodo della valutazione contingente. I successivi paragrafi precisano meglio ladomanda di valutazione, ossia quali tipologie di esternalità sono considerate nel-l’indagine e l’impostazione dello studio e poi trattano dell’analisi e dei risultati. Inconclusione vengono trattati i possibili modi di utilizzo degli indicatori monetaridelle esternalità come supporto alla decisione nei problemi di localizzazione deitracciati o della predisposizione di misure compensative dirette a enti territoriali ecomunità di residenti
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 P . 2 7 - 3 1
Nella programmazione e nella scelta tra progettiinfrastrutturali, lo studio di fattibilità tecnica ed economica
è sempre più spesso accompagnato da indagini econsiderazioni per gli aspetti legati alla compatibilità
dell’opera con l’ambiente; si tratta di prevedere e stimarequali potranno essere gli effetti indesiderati conseguenti alla
costruzione dell’infrastruttura (al di là dello scopo direttoper la quale è realizzata)
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:05 Pagina 27

Molti progetti comportano impatti impor-tanti sulla qualità e sulla quantità dei serviziche l’ambiente fornisce alla collettività. Inol-tre, nel caso di grandi opere accade spesso chegli impatti ambientali siano concentrati nelleimmediate vicinanze dell’infrastruttura, gra-vando sulle comunità locali, che fruiscono deibenefici che invece l’infrastruttura produce auna scala regionale o nazionale.
Le procedure di valutazione di impattoambientale, così come quella dell’incidenzaecologica, sono strumenti che comunementeinformano e dovrebbero regolare il processodi autorizzazione delle opere pubbliche. Neicasi di infrastrutture che presentano impattiambientali rilevanti, o che coinvolgono partidi territorio soggette a misure di protezioneambientale o riconosciute come aree partico-larmente vulnerabili dal punto di vista degliassetti ecologici, l’applicazione di questi stru-menti diventa più stringente e vincolante.
L’indagine ha avuto comeobiettivo la determinazione di
stime monetarie delle esternalitàambientali: indicatori del danno
percepito dalla popolazioneresidente in prossimità delle
linee di elettrodotto
Le risorse ambientali del territorio, anchenelle aree in cui non sono presenti elementi diunicità o particolare pregio, sono utili e dispo-nibili in quantità limitate, e sono a tutti gli ef-fetti beni (o servizi) economici, anche se spes-so il loro valore può non essere direttamentecontabilizzato attraverso un sistema comequello dei prezzi mercato, o attraverso formedi regolamentazione nell’assegnazione di dirit-ti d’uso.
Un atteggiamento di cautela nella gestionedelle risorse ambientali dovrebbe orientare l’a-nalisi economica della fattibilità dell’opera: ovepresenti, andrebbero individuate e riconosciutele esternalità ambientali, cioè quei flussi di be-nefici (costi) latenti, meno leggibili a causa del-la mancanza di prezzi o compensazioni.
Risorse ambientali e mercati ipotetici
La valutazione contingente mira a determina-re delle stime del valore che i cittadini attri-buiscono a un bene o servizio in assenza di unmeccanismo di mercato. Un modo per stimareil valore monetario, ad esempio nel caso di undanno o una perdita di qualità ambientale,consiste nel ricreare sperimentalmente, all’in-terno di un contesto simulato, dei meccanismisimili a quello del mercato, in cui gli individuiesprimono una valutazione implicita manife-stando le loro preferenze e rivelando attraver-so queste preferenze una disponibilità a paga-re. Il termine inglese contingent è inteso comeriferimento all’ipoteticità dello scenario usatocome strumento per rilevare le disponibilità apagare (meno frequentemente, in alternativaal criterio della disponibilità a pagare si utiliz-za il criterio della disponibilità ad accettarecompensazione).
Le preferenze individuali vengono di soli-to raccolte tramite interviste. Il rispondenteviene gradualmente introdotto a uno scenarioche descrive accuratamente la variazione diquantità/qualità ambientali oggetto della valu-tazione. A seconda di come viene disegnato ilmeccanismo che simula il pagamento, la di-sponibilità a pagare può essere espressa comesomma che il rispondente pagherebbe per ac-cedere a un miglioramento nel bene o servizioambientale, o piuttosto per la sua conserva-zione.
Un punto debole del metodo risiede pro-prio nell’ipoteticità della scelta. Preferenzeespresse attraverso il contesto sperimentalepotrebbero non corrispondere al comporta-mento, e quindi alle disponibilità a pagarereali dell’individuo. La distorsione da ipoteti-cità, così come molte altre possibili fonti dicondizionamento delle stime della disponibi-lità a pagare sono state oggetto di un ampio fi-lone di studi, che negli anni ottanta e novantasi è dedicato a ricercare modi per consolidaree validare il metodo attraverso la ricerca em-pirica. Schematizzando in breve i diversi passiper realizzare un’indagine di valutazione con-tingente, è necessario:• delineare con precisione quale sia il bene
o servizio oggetto della valutazione; • individuare i “valutatori”, cioè dei gruppi
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 728
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:05 Pagina 28

di cittadini di cui rilevare le preferenze inbase alla relazione che essi hanno con ilbene oggetto della valutazione (ad esem-pio fruitori diretti, potenziali, non fruitori,ecc.);
• estrarre un campione statistico rappresen-tativo dei gruppi individuati;
• comporre un questionario;• testare il questionario su una frazione suf-
ficientemente ampia del campione com-plessivo;
• avviare la fase di raccolta tramite intervistedirette, guidate, telefoniche o postali;
• condurre le analisi statistico-econometricheper la stima delle disponibilità a pagare.
Nel prossimo paragrafo riportiamo la de-scrizione di queste diverse fasi operative al-l’indagine condotta sulla rete degli elettrodot-ti in Piemonte.
La valutazione contingentemira a stimare il valore
che i cittadini attribuisconoa un bene o servizio
in assenza di un meccanismodi mercato
Cosa valutare?
L’indagine è stata costruita per determinare ilvalore monetario di diverse tipologie di ester-nalità relative agli impatti più direttamentepercepibili da cittadini residenti nelle imme-diate vicinanze delle maggiori linee di elettro-dotto (quelle con tensione di esercizio di 132,220 e 380 Kv). I principali tipi di esternalitàriguardano:• il danno connesso alla percezione di un in-
cremento del rischio per la salute dellepersone;
• esternalità connesse all’ingombro visivo,quindi al danno in termini paesaggistici;
• esternalità relative a impatti sulla fauna ela flora;
• il danno inteso come deprezzamento delleproprietà immobiliari.
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 29
La popolazione e il disegno del campionestatistico
La familiarità con il tipo di impatto ha guida-to la scelta della popolazione di riferimento. Ilgruppo identificato è quello dei residenti auna distanza inferiore ai 600 metri da tutte lelinee con tensione di esercizio pari a 132, 220e 380 Kv. Il totale stimato della popolazioneresidente all’interno del corridoio della retedegli elettrodotti della regione Piemonte am-monta a circa 2.613.000 abitanti. All’internodi questo gruppo 1.459 nuclei familiari sonostati raggiunti attraverso intervista telefonica.Nel territorio regionale sono state identificatedelle aree di dimensione inferiore, e il cam-pione è stato stratificato in base alla dimensio-ne demografica di queste sottozone regionalidenominate macroaree.
Scenario e mezzo di pagamento per lavalutazione delle disponibilità a pagare
Nel questionario sono state inserite diversedomande finalizzate ad avere una maggioreconoscenza dell’importanza che l’intervistatoattribuiva alle diverse tipologie di esternalità.Lo scenario ipotetico adottato ha descrittouna situazione in cui si prefigurava un pianoregionale per l’ammodernamento della rete.Una politica simile è effettivamente in atto at-traverso la realizzazione di interventi di inter-ramento soprattutto nell’area metropolitana ein adiacenza di grandi centrali, ma venivachiarita comunque la natura ipotetica delloscenario.
Veniva poi chiesto all’intervistato se, nelcaso di una consultazione referendaria, sareb-be stato disponibile a votare a favore di questopiano, se nel comune dell’intervistato avrebbecomportato la rimozione della linea di elettro-dotto vicina alla sua casa. La variazione di uti-lità proposta era quindi un miglioramento le-gato alla scomparsa delle esternalità negativedell’infrastruttura, in cambio della quale siprecisava che parte dei costi della rimozioneavrebbero gravato sulle famiglie residenti nelcomune, attraverso l’imposizione di una tassacomunale una-tantum, necessaria a sostenerealmeno in parte i costi dell’intervento. Il mer-
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:05 Pagina 29

cato prefigurato è quindi un mercato di tipopolitico (una votazione) e le disponibilità a pa-gare vengono espresse in termini di accetta-zione o rifiuto di questa tassa, adottata comemezzo di pagamento.
La domanda attraverso cui si indaga sulladisponibilità a pagare si presenta qui in un for-mato dicotomico: al rispondente viene cioèproposto un ammontare che lui può accettareo rifiutarsi di pagare. In ogni intervista la do-manda di elicitazione delle disponibilità a pa-gare è stata ripetuta incrementando o ridu-cendo il valore iniziale a seconda che la primarisposta fosse affermativa o negativa).
Il mercato prefigurato è unmercato di tipo politico (unavotazione) e le disponibilità apagare vengono espresse in
termini di accettazione o rifiutodi una tassa, adottata come
mezzo di pagamento
Il testo del questionario è stato scritto te-nendo conto del fatto che l’indagine serviva astimare tipi di esternalità qualitativamentedifferenti. In tal modo, presentando il mezzodi pagamento, sono stati usati valori moneta-ri differenziati a seconda delle risposte chel’intervistato ha fornito nella fase iniziale del-l’intervista. A individui che hanno dichiaratodi percepire una forma di danno particolar-mente rilevante, dovuta a un forte deprezza-mento dell’immobile sono state presentate se-rie di valori monetari più ampie e su ordini digrandezza più elevati, mentre agli intervistatiche hanno segnalato di essere infastiditi dal-l’infrastruttura in relazione a impatti visivi eambientali, ma non in modo particolarmentegrave, sono stati riservati vettori prezzo piùbassi e ristretti. In questo modo, le stime deldanno sono state condotte separatamente cal-colando valori specifici, separando dal restodel campione i rispondenti che dichiaravanodisponibilità molto elevate a causa di formegravi di deprezzamento delle loro proprietàimmobiliari.
I risultati dell’analisi econometrica e lestime della disponibilità a pagare
Il formato referendario, nella fase di analisidei dati, viene trattato attraverso un modelloeconometrico: quello usato per lo studio con-sidera le probabilità di risposte positive comeindicatore della attrattività dello scenario pre-sentato nell’intervista. Le caratteristiche chehanno un effetto nello spiegare le variazioni diutilità dei rispondenti vengono utilizzate dalmodello per interpretare le preferenze. L’o-biettivo è quello di individuare le caratteristi-che che hanno un effetto nello spiegare lastruttura delle preferenze, quindi di far emer-gere l’importanza che il cambiamento am-bientale e diverse altre possibili variabili han-no nel determinare variazioni nel livello di be-nessere individuale.
I modelli più semplici considerano comevariabili esplicative la variazione dello scena-rio ambientale (la rimozione dell’elettrodotto)e la variazione del reddito familiare conse-guente al pagamento della tassa. Queste pri-me analisi attribuiscono al danno ordinario eintermedio valori medi per nucleo familiare ri-spettivamente di 186 euro e 563 euro. I ri-spondenti che invece dichiarano un dannograve in relazione alla perdita di valore immo-biliare per la vicinanza all’elettrodotto, pre-sentano una disponibilità a pagare media di3.753 euro. Altre analisi hanno permesso diinserire all’interno del modello un maggiornumero di variabili, permettendo di stimaredei valori monetari del danno differenti infunzione di alcune caratteristiche del contestoterritoriale, della distanza fisica dall’infrastrut-tura e del tipo di esternalità che prevale nellapercezione dei rispondenti.
Conclusioni
In Italia la disponibilità di queste stime èestremamente ridotta, e i risultati propostisono rappresentativi in modo specifico dellarealtà regionale. Le esternalità rilevate da unsingolo nucleo familiare possono essere con-tabilizzate attraverso gli indicatori delle di-sponibilità a pagare che abbiamo stimato;questi vanno letti come valori medi, per con-
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 730
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:05 Pagina 30

durre ad esempio applicazioni di analisi co-sti-benefici nello studio della fattibilità dinuove tratte di elettrodotto. Gli stessi indi-catori si prestano come parametro di riferi-
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 31
mento per le stime puntuali del danno e neicasi in cui si prevedano misure compensati-ve di tipo monetario alle famiglie o agli entiterritoriali.
Orazio Borgianni
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:05 Pagina 31

LA DECISIONE NEIPROCESSI DI VALUTAZIONEE SELEZIONE DEI PROGETTI:
UN’ANALISI DELLEPROCEDURE ADOTTATE
DALLA REGIONE PIEMONTE
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
MARIA FRANCA
NORESE,Politecnicodi TorinoVALENTINA TORTA,NUVAL Piemonte
L’idea di ricostruire e sottoporre a un’analisi comparata i processi divalutazione e selezione dei progetti della Regione Piemonte nasceda alcune considerazioni che, in estrema sintesi, coincidono con le
seguenti osservazioni: gran parte delle politiche non puramente regolativeinglobano attività di valutazione e selezione di progetti; non da molto nor-me sul tema hanno interessato la pubblica amministrazione; le risorse co-noscitive assumono un ruolo importante nei processi di “assemblaggio”degli interventi pubblici, ma non sempre sono disponibili e facilmente re-peribili. Talvolta le azioni di finanziamento possono risultare molto com-plesse e la loro attuazione problematica mentre, in taluni casi, alla valuta-zione/selezione è attribuito un ruolo marginale rispetto alle altre fasi delprocesso, quasi costituisse una mera procedura “burocratica” conclusivadelle precedenti
Una “buona attività di valutazione/selezione” contribuisce invece alsuccesso del programma e dovrebbe essere considerata “centrale” nel pro-cesso d’attuazione o perlomeno strettamente interrelata con le altre attività.Essa dovrebbe costituire una sorta di filo conduttore tra le varie fasi: una
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 P . 3 2 - 3 9
La Regione è per sua natura un “ente intermediatore”, chenon eroga servizi finali ma, tendenzialmente, opera come
distributore di risorse pubbliche ad altri soggetti. L’attivitàdi selezione di progetti e iniziative da ammettere a
finanziamento assume pertanto uno spazio e una rilevanzadi primaria importanza
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:05 Pagina 32

buona valutazione/selezione è possibile solose nelle fasi precedenti gli obbiettivi sono sta-ti fissati in modo da permettere una buonastrutturazione del modello valutativo. L’atti-vità di selezione facilita la realizzazione degliobbiettivi fissati in precedenza e dovrebbe di-ventare il punto di partenza per successiveanalisi, volte al miglioramento del processo,fornendo informazioni che facilitano il moni-toraggio dei progetti in fase di realizzazione ecompletamento. Si innesca, così, un processodi miglioramento continuo che si realizza at-traverso l’apprendimento e l’acquisizione dinuove competenze, dove la procedura di va-lutazione/selezione precedente permette dimigliorare la successiva, ma anche la defini-zione dei bandi e in certi casi la programma-zione degli interventi pubblici.
In certe situazioni le competenze già ac-quisite e la tipologia delle procedure facilitanoquesto processo di continuo miglioramento,in altre il percorso è più difficile e può esserefacilitato dal confronto con le diverse realtàgeneratesi nell’organizzazione. Spesso però isoggetti che ricoprono un ruolo decisionalecambiano, disperdendo le competenze acqui-site, oppure tempi e budget ridotti non per-mettono di migliorare i modelli di valutazionee le procedure di valutazione/selezione deiprogetti. Per questo motivo è auspicabile con-solidare le competenze acquisite e rendere di-sponibili agli altri questi elementi di cono-scenza, sia su come rendere sempre più ade-guate le procedure di valutazione/selezionedei progetti, sia su come integrarle e correlar-le con le altre fasi del processo di attuazionedegli interventi pubblici.
Com’è nata l’analisi
L’esigenza di avviare un’indagine esplorativasulle attività di valutazione e selezione deiprogetti nasce con l’istituzione del Nucleo diValutazione e Verifica degli Investimenti Pub-blici della Regione Piemonte (di seguito NU-VAL), con l’intento di acquisire una conoscen-za strutturata di quanto prodotto nella messain opera delle azioni di finanziamento chehanno interessato la Regione e di renderla di-sponibile. Il lavoro prende avvio nel 2003 da
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 33
un’analisi commissionata al Master in Analisidelle Politiche Pubbliche (MAPP) dell’Uni-versità di Torino e si sviluppa nell’ambito del-la collaborazione con lo staff di consulenzatecnica della struttura.
Il NUVAL era interessato a capire quali era-no le competenze sviluppate dall’amministra-zione regionale in termini di valutazione e se-lezione dei progetti e quali carenze erano an-cora presenti e meritavano un intervento disupporto del nucleo. Ha ritenuto così cheun’analisi finalizzata alla lettura trasversaledelle modalità con cui venivano concesse sov-venzioni, contributi o vantaggi economici diqualunque genere, a persone ed enti pubblicie privati, potesse generare un buon numero diconoscenze ed essere seguita da momenti diriflessione che facilitassero o lo scambio dellebuone pratiche o l’approfondimento di quan-to si riteneva necessario per il perfezionamen-to dell’attività valutativa e il miglioramentodelle procedure in cui è inserita.
L’oggetto d’indagine e gli aspettimetodologici
Le principali problematiche associate alla va-lutazione e selezione dei progetti sono stateanalizzate con riferimento a 57 azioni di finan-ziamento che hanno interessato la Regionenell’anno 2003 e con il contributo di chi vi haoperato direttamente. Le azioni si riferisconoalle norme settoriali più importanti e agli stru-menti messi in atto con la programmazionecomunitaria del periodo 2000-2006. L’aread’osservazione è rappresentata dalle azioni de-stinate ai soggetti privati, alle imprese, agli en-ti pubblici o ai soggetti istituzionali (per la so-la realizzazione di infrastrutture volte al mi-glioramento delle criticità presenti in una dataarea che possono avere un’influenza direttasul sistema economico) e ai finanziamenti nelcampo della formazione professionale, dellosport, dell’istruzione, della cultura e dellospettacolo, dell’edilizia residenziale e dell’as-sistenza, che spesso rientrano in piani e pro-grammi a carattere pluriennale. La richiestadel Nucleo ha imposto dapprima un’analisidella situazione in cui intervenire e una disa-mina degli strumenti di Aiuto alla Decisione
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:05 Pagina 33

utilizzabili. Date le scarse risorse conoscitive adisposizione nell’organizzazione sulle proce-dure di valutazione e selezione adottate, l’ana-lisi doveva affrontare una situazione poco no-ta e complessa (soprattutto per la molteplicitàdei punti di vista da analizzare). Si è perciòdeciso di ricorrere a strumenti rivolti a identi-ficare le caratteristiche e la complessità del“contesto” e a strutturare un modello per de-scriverlo nella sua globalità e per aiutare a sce-gliere gli strumenti logici e matematici (in par-ticolare dell’Analisi Multicriteri) da adottarenelle specifiche situazioni. In questi casi l’ana-lisi è condotta con l’ausilio di schemi di rap-presentazione della conoscenza che si sta ac-quisendo sul problema, sul “contesto” e sulprocesso, con l’intento di riassumere e strut-turare gli elementi di conoscenza via via ac-quisiti, permettere il trasferimento e la condi-visione (mutuo apprendimento e convalida) efacilitare la progettazione (condivisa) dei pas-si successivi. La richiesta è stata poi formulatain termini operativi, traducendola nella realiz-zazione di un’analisi trasversale delle proce-dure di valutazione/selezione adottate in ungruppo di azioni di finanziamento e in un’a-nalisi dei processi in cui le procedure sono in-serite, nel tentativo di rispondere alle seguen-ti domande: quali sono le procedure e le moda-lità di selezione dei progetti che vengono adot-tate in Regione Piemonte? Sono riconducibili a“famiglie”? Quando e con che frequenza vengo-no adottate? Esistono esperienze significative,possibili miglioramenti o necessità di approfon-dimenti? Quali sono i processi di attuazione incui le procedure sono inserite? Sono anch’essiriconducibili a “famiglie”? Il problema princi-pale non era distinguere tra approcci di elabo-razione di procedure “buoni” o “cattivi” matra situazioni più o meno complesse in cui lanecessità di decidere si deve tradurre in rego-le e modelli di valutazione .
Per questo è stato dapprima necessariocompiere una scelta delle azioni di finanzia-mento da prendere in esame, tra le tante adot-tate dall’amministrazione, e delle fonti da cuireperire le informazioni. La scelta delle azioniè avvenuta con l’ausilio delle conoscenze pre-senti nella struttura e con la precisa volontà dinon coprire l’universo dei finanziamenti re-gionali, né di ottenere un campione statistica-
mente significativo ma piuttosto di disporre diun gruppo di azioni espressive (in termini diimpegno organizzativo e/o finanziario) dell’o-perato regionale e sufficientemente diversifi-cate, sia in relazione alle loro caratteristiche(destinatari e frequenza d’adozione) che al lo-ro processo di attuazione, privilegiando ovvia-mente le differenze. A seguito di una primacernita sono state escluse quelle destinateprincipalmente alla realizzazione di operepubbliche, per il cui finanziamento la Regio-ne solitamente predispone piani di interventoe ne delega l’attuazione agli enti locali, confrequenza continua o il più delle volte legataalla disponibilità finanziarie presenti in un da-to momento (frequente è l’adozione di PianiStralcio a budget prefissato), o adotta i recen-ti strumenti della programmazione negoziata.Proprio l’esistenza di logiche e di procedurediverse ha reso più appropriata una trattazio-ne separata del comparto.
È attraverso i bandi che sicomunicano ai soggetti
interessati gli obiettivi fissatidall’amministrazione e sono glistessi criteri di valutazione che,
esplicitando e riflettendo gliobiettivi che si intende
perseguire, diventano unostrumento di comunicazione
attiva
Le prime informazioni sono state raccolteleggendo i bandi e i documenti di program-mazione collegati. La scelta di utilizzare i ban-di è stata una precisa richiesta del responsabi-le del Nucleo, nella consapevolezza che la fasedi redazione e comunicazione delle forme disollecitazione all’esterno (bandi/inviti) assu-messe un ruolo importante per la valutazio-ne/selezione dei progetti. Infatti è attraverso ibandi che si comunicano ai soggetti interessa-ti gli obiettivi fissati dall’amministrazione e so-no gli stessi criteri di valutazione che, esplici-tando e riflettendo gli obiettivi che si intende
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 734
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:05 Pagina 34

perseguire, diventano uno strumento di co-municazione attiva.. Inoltre i bandi, approvatidirettamente dall’esecutivo regionale, sono fa-cilmente reperibili consultando o il BollettinoUfficiale o le pagine web regionali. La sceltadi utilizzare informazioni pubbliche ha per-messo di non “caricare” di richieste informati-ve le strutture regionali ma di coinvolgerle so-lo in un secondo momento, per “validare” leinformazioni acquisite e arricchire le cono-scenze con informazioni reali di processo.
La lettura dei bandi ha permesso di identi-ficare una scelta delle voci, considerate rap-presentative dell’operato regionale, e di strut-turarle in un modello di sintesi per ogni azio-ne di finanziamento. Il modello è costituito datre parti, costruite in modo da permettere di-versi livelli di lettura (veloce o approfondita):• la prima parte descrive le caratteristiche
generali dell’azione di finanziamento, ilcontesto programmatico di riferimento, leinformazioni relative alla fase di program-mazione dell’azione;
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 35
• la seconda è relativa al processo di attua-zione, di cui si è elaborata una rappresen-tazione sintetica. Per evidenziare le diversefasi dell’iter processuale si è provveduto arilevare nella documentazione esaminata leattività ricorrenti. Quando si è riscontratal’esistenza di più attività collegate tra loroe facilmente riferibili a una fase dell’iter,per l’oggetto o per la successione tempo-rale, si è cominciato a definirle e a rappre-sentarle, come “procedure strutturate”, inuno schema (Fig. 1) che sintetizza la se-quenza delle attività e procedure (nei ri-quadri), il/i soggetto/i che le sviluppa/no(a destra di attività e procedure), i vincolidi sequenza espressi mediante le frecceverticali e quelli temporali (a sinistra di at-tività e procedure). L’attività connessa al-l’espressione di pareri ad opera di organi-smi esterni al sistema regionale, o internima appartenenti a partizioni amministrati-ve diverse da quella che gestisce le attivitàprincipali dell’azione di finanziamento, è
Fig. 1 Esempio di rappresentazione del processo di attuazione di un’azione di finanziamento
Programmazione operativa/Attuazione del programma
Attività e procedure
Giunta settore
Raccolta delle proposte Settore(15.09.03-17.11.03)
periodica
Verifica normale SettoreEntro 90 giorni dalla scadenza
della presentazione
Istanze da presentare entro 60giorni dalla comunicazione
dell’ammissione
Comitato Provinciale Coni vs.Comitato Regionale Coni e
Federazione Italiana Sport Disabili
Valutazione selezione SettoreParere
Approvazione graduatorie/Ammissione a finanziamento
Giunta/Settore
Raccolta istanze concessione del finanziamento
Finpiemonte Istituto per il Credito Sportivo
Liquidazione e controlloFinpiemonte Istituto per il Credito Sportivo
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:05 Pagina 35

stata riportata a lato delle attività principa-li (a sinistra, con i vincoli temporali).
• la terza parte fornisce informazioni di ca-rattere generale e di dettaglio in merito al-la procedura di valutazione/selezione.Contiene una sintesi delle attività previste,la situazione progettuale (numero di pro-poste presentate, ammesse e finanziate,con l’indicazione delle motivazioni chehanno portato all’esclusione di quelle nonammesse) e le caratteristiche organizzativeconnesse alle attività (tempistica, oggetto,soggetto coinvolto e osservazioni dei re-sponsabili). Entra poi nel dettaglio dellesingole attività specificando: le disposizio-ni di riferimento, il modello di valutazioneindicato nel bando, le modalità di defini-zione e di aggregazione dei giudizi, le re-gole seguite nella selezione e nella riparti-zione delle proposte, la tipologia di risul-tato ottenuto con l’indicazione delle even-tuali regole di finanziamento adottate.
Le 57 schede di sintesi, prodotte con rife-rimento al modello descritto, sono state verifi-cate attraverso 25 interviste con i responsabiliregionali sfruttando sia i contatti in capo alNucleo (la rete dei testimoni privilegiati ècomposta dai membri del Comitato di Indiriz-zo del Nucleo e dalle persone coinvolte in unaprima Tavola rotonda sui temi della valutazio-ne nel 2002) che al settore Programmazioneregionale (persone coinvolte nella redazionedel Documento di programmazione economi-ca-finanziaria regionale). Le interviste hannopermesso di raccogliere informazioni reali diprocesso, tener conto dell’evoluzione delleazioni di finanziamento e rappresentare quellein divenire. Sono state realizzate proponendol’analisi delle schede prodotte e seguendo unatraccia “degli obiettivi del colloquio” sottopo-sta preventivamente alla struttura. Si è cercatodi fissarne una sola nell’arco di una stessagiornata e della durata massima di un’ora emezza. Solo dopo la trascrizione del contenu-to dell’intervista si è passati alla modifica e al-l’integrazione delle relative schede.
Per descrivere in modo sintetico la com-plessità associata ai diversi processi e ai “con-testi” in cui si sviluppano si è fatto ricorso aun altro tipo di rappresentazione che permet-
tesse di far emergere sia gli attori coinvolti cheil tipo delle relazioni che intercorrono tra lo-ro. Nella costruzione dello schema è stata mu-tuata una metodologia di “problem formula-tion”, in cui il sistema attoriale e le sue rela-zioni sono espresse graficamente con le nota-zioni indicate in figura 2 e qui proposte conun esempio relativo all’azione di finanziamen-to di figura 1.
L’esempio si riferisce a un processo gestitodal sistema regionale. Nello svolgimento delleattività di valutazione/selezione il sistema è te-nuto a interagire con almeno una strutturaesterna (Comitato provinciale CONI) che a suavolta interloquisce con altre partizioni territo-riali (Comitato regionale CONI e/o Federazio-ne italiana sport disabili). Le strutture sonochiamate a esprimere un parere in merito alleiniziative proposte (il giudizio verte per lo piùsulla conformità della proposta ad aspettinormativi). La particolarità del processo pro-posto è rappresentata dalla previsione di atti-vità di raccolta e di finanziamento differenzia-te in funzione della tipologia del proponente(soggetti con personalità giuridica in un casoe soggetti senza personalità giuridica nell’al-tro). Nello specifico, le attività di finanzia-mento prevedono il coinvolgimento di altridue sistemi attoriali (l’istituto per il creditosportivo in un caso e l’ente strumentale regio-nale nell’altro).
I principali risultati
I risultati generati dall’analisi sono di varia na-tura. Il primo nasce dal tentativo di giungere auna sistemazione terminologica delle attivitàrinvenibili nelle procedure di valutazione e se-lezione, cercando di ricorrere alle espressioniutilizzate nei bandi ma riducendo le voci di-verse usate per esprimere lo stesso significatoa quella che risulta più corretta, in relazione allinguaggio di contesto e alla letteratura di set-tore. La terminologia è stata ricondotta a cin-que voci:• verifica [di ammissibilità] formale;• verifica di conformità;• valutazione di merito;• selezione;• ordinamento.
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 736
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:05 Pagina 36

Particolarmente problematica ma impor-tante dal punto di vista operativo è la distin-zione tra la verifica di conformità formale e lavalutazione di merito.
Il secondo risultato consiste nell’identifi-cazione di quattro tipologie di base a diversi li-velli di complessità procedurale, con la descri-zione degli elementi che possono differenziar-le e delle azioni di finanziamento in cui sonoadottate. Appartengono alla prima tipologia leprocedure in cui viene operata esclusivamenteuna verifica dei requisiti formali indicati dalbando o quelle in cui viene anche prodotto unordinamento delle proposte che, in assenza diuna valutazione di merito, viene espresso o intermini di ordine di arrivo (“ordine cronologi-co di arrivo” o “protocollo”) o mediante un’e-strazione a sorte. Appartengono alla secondatipologia le procedure che vedono il decisoreimpegnato nella valutazione e nell’ordinamen-to dei progetti ma non nell’espressione di ungiudizio di non ammissibilità delle proposte(fatte salve le carenze di ordine formale) fina-lizzato alla selezione. Rispetto alle precedenti,
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 37
la terza tipologia si differenzia perché il deci-sore è impegnato in un’attività di selezionedelle proposte, operata tramite un giudizio(del settore o avvalendosi di un gruppo di tec-nici) o attraverso un’esclusione analitica, resaoperativa nel modello di valutazione. La quar-ta e ultima tipologia prevede modalità di valu-tazione/selezione simili alle precedenti, ma leadotta più volte e in modo combinato. In que-sti casi avviene almeno un cambiamento del-l’oggetto della valutazione/selezione (doman-de o progetti a diversi livelli di definizione, in-cluse le idee progetto) nel corso della proce-dura.
Infine, partendo dall’analisi delle variabilidi “contesto” e di processo sintetizzate neglischemi relativi al sistema attoriale, è stato pos-sibile identificare livelli distinti di complessitàprocessuale e organizzativa a cui sono associa-bili le azioni esaminate. Le caratteristiche del-le singole attività di valutazione /selezione so-no state poi studiate nei dettagli e legate criti-camente agli elementi di complessità dei pro-cessi in cui sono incluse. Ad ogni procedura è
Fig. 2 Esempio di rappresentazione del sistema attoriale e delle relazioni connesse a un’azione di finanziamento
Sistemaregionale
SistemaFinpiemonte
soggetti conpersonalità giuridica
soggetti senzapersonalità giuridicaSETTORE
COMITATO PROVINCIALE CONI
COMITATO REGIONALE CONI
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILI
ISTITUTO PERIL CREDITOSPORTIVO
sistema
sottosistema associato alla fasedi programmazione operativa
sottosistema attivo anche se nonformalizzato nel bando
funzione di pagamento econtrollo
proponente
presentazione di proposte ecomunicazioni (“esterno vs. interno”)
comunicazioni in merito all’ammissibilità(“interno vs. esterno”)
richiesta o espressione di un parere/giudizio
richiesta e espressione di un parere/giudizio
collaborazione a livello operativo o strategico
richiesta di integrazioni e comunicazioni(“sistema-esterno”)
Legenda:
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:05 Pagina 37

stata associata una scheda di analisi dei puntidi forza e di debolezza del modello valutativoe delle attività valutative e di selezione.
La disponibilità di questi elementi di co-noscenza ha consentito di approfondire l’ana-lisi delle procedure di valutazione e selezionedei progetti con un modello e un metodo mul-ticriteri, assegnando ciascuna procedura a unaspecifica classe di complessità processuale-or-ganizzativa e procedurale. Questo risultatopotrebbe dimostrarsi utile in futuro permet-tendo di tradurre in un modello analogo ogniprocedura nuova, prima di definirne nei det-tagli la sequenza delle attività e i contenuti.Utilizzando lo stesso metodo diventa possibileidentificare la classe di appartenenza dellanuova procedura e sapere quali altre, con ca-ratteristiche analoghe, sono già state sviluppa-te in Regione. Con le schede di descrizionestrutturata delle procedure e delle fonti infor-mative che le hanno prodotte e testate, diven-ta facile analizzarne i contenuti, la struttura egli elementi di forza e debolezza ed è possibi-le attivare relazioni che permettano di acquisi-re una conoscenza diretta dei risultati, delledifficoltà incontrate e delle strategie adottateper limitarne gli effetti.
Conclusioni e spunti di riflessione
A fronte delle difficoltà interpretative dei ban-di regionali, generate dall’uso di accezioni ter-minologiche molto diverse e dalle differentimodalità di redazione dei programmi, si è ri-scontrata una buona diffusione dell’informa-zione in merito alle azioni di finanziamentopromosse dall’ente e ai criteri di valutazioneutilizzati.
Le conoscenze acquisite hanno permessodi proporre, oltre alla rilettura strutturata dinumerosi processi di valutazione e selezionedei progetti, anche una strutturazione deglielementi di cambiamento che hanno interes-sato la messa in opera delle azioni di finanzia-mento prese in esame, le problematiche chesono ancora presenti e le soluzioni adottatedall’organizzazione nel tentativo di ridurle.Buona è stata la risposta dei responsabili re-gionali all’iniziativa avviata dal Nucleo e note-vole la disponibilità a fornire informazioni
reali di processo (in un solo caso l’attività èstata inizialmente percepita come un control-lo). Condiviso è stato il richiamo alla necessitàdi predisporre una documentazione chiara etrasparente e di migliorare la comunicazionetra i proponenti e le strutture regionali, comeanche quella di garantire la corrispondenzatra le azioni finanziarie, le strategie e gli obiet-tivi operativi migliorando, se possibile, anchel’efficacia delle azioni “poste in essere” dal-l’amministrazione regionale.
Alcuni degli elementi di conoscenza resisidisponibili con l’analisi sono stati poi utilizza-ti nella progettazione di un corso di formazio-ne commissionato dal NUVAL al Laboratoriodi Politiche Pubbliche (LAPO) di Torino e de-stinato ai soggetti coinvolti a vario titolo in at-tività di monitoraggio e valutazione all’internodella Regione Piemonte; la buona risposta allaprima edizione ha reso necessario realizzarneuna seconda nello stesso anno e in entrambele occasioni sono state proposte linee guidaper un’analisi critica delle procedure di valu-tazione/selezione e utilizzati i casi raccolti perla predisposizione degli esempi pratici.
Le conoscenze acquisite hannopermesso di proporre una
strutturazione degli elementi dicambiamento che hanno
interessato la messa in operadelle azioni di finanziamento leproblematiche che sono ancorapresenti e le soluzioni adottate
Più “problematico” è risultato invece l’a-spetto legato alla restituzione dei risultati del-l’analisi agli stakeholder (le persone a vario ti-tolo coinvolte dal Nucleo) così come il poterdare seguito alle raccomandazioni (dissemina-re i risultati all’interno dell’organizzazione, va-lutare l’opportunità di predisporre linee gui-da per la valutazione e selezione dei progetti ela possibilità di utilizzare un sistema di sup-porto alle decisioni connesse alla creazione diuna procedura di finanziamento nuova in unsettore, quando altri identificati dal sistema,
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 738
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:05 Pagina 38

dispongono già di conoscenze ed esperienzefacilmente traducibili in linee guida adegua-te). I cambiamenti intercorsi nella strutturaorganizzativa del NUVAL si sono protratti sinoagli inizi del 2007 e possono aver influito oltreche sulla diffusione dei risultati, sul manteni-mento della rete, interna (persone coinvolte in
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 39
attività di valutazione) o esterna (altri nuclei eosservatori), costruita in relazione alla proble-matica della valutazione e selezione dei pro-getti, come anche sulla possibilità di un lorouso nella fase di ri-programmazione e di defi-nizione degli strumenti attuativi per il prossi-mo settennio.
Carlo Saraceni
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 39

LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE
RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN 2 ATTI
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
PIETRO CURZIO, già Direttoregeneraledell’AssembleaLegislativa dellaRegione Emilia-Romagna,componente delNucleo diValutazione delConsiglioRegionale delFriuli-VeneziaGiulia
SCENA PRIMA
L’ambiente fisico e psicologico
Siamo, nella tarda mattinata di un giorno di aprile, in una stanza di un uffi-cio pubblico, nella quale due dirigenti, appoggiati a un elegante tavolo ova-le, stanno per iniziare il colloquio di valutazione. La porta, che si affaccia sudi un corridoio di passaggio, è chiusa, in contrasto con quanto avviene nor-malmente. Il fatto è che oggi c’è il colloquio di valutazione e, allora, comesempre accade in tali circostanze, la porta deve restare chiusa.
Il valutatore è andato di persona, prima di cominciare il colloquio, aprocurarsi una bevanda da offrire al suo interlocutore; si prepara a svol-gere il suo compito con impegno e, quindi, fa di tutto perchè il suo inter-locutore si senta a proprio agio. D’altra parte, le due persone, poste l’unadi fronte all’altra, si conoscono ormai da anni, hanno già vissuto un’espe-rienza del genere, in fondo c’è una reciproca stima, per cui l’ambiente do-vrebbe essere rilassato, quasi amichevole. E, invece, c’è tensione. Il moti-vo sta nel fatto che un colloquio di valutazione è sempre delicato e, inol-tre, il dirigente, che sta per essere valutato, tra qualche settimana lasceràil servizio, andrà in pensione. Si usa l’espressione “sta per essere rottama-
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 P . 4 0 - 4 3
L’attività di valutazione del personale, nella pubblicaamministrazione è una tema di notevole rilevanza che,
anche di recente, ha attratto molta attenzione. Numerose ecomplesse sono le questioni che entrano in gioco in questaattività e il lavoro che segue prende in considerazione unospecifico profilo – la relazione interpersonale tra valutatore
e valutato – tanto importante quanto scarsamenteconsiderato nei modelli ufficiali
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 40

to” in un’operazione di “svecchiamento” e,per la verità, solo queste frasi giustifichereb-bero la tensione! Di conseguenza il futuropensionato vive questo momento come il cul-mine della sua carriera, una sorta di rendi-conto finale.
Il dirigente che valuta è al suo sesto collo-quio in questo mese di aprile; conosce la faticadi questi dialoghi, e il grande lavoro che c’èdietro; calibra le parole, pur procedendo consufficiente speditezza nell’illustrazione dellesue argomentazioni.
Il DialogoIl valutatore (d’ora in poi Carlo) legge i risul-tati dei tanti indicatori elaborati e monitoraticon attenzione durante l’anno, al fine di di-mostrare, per esempio, quale livello di colla-borazione ha prestato il dirigente valutato(d’ora in poi Luciano) nei confronti dei colle-ghi degli altri settori e, ancora, quale creditoformativo lo stesso ha maturato, e quanto neha sollecitato tra i collaboratori del suo repar-to, o di quanta innovazione si è reso promoto-re, attraverso proposte di miglioramento oinediti progetti. I dati sono stati raccolti conscrupolo durante l’anno; sono stati studiati daCarlo, prima di formulare il giudizio, per cuinon servono ad avallare il “voto” che sta perdare a Luciano, maturato magari sulla base dialtri criteri, ma costituiscono per Carlo gli uni-ci presupposti oggettivi sui quali basare la suavalutazione finale.
Oltre ai dati relativi ai comportamenti or-ganizzativi, Carlo e Luciano esaminano i risul-tati raggiunti, dal punto di vista, per esempio,degli impegni di spesa assunti rispetto allesomme a disposizione, o dal punto di vistadell’efficienza e dell’efficacia di alcuni provve-dimenti amministrativi adottati, con particola-re riferimento al contenzioso che ne è derivato(e, proprio quell’anno, un cittadino aveva pro-mosso un ricorso giurisdizionale, il cui esito siprofilava delicato per l’amministrazione, perpresunte irregolarità, peraltro, del tutto for-mali, commesse durante il procedimento). Ta-li dati non costituivano una novità, perché, tragiugno e settembre dell’anno precedente, era-no state effettuate un paio di verifiche sull’an-damento dell’attività e Luciano aveva ricevuto
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 41
da Carlo qualche sollecitazione rispetto allainsufficiente spinta all’innovazione manifesta-ta e qualche rilievo per quanto riguarda la ca-pacità di relazione, soffocata dalla scarsa pro-pensione a diffondere informazioni.
Il valutatore e il dirigentevalutato oltre ai dati relativi aicomportamenti organizzativi,
esaminano i risultati raggiunti,dal punto di vista degli impegni
di spesa assunti rispetto allesomme a disposizione o
dell’efficienza e dell’efficacia dialcuni provvedimenti
amministrativi adottati
Alla fine del colloquio, Carlo, che inrealtà già prima dell’incontro, sulla base deidati raccolti, aveva ritenuto di valutare “po-sitivo” (qualcosa di meno, quindi, di “eccel-lente”) il contributo offerto da Luciano du-rante l’anno, comunica a quest’ultimo talegiudizio. Naturalmente non è prevista alcu-na discussione, nessun ripensamento sul giu-dizio espresso, che non può che essere ulti-mativo. È questa, davvero, per Carlo una re-gola inderogabile, maturata nei sei anni diesperienza, pena il venir meno di qualsiasicredibilità per chi valuta. Ciò non toglie cheCarlo non si alzi, non chiuda unilateralmen-te il dialogo, pare proprio che voglia comun-que ascoltare il parere dell’interessato. Èun’attesa tutt’altro che svogliata. E alloraLuciano si fa scuro in volto, parla a scatti esostiene che certo anche negli anni passatiaveva ricevuto lo stesso giudizio, e che neaveva anche capito le motivazioni, pur semai le aveva condivise, ma quest’anno è di-verso. È l’ultimo anno di servizio, il trentesi-mo alle dipendenze dello stesso ente, per cuiil giudizio su quest’ultimo anno assume og-gettivamente un altro valore, potendosi con-figurare un giudizio alla carriera! Non lo hamai fatto in passato, questa volta si sente dichiedere un ripensamento a Carlo, in modo
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 41

da ottenere il giudizio “eccellente”, da riferi-re alla lunga carriera svolta nell’ente; vuolelasciare il lavoro con questa soddisfazione:crede di averne diritto!
Non è prevista alcunadiscussione, nessun
ripensamento sul giudizioespresso. Questa è una regola
inderogabile, pena il venirmeno di qualsiasi credibilità
per chi valuta
Carlo si ferma, riflette, capisce il vero disa-gio che Luciano ha manifestato; pensa al sen-so di appartenenza all’ente mostrato in tantianni dall’uomo che ha di fronte; sente d’altraparte il peso della coerenza con i giudiziespressi nei confronti degli altri dirigenti, edel rigore nel tenere ferma la convinzione, percui non esiste una valutazione sulla carriera,ma un giudizio sull’attività svolta, anno peranno e, alla fine, dopo qualche attimo di forteintensità… conferma il giudizio!!
Il sipario cala, mentre i due si stringono lamano, con una traccia di sofferenza sui voltidi entrambi e con l’espressione di un sincerodubbio nel viso di Carlo!
SCENA SECONDA
L’ambiente fisico e psicologico
Non cambia l’ambiente. È la stessa stanza, an-cora la porta chiusa, il tavolo ovale, un vassoiocon una bottiglia d’acqua e due caffè, il solitovalutatore, abbastanza sicuro, pur se provatodal colloquio precedente; di fronte, una don-na, con la fronte alta, con un atteggiamento disicurezza, non di spavalderia, con aria serena,tranquilla. Anche in questo caso, tra i due,non vi è alcun cenno di sfida, che pur è emer-so in altri colloqui, perché i due dirigenti han-no lavorato insieme e bene, durante l’anno ap-pena trascorso, attorno a comuni progetti.
In più, rispetto al colloquio precedente,c’è da dire che la dirigente (d’ora in poi Mar-gherita) è stata una delle poche a raccoglierel’invito della direzione a fare una propria au-tovalutazione, per cui, nei giorni precedenti alcolloquio, ha consegnato una scheda, nellaquale si è attribuita non solo il giudizio di “ec-cellente” ma anche un risultato numerico al-tissimo.
Il dialogo
Carlo inizia il dialogo proprio partendo dallascheda consegnata da Margherita, leggendoneil contenuto. Margherita tiene a sottolineareche per lei è stato importante aver redattoquella scheda, perché ciò le ha consentito diritagliarsi un proprio autonomo spazio, riem-pito di proprie forti convinzioni.
Ed è proprio su tale autovalutazione che sisposta il nucleo del ragionamento. Certo, an-che in questo caso non si trascurano i dati rac-colti, secondo lo schema, comportamenti or-ganizzativi/risultati raggiunti. E anche perMargherita il giudizio, secondo Carlo, devefermarsi a “positivo”, perché, accanto a puntedi lavoro eccelso vi sono stati forti tracce didebolezza nella quotidianità nel servizio pre-stato, causate anche da un polso a volte nonsempre fermo usato nei confronti dei collabo-ratori del reparto dalla stessa diretto; in so-stanza, accanto a un’ottima performance sulpiano dell’innovazione e progettazione, Mar-gherita non ha dato prova di analogo risultatonella gestione delle attività ordinarie.
Margherita ascolta, controbatte con calma,ma quasi con distacco, perché per lei “quel checonta – così si esprime – è stata la sua autova-lutazione”. “Nessun atto di superbia – continuarivolgendosi a Carlo – “rispetto il Suo giudizio,capisco il ragionamento, ma non m’interessa. Ioquest’anno ho fatto il massimo, ho lavorato conimpegno, ho provato grande soddisfazione per irisultati ottenuti, ho acquisito consensi superio-ri alle mie attese. Certo, sarebbe stato impor-tante ottenere il giudizio di “eccellente” dal-l’Amministrazione che Lei rappresenta, ma nonimporta, perché comunque io sono orgogliosaper quanto ho fatto. Per me conta più l’autova-lutazione che la Sua valutazione!”
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 742
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 42

Carlo questa volta sorride, mostra addirit-tura soddisfazione per l’orgoglio professionaleespresso dalla dirigente, ma non mostra il mini-mo dubbio nel confermare il giudizio di “posi-tivo”. Anche in questo caso i criteri valutatividiscussi, conosciuti e verificati non gli concede-vano alcuna possibilità di cambiamento.
Margherita si alza lascia la stanza congrande tranquillità, senza nessun atteggiamen-to di superiorità, tutt’altro. Carlo, raccoglie lecarte, si prepara ad andar via, ancora con tan-ti dubbi, questa volta non sul giudizio espres-so, ma sull’utilità della stessa valutazione, afronte di una convinzione, così profonda co-me quella espressa da Margherita, non espres-sione di autoreferenzialità, ma di un altropunto di vista che le regole esistenti non han-
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 43
no consentito di prendere in considerazione.Sentimenti, bah, cosa d’altri tempi, pensa!
Quel che è certo è che in questo caso laspinta al miglioramento che è, o dovrebbe es-sere, il fine ultimo della valutazione, non si ècertamente realizzata. Non si è neppure rag-giunto un profondo convincimento di Carlo,accolto peraltro sempre con grande perples-sità dai colleghi, secondo cui una valutazioneè buona ed efficace solo quando vi è consensotra valutatore e valutato sul giudizio espresso.Nel caso appena descritto forse il valutatoreavrebbe dovuto cambiare il suo voto finale,ma Carlo, sulla base delle rigide norme esi-stenti e delle regole di comportamento che si èautoimposto, non ha ritenuto di poterlo fare.
Cala definitivamente il sipario.
Èandata ieri sera in scena alteatro Verdi la prima rap-
presentazione di un ineditospettacolo di un autore salerni-tano, dirigente di un ufficio fi-nanziario, alle prese per la pri-ma volta con la stesura di uncopione teatrale.
Spazio ai sentimenti, de-nuncia dello scarto tra modellie loro applicazione, consapevo-lezza dell’importanza dell’ascol-to e del dialogo: questi i temiemersi dai due difficili confron-ti tra dirigenti pubblici, durantel’annuale colloquio di valutazio-ne, portati ieri sera sulla scena.
Un testo che solleva dubbi,che si pone come una criticaverso approcci semplicistici incui spesso si cade, quando si af-frontano i temi dell’organizza-zione del lavoro e, in particola-re, della valutazione. Scopo del-lo spettacolo non era tantoquello di spingere il pubblico ascegliere una tra le diverse posi-zioni assunte dal valutatore edai valutati, quanto quello discompaginare certezze, di sbat-tere sulle prime pagine delle
nostre agende le storie, i fatti,anche le angosce di personesempre ignorate dai proclami,dalle inchieste, dai programmi.
Nella pubblicazione di pre-sentazione dello spettacolo, l’au-tore, in servizio nella PubblicaAmministrazione dal 1974, cosìscrive: “Alla fine del primo annodi lavoro, mi trovai sul tavolouna mattina una busta chiusa, al-l’interno della quale era annota-ta su di un foglio la parola ‘otti-mo’ con una scarna motivazione.Vigeva, allora, il Dpr 10 gennaio1957, n. 3, che prevedeva lacompilazione per ciascun impie-gato di rapporti informativi, sul-la base dei quali veniva attribui-to uno dei seguenti giudizi com-plessivi: ‘ottimo’, ‘distinto’,‘buono’, ‘mediocre’, ‘insufficien-te’. Non vi era alcun colloquio divalutazione, in premessa non viera la definizione di obiettivi,appariva oscuro l’utilizzo di queigiudizi e, comunque, era forte laconvinzione che fosse ‘l’obbe-dienza’ più che ‘la capacità pro-fessionale’ il criterio di valutazio-ne. Dopo 50 anni i contenuti, le
modalità, gli obiettivi della valu-tazione sono certamente altro:accordi sindacali, formazione,norme nazionali e regionali han-no stravolto l’impianto del TUdel 1957, presentando la valuta-zione come un momento traspa-rente di crescita professionale.Eppure...”
Fin qui l’autore; resta aglispettatori e a chi avrà modo dileggere i testi riflettere sulla ne-cessità di scavare nella realtà, dinon fermarsi a conoscere i datiriassuntivi relativi all’applica-zione di una determinata nor-ma, ma di praticare il dialogo,di dare spazio ai sentimenti in-dividuali, di registrare la grandevarietà delle situazioni persona-li. Lo sbocco di tale riflessione ètutto da costruire, il percorsoper giungere ad esso, quello sì,è delineato; passa attraverso laricerca, la curiosità, il confron-to, la fiducia.
Di qui l’invito ad… andareal teatro Verdi: può essere utile!!
Critico teatraleGiuseppe Pacilio
“IL MATTINO”Pagina cultura-spettacoli
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 43

VALUTARE LAPERFORMANCE DEI CENTRI
PER L’IMPIEGO
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
VALENTINA
BATTILORO,LUCA MO
COSTABELLA,ProgettoValutazione
ICentri per l’Impiego sono stati negli ultimi anni oggetto di numerose atti-vità di indagine, da parte soprattutto dell’Unione Europea, dell’Isfol e delleAgenzie regionali del lavoro. La maggior parte di queste analisi risponde a
esigenze informative di soggetti esterni al singolo sistema provinciale dei Centriper l’Impiego.
Una esperienza diversa è quella nata dalla necessità del Servizio Lavoro diuna provincia del Nord di dotarsi un sistema per valutare la performance deiCentri per l’Impiego operanti sul proprio territorio. Il committente dello studiodi valutazione presentato in questo articolo ha espresso l’esigenza di confronta-re sistematicamente i propri Centri in termini di servizi erogati e di risultati rag-giunti. La richiesta specifica è quella di definire un sistema di misure utili a evi-denziare l’esistenza e le cause di eventuali differenze nella performance tra iCentri della Provincia, in modo da consentire interventi correttivi in grado dimigliorarla. La performance di un servizio è il risultato di un insieme di fattori,alcuni di carattere esterno, altri interni. Nel caso dei servizi per l’impiego, tra iprimi si distinguono le risorse a disposizione dei Centri, le caratteristiche dell’u-tenza servita, le caratteristiche del mercato del lavoro in cui ogni singolo Centroagisce. Tra i fattori interni, che dipendono cioè dal comportamento dei Centristessi, rientrano ad esempio le diverse modalità operative adottate, l’organizza-zione interna, l’intensità e l’abilità con cui si svolgono le proprie funzioni.
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 P . 4 4 - 4 9
Sul finire degli anni novanta i servizi per l’impiego hannosubito nel nostro paese un processo di radicale riforma,che ha visto la sostituzione degli Uffici di Collocamentocon i Centri per l’Impiego. Questi ultimi non svolgonopiù un ruolo puramente amministrativo, limitandosi a
registrare lo stato di disoccupazione, ma offrono servizi disupporto alla ricerca di lavoro (informazione,
preselezione, orientamento, incontro domanda-offerta ecollocamento mirato per i disabili)
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 44

Il disegno dell’analisi di performance
Se si osservano le esperienze di analisi volte adescrivere l’attività degli enti pubblici non èinfrequente imbattersi in proposte che preve-dano la creazione di imponenti batterie di in-dicatori, che si prefiggono di cogliere nei mi-nimi dettagli qualunque aspetto dell’attività ditali enti. Un procedimento di questo tipoespone a una serie di problemi, legati tanto al-l’utilizzabilità quanto alla possibilità di pro-durre le informazioni richieste. Da un lato, lemoltitudini di indicatori nascondono, dietro aun’apparente ricchezza informativa, una realepovertà nella possibilità di trarre informazioniutilizzabili: molte misure proposte sono sem-plicemente inutili, spesso anche solo a scoporendicontativo. Dall’altro lato, molte misureproposte sono difficilmente ricavabili se non aseguito di costose rilevazioni ad hoc dei datinecessari. Nel lavoro qui descritto la scelta èstata invece quella di individuare un numerocontenuto di indicatori dell’attività dei Centri,facendo piuttosto attenzione a che questi fos-sero realmente rappresentativi delle attivitàsvolte e fossero misurabili con le informazionia disposizione della Provincia.
Caratteristica importante del lavoro è infat-ti rappresentata alla natura dei dati utilizzati.La possibilità di misurare alcune dimensionidell’operato dei Centri è legata alla disponibi-lità di dati utili allo scopo e, come detto, èspesso subordinata all’implementazione di ri-levazioni ad hoc. Il lavoro in esame si è invecelimitato, per richiesta della committenza, all’u-tilizzo degli archivi amministrativi dei Centriper l’Impiego: si tratta di un database relazio-nale (inizialmente gestito localmente, in modoautonomo, da ogni singolo Centro) contenenteinformazioni sugli iscritti ai Centri, i servizi daquesti ricevuti, oltre che sugli avviamenti avve-nuti sul territorio di competenza, le imprese e isoggetti coinvolti. La scelta di concentrarsi suidati esistenti ha da un lato permesso di svolge-re il lavoro senza che l’amministrazione soste-nesse costi eccessivi, dall’altro ha vincolato lascelta delle grandezze da misurare, limitandolaalle poche che si basavano su informazionipresenti negli archivi amministrativi.
I passi necessari per l’utilizzo dei dati a ta-le fine sono stati sostanzialmente:
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 45
• l’apprendimento e l’approfondimento del-la struttura dei database utilizzati, la verifi-ca della qualità e affidabilità dei vari tipi diinformazioni registrate;
• l’individuazione di tutte le informazioni chepotessero essere utili a descrivere l’operatodei Centri nell’erogazione dei servizi;
• un costante confronto con i direttori e glioperatori dei Centri per l’Impiego, perverificare la completezza delle informa-zioni disponibili, e individuare quali diqueste fossero inserite in modo omoge-neo e si prestassero dunque a una letturacomparata.
L’analisi si è sviluppata per fasi successi-ve. È stato necessario in primo luogo definireil ventaglio di attività in cui si declina “l’ope-ratività” dei Centri: questo è stato fatto rico-struendo il percorso di servizi che un utentepuò realisticamente effettuare in un certo ar-co di tempo presso i Centri per l’Impiego delterritorio analizzato. In secondo luogo sonostate scelte, tra le informazioni disponibili suiservizi erogati, quelle più utili a descrivere laperformance dei Centri. Infine è stato neces-sario individuare gli indicatori in grado disintetizzare adeguatamente le informazionirilevate.
Le attività che caratterizzano “l’operatività”dei Centri
L’utente che si rivolge a un Centro per l’Im-piego ha davanti a sé un potenziale “percorsodi servizi”: è stato innanzitutto necessario ca-pire come si articola tale percorso e in che mi-sura esso sia omogeneo e confrontabile tra iCentri. Nella nostra esperienza, questa faseiniziale è stata affrontata rivolgendosi diretta-mente ai Direttori dei Centri e ai singoli ope-ratori impegnati nell’erogazione dei servizi.Partendo da un ventaglio di possibili attivitàelencate nei documenti ufficiali – quali il Ma-ster Plan regionale, il dettato legislativo e i sin-goli documenti attuativi – è stato chiesto agliaddetti ai lavori di individuare l’insieme di at-tività effettivamente svolte da tutti i Centri.
Il risultato di questa prima fase è stata lascoperta di uno scenario diverso da quello
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 45

ipotizzato inizialmente: alcuni dei servizi checi si aspettava di riscontrare nei Centri si tro-vavano a uno stadio di implementazione anco-ra embrionale. Inoltre, il grado di sviluppo dialcune attività era diverso tra un Centro e l’al-tro. In alcuni, per esempio, non erano ancorastati attivati svariati servizi, e in molti casi sot-to lo stesso nome soggiacevano servizi tra lorodiversi. È stato quindi necessario trovare unterreno comune, limitando l’analisi a quei ser-vizi erogati ordinariamente da tutti i Centri,sulla base dei quali poter effettuare dei con-fronti.
Nella prima fase dell’analisi ilmaggior risultato è stato la
scoperta di uno scenario diversoda quello ipotizzato: alcuni dei
servizi che ci si aspettava diriscontrare nei Centri si
trovavano a uno stadio diimplementazione ancora
embrionale. La maggiore sfida èstata quella di capire per ognunodei servizi considerati i diversimodelli di erogazione adottati
dai Centri
Un secondo ostacolo al confronto delle at-tività, oltre all’eterogeneità dei servizi erogatidai Centri, è rappresentato dal fatto che solouna parte dei servizi dei Centri è oggetto di re-gistrazione sistematica negli archivi ammini-strativi. I servizi per cui è stato possibile uti-lizzare informazioni registrate in manieraomogenea in tutti i Centri erano soltanto tre:il colloquio di preselezione, la segnalazione al-le aziende, l’inclusione nei progetti finanziatidal Programma Operativo Regionale (POR).Questi non erano esaustivi delle attività svolte,tuttavia i problemi di eterogeneità tra Centri edi disponibilità delle informazioni ammini-strative hanno determinato la scelta di consi-derare “il percorso di servizi” come la combi-nazione di questi soli tre elementi.
La maggiore sfida affrontata in questa pri-ma fase è stata quella di capire per ognuno deiservizi considerati i diversi modelli di eroga-zione adottati dai Centri, allo scopo di coglie-re similitudini o discrepanze. Questo ha con-sentito da una parte di eliminare alcune dellecause di non confrontabilità, dall’altra di po-ter meglio interpretare nelle fasi successive al-cune differenze di performance osservate.
L’individuazione degli indicatori utili adescrivere l’attività dei Centri
Punto di partenza per l’identificazione degliindicatori di performance è stata l’esplicitazio-ne di quello che ci si sarebbe aspettato di os-servare in un Centro per l’Impiego che fun-zioni al meglio.
Gli indicatori individuati in prima battuta,sulla base della disponibilità di dati, sono sta-ti di tre tipi:a) indicatori relativi alla composizione del
flusso di iscritti;b) indicatori relativi ai servizi erogati; c) indicatori relativi agli avviamenti.
I primi indicatori (gruppo “a”) non rap-presentano le attività dei Centri, ma tendonopiuttosto a evidenziare eventuali differenzenella modalità di registrazione di alcune cate-gorie di soggetti, o differenze di composizio-ne nei rispettivi bacini d’utenza. Essi perciònon si prestano tanto a un confronto diperformance, quanto piuttosto a una prelimi-nare verifica del grado di omogeneità degliutenti serviti, e della misura in cui i confrontidi performance possono essere viziati da dif-ferenze di partenza. Il gruppo “b” compren-de gli indicatori di misurazione dell’attività: lapercentuale di iscritti che non hanno ricevutoalcun servizio, la percentuale di utenti servitiche hanno ricevuto solo servizi elementari, lapercentuali di serviti che hanno fruito deglialtri servizi più intensivi. L’ultima categoria diindicatori (gruppo “c”) comprende gli indi-catori volti a cogliere gli esiti occupazionalidegli iscritti ai Centri. È ovvia la considera-zione che il Centro per l’Impiego non è l’uni-co attore in grado di incidere sulla probabi-lità di avviamento di un iscritto (dal momento
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 746
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 46

che questo può trovare lavoro con le proprieforze, oppure affidandosi anche ad agenziespecializzate per il collocamento), ma la pro-babilità di incidere sugli avviamenti è la mi-sura più immediata e interessante del risulta-to delle attività svolte.
Gli indicatori individuati inprima battuta, sulla base delladisponibilità di dati, sono stati
di tre tipi: relativi allacomposizione del flusso di
iscritti; relativi ai servizi erogati;relativi agli avviamenti
Ogni indicatore è stato espresso come per-centuale rispetto a una platea di potenziali be-neficiari dei servizi dei Centri.
Sul lato dei risultati ottenuti, i dati ammi-nistrativi permettono di cogliere solamenteeventi strettamente legati alla condizione lavo-rativa: questi sono stati quindi misurati in ter-mini di probabilità di avviamento (percentualedi avviati).
Sul lato delle attività, gli indicatori sonostati costruiti come percentuale di potenzialibeneficiari che hanno ricevuto i servizi deiCentri in un dato periodo.
Occorre a questo punto dare una precisadefinizione di potenziali beneficiari dei servi-zi. Nella pratica si è trattato di selezionare unadi due possibili alternative: lo stock degliiscritti ai Centri a una certa data oppure ilflusso di iscritti durante un determinato perio-do di tempo. La scelta è caduta sul flusso perdue motivi: da un lato, sullo stock di iscrittinon esistevano informazioni omogenee traCentro e Centro (prima di febbraio 2003, icriteri di registrazione delle informazioni ne-gli archivi variavano tra i Centri); dall’altro, èvalsa la considerazione che la performance va-da giudicata prioritariamente rispetto ai servi-zi resi agli utenti presi in carico più di recente(tale considerazione ha d’altronde un riscon-tro empirico: un’alta percentuale dei servizierogati in un certo periodo è destinata a sog-getti iscritti presso i Centri da pochi mesi).
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 47
Tenuto conto dei vincoli di disponibilità eomogeneità dei dati, è stato scelto di condurrel’analisi su un periodo di un anno (da febbraioa dicembre 2003). Si è deciso di definire laplatea dei beneficiari come quella degli iscrit-ti nella prima metà del periodo, in modo dalasciare a tutti una finestra di sei mesi succes-sivi all’iscrizione nei quali osservare gli altrieventi (servizi, assunzioni). Pertanto, ogni per-centuale (di serviti, di avviati) utilizzata era in-tesa come percentuale di eventi realizzati en-tro i primi 180 giorni dall’iscrizione. L’arcotemporale disponibile è quindi ristretto, so-prattutto per la probabilità di avviamento, cheandrebbe sensatamente misurata in un oriz-zonte più ampio. Questo limite comporta una“sottostima” della percentuale di avviati: unperiodo di osservazione maggiore consenti-rebbe di osservare un maggior numero di av-viamenti. Tuttavia tale criterio è applicatouniformemente a tutti i Centri, dunque nonne pregiudica il confronto.
L’utilizzo degli indicatori: la creazione di untermine di confronto
La creazione degli indicatori non costituisceche la prima fase di un processo che ha comeobiettivo la trasformazione dei dati in indica-zioni pratiche sul comportamento dei Centrie sulla natura delle differenze. Per operarequesta trasformazione è stato indispensabileun confronto approfondito con i Direttori deiCentri. Per capire se le misure proposte espri-messero adeguatamente l’attività e i risultatidei Centri, è stato chiesto a ciascuno di essi diattribuire un “voto” alla rilevanza di ogni in-dicatore. Questo passaggio è stato utile pergiungere da una prima batteria di indicatoriricavabili dai dati a disposizione a una piùcontenuta, eliminando quelli considerati pale-semente inutili e soffermandosi su quelli con-siderati invece più rappresentativi.
Gli indicatori sintetizzano fenomeni la cuipercezione non sempre è agevole, anche percoloro che gestiscono operativamente i servizi.Per ognuno degli indicatori è stato quindi chie-sto ai Direttori di indicare anche il valore che sisarebbero aspettati di osservare nel proprioCentro, nonché del valore minimo e massimo
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 47

che sarebbe stato “giusto” aspettarsi in condi-zioni normali. Il confronto ha evidenziato unaforte variabilità, tra Centri e tra indicatori, nel-la distanza sia tra risultati attesi e risultati regi-strati, sia tra i risultati ideali e quelli reali. Que-sto ha consentito ai Centri di maturare unamaggiore consapevolezza dei propri risultati edella loro distanza da quelli desiderabili, e diinterpretare in maniera critica i risultati otte-nuti con l’analisi, individuando tanto situazionidi carenza o di eccellenza quanto gruppi diCentri con differenti comportamenti.
Per trasformare i dati inindicazioni pratiche sul
comportamento dei Centri esulla natura delle differenze è
stato indispensabile unconfronto approfondito con i
Direttori dei Centri. Il confrontoha evidenziato una forte
variabilità, tra Centri e traindicatori, nella distanza tra
risultati sia attesi e registrati, siaideali e reali.
Esiti del lavoro e riflessioni conclusive
L’esperienza dell’analisi di performance è sta-ta utile per mettere in luce le potenzialità e ilimiti applicativi di un tale approccio. Un pri-mo aspetto da evidenziare è la cautela neces-saria nella lettura delle misure prodotte conquesta analisi, dovuta alla natura ancora pio-nieristica della stessa: non esiste infatti in Ita-lia una consolidata letteratura sui metodi peranalizzare la performance, in particolare per iservizi all’impiego. Non è immediato per lacommittenza interpretare i risultati ottenuti,tanto per la novità rappresentata da questo ti-po di analisi che per l’ovvia difficoltà di tra-durre in termini pratici le informazioni otte-nute dagli indicatori.
Affinché un’attività di questo genere siautile è prima di tutto necessario controllarel’attendibilità degli indicatori, verificando ad
esempio che misurazioni in differenti istantimostrino dei tratti comuni. È possibile infattiche l’operatività dei Centri muti in modo taleda rendere gli indicatori scelti incapaci di de-scrivere la realtà osservata. Inoltre le modalitàdi registrazione delle informazioni negli archi-vi amministrativi potrebbero cambiare neltempo, rendendo non confrontabili misure ot-tenute in istanti diversi, e richiedendone dun-que un “riallineamento”. Solo un’analisi ripe-tuta nel tempo, e regolari occasioni di con-fronto tra i valutatori e gli operatori, sarannoin grado di produrre indicatori utili per teneresotto controllo e valutare la performance deiCentri per l’Impiego.
Un fattore importante per lo svolgimentodi lavori come quello descritto è rappresenta-to dalla disponibilità e qualità delle informa-zioni amministrative. È necessario che la com-mittenza, una volta individuati i servizi da os-servare, si adoperi per registrare in modo si-stematico e omogeneo (tra singole unità osser-vate e nel tempo) le informazioni su di essi. Sitratta di un processo di non facile implemen-tazione, che richiede talvolta di modificare al-cuni criteri di registrazione, allo scopo di con-ciliare l’utilizzabilità amministrativa dei daticon la loro utilizzabilità statistica. In assenzadi una buona omogeneità, almeno relativa-mente alle principali informazioni che si vo-gliono sfruttare, ogni confronto sarà sottopo-sto a forti rischi di distorsione.
Solo un’analisi ripetuta neltempo, e regolari occasioni diconfronto tra i valutatori e glioperatori, saranno in grado diprodurre indicatori utili per
tenere sotto controllo e valutarela performance dei Centri per
l’Impiego
L’esperienza svolta ha evidenziato una se-rie di buoni motivi per guardare con attenzio-ne ai risultati che una simile analisi può pro-durre. Le misure proposte si sono rivelate ingrado non solo di cogliere differenze di
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 748
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 48

performance dovute a difficoltà momentaneeo a fattori contingenti, che anche grazie ad es-se si sono fatti risaltare, ma anche di rifletterel’affermarsi di stili operativi diversi tra le sin-gole unità osservate. Ad esempio, è sembrataemergere una differenziazione dei Centri traun approccio più “estensivo” all’offerta di ser-vizi, per cui le risorse disponibili sono dedica-te interamente a offrire un minimo a tutti gliiscritti, e un modello più “intensivo”, che con-centra le risorse su una fascia più limitata diutenti, a cui viene offerto di più, mentre altrisono lasciati a loro stessi. La definizione di in-dicatori di varia natura (di composizione, diattività, di risultato) consente anche di carat-
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 49
terizzare l’attività dei Centri su più dimensio-ni, individuando ad esempio eventuali corre-lazioni tra modalità operative, caratterizzazio-ne degli utenti serviti e determinati risultati.
È il caso di ribadire che una attività di mi-surazione della performance non deve averecome priorità quella di generare graduatoriedi enti. L’analisi aggiunge un supporto infor-mativo, di tipo quantitativo, che possa aiutaregli attori coinvolti a riflettere su quali siano ifattori critici che causano gli scostamenti traesiti attesi e reali, nonché tra gli esiti ottenutidalle singole unità operative, per suggerireeventuali correttivi in grado di migliorare gliaspetti ritenuti più carenti.
Gioacchino Assereto
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 49

IL SSR PIEMONTESE TRA PROGRAMMAZIONE
E MONITORAGGIO.QUALE RUOLO
PER LA VALUTAZIONE?
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
PIERVINCENZO
BONDONIO,Universitàdi Torino
Se ci si riferisse al livello micro dovremmo prendere in considerazionele valutazioni che vengono diffusamente condotte sull’efficacia dinuove tecnologie sanitarie (termine amplissimo, che comprende i far-
maci, le apparecchiature sanitarie, le procedure diagnostiche e terapeuti-che, ecc.) e chiederci quale sia il contributo che la sanità piemontese (i suoiricercatori e gruppi clinici, appartenenti alle università e alle strutture delSsr) forniscono in questo ambito. I metodi sono quelli, validati internazio-nalmente, della ricerca clinica, farmacologia e tecnologica e l’indagine sulladiffusione e gli esiti da parte di strutture e persone che operano in Regionedovrebbe essere condotta su una molteplicità di fonti (riviste e atti di so-cietà scientifiche, in primo luogo) che ne pubblicano gli esiti, sottoponen-doli a peer review. Non è l’intendimento di questo breve scritto.
Il livello immediatamente superiore è rappresentato dalla valutazionedi specifiche politiche sanitarie, ovvero di interventi complessi, realizzatida parte di numerosi soggetti, che utilizzando metodiche definite perse-
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 P . 5 0 - 5 5
La valutazione nel settore sanitario ha registrato negliultimi anni una sempre maggior attenzione, da parte sia
degli addetti ai lavori che dal pubblico in generale. Tuttavia,quando si avvia una riflessione sul ruolo della valutazionein questo settore occorre preliminarmente chiarire a qualelivello, a quali oggetti e a quali momenti ci si riferisce. Le
dimensioni della valutazione in ambito sanitario, conriferimento a un contesto territoriale dato (ciò che avviene
nel servizio sanitario piemontese, nel nostro caso) sonoinfatti assai articolate e non è detto che la qualità e
l’intensità che caratterizzano le valutazioni siano omogeneenei diversi livelli
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 50

guono fini anch’essi prefigurati, di solito de-scritti in termini di miglioramento dello statodi salute di specifiche popolazioni. In questoambito l’intervento pubblico è spesso preva-lente: si tratta di “campagne” che hanno spe-cifici target di popolazione (le popolazioni arischio, individuate come tali sulla base distudi epidemiologici), protocolli di attuazio-ne in genere rigidi e prevedono la collabora-zione di più centri, diffusi spesso su tutto ilterritorio regionale. L’iniziativa (e il finanzia-mento) a volte sono del livello statale (i pro-getti obiettivo del PSN), a volte di quello re-gionale, a volte ancora del livello locale (cam-pagne promosse da singole aziende sanitarie).Spesso gli interventi riguardano la prevenzio-ne, ove la precocità della diagnosi è discrimi-nante rispetto agli esiti delle terapie: è que-sto, ad esempio, il caso di Prevenzione sere-na, il programma di diagnosi precoce dei tu-mori della mammella e del collo dell’utero,attivo a Torino dal 1992 ed esteso all’interoterritorio regionale a partire dal 1996, e deglialtri screening in ambito oncologico. Altrevolte gli interventi intendono assicurare co-pertura contro il rischio di contrarre specifi-che malattie, come avviene per le campagnevaccinali. La sanità pubblica piemontese è,da sempre, molto attiva su questo fronte: lavalutazione è tipicamente effettuata ex ante,usando tecniche che utilizzano anche criterieconomici (analisi di tipo costo-efficacia, disolito), che cercano di dare risposte a doman-de – assai impegnative – quali: “qual è il co-sto di una vita salvata tramite la campagnaX?” e “le risorse che finanziano la campagnaY sono ben spese?”
Poiché a volte accade che le decisioni sianoprese sulla base di conoscenze non sufficienti afornire risposte pienamente affidabili alle do-mande, sarebbe saggio che altre valutazionifossero effettuate ex post, per ottenere ele-menti di feed-back ai fini di successive decisio-ni e dell’eventuale ridisegno degli interventi. Avolte ciò accade, come documentato dallepubblicazioni dei servizi di igiene e sanità pub-blica e di epidemiologia della Regione Pie-monte. Sede per riscontri degli esiti delle valu-tazioni sugli interventi effettuati, insieme almonitoraggio dello stato di salute della popo-lazione, potrebbe essere la relazione sullo stato
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 51
di salute della popolazione (che l’art. 13 dellal.r 18/2007, “Norme per la programmazionesocio-sanitaria e il riassetto del servizio sanita-rio regionale”, prevede sia redatta ogni trien-nio – l’ultima versione disponibile è del marzo2006: http://www.regione.piemonte.it/sani-ta/ep/salute2006/index.htm).
La valutazione, tipicamenteeffettuata ex ante, cerca di darerisposte a domande quali: “qual
è il costo di una vita salvatatramite la campagna X?” e “le
risorse che finanziano lacampagna Y sono ben spese?”
A valutazioni ex ante strutturate (nel sensoche sono state condotte sulla base di un mo-dello unificato di studio di fattibilità, dopo va-lidazione a livello nazionale e regionale) leaziende sanitarie piemontesi hanno fatto ri-corso quando (a fine anni ottanta) hanno pre-sentato i progetti di ristrutturazione/costru-zione di edilizia e di impiantistica sanitaria esociosanitaria destinati ad essere finanziatinell’ambito del piano decennale di interventiprevisto dall’art. 20 della l. finanziaria per il1988. Le varie versioni dello studio di fattibi-lità, previste per i diversi tipi di intervento(dalla costruzione di un nuovo ospedale alleristrutturazioni di parti di presidi esistenti, al-la costruzione di residenze assistenziali e sani-tarie, ecc.) comprendevano il rispetto di crite-ri di funzionalità sanitaria e la valutazione eco-nomica tramite proiezioni di lungo periodo distime dei costi e delle produzioni che l’operaavrebbe permesso di realizzare. Ancora oggile aziende sanitarie piemontesi, seppure al difuori di un modello prestabilito, fanno ricorsoallo strumento dello studio di fattibilità ognivolta che intendono realizzare interventi diedilizia e impiantistica sanitaria di un certoimpegno. E quindi offrono elementi utili a va-lutare la bontà, sui diversi piani, delle opereproposte.
A un livello diverso si collocano le azionidi programmazione e di conseguente monito-
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 51

raggio che costituiscono modalità di governoordinario del SSR.
Secondo la legge costitutiva (la n.833/1978), strumento centrale per il funziona-mento del SSN è la programmazione, declinataai due livelli di governo generale del sistema,nazionale e regionale (ma poi anche locale).Al livello nazionale spetta, con il PSN, di indi-care gli obiettivi e i livelli di prestazione chedevono essere garantiti a tutti i cittadini (mala prescrizione assumerà contenuti concretisolo 23 anni dopo, con l’accordo Stato-Regio-ni del 2001, art. 3); al livello regionale spettadi orientare il funzionamento del sistema conproprio PSR, che deve “uniformarsi ai conte-nuti e agli indirizzi del PSN” (art. 55). Il rap-porto tra programmazione nazionale e regio-nale si modifica, sfuma e diviene più comples-so con le riforme degli anni novanta:• la l. 502/1992 che assegna al PSR il compi-
to di definire le linee di organizzazione deiservizi, i criteri di finanziamento delleaziende sanitarie, le attività di indirizzotecnico e di supporto verso le aziende (an-che in tema di controllo di gestione e valu-tazione della qualità);
• la l. 229/1999, che ridefinisce il PSR comepiano strategico degli interventi per gliobiettivi di salute e il funzionamento deiservizi, in funzione delle esigenze specifi-che della popolazione regionale (“anche”in riferimento agli obiettivi del PSN).
Una revisione ulteriore dei rapporti tra idue livelli di programmazione si ha con il nuo-vo titolo V parte II Cost. (2001), che definiscela tutela della salute come materia a legislazio-ne concorrente tra Stato e Regioni, aumentan-do poteri e responsabilità delle regioni stessein tema di programmazione, gestione, finan-ziamento e controllo dei rispettivi SSR.
Va ricordato che fin dalla sua costituzioneil funzionamento del SSN, complessivamente enelle sue declinazioni regionali, ha garantitouniversalità di accesso a servizi la cui qualità èriconosciuta buona, quando non eccellente, inautorevoli sedi internazionali, ma è anche fon-te di preoccupazioni, su almeno due fronti di-versi. Un primo fronte riguarda la persistentedisomogeneità nella qualità e disponibilità del-le prestazioni che esso garantisce sul territorio
nazionale (seppure recentemente essa sia se-gnalata in lenta riduzione); un secondo fronteriguarda l’inefficienza (che si tende a collegarealla natura pubblica del SSN) e la sua imperfet-ta sostenibilità economico-finanziaria (legataalla natura open-ended dei servizi offerti e al-l’assenza o inefficacia dei meccanismi di rego-lazione della domanda – sia economici, comela partecipazione alla spesa, sia regolamentari,come i tentativi, mai portati veramente a fon-do, di vincolare la scelta dei fornitori cui gliutenti possono rivolgersi, come è prassi inve-ce, ad esempio, nel NHS britannico – a frontedella rete dei produttori). Le due riforme so-pra ricordate (e le molte altre meno sistemati-che complessivamente varate) rappresentanoaltrettanti tentativi di trovare soluzioni soddi-sfacenti a questi annosi problemi, con esiti cherestano tuttavia controversi e imperfetti.
Secondo la legge costitutiva del’78, strumento centrale per ilfunzionamento del SSN è la
programmazione, declinata aidue livelli di governo generale
del sistema, nazionale eregionale. Il rapporto tra
programmazione nazionale eregionale si modifica con le
riforme degli anni novanta. Unarevisione ulteriore dei rapporti
tra i due livelli si ha con il nuovotitolo V della Cost. nel 2001
La presenza costante di quelli che sonopercepiti come problemi nel funzionamentodel SSN ha quindi inevitabilmente orientatoanche i sistemi di programmazione, di moni-toraggio e, infine, di valutazione che da essi sipossono ricavare.
Accanto al previsto strumento del Piano(non dimentichiamo che il primo PSN ha vistola luce, dopo numerose false partenze, solonel 1994), il governo del sistema è stato garan-tito, a livello nazionale, con interventi ricor-
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 752
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 52

renti ma meno sistematici (come annualmenteavviene con le disposizioni sulla sanità previ-ste nella legge finanziaria, inevitabilmente in-fluenzati dalla congiuntura economica che ilPaese attraversa), oppure con atto governati-vo, come quello assunto in tema di Livelli Es-senziali di Assistenza, recependo nel 2001 ilgià ricordato accordo siglato in sede di Confe-renza Stato-Regioni.
Premessa ai provvedimentiregionali del 2007 è la situazione
di disavanzo che il SSRpiemontese ha registrato per il
2004, che sarebbe ostativo amaggiori finanziamenti statali
per le regioni “virtuose”, a menodella redazione e attuazione di
opportuno piano di rientro
Non diversamente è accaduto a livello re-gionale. In Piemonte, dopo un dibattito dura-to un anno, nell’estate scorsa è stata approvatala legge n. 85/2007 (“Norme per la program-mazione socio-sanitaria e il riassetto del servi-zio sanitario regionale”), che definisce, con al-cune innovazioni, strumenti, contesto e obiet-tivi della programmazione sociosanitaria regio-nale, ma tuttora non è stato ancora approvatodal Consiglio regionale né il Piano sociosanita-rio per il 2006-2010 (che la Giunta aveva pre-disposto già a metà 2005), né la delibera chesancisce i nuovi ambiti territoriali delle aziendesanitarie piemontesi (che prevede alcuni ac-corpamenti, cui è stata data attuazione provvi-soria, in via amministrativa). Tra la produzionenormativa regionale, che dà contenuto opera-tivo alla programmazione regionale, rilievoparticolare rivestono le direttive che annual-mente la Regione emana per orientare la pre-disposizione, da parte delle aziende sanitarieregionali, del Piano di riqualificazione dell’as-sistenza e di riequilibrio economico-finanziario(PRR). Esse rappresentano uno strumento fon-damentale con il quale la Regione esercita lesue funzioni di governo del SSR, indicando alle
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 53
aziende sia gli obiettivi strategici sostanziali intema di qualità dei servizi resi che gli obiettivistrumentali in tema di organizzazione e di ri-spetto degli equilibri economico-finanziari(anzi, della tempistica per il rientro dagli squi-libri che caratterizzano le gestioni). Le diretti-ve in vigore sono del luglio 2007 e riguardanoil 2007-2010 (D.g.r n. 59-6349 del 6 luglio2007 e D.g.r n. 84-6615 del 30 luglio 2007).Vale la pena di esaminarne brevemente il con-tenuto e il metodo che esso sottende.
Premessa ai provvedimenti è la situazionedi disavanzo che il SSR piemontese ha registra-to per il 2004, che sarebbe ostativo a maggio-ri finanziamenti statali per le regioni “virtuo-se”, a meno della redazione e attuazione diopportuno piano di rientro, concordato con iministeri della Salute e dell’Economia. Poichéil disavanzo piemontese non è dovuto, comeinvece in altri casi, alla presenza di aree dimarcata difformità rispetto agli standard (intermini di dotazione di posti letto, di tassi diospedalizzazione e di spesa farmaceutica) maa maggiori costi di esercizio diffusi su moltevoci, non sono utili manovre settoriali, ma so-no invece necessari interventi complessivi, chetrovano fondamento e dimostrazione nei PRR
aziendali. Alle aziende sanitarie si chiede per-tanto, in continuità sostanziale con le direttivedell’anno precedente (ma a loro parziale va-riante), di formulare obiettivi e piani per con-seguirli relativamente a quattro ambiti:• potenziamento e riorganizzazione delle at-
tività di prevenzione e promozione dellasalute e riqualificazione di specifiche fun-zioni assistenziali (si tratta di ambiti che ri-guardano direttamente i servizi resi ai cit-tadini);
• riorganizzazione della rete dei servizi e deipresidi (particolarmente rilevante per leaziende oggetto di accorpamento);
• revisione degli assetti organizzativi interni eadozione di misure di semplificazione delleprocedure amministrative e gestionali;
• perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario.
Per ciascun ambito, i documenti richiama-ti (nel testo e negli allegati) forniscono indiriz-zi articolati alle aziende per la redazione deiPRR e, soprattutto, per le iniziative da ricom-
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 53

predere in esso e realizzare, prescrivendo che“gli interventi (previsti) devono essere calen-darizzati e abbinati a indicatori di risultato o acriteri di valutazione dei loro esiti”. Puntualisono poi le prescrizioni in tema di formazionedel conto economico aziendale, con l’indica-zione del fabbisogno ammissibile per il 2007(contestualmente comunicato a ciascunaazienda). Per gli anni a seguire i documentienunciano i criteri cui la Regione si atterrà neldefinire i riparti di risorse e segnalano le va-riabili la cui valorizzazione sarà presa in consi-derazione per il calcolo.
Complessivamente, i documentiregionali tentano di fornire unquadro operativo complessivo
alle aziende sanitarie,vincolandole a seguire un iteromogeneo nel descrivere le
azioni che sono sollecitate adassumere
Complessivamente, i documenti regionalitentano di fornire un quadro operativo com-plessivo alle aziende sanitarie, vincolandole aseguire un iter omogeneo nel descrivere leazioni che sono sollecitate ad assumere. Piùche prescrivere il rispetto di valori predefinitidi una fitta e stringente rete di indicatoriquantitativi (come avveniva in passato), si la-sciano margini di discrezionalità alle aziendenel rappresentarli, con il vincolo della loro ve-rificabilità da parte regionale (come si è detto,il termine usato è “valutazione dei loro esiti”:termine sufficientemente elastico). Valutazio-ne regionale, dunque, quale sarà esprimibile,volta volta, sulla base del puntuale rispetto divalori e parametri (è questo il caso dei valoridel conto economico), oppure sulla base dellaplausibilità delle azioni che l’azienda dichiaradi volere intraprendere (ma con l’onere di in-dicare le modalità di riscontro).
Le aziende sanitarie dispongono tutte dipropri strumenti di informazione e governo,che hanno due capisaldi: un caposaldo sanita-rio, costituito dal sistema informativo sanita-
rio e un caposaldo economico, centrato sullacontabilità analitica. Utilizzandoli entrambi, leaziende sanitarie hanno costruito e fatto evol-vere nel tempo il proprio sistema di controllodi gestione, basato sui principi generali delladirezione per obiettivi, che prevede la reda-zione annuale del budget aziendale, sommadei budget delle unità operative. Al budget èassegnato, quindi, il compito di collettore del-le innovazioni organizzative e gestionali, chele unità operative titolari (tra le quali ruolocrescente è assegnato ai dipartimenti) nego-ziano annualmente con la direzione generaledell’azienda. Alcuni degli obiettivi assegnatialle unità (tipicamente: il rispetto di vincolieconomico-finanziari) sono strumentali alconseguimento degli obiettivi che la Regioneassegna al direttore generale. La certificazionedel conseguimento degli obiettivi di budgetviene effettuata annualmente dal Nucleo divalutazione aziendale, organo a tipica compo-sizione mista (interna ed esterna) e costituiscela base per l’attribuzione al personale (diri-gente e no) dei compensi incentivanti a dispo-sizione dell’azienda. Essi sono uno degli stru-menti a disposizione delle aziende (peraltrocon differenze significative nella dimensionedel fondo disponibile, frutto della storiaaziendale e in progressiva erosione a ogni rin-novo contrattuale) per tentare di incentivarecomportamenti, individuali e di gruppo, inmaggiore sintonia con gli intendimenti dell’a-zienda ed economicamente più produttivi.
Il conseguimento degli obiettividi budget viene accertato
annualmente dal Nucleo divalutazione aziendale, organo a
tipica composizione mista(interna ed esterna) e costituisce
la base per l’attribuzione alpersonale (dirigente e no) dei
compensi incentivanti
Sulla base delle conoscenze personali, ac-quisite in anni di partecipazione al nucleo di
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 754
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 54

valutazione di alcune aziende sanitarie pie-montesi (locali e ospedaliere), senza pretesaalcuna di cogliere la generalità di un fenome-no sul quale non esistono, a mia conoscenza,informazioni di sistema, provo a esprimerequalche osservazione sulla qualità dei proces-si che ho visto in opera e sulla possibilità diutilizzarli anche a fine valutativo.
La qualità dei processi è spesso soddisfa-cente e in miglioramento nel tempo, grazie alcrescere delle professionalità che si sono for-mate in azienda.
Il sistema di controllo di gestione è ingrado di fornire report economici precisi e dicrescente affidabilità e tempestività; soddi-sfacente (seppure certamente migliorabile) èanche l’abbinamento tra dati economici e mi-sure di prodotto e risultato. Le elaborazionipiù convincenti riguardano le attività ospe-daliere (per le quali vi è una lunga tradizionedi misurazione, ulteriormente migliorata conl’adozione dei DRG come misure della pro-duzione) e di sanità pubblica (ambito nelquale la Regione Piemonte vanta una tradi-zione di eccellenza nella programmazione re-gionale, assistita da coerenti parametri e mi-sure di monitoraggio). Meno assestate e cer-tamente perfettibili sono invece le elabora-zioni che riguardano le aree amministrative ela medicina di territorio.
Che dire del metodo con il quale gliobiettivi sono scelti e monitorati? Qui mi pa-re sussistano differenze significative (e forsenon del tutto giustificate) nelle prassi seguitedalle aziende (almeno, di quelle che cono-sco), che forse potrebbero essere utilmenteridotte mediante interventi regionali di indi-rizzo. Se è vero, come recita il credo azienda-lista, che gli obiettivi devono essere calibratisulle esigenze della singola azienda, è anchevero che una piena rappresentazione di que-ste ultime non sempre è in possesso della di-rezione aziendale.
L’asimmetria informativa opera anche al-l’interno delle aziende sanitarie! Il rischio diobiettivi autoreferenziali è sempre incomben-te. Come pure la tentazione di mascherare co-me obiettivo meritevole di compenso incenti-vante lo svolgimento di azioni e di attività cheinvece dovrebbero essere considerate piena-mente coperte dalla retribuzione ordinaria.
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 55
Seppure migliorabile, il processo di budget hatuttavia prodotto effetti positivi nelle aziende,aumentando la partecipazione e diffondendola consapevolezza sugli andamenti, in sensolato (compresi importanti aspetti della qualitàdelle prestazioni), della gestione. Sarebbequindi sbagliato abolirlo o ridurne l’ambito diapplicazione.
Un’osservazione finale sulla valenza valu-tativa dell’imponente massa di informazioniche le aziende sanitarie sono tenute a fornirealla regione con la redazione dei PRR, e di cuidispongono al proprio interno, come sotto-prodotto del controllo di gestione dei proces-si budgetari.
Che dire del metodo con il qualegli obiettivi sono scelti e
monitorati? Il rischio di obiettiviautoreferenziali è sempre
incombente. Seppuremigliorabile, il processo dibudget ha tuttavia prodottoeffetti positivi nelle aziende,
aumentando la partecipazione ediffondendo la consapevolezza
sugli andamenti
È del tutto evidente che quelle informa-zioni non possono produrre, di per sé, formedi valutazione riconducibili alla policy evalu-tation. Perché ciò accada occorre che essesiano probabilmente integrate e siano ogget-to di trattamento e di elaborazione, utilizzan-do i metodi e le tecniche, quantitative e qua-litative, proprie di quella disciplina. I proble-mi che varrebbe la pena di affrontare nonmancano certo. Ad esempio, sono certo me-ritevoli di risposta domande quali: “Come sispiegano i differenziali di costo per presta-zioni analoghe effettuate da aziende o presididiversi? Si giustificano? Si può ed è opportu-no cercare di porvi rimedio e come?”. Mi pa-re possa essere un fertile terreno di lavoroper l’ARESS, l’Agenzia regionale per i servizisanitari.
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 55

VALUTARE LE POLITICHEPER L’INTEGRAZIONE
SOCIALE DEGLI IMMIGRATIRIFLESSIONI A MARGINE
DI UN’ESPERIENZA DI LAVORO
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
ENRICO ALLASINO,IRES Piemonte,MARCO SISTI,ProgettoValutazione
In Italia esistono da tempo leggi e documenti programmatici che indica-no l’integrazione sociale dei cittadini immigrati come una priorità inmolti ambiti d’intervento pubblico. Di solito a questa indicazione di
massima non segue una precisa individuazione degli strumenti da impiega-re affinché tale obiettivo venga perseguito. Come accade di frequente,quando negli atti ufficiali si formulano finalità di ampia portata e di diffici-le definizione operativa, non solo il passaggio dal dire al fare è tutt’altro chescontato, ma manca anche una descrizione di come tale passaggio dovreb-be avvenire. Attraverso l’adozione di quali specifiche politiche? Con qualirisorse? Intervenendo con quali soluzioni su quali problemi? Il compito dirispondere a queste domande è spesso rinviato alle singole amministrazionilocali e alle organizzazioni del privato sociale che operano sul territorio,chiamate a interpretare indirizzi generali e a tradurli in iniziative e attivitàconcrete. La responsabilità delle decisioni su cosa e quanto realizzare, per-ché realizzarlo, come e a favore di chi, viene perciò trasferita dal centro al-
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 P . 5 6 - 6 1
Le politiche per l’integrazione sociale sono spesso composteda una miriade di interventi di piccola entità, realizzati alivello locale da una molteplicità di attori, sia pubblici che
privati. Tale frammentazione provoca dispersione diconoscenze e non permette di capitalizzare le esperienze. In
che modo la valutazione può essere d’aiuto?
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 56

le “periferie”. Naturalmente questo produceun’elevata frammentazione degli interventiche finiscono per differenziarsi fortemente traloro, se non per lo scopo di fondo al qualetendono, per le ricette di policy che applicano
Dalla frammentazione nasce un’esigenza di“valutazione”
Ci troviamo dinanzi a ciò che gli anglosassonidefiniscono “aggregate multisite programs”:programmi d’intervento compositi, che fannoriferimento a un’unica finalità e a una solafonte di finanziamento centrale, ma che al lo-ro interno presentano una grande varietà diapprocci e di strategie d’intervento. Questomodo di operare della pubblica amministra-zione non è di per sé sbagliato e anzi applicaun criterio di buon governo – il principio disussidiarietà – molto enfatizzato negli ultimianni. Tuttavia, il decentramento nelle decisio-ni innesca una naturale tendenza alla perditadi informazione. In questo processo di delegail livello di governo superiore, che in teoriadovrebbe conservare funzioni di coordina-mento e programmazione, stenta ad avere unachiara visione di quanto viene realizzato all’in-terno del suo territorio. Allo stesso tempo, isingoli enti locali, impegnati nel dare rispostaa istanze particolari, non hanno l’energia e lerisorse necessarie per incontrarsi, confrontarsie riflettere, in modo sistematico, sulle diversesoluzioni che hanno messo in atto e sui risul-tati che individualmente hanno raggiunto.
“Aggregate multisite programs”:programmi d’intervento
compositi, con un’unica finalitàe una sola fonte di
finanziamento centrale, ma congrande varietà di approcci e di
strategie d’intervento
La frammentazione degli interventi generacioè una dispersione di conoscenze – e unamancata capitalizzazione delle esperienze –
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 57
che a sua volta fa emergere, negli stessi sog-getti attuatori, un’insoddisfazione diffusa ri-guardo alla loro reale capacità di assumerescelte pienamente informate e, dunque, piùconsapevoli. Da questa insoddisfazione puònascere una peculiare domanda di valutazio-ne, motivata in parte dalla volontà dell’entecentrale di chieder conto di quanto è accadutoin seguito all’erogazione dei finanziamenti, ein parte dalla voglia degli enti che realizzanogli interventi di apprendere se e come è possi-bile fare meglio di quanto già non stiano fa-cendo.
Un’esigenza conoscitiva di questo tipo hamotivato la richiesta, avanzata al nostro grup-po di lavoro (composto da Enrico Allasino eRoberta Valetti – Osservatorio sull’immigra-zione dell’IRES – Piemonte e da Marco Sisti eStefania Tron – ProgettoValutazione) dallaDirezione Politiche Sociali della Regione Pie-monte, di costruire un sistema di monitorag-gio e valutazione degli interventi finanziati dalFondo regionale per l’immigrazione.
Gli interventi del Fondo per l’immigrazionedella Regione Piemonte
In Piemonte la principale fonte pubblica di fi-nanziamento delle politiche per l’integrazionesociale degli immigrati è il Fondo regionale perl’immigrazione. Con una disponibilità di risor-se che oscilla intorno ai due milioni e mezzodi euro ogni anno, il Fondo viene distribuitodalla Regione alle amministrazioni provincialisulla base di alcuni indicatori demografici co-me il numero di immigrati presenti nelle ri-spettive aree. In seguito, le Province erogano ifinanziamenti a enti diversi – Comuni, Comu-nità montane, Consorzi socio-assistenziali,ospedali, questure, associazioni – che presen-tano progetti d’intervento. La scelta dei pro-getti da finanziare avviene sulla base degli in-dirizzi dettati da programmi regionali a valen-za triennale.
L’ultimo dei programmi triennali approva-ti dalla Giunta regionale è il Piano Integratodell’Immigrazione (2007-2009). All’internodel Piano sono definiti 14 obiettivi che spazia-no tra diversi settori d’intervento: dalla scuolaalla sanità; dal lavoro alla giustizia.
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 57

Tra i 14 punti in elenco compare anchel’impegno di “valutare l’efficacia delle politi-che previste dal Piano”. Con l’approvazionedi questo obiettivo – si afferma nel docu-mento –“s’intende favorire la messa in atto diun sistema di monitoraggio e valutazione chepermetta di conoscere l’impatto che il PianoRegionale Integrato dell’Immigrazione e iPiani Provinciali hanno avuto sul territorio, irisultati conseguiti in relazione agli obiettiviprevisti.
Il sistema deve fornire, inoltre, un’analisisia qualitativa che quantitativa dei progettirealizzati e individuare le buone prassi. Ilprocesso di valutazione, che coinvolge gli at-tori ai diversi livelli, fornisce elementi utiliper rivedere le strategie di intervento e ripro-grammare le politiche del settore”. Il nostrolavoro consiste nel tentativo di dare seguito aquesta particolare esigenza di valutazione.Nel farlo, emergono alcune difficoltà checrediamo valga la pena raccontare, seppurein sintesi.
Controllo sui conti o apprendimento sullepolitiche?
La prima difficoltà è di ordine generale e nonappartiene solo a questo caso. Essa consistenel tenere ben distinti gli obiettivi conosciti-vi che possono motivare la costruzione di unsistema di “monitoraggio e valutazione” e,sulla base di tale distinzione, impegnare leamministrazioni in differenti strategie di la-voro. Nelle politiche che prevedono un pas-saggio di risorse da un ente centrale a entiperiferici esiste sempre, per l’ente sovra-or-dinato, la necessità di procedere a una verifi-ca delle spese sostenute a livello locale. Sitratta di un’attività tipica delle burocraziepubbliche, che si compie su dichiarazioni dispesa, fatture e note contabili. L’obiettivo èdi accertare che le risorse siano state utilizza-te per gli scopi previsti; che siano stati rispet-tati criteri di regolarità; che non vi siano sta-te appropriazioni indebite o ingiustificate. Sitratta di un monitoraggio capillare, svolto a
I quattordici obiettivi del Piano Regionale Integrato dell’Immigrazione (2007-2009)
La Regione organizza un sistema di tutela e promozione sociale delle persone straniere at-traverso iniziative volte a favorire il processo di integrazione sociale, quali:• favorire il coordinamento di istituzioni, enti e associazioni presenti sul territorio;• sviluppare la conoscenza e la sensibilizzazione del fenomeno migratorio;• promuovere e sostenere l’informazione relativa all’accesso ai servizi e la formazione de-
gli operatori che a vario titolo interagiscono con le cittadine e con i cittadini stranieri;• promuovere la conoscenza della cultura italiana e delle culture di provenienza delle cit-
tadine e dei cittadini stranieri;• favorire l’inserimento scolastico;• favorire la formazione, la riqualificazione professionale e l’inserimento lavorativo degli
stranieri;• favorire l’inserimento abitativo degli stranieri;• promuovere la salute delle cittadine e dei cittadini stranieri;• promuovere la partecipazione alla vita pubblica locale delle cittadine e dei cittadini stra-
nieri e percorsi di cittadinanza attiva;• agevolare l’integrazione delle donne straniere;• promuovere iniziative volte a individuare e contrastare forme di razzismo o di discrimi-
nazione a causa dell’origine etnica, geografica o religiosa;• favorire gli interventi a favore delle fasce più deboli della popolazione straniera, quali i
minori, in particolare non accompagnati, i richiedenti asilo, i rifugiati politici, le vittimedella tratta e le persone con problemi di giustizia;
• promuovere iniziative nell’ambito delle Relazioni Internazionali con i Paesi di origine;• valutare l’efficacia delle politiche previste dal presente Piano.
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 758
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 58

fini strettamente contabili, su tutte le proce-dure di spesa.
Al controllo sui conti si accompagna tal-volta l’esigenza di dare un giudizio sul meritodegli interventi e dei progetti finanziati. Comesono stati realizzati? Quante e quali personehanno coinvolto? Si sono rivelati utili? Ri-spondendo a tali quesiti si vuol apprendere sele politiche promosse hanno davvero contri-buito, e in che modo, a risolvere i problemidegli immigrati. Come è facilmente intuibile,raccogliere informazioni (e formarsi un’opi-nione) su quest’ultimo aspetto è un’operazio-ne molto più complessa della precedente.
I soggetti finanziatori degliinterventi tendono a richiedereuna rendicontazione sia delle
spese sostenute che sulla bontàdelle azioni intraprese
Nella pratica amministrativa corrente que-ste due esigenze, così diverse tra loro, finisconoperò per confluire nella stessa procedura diraccolta di informazioni: la distribuzione di unascheda di rendicontazione (cartacea) che, altermine del ciclo di finanziamento, ogni entedeve compilare, firmare e restituire (con i rela-tivi allegati) al suo referente superiore. Oltre afornire una dettagliata descrizione delle spesesostenute, a ciascun ente viene anche chiesto dirispondere per iscritto a domande relative allaqualità e all’efficacia degli interventi realizzati.L’idea è che attraverso queste semplici doman-de rivolte al singolo soggetto attuatore si riescaa cogliere qualche informazione di interessesulla sostanza dei progetti finanziati. In realtà,la procedura descritta, funzionale al controllocontabile, si rivela del tutto inadeguata a cono-scere attuazione e risultati degli interventi. Sel’interesse è capire come funzionano le politi-che e quali effetti esse producono, è necessariocambiare drasticamente sia modalità di rileva-zione, che strategia di analisi.
Abbandonare la scheda di rendicontazione(e la logica a questa sottostante) non è però co-sì semplice, in quanto impone innanzitutto un
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 59
salto di natura culturale. Per farlo, occorre chele amministrazioni coinvolte siano pronte a:• non pretendere di avere una conoscenza
“universale” sugli interventi finanziati – ti-pica invece della verifica contabile – ma, alcontrario, selezionare solo alcuni aspetti dialcune politiche sui quali effettuare ap-profondimenti;
• non impostare l’attività di rilevazione delleinformazioni (e la conseguente valutazio-ne) sulla ciclicità e le scadenze degli eserci-zi contabili o dei piani di finanziamento;
• non richiedere necessariamente documen-tazione ufficiale a supporto delle informa-zioni raccolte;
• investire tempo e risorse nella produzionedi informazioni;
• allontanarsi dal ruolo di controllore, cheverifica la correttezza delle azioni altrui, egiocare quello del facilitatore, che contri-buisce, con approccio collaborativo, a ri-solvere problemi.
L’ambizione di conoscere l’impatto
Il Piano Integrato per l’Immigrazione ponecome obiettivo del sistema di monitoraggio evalutazione la conoscenza dell’impatto sul ter-ritorio. Si tratta di una formula tipica, utilizza-ta nei testi di legge e negli atti amministrativi.Ma cosa significa esattamente? Dal tentativodi rispondere a questa domanda nasce il se-condo ordine di difficoltà.
La frammentazione degliinterventi rappresenta unostacolo in sede valutativa
qualora essi mirino a conseguireobiettivi diversi e non sempre
chiaramente definiti
Solitamente per “impatto” si intende ilcambiamento prodotto da una politica pub-blica su uno specifico problema collettivo. Pervalutarlo occorre perciò affrontare un proble-ma di attribuzione di causalità. Ma ancor pri-
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 59

ma occorre che sia ben chiaro su che cosa, ov-vero su quale specifico aspetto del problema,quel certo intervento intende incidere. Si puòad esempio valutare l’impatto della formazio-ne professionale sulle chance occupazionalidegli immigrati che hanno partecipato ai cor-si; oppure l’impatto di un’attività di mediazio-ne culturale svolta a scuola sulla facilità d’in-serimento degli alunni provenienti da paesiesteri. L’elenco dei possibili esempi potrebbecontinuare, ma il messaggio è uno solo: quan-do si parla di valutazione d’impatto non è per-messo stare sulle generali.
In altre parole, non si può valutare l’im-patto del Piano su “l’integrazione sociale”, oancor peggio sul “territorio”. Se si intendegiungere a una valutazione, è necessario defi-nire con assoluta precisione qual è il fenome-no (ad esempio la difficoltà di accesso sulmercato del lavoro o di inserimento a scuoladegli alunni stranieri) che una certa politicapubblica cerca di influenzare positivamente.
Nel portare avanti questo chiarimento, laframmentazione degli interventi non aiuta;piuttosto costituisce un ostacolo, in quanto iproblemi sui quali si vuol ottenere un impat-to sono tanti, quasi quanti sono i progetti fi-nanziati. Il Piano regionale si compone infat-ti di politiche locali condotte da soggetti di-versi, attraverso approcci differenziati: ognianno si finanziano circa 200 progetti sull’in-tera regione, che hanno dimensioni, finalità edestinatari diversi. In questa situazione pro-cedere a una valutazione d’impatto del tipoche abbiamo illustrato è impossibile (e inuti-le). Non solo non si riesce a stabilire su qua-le particolare fenomeno misurare l’impatto,ma lo stesso oggetto della valutazione, ovve-ro il Piano regionale, è di difficile definizio-ne, in quanto poliedrico, sfaccettato, mul-tiforme. Se si vuol davvero lavorare sul ver-sante del monitoraggio e dalle valutazione, èallora opportuno partire da obiettivi menoambiziosi e più realistici.
Capire (insieme) la ratio e il funzionamentodelle politiche
Un obiettivo più modesto (ma utile) per le at-tività di monitoraggio e valutazione consiste
nel tentare di capire la ratio e il funzionamen-to delle politiche adottate a livello locale. È suquesto obiettivo – al quale in verità fa riferi-mento lo stesso Piano regionale, quando sot-tolinea la necessità di individuare “buoneprassi”, attraverso la partecipazione degli at-tori coinvolti ai diversi livelli – che il gruppodi lavoro si sta attualmente impegnando. L’i-dea è di creare una sorta di “banca delle espe-rienze”: dove per ogni problema, legato allacondizione dell’essere immigrato, vi sia un’a-nalisi critica delle policy messe in atto dalle or-ganizzazioni locali.
Il punto di partenza è la scarsa conoscenzaesistente sugli interventi realizzati dalle singo-le amministrazioni. Ogni ente lavora per con-to proprio e i momenti di scambio di informa-zioni sono sporadici e superficiali. L’unicoflusso informativo regolare passa attraverso ilsistema di rendicontazione su carta che si è ri-velato inefficace per offrire una conoscenzasul merito dei problemi affrontati e sull’utilitàdelle soluzioni impiegate. Inoltre, si tratta diun flusso di informazione unidirezionale: par-te dal basso, raggiunge il livello regionale e poidi fatto muore.
Un obiettivo per le attività dimonitoraggio e valutazione è lacreazione di una sorta di “bancadelle esperienze”: dove per ogniproblema, legato alla condizione
di immigrato, vi sia un’analisicritica delle policy messe in atto
dalle organizzazioni locali
Per arricchire questo processo informativosi è deciso di selezionare alcune famiglie di in-terventi, legate da un medesimo tema afferenteai macro-obiettivi indicati sul Piano regionale(ad esempio gli interventi volti ad agevolarel’accesso all’abitazione da parte degli immigra-ti; o a fornire informazione sui servizi di pub-blica utilità; o ancora all’inserimento scolasti-co). Per ogni famiglia di interventi si costituiràun tavolo interistituzionale (che faccia perlopiùuso di strumenti telematici di comunicazione e
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 760
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 60

di scambio di informazioni) al quale potrannopartecipare i diversi soggetti coinvolti nell’at-tuazione delle politiche (funzionari dei vari en-ti locali, ma anche responsabili di organizzazio-ni del privato sociale e operatori).
I singoli tavoli – non più di tre in fase diprima applicazione – nascono per svolgere leseguenti attività:• giungere a una definizione condivisa del
problema che motiva l’esistenza di unacerta famiglia di interventi;
• ricostruire la ratio degli interventi realizza-ti a partire da quel particolare problema;
• identificare i risultati attesi dalle soluzioniadottate;
• formulare su ciascun aspetto domande divalutazione alle quali sia possibile dare unarisposta basata su evidenza empirica;
• individuare possibili strategie di raccolta eanalisi per darvi risposta;
• procedere alla raccolta delle informazioni;
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 61
• discutere gli esiti dell’attività di valutazio-ne e comunicarli all’esterno.
Si tratta naturalmente di una sfida impe-gnativa che rompe con i classici modelli dimonitoraggio e valutazione, nei quali gli enticoinvolti sono considerati esclusivamente co-me fonti di informazione. In questo nuovoschema, essi non sono più soltanto soggetti aiquali somministrare questionari, spesso maldisegnati e contenenti domande ambigue edalla difficile interpretazione; i rappresentantidegli enti locali e del privato sociale diventanoi protagonisti di un processo di apprendimen-to collettivo, all’interno del quale il loro con-tributo è utile non solo per trovare le risposte,ma anche per definire le domande di valuta-zione e per interpretare le informazioni rac-colte. Una piccola rivoluzione copernicana dalrisultato incerto, ma sulla quale vale la penascommettere.
Dughet Gaspard
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 61

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
E ACCORDI DIPROGRAMMA QUADRO:ANALISI DEI PROCESSI DI IMPLEMENTAZIONE
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
DAVIDE BARELLA,IRES Piemonte
L’Intesa Istituzionale di Programma (IIP) e i relativi Accordi di Pro-gramma Quadro (Apq) costituiscono uno dei principali strumenti diprogrammazione negoziata. Introdotti nell’ordinamento con la legge
n. 662 del 1996 e diventati operativi circa tre anni dopo, IIP e Apq sonostati regolamentati (e parzialmente riformati) attraverso una serie di delibe-razioni Cipe. L’Intesa è, in estrema sintesi, il documento nel quale il Go-verno nazionale e la Giunta regionale indicano programmi e interventi vol-ti a favorire lo sviluppo economico e sociale regionale (e in particolare del-le aree sottoutilizzate), e per i quali pare indispensabile una loro azione con-giunta. Gli Accordi di Programma Quadro rappresentano gli strumenti at-tuativi dell’Intesa e sono composti di iniziative e progetti solitamente arti-colati per settori (o programmi) di intervento che possono coinvolgere, inqualità di soggetti attuatori e/o finanziatori, una pluralità di attori (ammi-nistrazioni comunali, province, consorzi, fondazioni, ecc.)
IIP e Apq sono pertanto riconducibili al fenomeno della “contrattualiz-zazione delle politiche pubbliche” e registrano, nel loro processo di formu-lazione e attuazione, sia la necessaria presenza di attori pubblici afferenti adiversi livelli di governo (nazionale, regionale e locale) che il potenziale
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 P . 6 3 - 6 6
La programmazione negoziata costituisce ormai una tipicamodalità d’azione dei soggetti pubblici. I suoi principalistrumenti operativi (intese istituzionali di programma,
accordi di programma quadro, patti territoriali, contratti diprogrammi e contratti d’area) presentano caratteristiche
assai originali che pongono alcune peculiari difficoltàquando si intende procedere a una loro analisi e valutazione
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 62

coinvolgimento di soggetti privati. Uno deitratti distintivi del meccanismo Intesa e Ac-cordi risiede nell’aver previsto un apposito si-stema di monitoraggio al fine di verificare lafase realizzativa degli Apq.
Le IIP, una per ogni Regione, sono statesottoscritte nel biennio 1999-2000 e ad esse èseguita la stipula di circa 500 Apq. All’IntesaIstituzionale di Programma Governo naziona-le-Regione Piemonte, sottoscritta nel marzodel 2000, è seguita (periodo 2000-2006) la sti-pula di circa 30 Apq per un ammontare com-plessivo di finanziamenti di circa 1,5 miliardidi euro (il 40% dei quali a valere su risorse di-stribuite dal Cipe). Tali risorse finanziariehanno sostenuto la realizzazione di iniziative eprogetti in una molteplicità di campi di inter-vento (beni culturali, risorse idriche, turismotermale, difesa del suolo, bonifica di siti inqui-nati, trasporti, ricerca, e-government, ecc.) Inparticolare, attraverso il meccanismo Intesa eAccordi, sono state promosse e sostenute (so-prattutto nelle aree sottoutilizzate) iniziativedi rilevanza, natura e dimensione assai diversa(recupero e valorizzazione della Reggia di Ve-naria, costruzione e ampliamento di depura-tori, realizzazione di nodi di interscambio pas-seggeri, approntamento di difese spondali suicorsi d’acqua, erogazione a sostegno di pro-getto di ricerca, ecc.)
Obiettivi, destinatari e metodi dello studio
Lo studio sull’esperienza piemontese del mec-canismo Intese e Accordi, realizzato dall’IRES
Piemonte e promosso dal Nucleo di Valuta-zione della Regione (NUVAL), ha avuto qualecommittente e principale destinatario la Dire-zione Programmazione e Statistica (SettoreValutazione Progetti e Proposte di Program-mazione Negoziata). Il lavoro, avviato nellaseconda metà del 2003, si è concluso nella pri-mavera del 2005 con la presentazione pubbli-ca del rapporto di ricerca. Negli anni successi-vi è comunque proseguito il rapporto tra ri-cercatori e committente per aggiornare e/oapprofondire quelle parti del lavoro ritenutedi maggior interesse.
La richiesta iniziale sottolineava l’esigenzadi “valutare l’Intesa” e ciò ha reso necessario
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 63
chiarire preventivamente quale tipo di valuta-zione potesse essere proponibile all’interno diuna esperienza di programmazione non anco-ra consolidata. Fin dalle prime fasi del lavorosi è proceduto in parallelo al fine di “prenderele misure” dell’oggetto da studiare (il mecca-nismo Intese e Accordi) e di individuare lepossibili domande valutative. La possibilità dieffettuare una valutazione complessiva dei ri-sultati conseguiti attraverso l’Intesa e gli APQ
è stata esclusa fin dall’inizio. Innanzitutto, l’e-terogeneità dei singoli APQ (beni culturali, di-fesa del suolo, risorse idriche, ecc.) avrebbe ri-chiesto lo svolgimento di specifiche indaginiad hoc con la preliminare individuazione didiverse domande valutative in ragione dei di-versi settori e/o interventi. In secondo luogo,molte iniziative promosse attraverso gli APQ
riguardavano opere infrastrutturali la cui rea-lizzazione, come è noto, richiede tempi lunghi(e all’avvio della ricerca molte opere erano an-cora in fase di progettazione). Il lavoro di in-dagine è stato perciò indirizzato in misuraprevalente verso un’analisi di processo, coneventuali approfondimenti tematici (messi apunto nel corso dell’indagine) per risponderea specifiche richieste del committente.
A fondamento dello studio divalutazione ci sono diverse
esigenze: restituire un’immaginedello sforzo
dell’amministrazione regionalenel portare a termine gli impegni
assunti con l’accordo, faremergere le principali difficoltà,
consolidare e diffondere laconoscenza acquisita
A fondamento dello studio di valutazionec’erano, per il nostro committente, diverse esi-genze: restituire un’immagine dello sforzo in-trapreso dall’amministrazione regionale nelportare a termine gli impegni assunti con l’ac-cordo, far emergere le principali difficoltà in-contrate nell’attuazione del meccanismo Inte-
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 63

sa e Accordi, consolidare e diffondere la co-noscenza acquisita dagli apparati regionali nelcorso di questa esperienza di programmazio-ne negoziata. Per dar risposta a tali esigenze, illavoro di analisi è stato articolato nelle se-guenti attività:• ricostruzione del processo di formulazione
dell’Intesa e degli APQ piemontesi;• analisi delle caratteristiche generali dei di-
versi APQ al fine di individuarne le tipolo-gie principali;
• analisi del funzionamento delle previsteprocedure di monitoraggio (e connessionicon strumenti analoghi e preesistenti);
• prime elaborazione dei dati acquisiti attra-verso il sistema di monitoraggio;
• parziale approfondimento valutativosull’APQ in materia di beni culturali;
• analisi di analoghe esperienze di policy inaltri paesi europei (Contrats de Plan Statoe Regioni in Francia).
L’analisi della documentazione ammini-strativa, le interviste con testimoni privilegiati(in prevalenza funzionari dell’apparato ammi-nistrativo regionale) e l’archivio informativocostituito dai dati acquisiti dal sistema di mo-nitoraggio sono stati le principali fonti impie-gate nel lavoro. Per svolgere al meglio il lavo-ro si è inoltre ritenuto opportuno costituire ungruppo di lavoro interdisciplinare che ha inte-ragito, talora al suo completo più spesso perspecifiche tematiche, con la committenza.
I risultati emersi
Il compito di riassumere i principali risultatiemersi dallo studio non è particolarmente age-vole in ragione dei diversi profili di indaginesvolti. Rinviando i lettori interessati alla lettu-ra del rapporto di ricerca (scaricabile dal sitowww.ires.piemonte.it), ci limiteremo qui a ri-chiamare solo alcuni puntuali spunti di rifles-sione per esemplificare la natura delle consi-derazioni sviluppate nel corso dell’indagine.In prima battuta, si è cercato di individuare edescrivere i contenuti delle politiche sotteseall’esperienza del meccanismo Intese e Accor-di e di rendere conto delle caratteristiche del-le iniziative promosse e sostenute attraverso i
singoli APQ. Tale compito è stato piuttostoagevole grazie alla notevole disponibilità didati amministrativi che, opportunamente sin-tetizzati, hanno consentito di ricostruire ilprofilo di questa esperienza di programmazio-ne negoziata nelle sue diverse componenti(dall’IIP ai singoli APQ fino ai relativi inter-venti).
Tale attività ha inoltre consentito, attraver-so gli incontri svolti con i funzionari regionali,di far emergere il diverso significato che i sin-goli settori coinvolti hanno attribuito all’APQ
evidenziando le diverse funzioni svolte dallamedesima strumentazione (IIP e APQ). Adesempio, per i beni culturali, l’APQ ha rappre-sentato sia l’occasione per fare il punto dellasituazione in un settore che negli ultimi anniaveva registrato una notevole vitalità, sia la se-de per porre le basi di futuri e impegnativi in-terventi e concordare compiti e responsabilità(finanziarie e attuative) tra i principali attoricoinvolti (Regioni, Soprintendenze, Fondazio-ni, Comuni, ecc.)
Attraverso gli incontri con ifunzionari regionali è emerso ildiverso significato che i singoli
settori coinvolti hanno attribuitoall’APQ evidenziando le diversefunzioni svolte dalla medesima
strumentazione
Nel caso della difesa del suolo, l’APQ è in-vece stato interpretato come uno strumentoattraverso il quale finanziare singoli interventie progetti che da tempo erano in agenda oprogrammati ma che facevano fatica ad acce-dere alle necessarie fonti di finanziamento. Ilquadro generale ha così permesso di com-prendere come, la medesima strumentazione(IIP e APQ), sia stata opportunamente “adat-tata” ai singoli contesti di settore (ognuno ca-ratterizzato da specifici quadri normativi e di-stinte programmazioni settoriali). Tale baga-glio informativo ha consentito alla DirezioneProgrammazione di individuare i punti di for-za e di debolezza delle diverse interpretazioni
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 764
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 64

adottate dagli apparati regionali al fine di at-trezzarsi al meglio per adeguarsi ai cambia-menti apportati, in sede nazionale, alle regolee alle procedure relative agli APQ.
Uno degli elementi che maggiormente ca-ratterizza e qualifica il meccanismo Intese eAccordi risiede nell’approntamento di oppor-tuni strumenti di verifica e monitoraggio. L’u-nità elementare delle attività di monitoraggioè costituita dalla scheda-intervento che deveessere compilata, per ogni progetto o iniziati-va, in sede di stipula dell’accordo quadro eaggiornata ogni sei mesi. Le informazioni rac-colte permettono di ricostruire le caratteristi-che del progetto nei suoi diversi profili (pro-cedurali, finanziari, ecc.), sia in chiave previ-sionale che effettiva. L’analisi del sistema dimonitoraggio (e dei dati in esso contenuti) haconsentito di evidenziare alcuni aspetti rile-vanti del processo attuativo (tanto del moni-toraggio che degli interventi). Innanzitutto,alcune Direzioni regionali hanno, soprattuttoall’inizio, considerato il monitoraggio più co-me un obbligo burocratico che come una ri-sorsa atta ad accrescere le loro capacità di ve-rifica del processo attuativo degli interventi.Ciò è dipeso – oltre che dalla rigidità delleprocedure – da una non sufficiente chiarifica-zione degli obiettivi del monitoraggio all’in-terno delle strutture responsabili dei vari APQ
e dalla preesistenza, in molti settori, di altreattività di monitoraggio (discrezionali e non).In secondo luogo, con i dati acquisiti attra-verso il monitoraggio, è stata ricostruita latempistica degli interventi. Il forte scosta-mento registrato tra i tempi previsti e quellieffettivi ha condotto a esaminare, in via esplo-rativa, le procedure amministrative seguitenei diversi settori (in particolare degli inter-venti relativi a infrastrutture pubbliche). L’e-laborazione dei dati ha permesso di eviden-ziare che, nella maggior parte dei casi e senzaparticolari differenze tra APQ, la fase piùcomplessa (e maggiormente impegnativa sot-to il profilo del tempo richiesto) è quella rela-tiva all’approvazione del progetto definitivo.Le ragioni di ciò sono da ricondurre alla ne-cessità di acquisire, in questa fase, pareri, nul-la-osta e autorizzazioni necessarie per le di-verse opere ovvero a variabili che concerno-no le procedure da seguire nella realizzazione
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 65
delle opere pubbliche sulle quali, tuttavia, ilmeccanismo Intese e Accordi non può inci-dere in modo diretto. Attraverso queste ela-borazioni si è cercato di sottolineare la neces-sita di procedere a una più attenta selezionedegli interventi (o all’individuazione di op-portuni accorgimenti) pena l’elevato rischiodi incorrere nel disimpegno del finanziamen-to nazionale.
Nella maggior parte dei casi lafase più complessa dell’APQ èquella dell’approvazione del
progetto definitivo a causa dellanecessità di acquisire pareri,
nulla-osta e autorizzazioni per lediverse opere
Inoltre, sempre nell’ambito di tale filonedi lavoro, sono stati elaborati una serie di sem-plici indicatori sintetici sullo stato di attuazio-ne (ad esempio la velocità di spesa). Infine,un’osservazione aggiuntiva ha riguardato laconstatazione che, in molti settori, sono pre-senti diversi sistemi di monitoraggio. Acco-munati da analoghe finalità, tali sistemi opera-no tuttavia con diverse regole di funziona-mento e distinte piattaforme informatiche ge-nerando un carico di lavoro per gli apparatiregionali che non pare sempre giustificato.
Infine, su un altro fronte di attività, è sta-ta svolto un lavoro ad hoc sulle modalità difunzionamento di uno strumento per moltiaspetti analogo al meccanismo Intese e Ac-cordi: i “contratti di piano” (Contrats de plansEtat-Région) istituiti in Francia a partire dallametà degli anni ottanta. L’analisi comparatadei due strumenti ha offerto alcune indicazio-ni importanti. Innanzitutto, anche nell’espe-rienza francese è stata abbandonata, per ilmomento, qualsiasi ipotesi di valutazione expost complessiva del Contrats de Plan. Il di-spositivo di valutazione partenariale dei variprogrammi contenuti nei Contrats de Planpresenta invece aspetti molto interessanti perquanto concerne i meccanismi di concerta-zione nella scelta dei programmi da sottopor-
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 65

re a valutazione, l’indipendenza e la traspa-renza dell’attività di valutazione e il processodi apprendimento all’interno delle varie unitàdella Pubblica amministrazione al quale dàluogo. Infine, per quanto concerne il monito-
raggio, il sistema francese appare molto diso-mogeneo tra le varie regioni e molto menostrutturato di quello italiano: una volta tantoci collochiamo bene in un confronto interna-zionale.
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 766
Maestro del Giudizio di Salomone
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 66

LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
L’ESPERIENZA CONDOTTACON LA VALUTAZIONE DEL DOCUP 1994-1999
RENATO COGNO,IRES Piemonte
Le politiche promosse attraverso i fondi strutturali europei,per le rilevanti conseguenze che hanno nel contesto regionale,sono da tempo oggetto di analisi da parte dell’Ires Piemonte.
Qui viene descritta l’esperienza relativa a una valutazionesvolta negli anni passati sull’attuazione del Documento Unico
di Programmazione (DOCUP) piemontese del periodo 1994-1999. Tale indagine, realizzata su richiesta della Direzione
Industria della Regione Piemonte, è stata svolta tra il 2001 eil 2002 e partiva da una analoga esperienza di ricerca svoltaper il precedente periodo di programmazione comunitaria.Qui si illustra la modalità di definizione delle domandevalutative (cosa analizzare e perché), la progettazione el’organizzazione dell’analisi, i principali risultati emersi
L’oggetto del lavoro
Il DOCUP è un programma pluriennale di interventi (pubblici e privati) chericadono su una porzione significativa del territorio piemontese. Cofinan-ziato dai fondi strutturali destinati all’obiettivo comunitario di riconversionedelle regioni gravemente colpite da declino industriale, il programma era de-stinato solo ad alcune zone del Piemonte (le aree considerate eligibili dal-l’UE): la provincia di Torino (ma solo una parte del capoluogo); la ValleScrivia, che è una sub-area della provincia di Alessandria; la gran parte delVerbano-Cusio-Ossola. Nel complesso le tre aree riguardano circa metàdella popolazione piemontese.
Il programma interviene su diverse aree e settori economici: la riqualifi-cazione delle PMI, la valorizzazione delle potenzialità turistiche, la diffusio-ne di tecnologie ambientali o innovative, la tutela ambientale. Gli strumen-ti d’intervento impiegati nel programma sono diversi: dal sostegno finan-ziario diretto all’investimento di singole PMI, al sostegno alla realizzazionedi infrastrutture, alla promozione e sostegno di specifici programmi di svi-luppo locale, destinati a comprensori delimitati. In generali i vari interven-
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 P . 6 7 - 7 2
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 67

ti richiedono la compartecipazione finanziariadei beneficiari finali degli investimenti, qualile imprese, gli operatori, gli enti locali.
Va ricordata la natura negoziata di questapolitica. Il DOCUP è stato definito e approvatocongiuntamente dai partner pubblici che lo fi-nanziano: Unione Europea, governo naziona-le, amministrazione regionale. Attraverso il la-voro di opportuni organi paritetici (quali i Co-mitati di Sorveglianza) gli stessi partner si im-pegnano a verificare l’attuazione del program-ma, ad apportarvi le modifiche ritenute op-portune e a esaminare i risultati conseguiti. Laregia complessiva della gestione è affidata allaDirezione Industria della Regione Piemonte.
Le altre valutazioni disponibili
La corresponsabilità e il coinvolgimento di di-versi soggetti istituzionali implica anche unapossibile diversità negli obiettivi che ognunodi questi soggetti persegue con il DOCUP. Talediversità si riflette nella presenza di diverse at-tività di monitoraggio e valutazione che riguar-dano il programma (a livello aggregato o nellesue diverse componenti).
La corresponsabilità di diversisoggetti istituzionali nel DOCUPimplica l’esistenza di diversitànegli obiettivi che ognuno diquesti soggetti persegue. Tale
diversità si riflette nellaesistenza di diverse attività di
monitoraggio e valutazione dellostesso programma
Tra queste attività si segnalano i periodici rap-porti dei valutatori indipendenti e del Comita-to di Sorveglianza, i questionari e monitoraggisulle misure DOCUP richiesti dall’UE, i docu-menti interni regionali di rendicontazione degliinterventi regionali propri utilizzati nell’ambitodel DOCUP. La Commissione Europea, infine,elabora rapporti comparativi di carattere inter-
regionale utilizzando diversi parametri di riferi-mento predisposti dalle diverse regioni.
La definizione delle esigenze conoscitive edella strategia valutativa
Il lavoro dell’IRES Piemonte è stato realizzatosu incarico della Direzione Industria della Re-gione Piemonte, cioè il soggetto con le mag-giori responsabilità gestionali nel programma.In estrema sintesi, il committente ha volutopromuovere uno studio sull’attuazione e suirisultati dal DOCUP, intesi come le conseguen-ze socioeconomiche e territoriali del program-ma. Peraltro la definizione specifica delle do-mande valutative, cioè gli obiettivi della ricer-ca, ha richiesto tempo e una progressiva messaa fuoco effettuata con il committente (la Dire-zione Industria).
La definizione specifica delledomande valutative, cioè gli
obiettivi della ricerca, harichiesto tempo e una
progressiva messa a fuocoeffettuata con il committente
In primo luogo sono state identificate e re-cepite le diverse esigenze conoscitive del com-mittente. Una prima esigenza manifestata eraquella di una verifica dell’impatto occupaziona-le realizzato con il DOCUP nel complesso e inparticolare per gli interventi (misure) che ave-vano questo obiettivo esplicito (le misure diaiuto finanziario diretto all’investimento dellePMI, che assorbono una quota rilevante dellerisorse pubbliche previste nel DOCUP). È que-sto un aspetto preso in considerazione sin dal-le valutazioni preliminari del programma an-che se, ovviamente, solo in termini previsiona-li di impatto occupazionale atteso.
Un secondo tipo di esigenza manifestatadal committente era una descrizione sinteticadella allocazione degli investimenti coinvoltidal DOCUP; opportunamente aggregata: per ti-po di intervento (infrastrutture, investimenti
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 768
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 68

Le AIA e i PIS: realizzazioni ed efficacia. IParchi scientifici e tecnologici.Gli interventi di valorizzazione del turismo.La progettualità integrata: domande postealla valutazione. Caratteristiche, efficacia e impatto sul territo-rio dei Progetti Integrati.
Organizzazione del lavoro svolto
Premessa al lavoro è stata una descrizione del-l’allocazione complessiva degli investimentipromossi dal DOCUP, articolata per ambitoterritoriale, per tipo e natura dell’intervento,per tipo di soggetto beneficiario.
Il lavoro si articola in diverse valutazioni,cioè diverse indagini rivolte a rilevare l’effica-cia delle principali componenti del Program-ma. Ogni indagine è stata costruita ad hoc alfine di utilizzare le specifiche metodologie ri-chieste nei singoli casi. La prima indagine ri-guardava l’efficacia delle iniziative di incenti-vazione all’investimento diretto delle PMI (chesi basava su un’erogazione finanziaria direttaai beneficiari finali). In questo caso si è stima-to l’impatto netto della misura adottando l’ap-proccio controfattuale (confronto tra l’anda-mento occupazionale delle imprese beneficia-te con quello di imprese non beneficiate).
Per le misure di incentivazioneall’investimento diretto delle
PMI si è stimato l’impatto nettodella misura adottando
l’approccio controfattuale, cioè ilconfronto tra l’andamento
occupazionale delle impresebeneficiate con quello diimprese non beneficiate
Altre due indagini hanno riguardato le mi-sure di sostegno alla realizzazione di opere di uti-lità collettiva a favore del tessuto produttivo lo-cale di PMI (i parchi tecnologici, le aree indu-striali, specifici programmi di ricerca). In esse:
delle PMI, ecc.), articolazione territoriale (learee eligibili, subaree regionali, singoli comu-ni) e categorie di soggetti beneficiari.
Una terza e ultima esigenza manifestatadal committente riguardava invece l’attuazio-ne e/o l’efficacia di specifici interventi (misure).La Direzione Industria era interessata a esa-minare le conseguenze connesse alla realizza-zione di aree e altre strutture destinate all’in-sediamento di PMI: una politica questa di lun-ga tradizione nell’esperienza regionale pie-montese e che, nel corso degli anni, ha benefi-ciato di significativi finanziamenti e diverseformulazioni (Aree Industriali Attrezzate, Po-li Integrati di Sviluppo).
Il gruppo di lavoro (formato da ricercatoridell’IRES ed esperti esterni) ha poi individuatodue ulteriori politiche da sottoporre a indagi-ne: i Parchi tecnologici e il Programma integra-to di intervento in materia turistica.
Si è così concordata l’articolazione del lavo-ro da svolgere (vedi riquadro) e avviati gli op-portuni contatti con uffici regionali coinvoltidagli specifici interventi (i diversi settori dellaDirezione Industria e della Direzione Turi-smo) per verificarne disponibilità e interessi eacquisire ulteriori informazioni ed esigenze.Infatti, si è manifestata un’ulteriore esigenzaconoscitiva, comune a diverse politiche delDOCUP: quella di disporre di un quadro infor-mativo sugli investimenti realizzati che consen-ta una comparazione tra i singoli soggetti rea-lizzatori di investimenti: ciò al fine di indivi-duare le best practices di taluni interventi.
DOCUP 1994-1999Articolazione e temi affrontati nella valuta-zione
Strategia e struttura del Programma. Attuazione del Programma: fasi di program-mazione; la selezione dei progetti finanziati. Distribuzione territoriale degli investimenti.Gli interventi sul tessuto delle PMI attraversoaiuti diretti alle imprese: incidenza degli in-vestimenti sul territorio; impatto occupazio-nale degli interventi.La creazione di esternalità per le imprese e ilterritorio: valutare la realizzazione di infra-strutture per le PMI.
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 69
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 69

• si analizza la rispondenza degli investi-menti ai bisogni locali e settoriali;
• si esamina l’incidenza degli interventi sulladinamica di crescita (economica e/o occu-pazionale) delle aree coinvolte.
Per tali indagini si è fatto ricorso perlopiùa interviste ai soggetti responsabili della rea-lizzazione delle opere (amministrazioni locali,società di intervento regionali, direttori deiparchi tecnologici).
Un terzo gruppo di indagini si è focalizza-to sul sostegno a programmi di sviluppo locale,attraverso il quale si cerca di far convergere leazioni di sviluppo messe in campo da una plu-ralità di attori che operano in specifiche areeterritoriali. Si tratta di governare gli obiettivi ele azioni di diversi operatori economici pre-senti in un limitato territorio, ricorrendo a piùstrumenti e modalità di intervento. Tale mo-dalità di intervento incentiva la progettualitàdei territori, costituti da aree a vocazione turi-stica (esistente o potenziale). In quest’ambitosi è anche cercato di valutare l’utilità di un’a-zione che mira a stimolare non una singola especifica realizzazione o intervento, bensì l’e-laborazione e il consolidamento della proget-tualità locale.
Il lavoro si articola in:svolgimento di diverse indaginirivolte a rilevare l’efficacia delle
componenti del Programma;comparazione dei diversi
strumenti di intervento di cuidispone la Regione per
investimenti volti allo sviluppo
Tale articolazione del lavoro ha consentitoinoltre di comparare i diversi strumenti di in-tervento di cui dispone l’ente regionale per fa-vorire investimenti volti allo sviluppo: gli aiu-ti finanziari diretti alle imprese, le infrastrut-ture a utilità collettiva, i servizi alle imprese, leazioni volte al coordinamento delle iniziativelocali di sviluppo economico.
La conduzione delle valutazioni
Il lavoro è stato progettato da un gruppo stabi-le di ricercatori dell’IRES cui si sono affiancatiesperti e consulenti per specifiche funzioni eattività. I ricercatori di Pro.Va. hanno condot-to la prima delle indagini indicate (quella ine-rente l’impatto occupazionale degli incentiviall’investimento per le PMI). Altre indagini so-no state condotte direttamente dai ricercatoriIRES, alcune con la collaborazione di espertiesterni. Il raccordo con gli uffici regionali è ri-sultato marginale e discontinuo.
Si sono privilegiati i contattidiretti con i soggetti beneficiari
dei finanziamenti del Docup, chehanno realizzato e gestito i vari
investimenti e interventi
Le fonti informative impiegate nel corsodell’indagine sono state numerose e assai di-versificate. In generale si è fatto un limitato ri-corso a fonti amministrative interne degli uffi-ci regionali. Essi hanno messo a disposizionesoprattutto alcuni dati delle istruttorie deiprogetti ammessi a finanziamento. Per quantoriguarda l’attuazione e l’avanzamento degli in-terventi, la fonte principale sono stati i perio-dici rapporti predisposti per il Comitato diSorveglianza dalla segreteria tecnica regionalee i rapporti elaborati dal valutatore indipen-dente (Ecoter).
In generale si sono privilegiati i contatti di-retti con i soggetti beneficiari dei finanziamentidel DOCUP, che hanno realizzato e gestito i variinvestimenti e interventi (amministratori locali,società di intervento, i direttori dei Parchi).
La mancanza di un raccordo stabile con levarie strutture regionali coinvolte e gli scambiinformativi limitati hanno talora creato alcunesovrapposizioni. I beneficiari degli interventisono stati oggetto di più d’una rilevazione dimonitoraggio da parte degli uffici regionali.Peraltro, l’incompletezza di tali rilevazioni ol’indisponibilità dei risultati ne hanno impedi-to l’utilizzo.
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 770
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 70

Infine sono stati utilizzati dati statistici (suiterritori, sulle imprese, sull’occupazione) difonte esterna (INPS, ISTAT, centri regionali perl’impiego, APT).
Quali risultati ottenuti
Alcuni brevi e schematici cenni al tipo di ri-sultato emerso con il lavoro svolto. In genera-le si sono considerati soprattutto aspetti di ef-ficacia degli specifici interventi o politichecomprese nel DOCUP. Non si sono considera-te l’efficienza tecnica ed economica dei singo-li interventi o delle specifiche politiche; si so-no anche trascurati gli aspetti di gestione fi-nanziaria – trattati soprattutto dalle altre valu-tazioni.
Sono emerse differenze tra ibacini nella capacità di utilizzare
i finanziamenti disponibili(interventi di incentivo diretto
alle PMI): le diverse capacità deibacini di usare le opportunitàpaiono essersi consolidate di
programmazione inprogrammazione
L’analisi della distribuzione territoriale de-gli investimenti è stata condotta con riferi-mento ai 49 bacini corrispondenti ai centriper l’impiego: si tratta di partizioni del terri-torio arbitrarie, amministrative, ma considera-te comunque utili per finalità conoscitive.Emergono differenze tra i bacini nella capacitàdi utilizzare i finanziamenti disponibili. Talidifferenze sono di interesse, soprattutto conriferimento agli interventi di incentivo direttoalle PMI: le diverse capacità dei bacini di usarele opportunità paiono essersi consolidate diprogrammazione in programmazione (si sonoconsiderati quattro diversi periodi dal 1989 al1999); tali differenze non paiono riconducibi-li ad aspetti dimensionali dei bacini, oppure distruttura economica prevalente delle imprese.
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 71
Piuttosto possono derivare da un apprendi-mento: il tessuto delle PMI di certe aree, al dilà della caratterizzazione economica, manife-sta una maggior capacità di utilizzare i finan-ziamenti disponibili.
Emerge una relazione positivatra dinamismo socioeconomico
locale e performancecomplessive degli investimenti
realizzati
L’indagine sugli incentivi all’investimentodelle PMI ha misurato l’impatto degli incentiviforniti all’investimento. Si è considerato solol’impatto occupazionale, che risulta limitato:l’andamento occupazionale delle PMI benefi-ciate e dei settori coinvolti non è significativa-mente diverso di quello delle altre PMI, nonbeneficiate dal DOCUP.
L’indagine sulle aree attrezzate e sui Poliintegrati di sviluppo ha misurato l’attrazioneeffettiva che queste strutture hanno potutoesercitare sulle imprese piemontesi, e l’impattoeconomico che le stesse strutture hanno avutosul territorio che le ospita. L’indagine rivelauna elevata adeguatezza delle opere ai bisognilocali. Le esternalità risultano decrescenti pas-sando dai Parchi ai PIS alle AIA. L’indagine suibeneficiari ha anche identificato le percezionidei gestori delle strutture e individuato alcunisuggerimenti per le politiche settoriali.
L’indagine sui Parchi tecnologici costitui-sce invece la prima indagine piemontese inmerito, relativamente a una politica iniziatacon il DOCUP 1989-93 e proseguita nel DOCUP
qui considerato. Ha messo in evidenza l’one-rosità di una politica volta a creare esternalitàampie, con ricadute potenziali sull’intera co-munità economica regionale.
Attraverso l’analisi sui 13 Progetti TuristiciIntegrati si sono individuate le caratteristicheeffettive dell’integrazione. Quindi si sono mi-surate le performance dei singoli progetti edevidenziate le best practices. Si sono anche in-dividuati possibili elementi esplicativi di taliperformance.
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 71

In generale emerge una relazione positivatra dinamismo socioeconomico locale e perfor-mance complessive degli investimenti realiz-zati. Tale relazione è netta nel caso delle areeper insediamenti produttivi: nei contesti piùdinamici, le aree realizzate risultano anchepiù dotate di servizi alle imprese, e le perfor-mance complessive ottenute sono migliori(imprese più qualificate, incremento occupa-zionale). Nel caso dei progetti turistici inte-
grati è netta soprattutto la relazione inversa:nei contesti meno dinamici, con minor poten-ziale, le performance complessive ottenutesono inferiori. Una parziale conferma puòtrarsi anche nel caso del sostegno finanziariodiretto all’investimento delle PMI: non sono iterritori caratterizzati da maggior bisogno(maggior disoccupazione) ad aver sfruttatomaggiormente le opportunità concesse dalDOCUP.
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 772
Dosso Dossi
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 72

LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
VALUTARE ILMICROCREDITO: L’ANALISI
DI UN PROGETTOCONDOTTO IN ITALIA
FRANCESCA
ANGLOIS,ProgettoValutazione
L’obiettivo del microcredito consiste nel rendere effettivo il diritto diaccesso al credito, consentendo ai soggetti più meritevoli – per capa-cità, competenze o idee – di avviare un’iniziativa imprenditoriale, an-
che se privi delle garanzie reali abitualmente richieste dalle banche per laconcessione di prestiti. L’esperienza di microcredito più nota è sicuramen-te quella condotta dalla Grameen Bank, una banca rurale, fondata daMuhammad Yunus negli anni Settanta in Bangladesh, che concede prestitia persone che vivono in condizioni di povertà ed emarginazione. Parallela-mente a questa esperienza, sia nei paesi in via di sviluppo (Pvs) che in quel-li a industrializzazione avanzata, si sono andate affermando molte iniziativeanaloghe, sponsorizzate da enti pubblici e da organizzazioni del privato so-ciale. Alla fine del 2004, secondo i dati del Microcredit Summit Campaign,si contavano in tutto il mondo circa 2.572 programmi di microcredito, checoinvolgevano più di 67 milioni di beneficiari
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 P . 7 3 - 7 8
Dare una definizione univoca di cosa sia il “microcredito”,soprattutto nei paesi industrializzati, non è un’operazionesemplice; dietro a questa espressione si ritrovano attività e
interventi spesso molto diversi tra loro. In linea di massimasi può dire che il microcredito è uno strumento con cui
vengono messi a disposizione di soggetti esclusi dal sistemadi credito tradizionale finanziamenti di modesta entità, per
sostenere la realizzazione di progetti imprenditoriali oformativi. Nel corso degli ultimi anni, anche in Italia, sistanno diffondendo numerose iniziative di questo genere
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 73

La logica del microcredito
L’esclusione dal mercato del credito dei sog-getti più deboli non è tipica soltanto dei PVS;anche nei paesi più ricchi accade che una fet-ta consistente della popolazione sia lasciatafuori dai servizi finanziari più tradizionali. Adesempio, in Italia, secondo i dati ISTAT, oltre 7milioni e mezzo di persone – circa il 15% del-la popolazione – vivono in stato di povertà e,secondo un’indagine condotta nel 2004 dallaBanca d’Italia, oltre 2 milioni e 900.000 fami-glie italiane non hanno la possibilità di acce-dere a servizi bancari, quali l’accensione dimutui o l’attivazione di piccoli prestiti.
Gli interventi di microcredito sibasano sull’ipotesi che il sistema
bancario applichi dellerestrizioni eccessive nella
concessione dei prestiti e finiscaper non finanziare soggetti chesarebbero comunque prestatari
affidabili
Gli interventi di microcredito si basanodunque sull’ipotesi che il sistema bancario ap-plichi delle restrizioni eccessive nella conces-sione dei prestiti e finisca per non finanziaresoggetti che, sebbene vivano situazioni di for-te disagio economico, sarebbero comunqueprestatari affidabili, essendo in possesso siadelle idee che della volontà necessaria, perportarsi fuori da tali situazioni e restituire ildenaro prestato fino all’ultima rata. In questaprospettiva tali restrizioni determinano un’al-locazione delle risorse finanziarie che risultainefficiente da un punto di vista sociale.
Il progetto della Compagnia di San Paolo
Per dare una risposta a questo problema, laCompagnia di San Paolo di Torino ha avviatonel 2003 il progetto sperimentale “Microcre-dito Sociale”. Attraverso il finanziamento diattività imprenditoriali e percorsi formativi, la
Compagnia offre a soggetti esclusi dal creditotradizionale, opportunità di crescita finalizza-te al raggiungimento dell’indipendenza eco-nomica.
Il progetto è stato realizzato in quattro di-versi contesti territoriali, le province di Geno-va, Roma e Napoli e il territorio dell’Arcidio-cesi di Torino. L’implementazione sul territo-rio è stata seguita da quattro Enti non profit: laFondazione don Mario Operti di Torino, laFondazione Antiusura S. Maria del Soccorsodi Genova, la Fondazione Risorsa Donna diRoma e la Fondazione S. Giuseppe Moscati diNapoli. Questi Enti hanno il compito di inter-cettare le richieste e seguire le attività di istrut-toria e accompagnamento dei richiedenti lun-go tutto l’iter procedurale.
La Compagnia di San Paolo diTorino ha avviato nel 2003 il
progetto sperimentale“Microcredito Sociale” che offreopportunità di crescita a soggetti
esclusi dal credito tradizionale
La Compagnia ha messo a disposizione unfondo di garanzia di 400.000 euro per ciascu-no dei quattro enti di riferimento, oltre agliimporti necessari per garantire la gestioneoperativa, le azioni di comunicazione, il moni-toraggio e la valutazione. La Banca IntesaSanpaolo e il Sanpaolo Banco di Napoli han-no il compito di chiudere la fase di istruttoriaeffettuando la valutazione conclusiva della ri-chiesta e provvedendo, in caso di giudizio po-sitivo, all’erogazione del credito.
Il finanziamento massimo concedibile am-monta a 20.000 euro per le persone fisiche e a35.000 euro in caso di società di persone o dicooperative sociali; l’importo minimo è pari a2.000 euro per l’avvio e lo sviluppo di attivitàeconomiche e a 1.000 euro per i progetti rife-riti all’occupabilità, ossia il pagamento di cor-si di formazione e qualificazione professiona-le. Sui prestiti concessi viene pagato un tassod’interesse, corrispondente all’Euroirs – il pa-rametro utilizzato come base per il calcolo del
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 774
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 74

tasso di interesse del mutuo a tasso fisso a li-vello europeo – più uno spread dello 0,50%.Il piano di ammortamento è stabilito sulla ba-se delle caratteristiche dell’impresa finanziatae può variare da un minimo di 18 fino a unmassimo di 60 mesi, rimborsabile in rate men-sili costanti, previa accensione di un rapportodi conto corrente a condizioni agevolate.
La valutazione tenta di darerisposta a una duplice esigenza:
tenere sotto controllol’implementazione del progetto;
avere riscontri in merito allericadute
Parallelamente alla fase di progettazione laCompagnia ha commissionato a Progetto Va-lutazione il monitoraggio e la successiva valu-tazione dell’intervento. Il disegno di valuta-zione è nato quindi nella migliore delle condi-zioni possibili: una domanda maturata in senoalla committenza nel momento stesso in cuil’intervento è stato ideato. In particolare, lavalutazione tenta di dare risposta a una dupli-ce esigenza della committenza: • da un lato tenere sotto controllo l’imple-
mentazione del progetto, delegata in buo-na parte agli enti non profit;
• dall’altro avere riscontri in merito alle rica-dute dell’intervento che, soprattutto nellefasi iniziali, erano tutt’altro che scontate.
La costruzione del sistema di monitoraggio
La prima esigenza nasce dalla necessità dimantenere un buon livello di conoscenza sul-l’intervento attraverso l’osservazione direttadel processo di implementazione condotto daisingoli Enti e attraverso la descrizione e la mi-surazione sistematica di ciò che è stato pro-dotto in ognuno dei quattro territori. È statoperciò predisposto un sistema di monitorag-gio che ha permesso nel tempo di raccoglierein modo puntuale una serie di informazioni edi restituire, con cadenza regolare, un’adegua-
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 75
ta documentazione empirica. L’azione si è ar-ticolata in cinque momenti principali: • scelta delle variabili da osservare, effettua-
ta tramite un’attenta analisi del processo diselezione delle domande e verifica dellapossibilità di ottenere dai quattro entiinformazioni omogenee;
• costruzione di un modello di rilevazioneunivoco per tutti e quattro gli enti;
• applicazione del modello mediante la rile-vazione periodica dei valori;
• ricorrenti discese sul campo che, attraver-so l’osservazione diretta e l’ascolto degliattori coinvolti nel progetto, permettonodi raccogliere informazioni sulle modalitàd’interazione tra operatori e beneficiari nelcontesto specifico in cui hanno luogo;
• realizzazione di interviste per approfondi-re le problematiche emerse e individuarele procedure più adatte ai singoli contesti.
Nella prima fase di attività la difficoltàprincipale è consistita nel rendere più siste-matiche e omogenee tra loro le procedure diraccolta dei dati adottate nei diversi contestiterritoriali. Al termine del lavoro si è decisodi raccogliere presso ogni ente informazionidettagliate in merito a sei dimensioni ben de-finite:• le procedure di presa in carico delle do-
mande di finanziamento; • le caratteristiche dei richiedenti; • le modalità utilizzate dai quattro Enti du-
rante la fase di istruttoria; • gli esiti dell’istruttoria; • le caratteristiche dei prestiti erogati dalle
banche; • il tasso di restituzione da parte dei benefi-
ciari.
A tre anni dall’avvio del progetto sono sta-ti approvati da parte dei quattro enti circa 200finanziamenti. Se si considerano le 957 richie-ste, è stato approvato il 21% delle domande,mentre se si escludono dal denominatore ledomande pendenti al 30 settembre 2007 (percui l’esito è ancora incerto) tale percentualesale al 24%. La probabilità che una richiestavenga approvata sta quindi tra questi due va-lori, cioè un numero che varia tra un quinto eun quarto dei richiedenti viene soddisfatto e
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 75

riceve il finanziamento. Le domande presen-tate dalle donne – pur essendo nel complessomeno numerose di quelle presentate dagli uo-mini – hanno avuto un tasso di successo mag-giore. Allo stesso modo le domande sono sta-te presentate in prevalenza da cittadini italia-ni, ma la probabilità di approvazione è ten-denzialmente più favorevole per i cittadinistranieri.
I progetti approvati sono tra loro moltoeterogenei per tipo di attività finanziata: pre-valentemente attività commerciali di vendita(vendita di mobili, di articoli africani, di scoo-ter, di articoli di abbigliamento, ma anchevenditori ambulanti) seguiti da attività di ser-vizi (apertura di asili, avvio di lavanderie, diservizi internet, di attività informatiche contoterzi). I progetti per la copertura di debiti, puressendo stati richiesti, non sono stati approva-ti in nessun caso.
Le attività con minor rischio diinsolvenza sembrano essere
quelle di ristorazione e quellelegate ai servizi
La registrazione sistematica del tasso di re-stituzione, attraverso il controllo delle ratenon pagate da parte dei beneficiari, ha per-messo di verificare se e in che modo la proba-bilità di insolvenza sia influenzata dalle carat-teristiche del beneficiario. A seconda delle ca-ratteristiche del richiedente è stata calcolata –attraverso il modello statistico probit – la per-centuale di prestiti con più di tre rate di ritar-do sul totale dei finanziamenti concessi. Ne è
emerso che le domande presentate da donnestraniere, e da chi ha avuto esperienze di lavo-ro dipendente, hanno una minore probabilitàdi insolvenza.
L’analisi delle ricadute sui beneficiari
La seconda esigenza sollevata dalla Compa-gnia – ovvero il problema dell’efficacia del mi-crocredito – è stata affrontata in un secondomomento. Si tratta in pratica di capire se l’in-tervento di microcredito promosso dallaCompagnia ha prodotto o meno le conse-guenze desiderate sui destinatari dei finanzia-menti. Per tentare di rispondere a queste do-mande è stato necessario aspettare alcuni annidal momento della concessione dei primi pre-stiti, affinché gli eventuali effetti derivanti dal-l’accesso al credito avessero la possibilità dimanifestarsi.
Si tratta di un’attività di valutazione piut-tosto innovativa, in quanto fino a oggi non esi-stono molti studi che tentano di stimare gli ef-fetti del microcredito. In molte delle valuta-zioni realizzate – nella maggior parte dei casicondotte nei PVS – piuttosto che stimare glieffetti ottenuti sui beneficiari, ci si limita a rac-contare “storie di vita” che descrivono casi disuccesso; oppure si utilizzano alcuni indicato-ri che descrivono l’implementazione del pro-gramma (numero di finanziamenti concessi,importo erogato e tasso di restituzione), comeevidenze del successo degli interventi.
Anche in Italia, sebbene le iniziative legateal microcredito si stiano rapidamente diffon-dendo, non esistono delle valutazioni che nemettano in discussione l’efficacia. I motivi diquesto ritardo possono essere individuatiprincipalmente nell’alto costo delle valutazio-
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 776
Tab. 1 L’attuazione del microcredito sociale nelle quatto città*
N. Domande ricevute 957
N. Domande approvate 201
Importo erogato complessivo (in Euro) 2.291.050
Importo medio concesso (in Euro) 11.571
N. Domande respinte 218
N. Domande abbandonate dal richiedente 413
*Dati al 30 settembre 2007
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 76

ni rispetto ai fondi stanziati per gli interventi,nel numero basso di soggetti beneficiati e diimporti erogati per singolo programma, non-ché nella difficoltà di adattare all’intervento imetodi classici della valutazione d’impatto.
A oggi non esistono molti studiche tentano di stimare gli effetti
del microcredito. Moltevalutazioni più che stimare gli effetti raccontano “storie di vita” che descrivono casi
di successo
Il problema fondamentale, quando si deci-de di valutare gli effetti di un intervento, con-siste nel definire la variabile risultato da consi-derare e, successivamente, nell’impostare unmodello di analisi che riesca a offrire una sti-ma ragionevole di ciò che sarebbe successo inassenza dell’intervento (situazione controfat-tuale). Nel caso del microcredito la difficoltànella scelta della variabile-risultato deriva dal-la molteplicità delle variabili in gioco e, so-prattutto, dalle relative possibilità di misura-zione. Infatti, a un livello molto generale, ladomanda che ci si pone è: “i soldi spesi sonoserviti a portare i beneficiari fuori dalla condi-zione di povertà o di esclusione?” Per rispon-dere a un interrogativo del genere è però ne-cessario definire concetti complessi quali po-vertà ed esclusione, difficilmente catturabilida un singolo indicatore.
È dunque indispensabile maturare unacerta consapevolezza riguardo i limiti dellostrumento di valutazione messo a punto, te-nendo ben presenti le caratteristiche del con-testo (paesi industrializzati vs. PVS) in cui l’a-nalisi si colloca. Difficilmente le variabili e imodelli di analisi utilizzati nel caso dei PVS
possono essere adottati tout court all’internodi un contesto economico sviluppato. Né puòessere realistico pensare di poter cogliere l’au-spicato “impatto sociale” di un intervento diquesto genere in tutte le sue possibili accezio-ni e implicazioni. Non è realistico immaginaredi poter misurare gli effetti del microcredito
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 77
su aspetti della vita quali la gestione e l’utiliz-zo dei risparmi, né tanto meno in merito al-l’empowerment dei soggetti beneficiati, in ter-mini di miglioramento dei rapporti sociali e/ofamiliari, o ancora in merito alla loro possibi-lità di migliorare l’accesso alle risorse, alla tec-nologia e al mercato. Quello che è sensato fa-re è cercare di cogliere la ricaduta dei finan-ziamenti su alcuni aspetti specifici, cercandodi scomporre il concetto generico di “benefi-cio” in una serie di variabili, osservabili e mi-surabili.
Nel caso del “Microcredito sociale” si èpensato di realizzare un’indagine presso i be-neficiari dei prestiti, a distanza di tre anni dal-la concessione degli stessi. L’attenzione si è fo-calizzata su quattro aspetti ritenuti particolar-mente rilevanti.
La capacità di restituzione del prestito. In-teso come indicatore di solidità e di stabilitàdelle attività finanziate e, conseguentemente,come parametro minimo per la valutazionedel raggiungimento dell’autosufficienza eco-nomica da parte dei beneficiari. La capacità direstituire correttamente e per tempo le ratedel prestito rappresenta il primo indicatore disuccesso del finanziamento; ciò perché è ra-gionevole immaginare che l’attività economi-ca sia perlomeno in grado di sostenere il pro-prio indebitamento.
L’addizionalità del progetto. Intesa comecapacità del microcredito di offrire opportu-nità di crescita a soggetti che altrimenti ne sa-rebbero stati esclusi. Si vuole capire che cosaavrebbero fatto i soggetti beneficiati se nonavessero ricevuto il finanziamento. Avrebberoavviato/potenziato ugualmente l’attività, op-pure l’intervento rappresenta un volano perprogetti che in sua assenza non sarebbero sta-ti realizzati?
La variazione della condizione lavorativa.Intesa come capacità del progetto di modifi-care lo stato professionale dei soggetti benefi-ciati - trasformando il lavoro potenziale in la-voro effettivo e convertendo situazioni di la-voro precario, o di inoccupazione, in condi-zioni di lavoro stabile.
La variazione della situazione economica.Intesa come variazione del reddito dei benefi-ciari. Si vuole verificare la capacità del proget-to di rendere economicamente autosufficienti
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 77

– attraverso la creazione di lavoro stabile –soggetti che altrimenti si sarebbero trovati incondizioni economiche precarie (in quantosoggetti non bancabili).
Occorre cogliere la ricaduta deifinanziamenti su alcuni aspetti
specifici, cercando di scomporreil concetto generico di
“beneficio” in una serie divariabili, osservabili e misurabili
Le informazioni necessarie sono raccolteattraverso la somministrazione di interviste te-lefoniche semistrutturate a tutti i beneficiaridell’intervento. Lo scopo dell’indagine è du-plice: da un lato, si ricostruiscono a posteriorile variazioni osservate rispetto alle quattro va-
riabili sopra elencate; dall’altro, occorre stabi-lire se tali variazioni possono essere ragione-volmente attribuite in senso causale all’otteni-mento del credito. Si cerca di raggiungerequesto secondo obiettivo, chiedendo ai direttiinteressati di esprimere un’opinione su quan-to il finanziamento concesso abbia davvero in-fluenzato eventuali miglioramenti nella lorosituazione lavorativa ed economica.
Al termine dei primi anni di attività e diparallelo monitoraggio, le informazioni rac-colte hanno permesso di analizzare critica-mente sia le modalità di realizzazione degli in-terventi, che le caratteristiche dei richiedentie dei beneficiari dei prestiti. L’analisi ha messoin evidenza le principali criticità riscontrate e,proponendo correttivi e buone prassi da adot-tare, ha consentito di avviare una riflessioneriguardo i possibili sviluppi del progetto. Neiprossimi mesi saranno presentati i risultatidell’indagine condotta per stimare gli effettidell’intera iniziativa.
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 778
Filippo de Pisis
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 78

LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
LA VALUTAZIONE DI UNINTERVENTO A SOSTEGNO
DELLA RICERCAINDUSTRIALE IN PIEMONTE
MICHELA ROCCA,GIANLUCA STRADA,ProgettoValutazione
Imoderni paesi industrializzati dedicano una parte sempre più signifi-cativa del loro reddito ad attività di ricerca di base, applicata e di svi-luppo tecnologico (R&S): l’attenzione alla sperimentazione di nuove
tecnologie e di prodotti innovativi è molto elevata sia nelle università enei laboratori pubblici, che nelle imprese private. Questo non sembraperò accadere in Italia dove la capacità di investire in ricerca e di inno-vare cresce meno rispetto a quanto si verifica nelle altre economie occi-dentali sviluppate. Secondo quanto riporta il Libro Bianco “La valuta-zione della ricerca” – a cura del Consiglio Italiano delle Scienze Socialipubblicato nel 2006 – l’incidenza della spesa per R&S finanziata dalleimprese sul prodotto interno lordo, nel periodo 1997-2004, è risultata inmedia dello 0,55%, contro l’1,23% riscontrato nell’Europa a 25. So-prattutto il settore privato sembra non ritenere vantaggioso investire inR&S, sia per la debolezza delle forme di tutela delle conoscenze ottenu-te grazie alla ricerca, sia per l’elevata incertezza che caratterizza investi-menti di questo tipo: non sempre a fronte delle cospicue risorse spese viè la garanzia di un risultato redditizio
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 P . 7 9 - 8 4
La ricerca industriale è argomento quanto mai attualenell’agenda dei policy maker a tutti i livelli di governo.
Considerata come uno dei principali fattori di innovazionead essa sono destinati incentivi economici erogati dal settorepubblico. Nonostante ciò, vi è ancora una scarsa conoscenza
sulla capacità di questi incentivi di aumentare gliinvestimenti in ricerca
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 79

Per colmare il ritardo italiano e aumentareil livello degli investimenti in ricerca e svilup-po da parte delle imprese, è convinzione co-mune che sia necessario l’intervento pubblico.Già da un decennio a questa parte sono statepromosse, a livello sia nazionale che regionale,numerose politiche per incentivare le impresea intraprendere progetti di ricerca finalizzatiall’innovazione dei prodotti e dei processiproduttivi. L’idea di fondo è che l’interventopubblico, sostenendo in parte i costi delle at-tività di ricerca, possa incidere sul comporta-mento delle imprese, portandole a sostenereinvestimenti che altrimenti non verrebberopresi in considerazione.
La legge n. 598 “Incentivi a sostegno deiprogetti di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo”, emanata nel 1994, risponde aquesta logica. Si tratta di uno strumento voltoad agevolare le piccole e medie imprese (PMI)mediante un contributo finanziario a parzialecopertura degli investimenti per progetti diR&S. Nel 1997, nel quadro del decentramen-to amministrativo previsto dalla legge Bassa-nini, la competenza in materia di incentivi alleimprese è stata trasferita alle Regioni, che ne-gli anni successivi ne hanno disciplinato l’at-tuazione.
In virtù di questa delega, nell’ottobre del2004 la Giunta Regionale del Piemonte hapubblicato il primo bando di incentivazioneper progetti di ricerca industriale e sviluppoprecompetitivo. Il bando invitava le impreselocalizzate in Piemonte a presentare progettidi ricerca; dopo un’accurata valutazione daparte di esperti, i progetti sarebbero stati am-messi a finanziamento oppure esclusi.
La legge 598/94 in Piemonte: il BandoRicerca e Sviluppo
Le caratteristiche principali del bando pub-blicato nel 2004 sono:• dotazione finanziaria pari a 70 milioni di
euro; vengono tuttavia accettate domandedi finanziamento fino ad una soglia pari a84 milioni di euro complessivi, corrispon-denti ai 70 milioni stanziati aumentati diuna quota del 20% (overbooking) per te-nere conto delle decurtazioni dei costi am-
messi e delle “bocciature” previste in fasedi selezione dei progetti;
• ammissione al finanziamento a fronte digiudizio positivo da parte di un espertotecnico esterno alla Regione; non è previ-sta la formazione di una graduatoria;
• finanziamento concesso calcolato sui costidel progetto ritenuti ammissibili (da unminimo di 200.000 ad un massimo di1.800.000 euro) in sede di selezione ecomposto da una quota a fondo perdutopari al 10% e da una quota di finanzia-mento agevolato pari al 50%;
• possibilità di partecipare al bando in col-laborazione con un istituto di ricerca pub-blico piemontese, beneficiando di un in-cremento della quota di fondo perdutodel 5% dei costi del progetto ammissibili;
• durata di esecuzione dei progetti vincola-ta: dai 12 ai 36 mesi.
Com’è nata la domanda di valutazioneLa ricerca industriale è argomento quanto maiattuale nell’agenda dei policy maker a tutti i li-velli di governo. Considerata come uno deiprincipali fattori di innovazione ad essa sonodestinati incentivi economici erogati dal setto-re pubblico. Nonostante ciò, vi è ancora scar-sa conoscenza sulla capacità di questi incenti-vi di aumentare gli investimenti in ricerca e ditradursi in un miglioramento della competiti-vità delle imprese. Come accade in altri setto-ri d’intervento, anche in questo si continuanoa finanziare politiche e programmi incentivan-ti, anche se non esiste alcuna evidenza riguar-do la loro efficacia.
In realtà, su questo versante qualcosa re-centemente sta cambiando, almeno a livellolegislativo. Sono sempre più numerosi i testidi legge, che contengono clausole valutative,cioè norme che vincolano l’esecutivo regiona-le a rendere conto di come una legge è stataattuata, delle difficoltà incontrate nel processodi attuazione e degli effetti prodotti. Un arti-colo di questo tipo è contenuto nella l.r. 34 del22 novembre 2004 “Interventi per lo sviluppodelle attività produttive” – che prefigura la co-stituzione di un Fondo unico per le impresenel quale saranno convogliati anche i finanzia-menti della 598 e che, all’art. 14, prevede un
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 780
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 80

mandato specifico a carico della Giunta regio-nale per le attività di valutazione.
La conoscenza su tutto ciò chesuccede dopo che una legge èstata approvata, o un bando è
stato emanato, risulta assailacunosa: le informazioni adisposizione sono poche espesso non sono del tutto
intelligibili
Nonostante il provvedimento con il qualeè stato pubblicato il bando 598 del 2004 nonprevedesse all’epoca alcun obbligo valutativo,i dirigenti della Direzione Industria della Re-gione Piemonte hanno ritenuto comunqueopportuno procedere con un’analisi del pro-cesso d’attuazione dell’intervento e una valu-tazione degli effetti. In generale, la conoscen-za su tutto ciò che succede dopo che una leg-ge è stata approvata, o un bando è stato ema-nato, risulta assai lacunosa: le informazioni adisposizione sono poche; non vengono raccol-te in modo sistematico e spesso non sono deltutto intelligibili. Un’accurata indagine delprocesso di attuazione è utile per mettere inluce eventuali difficoltà nel conseguimentodei risultati che ci si era prefissi e per poterapportare correttivi al disegno della politicanel tentativo di migliorarne l’efficacia.
Inoltre, in questo caso l’amministrazioneregionale non aveva un controllo diretto sututte le fasi d’attuazione del provvedimento equesto rendeva ancora più difficile conoscerealcuni aspetti essenziali dell’intervento. Il va-glio delle domande, la selezione dei progetti el’erogazione dei finanziamenti è stata affidataa un ente gestore esterno alla Regione (Me-diocredito Centrale) e questa delega ha pro-babilmente motivato i dirigenti regionali a vo-ler essere correttamente informati su quantoera stato fatto.
I dirigenti regionali hanno perciò commis-sionato a un valutatore esterno lo studio di va-lutazione che è partito a circa un anno di di-stanza dall’uscita del bando di finanziamento.
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 81
Gli obiettivi dello studio erano due: 1) fornireuna descrizione del funzionamento dell’inter-vento e una spiegazione delle eventuali criti-cità emerse; 2) valutare in che misura l’agevo-lazione concessa ha incentivato la realizzazio-ne di attività di R&S da parte delle imprese.
Gli obiettivi dello studio eranodue: fornire una descrizione delfunzionamento dell’intervento euna spiegazione delle criticità;valutare come l’agevolazione
concessa ha incentivato leattività di R&S da parte delle
imprese
Come conoscere l’attuazione?
Una prima fonte informativa per indagare l’at-tuazione dell’intervento sono i dati contenutinelle domande d’ammissione e nei documentirelativi all’istruttoria. L’archivio amministrati-vo delle imprese che hanno presentato un pro-getto di ricerca contiene una serie di informa-zioni utili per dare un quadro delle caratteri-stiche sia delle imprese finanziate che di quelleche non hanno superato l’istruttoria; dell’en-tità dei progetti e dei finanziamenti concessi.Tuttavia questi dati non sono sufficienti a fareemergere tutti gli aspetti problematici che ri-guardano il processo di attuazione dell’inter-vento.
Per questo motivo si è deciso di procede-re a una raccolta diretta di dati, intervistandogli imprenditori e i responsabili delle attivitàdi ricerca delle aziende finanziate. Il contattodiretto con le imprese offre infatti la possibi-lità di ascoltare l’opinione di coloro che han-no redatto il progetto di ricerca, presentato ladomanda di ammissione al finanziamento, eseguito tutte le fasi conseguenti la sua presen-tazione. Questo garantisce un indubbio valo-re aggiunto rispetto ad informazioni di carat-tere meramente amministrativo e contabile.La prospettiva dell’analisi viene ampliata, inquanto include le percezioni e i punti di vistadei fruitori dell’agevolazione su eventuali
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 81

aspetti problematici dell’intervento. Adesempio, il disbrigo delle pratiche per presen-tare la candidatura dei progetti può apparireagli occhi degli imprenditori particolarmentecostoso, con l’effetto indesiderato di disin-centivarli, invece che di stimolarli, nelle lorodecisioni di investimento. Oppure le proce-dure seguite dall’ente gestore per le fasi di se-lezione dei progetti e di erogazione dei finan-ziamenti possono subire degli impasse inatte-si, allungando enormemente i tempi necessa-ri a conoscere l’esito finale dell’istruttoria.Ascoltare la voce degli imprenditori, o dei lo-ro dipendenti, su queste criticità può esseremolto utile per comprendere il reale funzio-namento della politica.
Una prima fonte informativa perindagare l’attuazione
dell’intervento sono i daticontenuti nelle domande
d’ammissione e nei documentirelativi all’istruttoria
Come stimare l’effetto incentivante?
Questo secondo obiettivo conoscitivo è deci-samente più sfidante. Si tratta di stimare l’ef-fetto incentivante del finanziamento regionalesulle decisioni d’investimento adottate dall’im-presa, cioè di valutare la capacità dell’interven-to pubblico di dar vita a progetti di ricerca chealtrimenti non sarebbero partiti. Il problemafondamentale, in generale, è riuscire a isolarequella parte di cambiamento attribuibile diret-tamente all’intervento pubblico da quella ge-nerata da tutti gli altri fattori esogeni che pos-sono influire sul fenomeno analizzato. Ciòcomporta, in questo caso, la necessità di rico-struire quello che sarebbe successo in assenzadel finanziamento e determinare quanti degliinvestimenti effettuati dagli imprenditori sa-rebbero stati realizzati comunque.
Per tentare di rispondere a questo interro-gativo sono ipotizzabili diverse strategie. Tut-tavia alcune specifiche caratteristiche di que-sto intervento limitano l’uso di disegni di ri-
cerca basati sull’impiego di metodi statistici.Alla luce anche delle limitate risorse disponi-bili per la valutazione, si è optato per un dise-gno meno complesso, basato sulla rilevazionedelle percezioni dei beneficiari dell’interven-to. Anche in questo caso si tratta di rivolgersidirettamente agli imprenditori e chiedere lorose – e in che misura – il finanziamento pubbli-co abbia “fatto la differenza”, cioè abbia sti-molato la nascita di progetti e consentito larealizzazione di attività di ricerca che altri-menti non sarebbero state attuate, oppure chelo sarebbero state solo parzialmente o in tem-pi più lunghi; o se, viceversa, i progetti per iquali è stato chiesto un sostegno sarebberostati realizzati comunque, con le stesse moda-lità e negli stessi tempi.
L’indagine è stata svolta tramite un que-stionario telefonico sottoposto ai responsabilidel settore ricerca o ai titolari dell’impresa.Sono state interpellate tutte le imprese am-messe al finanziamento: di queste circa il 90%ha accettato di collaborare, rendendosi dispo-nibile ad essere intervistato.
A fronte degli indubbi vantaggi operativi(immediatezza di esecuzione, facilità di letturadei risultati) non va trascurato un limite im-portante di questo metodo di valutazione: i ri-sultati ottenuti si basano sulle dichiarazionidei diretti interessati che, almeno in teoria,possono avere interesse a distorcere le rispo-ste; oppure possono avere una percezione fal-lace di ciò che sarebbe loro accaduto in assen-za di intervento.
I risultati dell’analisi
I risultati esposti di seguito si riferiscono al-l’indagine condotta sul bando del 2004; tutta-via tendenzialmente gli stessi rilievi vengonoconfermati dall’analisi ripetuta per il bandodel 2005 e ancora in corso di svolgimento.
L’agevolazione complessivamente conces-sa alle imprese finanziate è pari a poco piùdella metà delle risorse inizialmente stanziate:solo 36 milioni di euro dei 70 disponibili so-no stati effettivamente utilizzati. Sul bassoutilizzo delle risorse disponibili hanno influi-to, sia un tasso di ammissione inferiore alleaspettative (94 finanziamenti concessi su un
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 782
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 82

totale di 176 richieste), sia consistenti ridu-zioni sui costi dei progetti ammissibili a fi-nanziamento (mediamente il 20% in menoper ogni singolo progetto). La selezione è ri-sultata infatti più severa rispetto alle previsio-ni: oltre al cospicuo numero di progetti re-spinti, per tutti gli altri solo una parte è statasovvenzionata.
L’agevolazionecomplessivamente concessa alle
imprese che sono statefinanziate è pari a poco più dellametà delle risorse stanziate: solo
36 milioni di euro dei 70disponibili sono stati
effettivamente utilizzati
A questa prima criticità, emersa dall’esamedella documentazione amministrativa, si sonoaggiunti ulteriori snodi problematici eviden-ziati dai beneficiari intervistati. Ad esempio itempi per la presentazione del progetto sonorisultati, per alcuni, troppo stringenti. Il lassodi tempo intercorso tra il momento in cui leimprese hanno appreso dell’esistenza del ban-do e il termine per la presentazione delle do-mande non sempre consente una riflessioneapprofondita sulle potenzialità dell’investi-mento; il progetto di ricerca, che ha avuto unagenesi affrettata per rispettare i tempi del ban-do, può allora rivelarsi inadeguato nel mo-mento della sua realizzazione.
Anche a proposito dei tempi di attesa perl’esito dell’istruttoria – nella gran parte deicasi superiori ai 6 mesi – i beneficiari hannoespresso insoddisfazione. Molte imprese si
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 83
sono viste costrette a rinviare la realizzazionedi alcune parti del progetto o a modificarneinteramente la portata. In altri casi, nell’attesadel giudizio, hanno dovuto ricorrere a fontidi finanziamento alternative, indebitandosicon istituti di credito o ricorrendo a risorseproprie. Inoltre i tempi di erogazione del fi-nanziamento risultano essere eccessivamentelunghi. Molte imprese dichiarano di averpressoché completato il progetto di ricercasenza aver ricevuto nemmeno una parte delcontributo. Gli adempimenti burocratici ri-chiesti risultano poi eccessivamente gravosi;alcune difficoltà vengono riscontrate in pri-mo luogo nell’interpretazione delle richiestedel bando e, in un secondo momento, sia nel-l’adempimento delle formalità necessarie allapresentazione della domanda, che nella com-pilazione dei rendiconti delle spese sostenu-te. Ciò spesso rende necessaria la collabora-zione di consulenti per il disbrigo di parte odi tutte le formalità, con oneri anche moltogravosi per l’impresa.
Più della metà delle impreseritiene che in mancanza delfinanziamento non avrebbe
potuto realizzare il progetto cosìcome lo ha realizzato. L’altra
metà ritiene che, in assenza difinanziamento, l’impresa
avrebbe comunque realizzato ilprogetto con altre risorse
Il secondo obiettivo conoscitivo formulatonella domanda di valutazione riguardava gli
BANDO 2004 DOMANDE PRESENTATE TOTALE RICHIESTO (€) TOTALE CONCESSO (€)
Ammesse 94 46 milioni 36 milioni
Non ammesse 82 37 milioni
Totale 176 83 milioni 36 milioni
Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dalla Direzione Industria
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 83

effetti sui beneficiari in termini di capacità in-centivante della legge 598, ovvero si chiedevaun giudizio sulla capacità delle agevolazioni distimolare l’attività di R&S nelle PMI piemon-tesi. A questo scopo, all’interno del questiona-rio utilizzato per le interviste, è stata previstauna domanda con cui si è cercato di coglierela capacità del bando 598 di stimolare nuovaprogettualità o di modificare le abituali atti-vità di ricerca.
Mentre il 20% delle imprese ammette dinon essere stata influenzata dal bando 598,cioè di non essere stata indotta a intraprende-re progetti di R&S dalla possibilità di ottenerel’incentivo regionale, il restante 80% ritieneche l’uscita del bando abbia portato a modifi-care almeno in parte la strategia dell’impresa,anticipando o ampliando un progetto già inprogramma. Più della metà delle imprese ri-tiene che in mancanza del finanziamento nonavrebbe potuto realizzare il progetto così co-me lo ha successivamente realizzato: alcuneavrebbero dovuto ridimensionarlo, altre rin-viarlo a un momento di maggiore disponibi-lità finanziaria. L’altra metà degli interpellatiritiene invece che, in assenza di finanziamen-to, l’impresa avrebbe comunque realizzato ilprogetto con altre risorse.
Emerge un quadro assai eterogeneo di at-teggiamenti. • Per una minoranza di imprese, l’effetto in-
centivante della misura pare essere nullo:l’agevolazione ha rappresentato per questeimprese una sorta di “premio” per aver in-vestito in ricerca, ma non ne ha modificatoi comportamenti.
• Altrettanto rari sono i casi in cui l’agevola-zione ha avuto un effetto determinante:poche sono le imprese che affermano diessere state indotte a investire in ricerca,meno ancora quelle che dichiarano cheavrebbero dovuto abbandonare il progettose non avessero ricevuto il finanziamento.
• Per la maggior parte, l’agevolazione pub-blica ha rappresentato invece un sostegnoimportante: in sua assenza quasi tutteavrebbero dovuto ridimensionare i propriprogetti, realizzarli in tempi più lunghi, o
rinunciare ad altri che hanno nel frattem-po messo in cantiere.
Come sono state utilizzate le indicazionifornite
I risultati dello studio presentato ai dirigentidella Direzione Industria hanno messo in luceuna serie di criticità e suggerito alcune possi-bili modifiche da apportare in sede di revisio-ne del secondo bando 598 Ricerca e Sviluppo,pubblicato a fine 2005.
Il primo aspetto emerso è stato la mancataassegnazione di tutte le risorse stanziate, chelimita di fatto la capacità di sostegno alla R&S– obiettivo principale dello strumento – e chein aggiunta determina una giacenza di risorseche potrebbero essere impiegate diversamen-te. Uno dei primi correttivi apportati è statoquello di aumentare la quota di overbooking -ovvero le candidature in eccesso rispetto allerisorse disponibili - dal 20% al 30%, per con-sentire di “rimpiazzare” i progetti esclusi o ri-dimensionati in fase di istruttoria, aumentan-do così il numero di progetti potenzialmenteammissibili.
Un altro aspetto riconsiderato, alla luce diquanto emerso dall’indagine, è quello dei tem-pi necessari per lo svolgimento della faseistruttoria delle domande di finanziamento edella selezione dei progetti, sui quali gli im-prenditori avevano espresso perplessità. Per lagestione del bando 2005 i tempi sono stati inparte contingentati, introducendo vincoli piùstringenti nei confronti dell’ente gestore.
In conclusione, al di là delle conoscenzeacquisite e dei cambiamenti introdotti, puòessere rimarcata una certa sensibilità maturatadal committente rispetto al valore aggiuntoche può provenire da un’attività di valutazio-ne. I dirigenti della Direzione Industria, in se-guito allo studio di valutazione svolta sul pri-mo bando, hanno infatti espresso la volontà diapprofondire alcuni aspetti della politica conun’ulteriore discesa sul campo. L’analisi inquestione è in corso di svolgimento e verràconclusa a fine 2007.
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 784
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 84

LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
LA VALUTAZIONED’IMPATTO
DELLE POLITICHE DI AIUTO ALLE IMPRESE
DANIELE
BONDONIO,UniversitàPiemonteOrientale
Quante sono, sul totale, le imprese attive nel territorio regionale chericevono sussidi pubblici da qualcuna delle tante diverse possibilifonti legislative (di tipo regionale, nazionale o con co-finanziamen-
to Ue)? Come sono distribuite per dimensione d’impresa, settore d’attività earea di localizzazione le imprese che ricevono contributi pubblici? Quali zo-ne geografiche, settori d’attività o tipologie dimensionali d’impresa presen-tano la maggiore consistenza degli aiuti, in proporzione al relativo peso neltessuto produttivo regionale? Qual è l’impatto netto sull’occupazione del-l’insieme dei provvedimenti di aiuto (rispetto all’andamento occupazionaleche si sarebbe verificato in assenza dei sussidi pubblici)? Che eterogeneitàpresenta l’effetto netto dei contributi pubblici in rapporto alla tipologia diaiuto (contributi a fondo perduto versus finanziamenti agevolati), o in rap-porto al valore finanziario del sussidio concesso, o, infine, alla tipologia d’impresa sussidiata (per dimensione, localizzazione e settore d’attività)?
Introduzione
Sono tutte domande la cui risposta appare sempre più di vitale importanzaper il decisore pubblico (e per le amministrazioni regionali in particolare, al-la luce della loro accresciuta importanza sul tema (a seguito della creazione
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 P . 8 5 - 9 1
La riduzione delle risorse finanziarie a disposizionedell’operatore pubblico rende sempre più necessario
procedere a una attenta disamina delle misure di aiuto alleimprese, al fine di evitare la duplicazioni di interventi epromuovere un più efficace impiego dei finanziamenti
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 85

del fondo unico regionale d.l. 112 e 123 del1998) per gestire e programmare le misure diaiuto alle imprese a valere su un medesimo ter-ritorio. Eppure, fino a oggi, tali domande so-no rimaste largamente senza risposta (nel pa-norama italiano, ma anche in un buon numerodi altri paesi europei) per i seguenti motivi:• difficoltà nel disporre di basi dati statisti-
che contenenti puntuali informazioni ripe-tute nel tempo (ad esempio con cadenzaannuale) su ciascuna singola impresa attivasui territori regionali (con informazioni sulsettore d’attività, localizzazione, anno dicostituzione, e numerosità degli addetti[dipendenti e lavoratori autonomi] di cia-scuna singola impresa attiva);
• elevato numero dei provvedimenti legisla-tivi di aiuto alle imprese e alta frammenta-rietà degli enti gestori delle procedure digestione amministrativa dei sussidi, conconseguente difficoltà di reperimento de-gli archivi sui sussidi concessi ed erogatialle imprese beneficiate, contenenti infor-mazioni (in merito alla tipologia, ammon-tare e data dei contributi ricevuti da cia-scuna impresa beneficiata) incrociabili conle basi dati statistiche di cui sopra;
• scarsa attenzione alla realizzazione di studidi valutazione d’impatto degli interventipubblici, percepiti nell’ottica di strumentidi guida per il concreto miglioramentodella futura programmazione (anziché co-me elemento di mera celebrazione di meri-ti o demeriti riguardanti le decisioni prece-dentemente adottate).
Grazie a una ricerca biennale commissio-nata dal NUVAL della Regione Piemonte (dicui chi scrive ha diretto i lavori ed è autore delrapporto finale), per il territorio piemontese,sono invece ora a disposizione buona partedelle risposte alle domande di cui sopra. Ciòrappresenta un risultato di rilevante impor-tanza che si è concretizzato grazie a una seriedi motivi così riassumibili:• l’impegno della Regione Piemonte (per
mezzo del Settore Statistico Regionale) adacquisire le basi dati con le informazioniripetute nel tempo sull’anagrafica e i livel-li occupazionali dell’universo delle impre-se attive sul territorio regionale;
• l’intensa attività (svolta in stretta collabo-razione dal gruppo di lavoro che ha curatola presente ricerca, NUVAL e l’OsservatorioSettori Produttivi Industriali) di contatto erichiesta, ai diversi enti pubblici gestoridelle procedure amministrative, degli ar-chivi dei sussidi alle imprese concessi ederogati in merito a ciascuno dei provvedi-menti di aiuto presi in considerazione nel-l’analisi;
• la fattiva collaborazione tra alcuni organidella Regione (e in particolar modo il NU-VAL, la Direzione Commercio e Artigiana-to e l’Osservatorio dell’Artigianato, la Di-rezione Industria e l’Osservatorio SettoriProduttivi Industriali) e le forze accademi-che e delle istituzioni di ricerca presentisul territorio piemontese, nell’ambito dellemetodologie di valutazione d’impatto del-le politiche pubbliche, che operano da di-versi anni per diffondere nell’amministra-zione pubblica un ruolo più incisivo dellavalutazione d’impatto nei processi decisio-nali e nella futura programmazione degliinterventi.
Nel proseguo dell’articolo sono riassunti iprincipali risultati prodotti dalla ricerca bien-nale commissionata dal NUVAL, dal titolo “Lavalutazione degli interventi di sostegno alle at-tività produttive industriali nella Regione Pie-monte”, la cui relazione finale è stata redattanell’agosto 2006. In particolare: la seconda se-zione dell’articolo illustra in sintesi il quadrodelle analisi svolte nella ricerca; la terza sezio-ne è dedicata ai risultati circa la distribuzionedel complesso degli aiuti per tipologia d’im-presa beneficiata e localizzazione territoriale;la quarta sezione, infine, riassume i risultatidella valutazione dell’impatto netto occupa-zionale degli aiuti.
Le analisi svolte
Per potere valutare la distribuzione per tipo-logia d’impresa beneficiata e localizzazioneterritoriale, nonché l’impatto netto occupa-zionale dell’insieme dei provvedimenti di aiu-to a favore delle imprese piemontesi, è statosviluppato un sistema informativo basato sul-
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 786
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 86

l’incrocio tra i dati dell’Archivio Statisticodelle Imprese Attive (ASIA) (nonché del Cen-simento 2001 dell’Industria e dei Servizi del-l’ISTAT) e i dati degli incentivi concessi ederogati in merito a ciascun singolo provvedi-mento di aiuto (di fonte nazionale, regionale,conferita o con co-finanziamento UE) nel pe-riodo 2001-03.
I risultati ottenuti da questo tipodi analisi hanno permesso diottenere un quadro completo
delle tipologie di impresebeneficiate dai diversi
provvedimenti
Sulla base di tale sistema informativo, èstata evidenziatala la ripartizione sia del totaledegli aiuti concessi tramite il complesso dellemisure di intervento a carattere nazionale, re-gionale e comunitario, sia di quelli concessiper singola misura d’intervento, in base allecaratteristiche delle imprese beneficiate (set-tore di attività, dimensione per numero di oc-cupati, numero sedi produttive, fatturato) edel territorio di localizzazione delle impresebeneficiate
L’insieme dei sussidi erogati è stato inoltreanalizzato in rapporto alle caratteristiche deltessuto produttivo della regione, evidenzian-do quanta parte dell’universo delle impresepiemontesi, classificate per settore d’attività,dimensione e/o localizzazione geografica, èstata effettivamente beneficiata dai diversiprovvedimenti di aiuto nel periodo.
I risultati ottenuti da questo tipo di analisihanno permesso di fornire un quadro comple-to delle tipologie di imprese beneficiate dai di-versi provvedimenti, al fine di supportare la fu-tura eventuale razionalizzazione e/o semplifica-zione delle diverse misure in essere (evitandosituazioni di sovrapposizione e/o duplicazionedi provvedimenti simili) e hanno offerto al de-cisore regionale una base informativa d’insiemeper individuare eventuali situazioni di spere-quazione tra tipologie d’imprese per quanto at-tiene le possibilità di accesso agli aiuti.
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 87
Nell’ambito della ricerca è stato inoltreelaborato un modello di analisi statistico-eco-nometrico in grado di produrre stime attendi-bili dell’impatto occupazionale netto dei con-tributi erogati, vale a dire non la semplice va-riazione di addetti effettivamente registratanelle imprese beneficate dalle diverse tipolo-gie di aiuto, bensì la differenza tra tale varia-zione e una stima di ciò che si sarebbe verifi-cato in assenza degli aiuti.
Tale elemento è di basilare importanza perinformare correttamente il decisore pubblico:una variazione positiva dei livelli occupazio-nali delle imprese beneficiate da una partico-lare tipologia di aiuti non rappresenterebbeinfatti un sintomo inequivocabile di successodi tale tipologia. L’incremento occupazionaleregistrato nelle imprese sussidiate potrebbeinfatti essere stato causato anche da un positi-vo andamento economico congiunturale delsettore e dei mercati d’attività in cui questeoperano, anziché dall’effetto incentivante diuna particolare modalità di aiuto. Allo stessomodo, una variazione negativa dei livelli occu-pazionali delle imprese beneficiate non rap-presenterebbe necessariamente un sintomoinequivocabile di insuccesso di una particola-re modalità di aiuto, quando il quadro dell’an-damento economico congiunturale di riferi-mento fosse negativo.
Le caratteristiche del modello statistico-econometrico utilizzato per l’analisi dell’im-patto occupazionale netto delle diverse tipo-logie di aiuto è piuttosto complesso ed elabo-rato. In termini intuitivi (e a costo di qualchenotevole semplificazione), le caratteristichesalienti del modello possono però essere rias-sunte nel seguente modo: • La stima dell’impatto netto delle diverse
politiche di aiuto è ottenuta analizzando idati della variazione occupazionale regi-strata a cavallo del periodo di osservazione(2001-2003) sia delle imprese beneficiatedalla tipologia di aiuto in esame, sia diquelle non beneficiate;
• La variazione occupazionale registrata nel-le imprese non-beneficiate dalle diverse ti-pologie di aiuto, di volta in volta conside-rate, serve come base per la stima del con-trofattuale (cioè la variazione occupazio-nale che si sarebbe verificata nelle imprese
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 87

beneficiate in assenza della tipologia diaiuto in esame);
• Per evitare che parte della differenza nellavariazione occupazionale registrata tra leimprese beneficiate e le non beneficiate siadovuta al fatto che questi due gruppi diimprese sono stati sottoposti a diversecongiunture economiche (perché operantiin settori diversi, su diversi mercati o di di-mensione tendenzialmente diversa), in unprimo stadio del modello di analisi sonostate eliminate quelle imprese non-benefi-ciate che hanno caratteristiche complessi-ve non confrontabili con alcuna delle im-prese beneficiate e viceversa;
• Le differenze residue tra le caratteristichedei due gruppi di imprese (beneficiate enon-beneficiate) sono poi inserite in un se-condo stadio del modello statistico-econo-metrico utilizzato per l’analisi. In questosecondo stadio l’effetto delle differenze re-sidue tra le caratteristiche d’impresa deibeneficiari e non beneficiari, sulla variazio-ne occupazionale registrata nel periodo2001-2003, è stimato in modo separatodall’effetto dei contributi pubblici, in mo-do da identificare l’effettivo impatto nettodi quest’ultimi.
Nell’ambito della ricercaè stato elaborato un modello
di analisi statistico-econometrico in grado diprodurre stime attendibilidell’impatto occupazionalenetto dei contributi erogati
Quante, quali sono e che peso hanno le impre-se sussidiate da misure di aiuto pubblico
Le misure di aiuto alle imprese prese in consi-derazione nella ricerca sono sette provvedi-menti legislativi nazionali, sei provvedimenticonferiti alle regioni, quattro provvedimentiregionali e sette misure di intervento nell’am-bito del DOCUP, Ob.2. Queste misure, nel lo-ro complesso, rappresentano tutte le fonti di
contributo pubblico (di tipo regionale, confe-rito alle regioni, nazionali o co-finanziato dal-l’UE) disponibili per le imprese con attività in-dustriale localizzate sul territorio regionale(ad eccezione di sei soli provvedimenti legisla-tivi per i quali gli enti gestori delle proceduredi concessione dei sussidi non hanno trasmes-so le informazioni circa i contributi erogati: l.388/00 credito d’imposta; l. 662/96 patti terri-toriali al di fuori della provincia di Torino; l.488/92 per la parte di agevolazione ai proget-ti di ricerca; l. 662/96 Fondo centrale di Ga-ranzia; l. 46/82 Fondo Innovazione Tecnolo-gica).
Il quadro completo della distribuzionedelle imprese beneficiate (e del loro peso sultotale delle imprese attive), in base al settored’attività, la dimensione, la localizzazione geo-grafica e la tipologia di aiuto è descritto indettaglio nella relazione finale presentata alNUVAL della Regione Piemonte. In questa se-de, per motivi di spazio, è possibile sintetizza-re solamente alcuni degli elementi di maggio-re rilievo dei risultati, così riassumibili: • Volume complessivo dei sussidi concessi: nel
periodo 2001-2003 il totale dei contributiconcessi è stato pari a 621,6 milioni di eu-ro (valorizzando i finanziamenti agevolatiin base all’ESL –Equivalente SovvenzioneLorda, ovvero al costo effettivo della poli-tica di aiuto in termini di denaro pubblicospeso, computato come il valore attualedei mancati flussi di pagamento di interes-si per l’applicazione di un tasso agevolatoanziché quello di mercato).
• Numero imprese sussidiate: il numero com-plessivo di episodi di sussidio a impresebeneficiate è stato di 12.229 (per un totaledi 5.296 imprese beneficiate al netto degliepisodi di sovvenzione multipla e conteg-giando solamente le imprese beneficiaterintracciabili anche negli archivi ISTAT
–ASIA), con un valore medio dei contribu-ti per impresa beneficiata di 50.800 euro(1.560 euro per addetto).
• Distribuzione territoriale degli aiuti: il63,5% circa degli aiuti sono stati concessi aimprese nella provincia di Torino. Seguono,a grande distanza, gli aiuti concessi alle im-prese nella provincia di Cuneo (l’11,4% de-gli aiuti), quelli alle imprese con sede in
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 788
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 88

provincia di Alessandria (7,3%) e di Biella(4,6%), Novara (4,3%) e Asti (4,0%).
• Distribuzione degli aiuti per dimensioned’impresa: le imprese da 10 a 49 addetti so-no quelle che hanno ricevuto il maggiorvolume di aiuti (il 46% del totale). Seguo-no le imprese da 50 a 249 addetti (con il28% degli aiuti), le micro-imprese – fino a9 addetti – (con il 15%) e le grandi impre-se – con 250 o più addetti (con l’11%).
• Quota parte degli aiuti attribuita alle im-prese artigiane: circa il 15% del totale deisussidi erogati è stato attribuito a impreseartigiane (seppur nessuno dei provvedi-menti di aiuto analizzati fosse specificata-mente rivolto al comparto artigiano);
• Percentuale di imprese sussidiate da più diuna misura di aiuto: il 61,7% delle impresesussidiate è stata assistita da un solo prov-vedimento di aiuto. Il rimanente delle im-prese beneficiate è stato assistito: per il22,0% da due diversi provvedimenti diaiuto, per il 9,7% da tre provvedimenti eper il restante 3,9% da 4 o più provvedi-menti (fino a un massimo di 8 diversiprovvedimenti d’aiuto per due delle im-prese beneficiate).
• Incidenza delle imprese sussidiate sul totaledelle imprese attive: l’incidenza largamentepiù elevata delle imprese beneficiate sultotale delle imprese attive è registrata tra leimprese medie (50-249 addetti), con il63,5% di imprese sussidiate. Seguono, conun peso delle sussidiate del 42,7,5% e del37,5,3%, rispettivamente, le imprese gran-di (250 o più addetti) e le piccole imprese(da 50 a 49 addetti). Come prevedibile,dato il larghissimo numero di micro-im-prese (fino a 9 addetti) esistenti nel terri-torio regionale, il peso percentuale dellemicro-imprese sussidiate sul totale delleimprese attive dello stesso tipo registra in-vece il valore più basso (appena il 4,3%).
L’impatto occupazionale netto delle diversemisure di intervento
Il modello statistico-econometrico utilizzatoper la valutazione degli effetti netti occupazio-nali degli aiuti ha fornito stime d’impatto net-
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 89
to differenziate per: grado di intensità del co-sto economico del sussidio concesso (così co-me valorizzato dall’ESL), tipologia del sussidioconcesso (finanziamenti agevolati o contributia fondo perduto), dimensione e settore d’atti-vità delle imprese sussidiate. Le stime d’im-patto prodotte dal modello sono riferite alcomplesso dei 374,45 milioni di euro di valoredei contributi per i quali è stato possibileidentificare le imprese beneficiarie anche al-l’interno degli archivi dei dati ISTAT-ASIA. An-che in questo caso i risultati completi delleanalisi svolte sono contenuti nel rapporto fi-nale della ricerca commissionata dal NUVAL-Regione Piemonte, mentre, per ragioni di spa-zio, sono invece sintetizzati in questa sede so-lamente alcuni degli elementi di maggior rilie-vo dei risultati, così riassumibili:• L’effetto degli aiuti in base all’intensità del
costo economico del contributo concesso– I 6,5 milioni di euro spesi per aiuti di
valore economico unitario inferiore a9.661 euro hanno prodotto circa 2.467posti di lavoro addizionali rispetto allasituazione controfattuale (ciò che risa-rebbe verificato in assenza dei contri-buti) [+1,87 occupati per impresa sus-sidiata e costo medio per ogni posto dilavoro addizionale di 2.600 euro]. Co-me già precedentemente ricordato, ilvalore economico dei sussidi è intesocome costo, in termini di denaro pub-blico, dei contributi concessi e non co-me valore del finanziamento ricevutodall’impresa. Nel caso dei contributi afondo perduto questi due elementigrosso modo coincidono, mentre sonoinvece molto diversi per i finanziamen-ti agevolati, dove il costo del sussidioper l’ente pubblico è pari solamente alvalore del mancato introito di interessia prezzo di mercato.
– I 21,75 milioni di euro spesi per aiuti divalore economico unitario compresotra 9,661 euro e 25.685 euro hannoprodotto circa 2.235 posti di lavoro ad-dizionali (+1,69 occupati per impresasussidiata e costo medio per posto dilavoro addizionale di 9.700 euro).
– i 57,3 milioni di euro spesi per aiuti divalore economico unitario compreso
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 89

tra 25.685 euro e 69.857 euro hannoprodotto circa 4.229 posti di lavoro ad-dizionali (+3,20 occupati per impresasussidiata e costo medio per posto dilavoro addizionale di 13.500 euro);
– i 288,9 milioni di euro spesi per aiuti divalore economico unitario superiore a69.857 di euro hanno prodotto circa9.058 posti di lavoro addizionali (+6,87occupati per impresa sussidiata e costomedio per posto di lavoro addizionaledi 31.900 euro).
Le stime d’impatto prodotte dalmodello sono riferite al
complesso dei 374,45 milioni dieuro di valore dei contributi per
i quali è stato possibileidentificare le imprese
beneficiarie
• Finanziamenti agevolati versus contributi afondo perduto.Le stime d’impatto prodotte dal modellodi analisi permettono di differenziare glieffetti netti occupazionali prodotti dai fi-nanziamenti agevolati rispetto a quelli pro-dotti dai contributi a fondo perduto, o aforme di incentivazione mista fondo per-duto + fin. agevolato, a parità di valoreeconomico dei sussidi concessi.Per gli aiuti con valore economico unitario
fino a 9.661 euro i risultati evidenziano che:– i finanziamenti agevolati hanno genera-
to in media un incremento netto occu-pazionale per impresa sussidiata di2,53 posti di lavoro (con un costo me-dio per posto di lavoro di 850 euro);
– i contributi a fondo perduto hanno ge-nerato in media un incremento occu-pazionale per impresa di 1,52 posti dilavoro (con un costo medio per postodi lavoro pari a 3.580 euro);
– forme di incentivazione miste (contri-buti a fondo perduto + fin. agevolato)hanno generato un incremento mediooccupazionale per impresa di 2,55 po-
sti di lavoro (con un costo medio perposto di lavoro addizionale pari a2.351 euro).
Per le categorie di aiuti di valore economi-co unitario superiore a 9.661 euro, invece,le stime d’impatto del modello d’analisipermettono un confronto solamente tra icontributi a fondo perduto e il mix di con-tributi a fondo perduto e finanziamentiagevolati. Per queste categorie di contri-buti non è possibile stimare l’impatto oc-cupazionale dei finanziamenti agevolati inquanto questi ultimi hanno un valore sem-pre inferiore a 9.661 euro (soglia del I°quartile della distribuzione) e solo in trecasi un valore immediatamente superiore.Per questo tipo di aiuti, i risultati dell’ana-lisi evidenziano nel complesso una diffe-renziazione poco rilevante tra gli effettinetti dei contributi a fondo perduto e deisussidi misti (fondo perduto + fin. agevo-lato).
Conclusioni: alcune note esplicativesull’impatto occupazionale degli aiuti
Le stime d’impatto prodotte dal modello dianalisi hanno permesso di differenziare gli ef-fetti netti occupazionali prodotti da diverseintensità del valore economico degli aiuti e dadiverse modalità di sussidio (finanziamentiagevolati versus contributi a fondo perduto).
Quest’ultimo elemento, in particolare, of-fre evidenza empirica di primaria importanzaper supportare la futura programmazione del-le politiche di aiuto alle imprese. Nessuna del-le due modalità di sussidio ha infatti chiariaspetti di superiorità sull’altra: se da un lato icontributi a fondo perduto hanno potenzial-mente un maggiore potere incentivante rispet-to ai finanziamenti agevolati (in quanto garan-tiscono un maggiore “dono economico” alleimprese sussidiate), e per questo motivo po-trebbero generare maggiore addizionalità diinvestimenti e occupazione rispetto ai finanzia-menti agevolati, dall’altro lato essi permettonodi supportare un numero molto più limitato diprogetti di investimento d’impresa, a parità dirisorse pubbliche, rispetto ai finanziamenti
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 790
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 90

agevolati il cui costo per l’ente pubblico ero-gante è invece notevolmente inferiore (i finan-ziamenti agevolati, inoltre, potrebbero influirein modo rilevante sulle possibilità di investi-mento e assunzione di personale delle impresesussidiate anche per via di eventuali imperfe-zioni del mercato del credito, non in grado digarantire adeguati finanziamenti a quegli im-prenditori che, seppur con buoni piani di svi-luppo industriale, non dispongono tuttavia dirilevanti patrimoni a garanzia del prestito).
I risultati dell’analisievidenziano come i
finanziamenti agevolati, a paritàdi spesa di denaro pubblico per isussidi, determinino un miglioreimpatto occupazionale rispettoai contributi a fondo perduto
Il complesso dei risultati prodotti dall’ana-lisi circa gli effetti netti delle diverse modalitàdi sussidio, evidenziano come i finanziamentiagevolati, a parità di spesa di denaro pubblicoper i sussidi, determinino nel complesso unmigliore impatto occupazionale rispetto aicontributi a fondo perduto. Le stime d’impat-to evidenziate nella ricerca, e riportate in que-sto articolo, devono tuttavia essere lette inmodo corretto: il valore economico dei sussidinon deve essere confuso con l’ammontare difinanziamento percepito dall’impresa. Quan-do, per esempio, i risultati dell’analisi eviden-
LA V
ALUT
AZIO
NE D
IECI
ANN
I DO
PO –
LE
ESPE
RIEN
ZE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 91
ziano come + 2,53 posti di lavoro sia l’impattomedio occupazionale degli aiuti (per le impre-se sussidiate con finanziamenti agevolati di va-lore fino a 9.661), con un costo medio per po-sto di lavoro di 850 euro, ciò non deve signifi-care che ogni 850 euro di finanziamenti rice-vuti le imprese sussidiate abbiano generato2,53 posti di lavoro addizionali. 850 euro sonoinfatti, solamente il valore economico dei sus-sidi in termini di flusso di mancati introiti peri pagamenti di interessi relativi allo spread trail tasso agevolato applicato al finanziamento eil tasso effettivo di mercato.
Ciò che in sintesi l’analisi evidenzia è inve-ce il fatto che, seppur comportando un mino-re elemento “dono” per gli imprenditori sus-sidiati, i finanziamenti agevolati si dimostranocomunque in grado di influire sulle decisionidi investimento dei beneficiari grossomodo alpari dei contributi a fondo perduto. Per il fat-to che i finanziamenti agevolati sono menoonerosi, e permettono con la stessa spesa pub-blica finale di sussidiare un numero più alto diprogetti, questi risultano essere la forma di in-centivazione più incisiva, a parità di risorsepubbliche spese. Deve inoltre essere tenuto inconsiderazione che nell’analisi non è statopossibile considerare le spese di denaro pub-blico legate alle eventuali mancate restituzionidei finanziamenti erogati in caso di defaultdelle imprese beneficiate. Nella misura in cuitale elemento non fosse un elemento margina-le, l’effettivo margine di convenienza dei fi-nanziamenti agevolati rispetto ai contributi afondo perduto sarebbe in qualche misura mi-nore rispetto ai valori indicati nei risultati del-l’analisi.
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 91

Giovanni Lanfranco
1_92_informaIres_33 13-12-2007 17:06 Pagina 92

RICE
RCHE
RELAZIONE SULLASITUAZIONE ECONOMICA,SOCIALE E TERRITORIALE
DEL PIEMONTE
MAURIZIO MAGGI,IRES Piemonte
Per l’economia italiana il 2006 ha segnato una netta ripresa(+1,9%) dopo il 2005 a crescita zero, con un parziale
recupero del differenziale rispetto alla media europea cherimane comunque di circa un punto percentuale.
In Piemonte, se il 2005 era stato ancora un anno di crisi perl’economia regionale - che le recenti stime dell’ISTAT
confermano, indicando una caduta del PIL dell’1,6% e unacontrazione dei consumi delle famiglie dello 0,6%, il 2006 ha
invece fatto rilevare un progressivo miglioramento dellacongiuntura regionale: per l’anno appena concluso si puòstimare una dinamica positiva del PIL (+1,8%) pressoché
allineata a quella nazionale (+1,9%). Per il 2007 si prevedeche l’economia regionale continui a crescere (+1,1%) pur
evidenziando un rallentamento
Adeterminare questa favorevole dinamica avrebbero concorso sia laripresa della domanda interna che l’evoluzione positiva delle espor-tazioni. I consumi avrebbero dato un contributo decisamente posi-
tivo alla crescita invertendo la tendenza recessiva che avevano manifestatonel corso del 2005, crescendo a un tasso dello 0,9%, mentre gli investimentifissi lordi, dopo una riduzione nel 2005 si sarebbero espansi del 3% nel-l’anno passato, soprattutto nella componente produttiva (macchinari, at-trezzature, mezzi di trasporto), mentre gli investimenti in costruzioneavrebbero manifestato un qualche ripiegamento. Le esportazioni nel 2006hanno interamente recuperato la contrazione sperimentata nel 2005, cre-scendo del 3% in termini reali: in termini di valore hanno conseguito un ri-sultato decisamente più favorevole, aumentando dell’8,4%.
Sul piano dei confronti interprovinciali, emerge la vivacità del settoreautomobilistico, che traina la crescita della provincia di Torino, che denotauna performance più brillante rispetto alla media.
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 P . 9 3 - 1 0 1
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 93

I settori produttivi
Con il 2006, proseguono le difficoltà dell’agri-coltura italiana che, negli ultimi anni, ha qua-si sempre mostrato andamenti negativi. InPiemonte l’annata agraria 2006 ha mostratoesiti in parte diversi rispetto a quelli nazionalie nel complesso può essere giudicata in modomoderatamente positivo, pur in presenza dialcune criticità significative. Secondo le rileva-zioni del sistema Movimprese di Unioncame-re, che consente di monitorare la nati-morta-lità delle imprese, prosegue il trend storico diriduzione del numero di imprese agricole, siaa livello regionale che nazionale; tuttavia, ilsaldo negativo nasconde al proprio internouna certa vivacità imprenditoriale, segnalatadal cospicuo numero di nuove iscrizioni.
In Piemonte l’annata agraria2006 ha mostrato esiti
moderatamente positivi
La ripresa economica e il clima favorevoleche ha caratterizzato l’economia regionale nel2006 non sembrano trovare riscontro neiprincipali indicatori aggregati delle perfor-mance delle imprese artigiane, né sul giudizio
che queste ultime forniscono sull’economiapiemontese, come risulta dalle indagini sul-l’andamento dell’artigianato, soprattutto quel-la riferita alla seconda parte dell’anno. Infatti,se la rilevazione riferita alla prima parte del2006 evidenziava una chiara inversione dellatendenza negativa in cui l’artigianato era im-prigionato da cinque anni, nel corso del se-condo semestre il quadro pare stabilizzarsi,senza ulteriori slanci positivi.
Le previsioni per il primo semestre del-l’anno in corso sebbene siano migliori dei ri-sultati a consuntivo, non evidenziano un climadi ottimismo coerente con i segnali di ripresaeconomica. I saldi tra andamenti in crescita ein diminuzione delle performance delle azien-de e il clima di fiducia sull’economia regiona-le sono rimasti su valori negativi. Come piùvolte constatato, le caratteristiche strutturalidelle imprese e il profilo personale degli im-prenditori discriminano in misura sensibile leperformance delle imprese artigiane. Emergeche le imprese complesse (che impiegano ol-tre al/ai titolare/i alcuni dipendenti) esprimo-no andamenti largamente migliori di quellecostituite dal solo titolare o dal titolare coa-diuvato da un famigliare o uno/due soci; chele aziende strutturate, che impiegano almenocinque addetti, hanno performance di segnopositivo, laddove gli indicatori precipitanoquando l’impresa diventa micro o cellulare
RICE
RCHE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 794
Tab. 1 L’economia in Piemonte
MEDIA 2000 - 2005 2006 2007 PREVISIONI (MAGGIO 2007)
PIL 0,1 1,8 1,1
Consumi famiglie 0,3 0,9 0,8
Consumi collettivi 1,7 1,3 -0,2
Investimenti fissi lordi 3,3 3,0 -1,2
Esportazioni -2,0 3,0 0,3
Valore aggiunto totale 0,1 1,9 1,2
V.A. Agricoltura 0,4 1,0 1,0
V.A. Industria in senso stretto -3,8 2,9 1,6
V.A. Industria costruzioni 3,0 1,8 0,6
V.A. Servizi 1,4 1,7 1,1
Tasso di disoccupazione 5,6 4,4 3,7
Reddito disponibile 2,7 3,6 4,0
Deflatore dei consumi 2,7 2,4 2,0
Fonte: ISTAT, IRES-Prometeia
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 94

(un solo addetto); che esiste una chiara rela-zione lineare tra titolo di studio del titolare el’andamento economico e che il primo è cor-relato all’età.
I risultati delle analisi congiunturali vannoquindi relativizzate alla luce di queste consi-derazioni; al di là delle specifiche turbolenzemacro-economiche e delle oscillazioni delladomanda, la varietà di imprese del settorerende problematica l’individuazione di dia-gnosi univoche e soluzioni adatte per l’interocomparto. Per questa ragione si parla, conqualche semplificazione, di un doppio artigia-nato: da una parte imprese piccole ma in gra-do di definire assetti organizzativi e formuleimprenditoriali competitive, dall’altra un ba-cino di micro-attività, sovente gestite in modoinerziale, con troppi casi che sconfinano nel-l’economia di sussistenza.
Esiste un doppio artigianato: dauna parte imprese piccole ma
competitive, dall’altra un bacinodi micro-attività che sconfinano
nell’economia di sussistenza
Nel 2007 il settore delle costruzioni indicaun quadro di generale rallentamento, rispettoall’elevata dinamicità che ha caratterizzato ilsettore negli scorsi anni, che pare essersi ac-centuato durante l’anno. Si tratta di un effettoin parte atteso, tenuto conto del completa-mento di parte delle attività del settore colle-gate all’evento olimpico, e per l’approssimarsidi un picco nella crescita del mercato immobi-liare, che ha conosciuto una vivace dinamicanegli anni scorsi. Nel corso del 2006, tuttaviagli indicatori attestano una situazione ancoraespansiva e un contributo ancora positivo delsettore alla crescita dell’economia regionale,pur in un quadro più incerto. Le nuove co-struzioni residenziali, secondo accreditate sti-me, avrebbero realizzato nel 2006 una crescitadel 2,4%, allineata a quella dell’anno prece-dente, pur inferiore al dato di altre regioni ita-liane, mentre l’edilizia non residenziale è risul-tata in contrazione (-1,9%) dopo l’andamento
RICE
RCHE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 95
ancora favorevole del 2005 (+2,3%). Le infor-mazioni dell’Agenzia del Territorio sulle com-pravendite nel mercato residenziale indicanonel 2006 un’ulteriore crescita del dinamismonella regione, in particolare nelle province diCuneo, Torino e Asti; nelle province del Pie-monte orientale si riscontra invece un anda-mento poco dinamico del mercato, per quan-to rilevato da questo indicatore.
Il settore delle costruzioni indicaun quadro di generale
rallentamento rispetto agli scorsianni mentre il mercato dellecompravendite residenziali
registra dinamismo, inparticolare nelle province di
Cuneo, Torino e Asti
Il 2006 vede un compimento del percorsodi crescita numerica e di diffusione territoria-le della grande distribuzione, confermando leprevisioni della precedente Relazione IRES. Ilsistema distributivo commerciale piemontesepresenta così caratteristiche non solo di com-pletezza tipologica, ma anche di equilibrionella distribuzione territoriale.
È possibile ora fornire un’immagine del-l’articolazione territoriale del commercio inPiemonte al termine di un processo evolutivonon più condizionato da squilibri strutturalinella dotazione territoriale dei diversi formatcommerciali (dai mercati ambulanti, al piccolocommercio di “vicinato” nei centri urbani, aipiccoli supermercati e ai discount alimentari,agli ipermercati, ai centri commerciali, agli ou-tlet dell’abbigliamento, alle diverse forme digrandi superfici specializzate). Si segnala fra leiniziative innovative quella di Eataly, un puntovendita di prodotti enogastronomici di qualitàlocalizzato a Torino, nell’edificio che ha ospi-tato gli storici stabilimenti della Carpano.
Il turismo piemontese registra un discretoaumento delle presenze nel corso del 2006, su-periore al 8,6%. Si tratta del risultato più posi-tivo degli ultimi 15 anni, superiore a quello giàbuono del 2005, e conferma il costante trend
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 95

di crescita degli ultimi sei anni. L’aumento del-le presenze è trainato dalle province di Asti(22%) e Cuneo (19,8%) che probabilmentehanno beneficiato della saturazione dei postiletto in provincia di Torino (6,6%) nel periodoolimpico. Il quadro nazionale vede anch’essouna crescita della domanda, sia pure molto piùcontenuta. I primi nove mesi fanno registrare,infatti, una crescita del 3,4%, confermata dalpositivo andamento dei dati già disponibili subase annuale. Dal lato dell’offerta, la dinamicadelle nuove tipologie di ricettività (affittacame-re, agriturismo e B&B) a scapito dei campeggie in generale delle strutture extra-alberghierenei confronti di quelle alberghiere conferma letendenze già manifestate negli anni recenti. Ilbuon risultato nazionale del 2006 non eliminatuttavia i forti elementi di debolezza del turi-smo italiano: prezzi elevati, qualità ambientalegeneralmente diminuita, trasporti interni ca-renti quando non al limite del collasso. Alcunidi questi aspetti si presentano critici anche inPiemonte. Tuttavia, proprio la possibilità dimantenere e consolidare nel tempo – al di là dieventuali riassestamenti fisiologici – i positivirisultati ottenuti in termini di domanda negliultimi anni, spinge a una riflessione critica.
La difficoltà della concertazionedelle politiche connesse al
turismo e delle diverse iniziativespingono a una valutazione
attenta del concetto di“successo” in campo turistico
La rilevanza che assume l’integrazione tra lediverse politiche che hanno forti connessionicon il turismo (trasporti ma anche cultura, am-biente, urbanistica) nonché la constatazionedella difficoltà che incontra la concertazionedelle iniziative nei vari campi settoriali, spingo-no a una valutazione più attenta del concetto di“successo” in campo turistico. Le presenze so-no da questo punto di vista un indicatore in-sufficiente, come si ripete da anni, e altrettantovale per la dotazione fisica di strutture ricettivementre è cruciale la capacità di accoglienza di
una società locale nel suo complesso. Quandouna società è accogliente per i suoi cittadini lo èanche per i visitatori, turisti o migranti che sia-no: scarsa trasparenza dei prezzi, informazionipoco accessibili, trasporti carenti, orari rigidi enon adeguati alla domanda, carenze di sicurez-za, cantieri invadenti, scarsa cura del paesaggiosia urbano che extra-urbano sono alcune delletare – certamente non solo piemontesi – chevanno rimosse se vogliamo che i positivi risul-tati del turismo durino nel tempo – al di là di fi-siologici “rimbalzi tecnici” che potrebbero ma-nifestarsi nel 2007 – ma soprattutto siano fun-zionali a rendere migliore la vita di tutti e nonsolo di chi vive nella filiera turistica.
Aspetti infrastrutturali
L’affrancamento dell’economia piemontesedalla dipendenza energetica dalle fonti fossilie dall’importazione di energia è un obiettivodi lungo periodo che impone politiche e azio-ni di sviluppo a livello regionale delle filiereindustriali e delle attività commerciali e di ser-vizio concernenti le principali piattaformedelle energie rinnovabili e di materiali e at-trezzature per l’efficienza energetica.
Questa strategia rappresenta anche un’op-portunità rilevante per il rafforzamento dellepolitiche della ricerca e dell’innovazione, perla competitività e l’occupazione in settori tec-nologici avanzati, per la sostenibilità dello svi-luppo, in linea con le strategie europee indivi-duate dall’Agenda di Lisbona.
La situazione italiana delle rinnovabili el’industria del settore presentano debolezze esquilibri che sono il frutto tanto dei ritardinelle politiche di settore quanto della fram-mentarietà degli stessi provvedimenti incenti-vanti, quando adottati. Come conseguenza l’I-talia è in ritardo nello sviluppo delle strategiedi uso razionale e incremento delle rinnovabi-li, ma sta conoscendo in questi anni una fasedi vivace crescita.
In Piemonte, i settori del solare fotovoltai-co e delle biomasse legnose, dove le politichedi sostegno della domanda hanno segnato uncerto successo, presentano un serio squilibriotra la domanda (forte) e l’offerta (debole e inlenta evoluzione) di attrezzature e combustibi-
RICE
RCHE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 796
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 96

li. L’idroelettrico presenta potenzialità soprat-tutto come repowering, data la difficoltà socia-le di costruire nuovi invasi. La ricognizione, at-tualmente in corso, delle azioni svolte negli an-ni recenti nel campo energetico evidenzia unosforzo consistente, sia per numero di iniziativeche per consistenza finanziaria, ma che, so-prattutto di fronte a sfide crescenti, richiedeun coerente impegno strategico e pluriennale.
L’affrancamento dell’economiapiemontese dalla dipendenzaenergetica dalle fonti fossili edall’importazione di energia èun obiettivo di lungo periodo
Nel 2006 e rispetto alla situazione nazio-nale ed europea, si constata una buona diffu-sione delle ICT fra le imprese piemontesi e unasituazione meno buona fra i cittadini; emergeanche una rilevante diffusione territoriale del-la banda larga. La bilancia dei pagamenti tec-nologici continua a mostrare dati positivi peril Piemonte anche se si evidenzia qualche om-bra dal punto di vista dell’analisi di settore alivello di imprese, stazionarie come consisten-za e principalmente dedite ad attività con unpeso di innovazione probabilmente al di sottodelle potenzialità.
Per quanto riguarda le modalità di accessoalle reti, si assiste a una stasi del numero diutenti ma a una concentrazione dell’utilizzo inparticolare negli accessi a banda larga. Sonosoprattutto i servizi sanitari che guadagnanoterreno, dal 2005 al 2006, a scapito di quellibancari e di acquisto in genere. Da rilevare, ingenerale, l’impatto significativo che le ICT
sembrano mettere in mostra nei confronti del-le imprese e in misura minore per i consuma-tori e ancor meno per le attività che potrem-mo definire di cittadinanza (e-government).
Aspetti sociali
Nel 2006 la popolazione piemontese è in cre-scita per il quinto anno consecutivo. L’aumen-
RICE
RCHE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 97
to di residenti si deve al saldo migratorio posi-tivo che compensa il saldo naturale negativo.Detto altrimenti, il numero di coloro che sitrasferiscono in Piemonte supera quello di co-loro che invece vanno a vivere altrove e com-pensa nettamente il decremento naturale.
I nuovi residenti sono principalmente stra-nieri. Le nascite aumentano, soprattutto gra-zie al contributo degli stranieri, anche se nonin misura sufficiente a compensare i decessi.Nel confronto con le altre regioni, il Piemontesi caratterizza come regione in grado di attrar-re residenti, soprattutto dall’estero, in analo-gia con il resto del Centro-nord.
L’area metropolitana torinese, infine, con-ferma la crescita di popolazione, ma con unacerta differenza interna fra capoluogo, primae seconda cintura: il numero dei residenti, so-stanzialmente stabile nel comune di Torino,cresce nelle due cinture dove risultano positi-vi sia il saldo naturale, anche se di lieve entità,sia quello migratorio. Si rileva come nella pri-ma cintura il saldo migratorio sia modesto edovuto esclusivamente ai flussi con l’estero,mentre nella seconda cintura il saldo migrato-rio, decisamente più consistente, derivi so-prattutto dagli scambi con altri comuni, fracui Torino stessa.
Nel 2006 la popolazionepiemontese è in crescita per il
quinto anno consecutivo. Ilsaldo migratorio positivocompensa quello naturale
negativo
Relativamente al mercato del lavoro, ilquadro economico piemontese sembra ripren-dersi dopo una fase prolungata e intensa dicrisi industriale: l’indagine trimestrale Union-camere, che dalla seconda metà del 2001 reca-va indicatori negativi per il Piemonte in termi-ni di produzione, è tornata in attivo nell’ulti-mo trimestre del 2005 (+0,9%) e il dato siconsolida nell’anno 2006, con un tasso di cre-scita medio interannuale del 3,1%, trainatodai buoni risultati del metalmeccanico, dove
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 97

spicca la crescita dei comparti elettrico edelettronico (+6,3%) e dei mezzi di trasporto(+5,5%), mentre risulta ancora critico l’anda-mento del tessile (-1,5%).
D’altronde, l’uscita dal tunnel della crisiper il Gruppo Fiat, un dato ormai ufficiale,sancito dai brillanti risultati del 2006, rappre-senta un segnale importante, così come lo erastato in negativo l’annuncio dello stato di crisialla fine del 2002, e fa ben sperare per il futu-ro, per le evidenti ricadute su tutto il tessutoindustriale del bacino torinese e sulle sue pro-paggini nel resto della regione.
Il bilancio occupazionale 2006 in Piemon-te reca segno positivo, con una crescita di23.000 unità lavorative concentrata nei servizinon commerciali (che al momento non siamoin grado di articolare per comparti), portandoil numero degli addetti al di sopra della sogliadi 1.850.000 unità.
Dopo la battuta d’arresto dell’anno scorso,sembra riprendere vigore la spinta espansivadella componente femminile, che è protagoni-sta, salvo che in agricoltura, di una brillanteperformance, aggiudicandosi 21.000 dei23.000 occupati aggiuntivi: le lavoratrici sonoora il 42,5% del totale, contro il 41,9% del2005. Con questo risultato positivo le donnetornano sui livelli raggiunti nel 2002, recupe-rando le posizioni perdute negli ultimi anni,quando la crisi del settore moda e le ricadutesui servizi avevano penalizzato soprattutto lamanodopera femminile.
Il bilancio occupazionale 2006 inPiemonte reca segno positivo
anche grazie all’uscita dal tunnelper il Gruppo Fiat. Performanceparticolarmente positiva per la
componente femminile
Particolarmente positiva la performancepiemontese sul versante della disoccupazione:le persone in cerca di occupazione Eurostat siriducono nel 2006 del 13%, da 89.000 a78.000 unità, proseguendo la flessione già rile-vata l’anno precedente, che però quest’anno si
concentra fra le donne, mentre nel 2005 inte-ressava solo la componente maschile. Il tassodi disoccupazione scende a livelli ormai mera-mente frizionali (4,0%, rispetto al 4,7% del-l’anno scorso), con un divario di genere in di-minuzione, anche perché il dato maschile ècosì basso che c’è poco spazio per un’ulterio-re discesa: 3,2% contro 5,1% delle donne.
Alle spalle dei disoccupati propriamentedetti ci sono comunque oltre 45.000 personeche si definiscono “in cerca di lavoro”, manon rispondono a uno dei due parametri stan-dard di classificazione (disponibilità e ricercaattiva). L’area di disoccupazione “allargata”conta così 124.000 unità, numero non trascu-rabile, a cui si possono accostare le 34.000persone formalmente inattive, per i due terzidonne, che si dicono però disponibili o inte-ressate a lavorare a certe condizioni.
Il sistema dell’istruzione piemontese, nel-l’anno scolastico 2005/2006, si conferma inespansione, in linea con quanto si osserva an-che a livello nazionale. Sempre più stranierifrequentano le scuole piemontesi così come èin aumento il numero di anni che i giovanipassano sui banchi di scuola, sia per l’accessoormai generalizzato al livello prescolare siaper il progressivo innalzarsi del tasso di scola-rizzazione nel secondo ciclo.
Nella scelta della scuola superiore cresco-no le preferenze per i licei – scientifici in par-ticolar modo – e gli ex-istituti magistrali ri-spetto ai percorsi tecnici e professionali. Tor-nano ad aumentare nel complesso i titoli dimaturità, che compensano il calo delle qualifi-che e dei corsi integrativi. In questa fascia, lestudentesse conseguono risultati costante-mente migliori rispetto ai loro coetanei, contutti gli indicatori esaminati. Gli allievi chefrequentano scuole private – che sono in Pie-monte soprattutto scuole dell’infanzia – sonoin crescita in tutti i livelli scolastici. Anche ne-gli atenei piemontesi il numero degli iscritti èin aumento, mentre si registra una contrazio-ne dei laureati nel 2006. Questo decremento,in parte dovuto all’esaurirsi di percorsi di ri-qualificazione, rappresenta un primo passoverso una probabile stabilizzazione di un lun-go periodo di crescita
Lo scenario con il quale il servizio sanitarionazionale e regionale si sta confrontando è ca-
RICE
RCHE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 798
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 98

ratterizzato da un elevato grado di comples-sità: la popolazione sta invecchiando progres-sivamente, aumentano le condizioni di disabi-lità e di cronicità con una conseguente doman-da di salute sempre più ampia e articolata, chel’organizzazione attuale del sistema sanitario,focalizzato sulle patologie acute, con un’offer-ta sanitaria eccessivamente sbilanciata sull’o-spedale, spesso non è in grado di soddisfare.
Di fronte a fenomeni di tale portata l’esi-genza è quella di un aggiornamento della suaorganizzazione e della sua offerta.
Il Piemonte si evidenzia come una regionepiù vecchia e dipendente della media delle re-gioni italiane: l’indice di invecchiamento ècresciuto, dal 2001 al 2006, dal 21,3 al 22,4%, (in Italia dal 18,7 al 19,8).
In espansione anche il sistemadell’istruzione piemontese:
crescono le preferenze per i licei.Le studentesse conseguono
risultati costantemente miglioririspetto ai loro coetanei
L’analisi di genere evidenzia come le don-ne sembrerebbero aver interiorizzato più de-gli uomini l’idea della salute come bene da tu-telare adottando stili di vita corretti; l’analisidelle conseguenze dell’immigrazione sui biso-gni di salute evidenzia invece che, se il rischiorelativo di ricovero ospedaliero per gli stranie-ri residenti a Torino è uguale a quello degliitaliani, per alcune patologie gli immigratihanno maggiore probabilità di essere ricove-rati: gravidanze, parti e IVG, malattie infettivee parassitarie, malattie del sangue, quali ane-mie, traumatismi.
I dati di spesa attestano il Piemonte – 7miliardi di euro di spesa complessiva per ilSSN nel 2005 –, su valori di spesa pro capitesostenuta dal servizio sanitario pubblico leg-germente al di sopra della media nazionale(1.635 euro a fronte di 1.618), con un tasso dicrescita superiore, negli anni 2002-05, a quel-lo medio nazionale (quasi tutto concentratonel passaggio dal 2003 al 2004).
RICE
RCHE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 99
Scomponendo la spesa per livelli di assi-stenza, la quota spesa per l’assistenza ospeda-liera si evidenzia ancora superiore rispetto alleindicazioni nazionali: la prevenzione, che hastoricamente assorbito una quota marginaledella spesa sanitaria pubblica, potrebbe, percontro, rivelarsi uno strumento efficace percontenere l’impatto delle variabili economichee demografiche sulla spesa sanitaria: nel me-dio-lungo periodo, l’incremento della spesa inprevenzione potrebbe comportare una riduzio-ne più che proporzionale della spesa per acutiospedaliera sul totale della spesa sanitaria.
Lo scenario con il quale ilServizio Sanitario Nazionale e
Regionale si sta confrontando ècaratterizzato da un elevato
grado di complessità: lapopolazione sta invecchiando
più della media delle altreregioni italiane
La finanza locale
Con l’avvio della XV legislatura si è verificatauna ripresa di attenzione sul governo locale,dopo la battuta d’arresto degli anni preceden-ti. Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da: • una scarsa attenzione alle prospettive
aperte dal nuovo Titolo V della Costitu-zione (legge cost. n. 3 del 2001); addirittu-ra vi è stata una nuova e diversa bozza direvisione della Carta, che però non ha ri-cevuto conferma dal referendum popolaredel giugno scorso;
• imposizione di nuovi vincoli ai comporta-menti fiscali di alcune amministrazionipubbliche, in particolare gli enti territoria-li; peraltro la capacità di controllo non hagli stessi effetti in tutti i comparti della spe-sa pubblica: nella sanità e nelle retribuzionial personale è risultata meno efficace;
• scarso interesse al coordinamento finan-ziario tra Stato, Regioni ed enti locali, tan-to che l’Alta Commissione di Studio per ilFederalismo Fiscale, istituita in quella legi-
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 99

slatura, ha formulato proposte (settembre2005) che hanno avuto scarsissima eco neldibattito politico.
La ripresa di attenzione al governo localesi può descrivere secondo tre traiettorie.Quella dell’assetto delle competenze e dellerisorse; quella delle forme di controllo dellaspesa pubblica complessiva; quella della mo-dernizzazione. Queste traiettorie, per potersisviluppare, richiederanno tempi adeguati, ve-rosimilmente di legislatura.
Il clima di opinione
Rispetto al 2006, a febbraio 2007 il clima di fi-ducia in Piemonte, relativamente ai 12 mesifuturi, risulta peggiorato, analogamente aquanto è avvenuto a livello nazionale. Preva-lenza di insoddisfazione anche sui dodici mesitrascorsi, ma con trend in diminuzione. Leg-
germente negativa la percezione della situa-zione finanziaria familiare: si osserva un’ac-centuazione nelle difficoltà a risparmiare infuturo.
Sembra delinearsi un quadro di generalepeggioramento, in cui si evidenziano alcunisegnali di criticità delle prospettive per unacircoscritta fascia della popolazione regionale.
Buoni i giudizi sui servizi pubblici, conperformance particolarmente brillanti per lasanità, da quattro anni in costante crescita econ soddisfatti che superano ormai il 75%.
Interessante anche il risultato per i serviziscolastici che si collocano al sesto posto, masono gli unici – oltre alla sanità – a registrareconsensi univocamente crescenti e che totaliz-zano comunque oltre due terzi di soddisfatti.È significativo che due servizi al centro di infi-nite polemiche da parte dei media raggiunga-no questi risultati e ancor più che manifestinoun trend di gradimento costantemente cre-scente.
RICE
RCHE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7100
Febbraio 2004Febbraio 2005Febbraio 2006Febbraio 2007
Fig. 1 Problemi maggiormente sentiti (segnalazione dei due più importanti) - Valori percentuali
30,0
20,0
0,0
10,0
40,0
50,0
60,0
70,0
Crimina
lità
e sicu
rezza
Diffico
ltà a
trova
re lav
oro
Inqu
inamen
to e
degra-
do dell
’ambien
te
Tassaz
ione
ecce
ssiva
Fonte: indagine IRES
Diffus
ione
della d
roga
Immigr
azion
e
Serv
izi pub
blici
inadeg
uati
Scars
e riso
rse
tempo l
ibero
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 100

RICE
RCHE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 101
Fig. 2 giudizio positivo (“soddisfacente” o “buono”) sul funzionamento di alcuni servizi pubblici - Valoripercentuali
30,0
20,0
0,0
10,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0Se
rvizi
sani
tari
Serv
izicu
ltura
liPub
blica
sicur
ezza
Serv
izi
ambi
enta
liSe
rvizi
per l
o sp
ort
Serv
izisc
olas
tici
Tras
porti
pu
bblic
iSe
rvizi
per a
nzian
iSe
rvizi
per
la
prim
a inf
anzia Serv
izi
per i
l lav
oro
Serv
izi p
er le
per
sone
div.
abili
Fonte: indagine IRES
Febbraio 2004Febbraio 2005Febbraio 2006Febbraio 2007
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 101

OSSERVATORIOISTRUZIONE PIEMONTE
RAPPORTO 2006
RICE
RCHE
LUCIANO ABBURRÀ,CARLA NANNI,IRES Piemonte
Negli anni novanta il sistema dell’istruzione piemontese è statocaratterizzato dalla riduzione della sua estensione e
dall’ampliamento della sua copertura: meno sedi, meno allievi,meno diplomati; più alti tassi di prosecuzione e di
scolarizzazione. Dall’inizio degli anni 2000, il tratto prevalenteè diventato la trasformazione qualitativa delle diverse parti delsistema, accompagnata da sintomi progressivi di ripresa delleiscrizioni, dovute al crescente numero di allievi stranieri, in
rapida espansione dai livelli iniziali a quelli intermedi.Al superamento della metà dell’attuale decennio il sistema
appare di nuovo tutto in espansione: più iscritti a tutti ilivelli, dalla scuola primaria all’università, più diplomati e
ancor più laureati. Presenta invece ancora i segni dellariorganizzazione nella diminuzione degli insegnanti e dellesedi scolastiche, mentre – in attesa del dispiegamento degli
effetti dei propositi di riforma della scuola secondariasuperiore – si può cominciare a tentare qualche primobilancio dalla estesa ridefinizione dei corsi e percorsi
universitari realizzata negli anni precedenti
Per riepilogare un percorso che il nostro Osservatorio ha seguito e do-cumentato con continuità, si ricorda che fino alle soglie del 2000 lapopolazione scolastica e universitaria ha fatto registrare una sistema-
tica tendenza alla contrazione, con l’unica parziale eccezione della scuolamaterna. In tutti gli ordini di scuola precedenti l’università, alla riduzionedegli allievi faceva riscontro una diminuzione delle sedi scolastiche, persoppressione o accorpamento di quelle preesistenti. A tutti i livelli, com-presa l’università, il calo degli allievi trovava riflesso in una riduzione delpersonale insegnante, sia pure in misura meno che proporzionale
Tra il 2000 e il 2001 si sono registrati diversi segnali, che il 2002 ha confer-mato e il 2003 ha rafforzato, di esaurimento della tendenza al restringimento edi avvio di una ormai apprezzabile inversione. Il 2004 e il 2005 hanno conso-
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 P . 1 0 2 - 1 0 6
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 102

lidato questa tendenza alla ripresa e ne hannoconfermata l’estensione anche ai livelli medio-superiori, in forza del ruolo prevalente assuntodall’aumento degli studenti stranieri, rispetto al-la dinamica declinante o alla stasi di quelli au-toctoni. Nel 2006, ai livelli di base dell’istruzio-ne per il settimo anno consecutivo, nella scuolasecondaria superiore per il quarto anno, gli al-lievi del sistema d’istruzione piemontese pre-sentano dati in crescita apprezzabile.
Per i prossimi anni si profila un quadroancora in crescita delle dimensioni del sistemae della sua diversità interna, mentre l’impegnodei responsabili dovrà concentrarsi sulle inno-vazioni qualitative necessarie sia nella offertadi servizi formativi sia nella valutazione dei lo-ro rendimenti in termini di apprendimento.
Nel 2006, gli allievi del sistemad’istruzione piemontese
presentano dati in crescitaapprezzabile
Prosegue intanto lo scivolamento dell’on-da bassa della demografia giovanile dei pie-montesi sulle età superiori a quelle di perti-nenza del sistema scolastico strettamente inte-so. A livello post-secondario, però, la doman-
RICE
RCHE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 103
da di servizi educativi dipende soprattuttodalle preferenze e dalle scelte delle persone,che possono influenzare il risultato finale piùdella numerosità della popolazione delle clas-si d’età corrispondenti. Così, se a tutto il 2006gli iscritti all’università in Piemonte si man-tengono prossimi alle 100.000 unità, tale nu-mero rimane pari a meno di un quarto dei pie-montesi d’età compresa fra 19 e 25 anni: unodei tassi meno elevati d’Italia. I margini teori-ci d’incremento restano perciò molto consi-stenti, anche in rapporto ai contingenti delleetà più convenzionali. Va inoltre consideratoche una tendenza sempre più percepibile,benché non ancora sufficientemente ricono-sciuta, fa ritenere che nella definizione delladomanda complessiva d’istruzione e forma-zione superiore sarà sempre più rilevante ilcontributo delle classi d’età adulte, in un qua-dro che assegna alle molte forme di lifelonglearning un peso crescente rispetto alla educa-zione iniziale. È forse proprio da questo latoche sono da attendersi le più rilevanti tensionie domande di cambiamento negli assetti del-l’offerta formativa complessiva. Ma è anche diqui che possono realisticamente essere pro-dotte quelle modificazioni nelle qualificazionimedie della popolazione piemontese che mol-ti auspicano e tanti ritengono indispensabili auna effettiva ridefinizione su basi più solidedegli assetti economici e sociali della regione.
1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
Iscritti totali (sia italiani sia stranieri) Iscritti senza stranieri
500.000
490.000
510.000
520.000
530.000
540.000
550.000
560.000
570.000
Fig. 1 Contributo degli studenti stranieri all’andamento degli iscritti al sistema scolastico piemontese
Fonte: elaborazione IRES su dati Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 103

Sul piano della configurazione strutturaledei servizi, così come nella loro distribuzioneterritoriale, già negli anni novanta avevano pre-so avvio importanti cambiamenti qualitativi. Èperò a cavallo tra il precedente decennio e l’at-tuale che i mutamenti istituzionali hanno presouna consistenza maggiore, mentre un momentodi incertezza sembra ora riguardare l’accelera-zione dei cambiamenti impressa dai processi diriforma messi in campo negli anni scorsi.
Nella definizione della domandacomplessiva d’istruzione eformazione superiore sarà
sempre più rilevante il contributodelle classi d’età adulte
Quale che sia l’esito dei ripensamenti incorso, resta altamente auspicabile che gli sfor-zi e le realizzazioni non restino tutti concen-trati sull’offerta di formazione iniziale per igiovani, ma sappiano arricchire le opportunitàdi formazione in alternanza per gli stessi gio-vani (dei quali un’ampia quota non riesce a
fruire con successo dei benefici dell’attuale of-ferta scolastica) e le possibilità di educazione-istruzione-formazione per persone di tutte leetà, in un sistema che sappia allontanarsi pro-gressivamente dalle rigidità del tradizionalemodello sequenziale.
Merita segnalazione l’approfondimento chesi è dedicato, anche nel 2006, alle tendenze del-la scuola non statale in Piemonte, spesso al cen-tro di discussioni, ma meno di frequente ogget-to di analisi obiettive che diano conto della suaconsistenza, composizione e dinamica.
Per la prima volta, quest’anno, l’osservato-rio dedica uno specifico capitolo monograficoalla ricognizione delle informazioni disponibi-li sulle nuove lauree triennali, introdotte dallacosiddetta riforma del 3+2: nel Rapporto si dàconto della loro numerosità e distribuzioneper facoltà e indirizzi e delle scelte successivedi coloro che le hanno conseguite: all’internodel sistema universitario e sul mercato del la-voro. Il rapporto di ricerca è stato pubblicatoin forma più ampia e completa sul sito inter-net www.sisform.piemonte.it e in uno specifi-co “Contributo di ricerca” n. 212/2007 editodall’IRES. Una rinnovata attenzione verso l’u-niversità e i suoi mutamenti si giustifica ancheper la continua e considerevole crescita delle
RICE
RCHE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7104
Fig. 2 Andamento del tasso di scolarizzazione nella scuola secondaria di II grado. confronto Italia-Piemonte*
85
90
95
100
80
75
70
65
601996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
* La popolazione utilizzata nel tasso di scolarizzazione del 2005/2006 è una stima BDDE per il Piemonte e una stimaISTAT per la popolazione nazionale.
Fonte: elaborazione IRES su dati Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte e Banca Dati Demografica Evolutiva (perla popolazione 14-18 anni); per l’Italia: fino all’A.S. 1999/2000 dati ISTAT; dal 2000/2001 al 2000/2003 elaborazioneISFOL su dati ISTAT e MIUR; dal 2003/2004 elaborazione IRES su dati ISTAT e del Ministero della Pubblica Istruzione.
Italia Piemonte
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 104

persone coinvolte da questo livello d’istruzio-ne. Mentre gli iscritti complessivi agli ateneipiemontesi – pur con oscillazioni contingenti– si mantengono sulle 100.000 unità (valorecostante da 10 anni), i laureati continuano laloro crescita consistente e regolare, portando-si ad approssimare le 20.000 unità (cifra tripli-cata in 10 anni).
Resta altamente auspicabile chegli sforzi e le realizzazioni non
restino tutti concentratisull’offerta di formazioneiniziale per i giovani, ma
sappiano arricchire le possibilitàdi educazione-istruzione-
formazione per persone di tuttele età
Anche nel 2006, infine, si sono mantenutee aggiornate le informazioni sullo stato di rea-lizzazione delle riforme in ambito scolastico,incluse le modifiche apportate alle previsioniprecedenti attraverso provvedimenti ammini-strativi e leggi di bilancio. Si è proseguita l’at-tività di “osservatorio sulle riforme” il cui sco-po è esclusivamente informare il pubblico che
RICE
RCHE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 105
non se ne occupa in modo professionale suche cosa si è deciso che cambi nei sistemi del-l’istruzione e sul punto in cui è finora giunta larealizzazione di quanto si è deliberato.
Più in generale, tutto il Rapporto 2006 simantiene fedele a un’impostazione il più pos-sibile standardizzata, anche per rendere piùagevole la sua consultazione e fruizione daparte degli utilizzatori abituali: in primo luogole scuole e le istituzioni educative piemontesiche concorrono generosamente a fornire leinformazioni di base necessarie alla sua predi-sposizione.
Nel contempo, si è ormai solidamente af-fiancata all’edizione cartacea, anticipandoneanzi i tempi in misura rilevante, una versione“elettronica” consultabile in internet sia delRapporto sia delle Basi dati da cui esso traealimento. Fin dal 2000 è attivo il sito webwww.sisform.piemonte.it, di cui l’Osservato-rio Istruzione è stato il primo componentestrutturato. Il sito è affiancato da altre sezionisul sistema della formazione professionale e,insieme, consentono di dare corpo – in formeche andranno arricchite nel tempo – a quel-l’Osservatorio sul Sistema Formativo Pie-montese per cui esiste un impegno formaliz-zato in un Protocollo d’intesa da parte dellaDirezione Regionale Promozione AttivitàCulturali Istruzione e Spettacolo, della Dire-zione Regionale Formazione Professionale eLavoro e dell’IRES Piemonte.
Fig. 3 Andamento dei laureati in piemonte e in italia (fatto 100 il numero di laureati nell’a.a. 1996/1997)
Fonte: Segreterie universitarie, MIUR
150
200
250
300
50
100
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Piemonte Italia
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 105

Dal 2003, inoltre, il già citato sitowww.sisform.piemonte.it ospita anche unospazio dedicato alla Rilevazione PISA-OCSE
sui livelli d’apprendimento dei ragazzi e ra-gazze quindicenni di circa 40 paesi del mon-do a cui si è dedicato il numero scorso diInformaires.
Come di consueto, il Rapporto viene aper-to da un capitolo introduttivo che fornisceuna sintesi di tutto ciò che, in forme più anali-tiche è contenuto nei capitoli successivi. Neicapitoli 2, 3, 4, 5 si presentano dati e tendenzedei diversi livelli dell’istruzione scolastica, se-condo le informazioni raccolte annualmentedalla Regione Piemonte con un’apposita rile-vazione diretta presso l’universo delle scuolepiemontesi. Nel capitolo 6 si ripropone un ap-profondimento monografico sulla presenza el’evoluzione degli allievi stranieri nei diversi
segmenti del sistema dell’istruzione piemonte-se. Nel capitolo 7 si offre una sintetica rico-gnizione dello stato di realizzazione delleriforme riguardanti i livelli dell’istruzione pri-maria e secondaria, aggiornati all’autunno2006. Nel capitolo 8 ci si occupa del sistemauniversitario, nelle sue dinamiche reali (iscrit-ti, immatricolati, laureati, per atenei, facoltà,corsi di laurea). La trattazione cerca di risul-tare approfondita e ampia, e col maggior gra-do di tempestività consentito dalla collabora-zione delle segreterie dei diversi atenei pie-montesi, cui per temi specifici si aggiungequella dell’Osservatorio regionale sull’univer-sità e sul diritto allo studio.
Nell’ultimo capitolo, infine, si proponel’approfondimento monografico sugli esitidell’introduzione delle lauree triennali nelnostro sistema universitario.
RICE
RCHE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7106
Giulio Cesare Procaccini
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 106

RICE
RCHE
IMMIGRAZIONESTRANIERA IN PIEMONTE
RAPPORTO 2006
ENRICO ALLASINO,IRES Piemonte
È stato pubblicato recentemente il rapporto 2006sull’immigrazione straniera in Piemonte. Scopo della
pubblicazione è innanzitutto fornire interpretazioni e chiavidi lettura del fenomeno. Più in dettaglio esso riporta un
contributo della Direzione Regionale FormazioneProfessionale e Lavoro della Regione Piemonte con datigenerali sull’inserimento degli immigrati in Piemonte e
ipotesi sui fabbisogni di lavoro. Successivamente il lavoroanalizza l’inserimento lavorativo degli immigrati utilizzando
per la prima volta la rilevazione delle forze di lavorodell’ISTAT. Vengono poi illustrate le questioni più rilevantirelative all’abitazione e alla salute. In questo contributo sifornisce una sintetica presentazione dei principali risultati,
per i lettori interessati ad approfondire la materia si rinvia alsito dell’Osservatorio regionale sull’immigrazione
(www.piemonte.immigrazione.it)
Gli immigrati stranieri residenti in Piemonte sono in continua cre-scita, con una forte accelerazione dal 2001. Oggi i residenti stra-nieri hanno già raggiunto le quote stimate per il 2012. Tuttavia le
pur numerose nascite di figli di stranieri non bastano a compensare la di-minuzione della natalità tra gli italiani e si può ipotizzare che una sia purmodesta crescita economica creerà un ulteriore fabbisogno di lavoratori no-nostante i già consistenti flussi attuali. Quindi le politiche di accoglienza edi inserimento devono rispondere con la massima tempestività.
Lavoro
La quota di lavoratrici e di lavoratori stranieri in Piemonte è del pari in cre-scita, e la domanda di lavoro mantiene un ruolo centrale nel sostenere l’im-
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 P . 1 0 7 - 1 1 1
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 107

migrazione extracomunitaria e nel modellarnela distribuzione sul territorio. L’analisi mostrache tanto le previsioni di assunzioni quanto glieffettivi avviamenti al lavoro riguardano so-prattutto figure poco qualificate. Si rileva unaforte segmentazione di genere del mercato,che vede i maschi richiesti da specifici seg-menti della domanda di lavoro operaio delleimprese industriali e le donne richieste in unapiù generica area di lavoro nel campo dei ser-vizi, ritenuta meno qualificata, con una im-portante componente di domanda delle fami-glie. I maschi stranieri sono molto più presen-ti nell’area del lavoro generico e poco presen-
ti nelle professioni che richiedono qualifica-zione scolastica e tecnico-scientifica. Riesconoinvece ad essere rappresentati nell’area del la-voro qualificato della vendita e dell’imprendi-toria, ove non sono richieste credenziali diqualificazione scolastiche e tecnico-scientifi-che. Le femmine hanno difficoltà a inserirsinelle professioni tecniche e ad alta specializza-zione, ma anche nelle posizioni impiegatizie,sia pure non particolarmente qualificate dalpunto di vista tecnico, a differenza delle italia-ne. La presenza di famiglie extracomunitarieaumenta dove c’è lavoro per i maschi, e nondove c’è lavoro per le femmine. In complesso
RICE
RCHE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7108
Fig. 1 Percentuale di residenti stranieri sul totale dei residenti al gennaio 2006 per provincia in Piemonte
Fonte: Istat
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0Torino Novara Asti Alessandria Biella Verbania Piemonte Italia
5,3
Vercelli
5,0
Cuneo
5,85,5
6,3
5,6
4,3
3,7
5,3
4,5
Fig. 2 Residenti extracomunitari per area continentale delle prime 15 nazionalità, al 31 dicembre 2005
Elaborazione ORML su dati ISTAT
America 7,5
Africa 32,8
Europa 53,2
Asia 6,5
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 108

sembra che il sistema Piemonte debba ancorainvestire molte energie per valorizzare appie-no le competenze e le potenzialità delle lavo-ratrici e dei lavoratori immigrati.
La presenza di famiglieextracomunitarie aumenta dovec’è lavoro per i maschi, e non
dove c’è lavoro per le femmine
Scuola
Nel campo dell’istruzione scolastica, non c’èuna differenza sostanziale di rendimento traitaliani e stranieri, riconducibile a una qualchedifferenza culturale. A determinare le diffe-renze sono piuttosto la condizione sociale, illivello di istruzione della famiglia, il percorsodi arrivo e di stabilizzazione. Si sta formando
RICE
RCHE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 109
un gruppo consistente di ragazze e ragazzi convari anni di presenza in Italia, che presentanorendimenti scolastici migliori di quelli dei lorocompagni cittadini italiani. Questo avvieneoggi soprattutto negli istituti tecnici, ma av-verrà anche nei licei. È evidente che i bambinie gli adolescenti tendono ad assimilarsi, so-prattutto se l’aspetto fisico e la somiglianzadella lingua di origine rende la cosa più facile.Resta però una presenza notevole di stranierinei CTP (corsi per adulti), perché nel frattem-po l’immigrazione continua e, soprattutto peralcune provenienze, il numero di coloro chenon padroneggiano la lingua e non possonoimpararla solo conversando è molto alto.
Il sistema scolastico regionale, che avevaaffrontato l’arrivo dei primi studenti immigra-ti con impegno e dedizione, si scontra oggicon nuove difficoltà. In particolare, contro leintenzioni generalmente espresse, ci sonoscuole che accolgono allievi immigrati e scuo-le che invece tendono a escluderli, con il ri-schio evidente di creare ghetti scolastici. Inol-
Tab. 1 Allievi con cittadinanza non italiana nelle scuole in Piemonte
PROVINCE TOTALE STRANIERI % SUL TOTALE ALLIEVI
Alessandria 5.025 10,17%
Asti 2.562 10,00%
Biella 1.581 6,74%
Cuneo 6.494 8,11%
Novara 3.202 6,81%
Torino (dati USR) 21.230 7,52%
Verbano-Cusio-Ossola 787 3,71%
Vercelli 1.679 7,45%
Totale Piemonte 42.573 7,56%
Fonte: MPI 2006 e USR
Tab. 2 Capoluoghi con la più alta incidenza di alunni con cittadinanza non italiana (a.s. 2005-2006).
VALORI PERCENTUALI
Milano 12,7
Alessandria 11,8
Prato 11,5
Reggio Emilia 11,5
Torino 11,2
Fonte: Mpi
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 109

tre, le pur numerose iniziative avvengono tut-te all’insegna della precarietà e della tempora-neità. Tra qualche anno, infine, andrà in pen-sione un gran numero di insegnanti, lasciandospazio a colleghi più giovani. Questo fatto haaspetti positivi, ma l’uscita dei vecchi inse-gnanti vuol dire anche una enorme perdita diesperienza nell’accoglienza, nella formazionee nell’insegnamento dell’italiano come secon-da lingua ad allievi immigrati. Bisogna preve-dere forme di trasmissione di queste compe-tenze dai vecchi ai nuovi docenti.
Casa
Resta difficile, in generale, trovare case a prez-zi ragionevoli per italiani e stranieri, ma i disa-gi sono più acuti e specifici per questi ultimi,anche per l’accesso all’edilizia pubblica. Sonoin atto processi di diffusione della popolazio-ne immigrata verso quartieri periferici e dellacintura torinese, con prezzi più abbordabili.Aumenta anche il fenomeno dell’acquisto del-la casa da parte degli immigrati.
Si stima che le sistemazioni abitative in af-fitto riguardino tra il 65% e il 75% degli im-migrati regolari attualmente presenti in Pie-
monte, la casa in proprietà tra il 10% e il 20%e le sistemazioni precarie tra il 15% e il 25%.Il Rapporto presenta diverse esperienze e ini-ziative che hanno migliorato l’accesso all’abi-tazione per gli immigrati, caratterizzate dal-l’essere soluzioni praticabili in tempi brevi eadatte alle esigenze specifiche dei beneficiari.
Resta difficile, in generale,trovare case a prezzi ragionevoli
per italiani e stranieri, ma idisagi sono più acuti e specifici
per questi ultimi
Salute
Per quanto concerne lo stato di salute, in baseai dati sui ricoveri ospedalieri si evince che laprobabilità complessiva di ricovero si presen-ta quasi uguale per gli italiani e gli stranieri. Seperò si tiene conto della maggior frequenza diricovero per parto tra le donne immigrate, ilrischio di ricovero tra gli stranieri risulta mi-nore rispetto alla popolazione locale.
RICE
RCHE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7110
Fig. 3 Graduatoria dei rischi di ricovero comparati, al 2003
0 100 200
11. Complicazioni della gravidanza del parto e del puerperio
1. Malattie infettive e parassitarie
4. Malattie del sangue e degli organi ematopoietici
17. Traumatismi e avvelenamenti
15. Alcune condizioni morbose di origine perinatale
8. Malattie apparato respiratorio
TUTTI I RICOVERI
16. Sintomi, segni morbosi mai definiti
6. Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso
18. Visite, controlli
10. Malattie del sistema genito-urinario
7. Malattie del sitema circolatorio
9. Malattie apparato digerente
14. Malformazioni congenite
12. Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo
3. Malattie endocrine, nutrizionali, metaboliche e disturbi immunitari
2. Tumori
13. Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo
5. Disturbi psichici
194,1
170,3
164,7
134,8
116,2
104,7
102,2
100,4
98,7
90,4
90,0
89,0
86,5
78,7
73,8
69,5
67,9
54,6
26,6
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 110

Solo alcune cause di ricovero si presentanoin eccesso tra gli stranieri immigrati. Perquanto concerne le malattie infettive e paras-sitarie, le principali cause di ricovero (HIV-Aids, tubercolosi e malaria) rivelano la prove-nienza degli immigrati da zone ad endemiaelevata; è anche probabile che precarie condi-zioni abitative, alimentari e igieniche nel luo-go di insediamento contribuiscano all’aggra-vamento della malattia in immigrati già infetti.Non vi è però alcuna diffusione alla popola-zione locale.
Le malattie del sangue e degli organi ema-topoietici presentano un eccesso del 65% tragli immigrati. Si tratta prevalentemente dianemie (emolitiche ereditarie e da carenza diferro), che colpiscono soprattutto i soggettiprovenienti dall’Africa. I ricoveri dell’areamaterno-infantile (gravidanze regolari e pato-logiche, IVG, condizioni perinatali) rivelanoda un lato la maggior fertilità delle donne stra-niere, dall’altro le criticità della vita riprodut-tiva, della contraccezione e del percorso na-scita. I ricoveri proporzionalmente elevati pertraumatismi indicano la maggiore esposizionea fattori di rischio per la sicurezza nei luoghidi vita e di lavoro.
Viceversa, alcune voci nosologiche presen-tano meno ricoveri tra gli stranieri che tra gliitaliani, in proporzione. Per quanto concerne levoci più importanti, come le patologie cardio-vascolari o i tumori, si potrebbe essere in pre-senza di una manifestazione dell’effetto “mi-grante sano” (emigra solo chi è in buona salute)o del rientro dei migranti malati. In altri casi,oltre a questi meccanismi, potrebbero essere inopera delle difficoltà di accesso ai servizi.
In base all’esperienza dei paesi di vecchiaimmigrazione, ci si può aspettare che tra dueo tre decenni anche l’Italia veda strutturarsiforti disuguaglianze a carico delle minoranzeetniche, con alcune meno rilevanti variazionilegate a tratti genetici e di importazione, so-prattutto nella prima generazione, e a partico-lari specializzazioni di ruolo sociale ricopertedalle diverse minoranze; queste disuguaglian-ze risultano dall’influenza che la marginalizza-zione e la discriminazione razziale ha nellostrutturare lo svantaggio sociale ed economi-co, sia nella distribuzione di opportunità e ri-sorse, sia nell’accesso ai servizi. Questo pro-
RICE
RCHE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 111
cesso tende a sovrastare e controbilanciare ilforte vantaggio in termini di salute importatoattraverso la selezione dei più sani, almenonella migrazione volontaria legata a un pro-getto di lavoro. Questo processo di costruzio-ne sociale delle disuguaglianze etniche non èperò inevitabile. L’Italia sarebbe ancora intempo per evitare la deriva verso le disugua-glianze etniche di salute attraverso politicheper gli stranieri immigrati che includesseroanche la salute come criterio di valutazione.
Data la centralità che lademografia attribuisce al ruolodell’immigrazione straniera nelgarantire il rinnovamento della
forza di lavoro del nostro paese,la protezione del capitale di
salute importato è uninvestimento fondamentale
Le politiche dell’immigrazione dovrebberocalibrare, dunque, i loro interventi anche sulcriterio della salute, per poter in qualche modointerferire con questo processo di generazionedi svantaggi razziali e sociali di salute. Data lacentralità che la demografia attribuisce al ruo-lo dell’immigrazione straniera nel garantire ilrinnovamento della forza di lavoro del nostropaese, è chiaro che la protezione del capitale disalute importato con questi nuovi flussi migra-tori è un investimento fondamentale per il pae-se. Occorre pertanto tutelare la salute deglistranieri immigrati in ogni sede dove le politi-che dell’immigrazione possano proteggerla epromuoverla: le politiche del lavoro e della ca-sa, le politiche della sicurezza e dell’ambiente,le politiche urbanistiche. Il sistema sanitario,oltre a questo ruolo di patrocinio, dovrebbe asua volta preoccuparsi di contrastare i mecca-nismi che limitano l’accesso alle cure per glistranieri immigrati, sia relativamente alle bar-riere culturali, economiche e giuridiche sia re-lativamente alla esigenze di personalizzazionedell’offerta in alcune situazioni che richiedonouna medicina d’iniziativa.
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 111

GLI INVESTIMENTI DIRETTIALL’ESTERO DELLE IMPRESE
PIEMONTESITENDENZE, STRATEGIE E RISULTATI
RICE
RCHE
VITTORIO FERRERO,IRES Piemonte
Nel numero 2 del 2006 di “Informaires”, dedicatoall’internazionalizzazione del Piemonte, si erano offertealcune anticipazioni relative agli aspetti strutturali della
proiezione internazionale delle imprese piemontesi analizzataattraverso l’evoluzione dei flussi degli IDE (Investimenti
Diretti Esteri). Il lavoro è stato pubblicato all’inizio del 2007e ne riportiamo qui le principali conclusioni a complemento
di quanto già apparso su questo periodico.La ricerca si è avvalsa della banca dati Reprint sviluppata daR&P in collaborazione con il Politecnico di Milano. Tramiteessa è stato estratto un campione di imprese presso cui è stata
svolta l’indagine diretta. Sono state effettuate 33 intervistedirette: 30 imprese manifatturiere e 3 imprese di servizi. Il
rapporto è articolato in tre parti: la prima fornisce datistatistici di inquadramento per l’Italia e il Piemonte; la
seconda approfondisce i dati del database piemontese, mentrela terza è dedicata alla presentazione dei risultati.
L’indagine sugli IDE in Piemonte mostra un quadro che, senon può definirsi soddisfacente, appare tuttavia accettabile in
quanto, nonostante le note vicende del compartoautomobilistico, non vi sono stati smottamenti nelle posizionidetenute all’estero e resta intatta la possibilità, con la ripresa
economica, di una rinnovata fase espansiva.Come si è detto, molte informazioni su composizione,
caratteristiche, sbocchi geografici degli IDE delle impresepiemontesi sono ricavabili dal corrispondente database rivisto
e integrato ad hoc per questo lavoro e descritto nel“Contributo di ricerca” n. 208/2007 scaricabile dal sitodell’IRES. Qui si richiamano alcune delle evidenze più
significative
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 P . 1 1 2 - 1 1 6
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 112

Il quadro generale
Sebbene tra le imprese piemontesi con parte-cipazioni all’estero non manchino imprese dipiccola e piccolissima dimensione – poco me-no di un terzo delle imprese investitrici ha me-no di 50 addetti e il 19% ha meno di 20 ad-detti, con una presenza peraltro proporzional-mente maggiore nei servizi – numerosità e di-mensione delle iniziative crescono con il cre-scere della dimensione di impresa, con quasiil 39% delle partecipate riferibili a sole 35 im-prese investitrici con oltre 500 addetti. Risul-tati anche più netti si otterrebbero se si faces-se riferimento come indicatore, invece che al-le partecipate, ai loro addetti.
Un’analoga polarizzazione emerge, anchea prescindere dalla dimensione delle impreseinvestitrici, per quanto concerne il numero dipartecipazioni detenuto da ciascuna di queste:la netta maggioranza delle imprese investitrici– 219 su 376 – ha una sola partecipazione al-l’estero, e un ulteriore folto gruppo di 72 im-prese ha solo 2-3 partecipazioni. Specular-mente solo un ristretto gruppo di imprese in-vestitrici sembra avere i requisiti, almeno inprima approssimazione, di una vera “multina-zionale” o anche “piccola multinazionale”: in-dicativamente, 28 imprese hanno più di 10partecipate estere.
Solo un ristretto gruppo diimprese investitrici sembra avere
i requisiti, di una vera“multinazionale”
Ad approfondire il quadro, si è tentato diclassificare le imprese investitrici per tipologiadi investimento a seconda dell’attività preva-lente delle partecipate: produttiva (ulterior-mente suddivisa a seconda che si svolga nellearee Nord o Sud del mondo, ovvero in en-trambe), commerciale, commerciale integratada produzione, di servizio alle imprese. I ri-sultati di tale esercizio, che scontano l’inevita-bile rigidità derivante dall’applicazione di cri-teri classificatori convenzionalmente assunti,non appaiono tutti immediatamente intuitivi,
RICE
RCHE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 113
ma integrano e in qualche misura contribui-scono a mettere diversamente a fuoco le pre-cedenti osservazioni da un altro angolo pro-spettico:• Meno della metà delle imprese piemontesi
investitrici – 165 su 376 – ha attuato inizia-tive a carattere prevalentemente produtti-vo, e di queste solo 30 in aree sia del Nordche del Sud del mondo e, dato egualmentesignificativo, solo 4 dal 2000 in poi; in que-sto gruppo, a sottendere una forte disomo-geneità di situazioni e un carattere com-plessivamente ibrido, si ritrovano solo 8delle 20 imprese con più di 1.000 addetti,mentre 13 hanno meno di 250 addetti; adesse fanno capo tuttavia ben 413 delle1.437 partecipazioni complessivamentecensite.
• Le imprese investitrici che hanno attuatoiniziative prevalentemente produttive nellearee del Nord del mondo appartengono innetta maggioranza al gruppo delle impresepiccole e medio-piccole (41 imprese su 54hanno meno di 250 addetti), con un nu-mero limitato di partecipazioni estere (48imprese su 54 hanno tra 1 e 3 partecipa-zioni).
• Le imprese con investimenti esteri preva-lentemente produttivi localizzati nelle areedel Sud del mondo, come le precedentihanno per lo più dimensione piccola o me-dio-piccola (61 imprese su 81 hanno menodi 250 addetti) e un numero limitato dipartecipazioni estere (76 imprese su 81hanno tra 1 e 3 partecipazioni); caratterepeculiare, tuttavia, è che le loro iniziativesono state tutte attuate dal 1990 in poi;fanno parte del gruppo tutte le imprese in-vestitrici mosse da strategie di delocalizza-zione produttiva, anche se non è vero ilcontrario, ossia che tutte le imprese inve-stitrici del gruppo abbiano condiviso talemotivazione: alcune, infatti, sono impresedella componentistica auto che hanno se-guito il loro principale cliente in quella de-terminata localizzazione, altre hanno avutofinalità “market seeking” oltreché di ricer-ca di bassi costi di produzione, ecc.
• La tipologia più numerosa, comprendenteoltre un terzo delle imprese investitrici èquella costituita da imprese i cui gli IDE so-
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 113

no costituiti essenzialmente da filiali com-merciali; a testimoniare una situazione alriguardo tutt’altro che soddisfacente, 89imprese su 131 hanno una sola filiale com-merciale e, all’opposto, solo 14 imprese da4 a 20 filiali.
• Meno numerosa, ma più robusta appare latipologia delle imprese i cui IDE sono co-stituiti in prevalenza da filiali commercialiintegrati da investimenti produttivi suimercati più eccentrici e/o più dinamici;sono riconducibili a tale tipologia 35 im-prese, di cui 15 detengono tra 4 e 10 par-tecipazioni estere, altre 10 da 11 a 20 par-tecipazioni e 1 più di 20 partecipazioni; aconferma che vi appartengono anche uncerto numero di imprese grandi e mediograndi, 9 imprese hanno tra 250 e 1.000addetti e 5 imprese più di 1.000 addetti.
• Le imprese i cui IDE si sono indirizzati nelsettore dei servizi alle imprese risultano 45,di taglia piuttosto variegata, 5 di esse aven-do tra i 250 e i 1.000 addetti e 1 più di1.000 addetti; la maggior parte delle impre-se investitrici di questo gruppo ha tra 1 e 3partecipazioni estere, ma vi sono anche 5imprese che hanno da 4 a 10 partecipazionie 4 imprese che hanno 11 o più partecipa-zioni; in definitiva, la presenza estera delleimprese piemontesi nel settore dei servizialle imprese si conferma molto ridotta, maanche in questo caso si ritrova almeno unpiccolo nucleo di buon spessore.
Infine, meritano attenzione i dati relativialle iniziative intraprese tra 2000 e 2005. Sitratta di 244 nuovi IDE riferibili a 84 impreseinvestitrici, di cui 37 non detenevano in pre-cedenza nessuna partecipazione all’estero.Anche se si tiene nel debito conto la sottosti-ma del dato relativo a 2004 e 2005 per tutti isettori diversi dai tre oggetto di specifico ap-profondimento in quest’occasione (tessile ab-bigliamento, meccanica strumentale e auto-motive), resta l’esiguità del dato dovuta al ca-lo delle nuove iniziative, rispetto al biennioprecedente, che si manifesta già nel 2002-2003in concomitanza con la fase di recessione in-dustriale della regione. I settori interessati re-stano quelli tradizionali, anche se non si ma-nifestano accelerazioni neppure in quelle atti-
vità, come le produzioni tipiche del made inItaly, o in quelle aree geografiche, come i pae-si dell’Europa Centro-orientale o dell’AfricaSettentrionale, possibile sbocco di strategie didelocalizzazione produttiva. Al contempo, as-solutamente rarefatte e sporadiche restano leiniziative, ad esempio, nella chimica farma-ceutica o nelle macchine e apparecchi elettricie elettronici, nel manifatturiero o, in generale,nei servizi alle imprese.
L’indagine sul campo
I risultati dell’indagine sul campo, tenuto con-to che non è stata diretta a un campione rap-presentativo di imprese, ma a un gruppo di es-se operanti in alcuni specifici settori strategiciper l’economia piemontese e che sono stateescluse deliberatamente le grandi, presentanoun buon grado di coerenza e ben si inserisco-no nel quadro generale fin qui tratteggiato.
Il problema dell’investimento diretto assu-me connotati diversi in funzione delle specifi-cità di settore, ma anche del tipo di mercatoservito, in particolare beni intermedi (e in talcaso se l’offerta è costituita da una gamma diprodotti ristretta, al limite un solo prodotto, opiù ampia) ovvero beni di consumo finali (e inquesto secondo caso se l’offerta riguarda benidi massa o di fascia elevata).
Alcuni tratti generali sono tuttavia emersi:• i limiti, da ritenersi comuni a un’ampia
area di imprese operanti nei comparti delmade in Italy e del sistema moda, della so-luzione costituita dalla delocalizzazioneproduttiva;
• il carattere obbligato e quindi sostanzial-mente difensivo degli investimenti produt-tivi di imprese, in particolare di impresedella componentistica auto ma non solo,quando devono seguire all’estero il lorounico o principale cliente;
• la difficoltà delle piccole imprese ad af-frontare anche i passi più scontati richie-sti da un’operazione di IDE, spiega comeper un’ampia quota delle imprese investi-trici censite, la presenza all’estero resti li-mitata a una o comunque a pochissimepartecipazioni, talora assunte cogliendouna particolare occasione piuttosto che
RICE
RCHE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7114
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 114

attraverso un meditato processo di sele-zione, e lascia intendere l’elevato numerodi altre imprese probabilmente indotte arinunciare;
• la conferma che uno dei modelli di inter-nazionalizzazione più efficienti adottati èquello che integra un’ampia rete distribu-tiva, supportata dalla capacità di assistenzadei clienti in loco, con una presenza pro-duttiva diretta in alcuni mercati meno fa-cilmente servibili con una semplice pre-senza commerciale e di particolare rilievostrategico.
Come si è già avuto modo di affermare,non emergono elementi che confermino i ti-mori che gli IDE delle imprese piemontesi,neppure quelli indotti senz’altro da strategiedi delocalizzazione produttiva, abbiano avutoo possano avere un impatto negativo sull’oc-cupazione locale, se non ci si limita al brevissi-mo periodo e se si rimuove la clausola coeterisparibus, per tener conto dell’attività dei con-correnti e del probabilissimo rischio di spiaz-zamento di quelle imprese.
La difficoltà delle piccoleimprese ad affrontare talora
anche i passi più scontatirichiesti da un’operazione diIDE lascia intendere l’elevato
numero di altre impreseprobabilmente indotte a
rinunciare
Nemmeno si può assumere tout court cheogni iniziativa di IDE di un’impresa abbia ef-fetti positivi sul suo territorio di origine.Sembra piuttosto sensato assumere che untessuto economico sano e vitale esprimeràimprese in grado di sostenere processi di in-ternazionalizzazione quantitativamente signi-ficativi e qualitativamente efficienti e che lostesso tessuto economico avrà in sé i requisitiper cogliere le opportunità che ne deriveran-no e assorbire anche eventuali contraccolpidi breve periodo.
RICE
RCHE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 115
La situazione del Piemonte, inutile negar-lo, è ancora lungi da questa felice condizione.La stessa analisi fin qui condotta in tema diIDE delle imprese della regione porta a deli-neare un quadro di luci e ombre, a indicare unprocesso di trasformazione in corso ma anco-ra largamente irrisolto.
I dati complessivi sugli IDE, ad esempio,confermano la tenuta del sistema e gli stessidati e l’indagine diretta testimoniano della vi-talità e dell’eccellenza di non poche imprese.Al contempo, non si può non rilevare comedal punto di vista complessivo del sistemamanchino sia la massa critica sia dei segnaliconsistenti e non episodici di differenziazionee upgrading produttivo tali da giustificare ungiudizio francamente positivo.
Alla domanda se siano opportune e prati-cabili misure di sostegno alle imprese che in-tendono intraprendere iniziative di investi-mento diretto all’estero è difficile fornire unarisposta.
L’analisi fin qui condotta intema di IDE delle imprese della
regione porta a indicare unprocesso di trasformazione incorso, ma ancora largamente
irrisolto
Si può certo immaginare quanto meno perle piccole imprese una più puntuale informa-zione di base su mercati particolarmente “dif-ficili” ed eccentrici, sulle imprese italiane chegià vi operano (utile ad esempio a chi vogliaavviare attività di servizi), sulle aree di inse-diamento, sul grado di infrastrutturazione,sulla disponibilità di servizi di trasporto e lo-gistici, sulla possibilità di reperirvi altri servizispecialistici, legali, consulenziali, ecc. Nonsembra tuttavia ipotizzabile e neppure utileuna sorta di internazionalizzazione guidata.
Più in generale, sarebbe utile, per non direindispensabile, un approccio al tema degli IDE
in uscita, non solo scevro di pregiudizi negati-vi, ma che colga come per moltissime impreseitaliane il problema della crescita sia ad un
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 115

meno importante, per i compiti spettanti aun sistema finanziario in grado di offrire ser-vizi adeguati, ma anche assumere iniziativead esempio nel campo del private equity edel venture capital altrettanto rilevanti e ma-gari aggressive di quelle ormai abituali inEuropa e non solo.
tempo problema di assetti proprietari, fonti difinanziamento, organizzazione manageriale egovernance, e internazionalizzazione. Con tut-te le conseguenze che ne derivano per una po-litica industriale che, a tutti i livelli, non vogliacondannarsi a una vacua sommatoria di misu-re parcellizzate e quindi all’impotenza e, non
RICE
RCHE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7116
Fra’ Galgario
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 116

RICE
RCHE
PMI PIEMONTESI E MERCATO MONDIALE
FLUSSI DI APPROVVIGIONAMENTO E FORNITURA
RENATO LANZETTI Tra i fattori che nello scorso decennio hanno concorso adeterminare la perdita di competitività del sistema economico
nazionale e regionale si annovera, accanto al modello dispecializzazione – troppo orientato su produzioni ad alta
intensità di lavoro e a basso valore aggiunto – e alla ridottacapacità innovativa, l’eccessiva frammentazione dell’apparatoproduttivo in imprese di dimensioni inadeguate a sostenerestrategie ed investimenti per la ricerca, l’innovazione e la
internazionalizzazione. Eppure, negli scorsi anni, sono statele imprese minori a fornire un apporto significativo alla
tenuta produttiva e occupazionale del tessuto imprenditorialeitaliano e piemontese, compromessa dalle criticità di molti
grandi gruppi industriali.Questo paradosso ha indotto l’IRES ad avviare un programma
di ricerca dedicato alla evoluzione e ai cambiamenti delsistema delle PMI in Piemonte: nel 2005 è stata realizzata una
indagine sui loro percorsi di innovazione, nel 2006 è statacompletata una ricerca, di cui riportiamo qui la sintesi dei
principali risultati, volta a verificare come le PMI piemontesipartecipano ai mutamenti in atto nel sistema economico
internazionale che incidono sulle scelte dei bacini diapprovvigionamento e degli sbocchi di fornitura
Icomportamenti delle PMI e le scelte in merito all’operatività sui merca-ti, molto spesso sono condizionati dalle decisioni di altre imprese. In-fatti, nei tre quarti dei casi l’attività prevalente è di subfornitura, attua-
ta attraverso lavorazioni eseguite su materiali del committente o la realizza-zione su commessa di semilavorati e componenti. In queste condizioni l’im-presa ha pochi spazi di manovra per una scelta autonoma nella definizionedelle politiche da adottare. È il committente che elabora le strategie e ilsubfornitore è costretto a fare i propri programmi in base ad esse. Il rap-porto diretto con il mercato finale è poco frequente in tutte le dimensioni
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 P . 1 1 7 - 1 2 1
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 117

aziendali e tende a rarefarsi al diminuire delnumero degli addetti.
Ciononostante sono numerose le impresecon un raggio d’azione abbastanza ampio dapotersi confrontare con realtà anche lontanegeograficamente e con modalità operative dif-ferenti. La presenza sui mercati esteri, princi-palmente in veste di esportatori, ma anche diimportatori e, seppure in misura minore, diinvestitori, è nel complesso abbastanza diffu-sa: se è relativamente modesta nelle classi di-mensionali più piccole, raggiunge livelli moltoelevati nella classe di addetti superiore; bastaricordare a questo proposito che nella classe100-249 addetti il 97,4% delle imprese ha svi-luppato rapporti sui mercati internazionali afronte del 37,2% delle aziende da 10 a 19 ad-detti.
Va comunque osservato che in termini diconsistenze, ovvero di incidenza sul fatturato,è il mercato regionale quello più importante,sia per le vendite che per gli acquisti, seguito abreve distanza da quello nazionale.
La tendenza è quella di un progressivo svi-luppo delle vendite sui mercati esteri (lo testi-monia il trend in crescita della quota di fattu-rato export), che però solo raramente è ac-compagnato da una diversificazione geografi-ca degli sbocchi; anche in questi pochi casi ilriorientamento delle vendite appare, però, piùcome una risposta obbligata a mutate condi-
zioni di mercato (diminuzione della redditi-vità del mercato piemontese, calo della do-manda proveniente dal Piemonte) che una ri-cerca di opportunità aggiuntive. I mercatiesteri di riferimento restano quelli tradiziona-li per le imprese piemontesi, con Francia,Germania e Spagna nelle prime posizioni.
Il riorientamento dei flussi di vendita tro-va, almeno in parte, un freno nel fatto che dinorma l’individuazione di nuovi clienti esteriè frutto di una ricerca attiva effettuata dall’a-zienda stessa, azione che richiede un dispen-dio di energie e di risorse non sempre dispo-nibili presso una piccola o media impresa; neè conferma il fatto che la presenza di processidi diversificazione geografica delle vendite èpiù diffusa al crescere delle dimensioni. Piùraramente il primo contatto avviene per ini-ziativa dell’acquirente, sebbene molte impresegodano di una certa visibilità in quanto sonoleader nel proprio settore o comunque occu-pano una buona posizione sul mercato.
La ricerca in prima persona di nuovi clien-ti esteri è una modalità che consente all’im-presa di presentare direttamente le propriepotenzialità e può essere preferita proprio perquesto; spesso, però, rappresenta una sceltaobbligata in quanto le imprese non trovanovalidi supporti in questo campo da struttureesterne (enti, associazioni imprenditoriali,ecc.) né vantaggi dalla partecipazione a fiere.
RICE
RCHE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7118
Fig. 1 Presenza sui mercati esteri (percentuali)
60
50
40
30
20
10
0Import
24,8
Export
57,2
Collaborazione
6,5
Investimenti
4,0
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 118

Anche le nuove opportunità offerte da Inter-net non sembrano di grande utilità, special-mente per le imprese di dimensioni minori.
Sul versante degli acquisti il lavoro ha per-messo di accertare la loro rilevanza sull’eco-nomia delle imprese: materiali, semilavorati,componenti, lavorazioni, prodotti finiti da ri-vendere senza trasformazione mediamente so-no pari al 37,2% del fatturato. A questi devo-no poi essere aggiunti gli acquisti di servizi equelli di beni strumentali. Un insieme non in-differente per il bilancio delle aziende, chemerita quindi una particolare attenzione nellescelte dei bacini di approvvigionamento e, alloro interno, dei fornitori.
La domanda per gli acquisticorrenti si indirizza in primo
luogo verso fornitori piemontesimentre è meno frequente il
ricorso a fornitori esteri
La domanda per gli acquisti correnti si in-dirizza in primo luogo verso fornitori piemon-tesi e, in misura di poco inferiore, verso forni-tori localizzati in altre regioni italiane, mentreè meno frequente il ricorso a fornitori esteri.L’orientamento degli acquisti correnti, comun-que, dipende, in parte, dalla tipologia di atti-vità e dei materiali impiegati, in parte, dalle di-mensioni delle imprese; infatti, al crescere del-
RICE
RCHE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 119
le dimensioni i bacini di approvvigionamentosono geograficamente sempre più lontani.
Ancora più ristretto è il mercato di riferi-mento per gli acquisti di servizi: circa un’im-presa su due si rivolge all’esterno per esigenzeinformatiche, pubblicitarie, di consulenza tec-nica e organizzativa, ma il fornitore quasi sem-pre è una società localizzata nelle vicinanze e,comunque, in ambito regionale. Diverso inve-ce è il discorso dei beni strumentali; la do-manda si indirizza quasi in egual misura versoproduttori di altre regioni italiane e produtto-ri piemontesi, mentre i fornitori esteri copro-no solo una quota contenuta della domanda.
Per gli acquisti all’estero, siano essi di mate-riali, semilavorati, componenti, lavorazioni op-pure di prodotti finiti da rivendere o, ancora,di servizi o di beni strumentali, il mercato di ri-ferimento è la Germania e, solo a distanza, sicolloca in seconda posizione la Francia. Comeper le vendite, anche nel caso di acquisti all’e-stero l’individuazione dei potenziali fornitori èfatta quasi sempre direttamente dall’impresa.
Per gli acquisti all’estero ilmercato di riferimento è la
Germania e solo a distanza laFrancia
Nel complesso, l’offerta proveniente dagliattuali bacini di approvvigionamento sembrasoddisfare le esigenze delle imprese, conside-
Fig. 2 Aree di approvvigionamento
Estero 13,2
Piemonte 46,0Italia 40,8
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 119

rato che solo in un numero veramente esiguodi casi sono in atto processi di riorientamentodella domanda verso aree diverse da quellefrequentate fino a oggi.
La mancanza di interesse per le potenzia-lità offerte dal mercato globale sembra deriva-re non solo dal fatto che l’offerta attuale è pie-namente valida, ma anche da una certa diffi-coltà a cogliere le opportunità che esso offre.
In effetti, la globalizzazione per le PMI pie-montesi comporta principalmente l’ingressosul mercato di nuovi paesi produttori a costicompetitivi e la lievitazione dei prezzi dellematerie e dei semilavorati per l’incrementodella domanda; in altre parole, si traduce piùin una minaccia che in una opportunità.
Il riorientamento verso i mercatiesteri comporta un impegno in
termini organizzativi e di risorseumane, di cui però spesso le
imprese non riescono a coglierel’entità
Le strategie che le imprese stanno metten-do in atto per fronteggiare i mutamenti pre-senti sui mercati internazionali sono conse-guenti e mirano, in primo luogo, all’innalza-mento del livello qualitativo e tecnologico e,successivamente, a un riposizionamento dellaproduzione su una fascia di mercato più alta.Gli interventi, dunque, puntano più sugliaspetti produttivi che su quelli commerciali,riproponendo un cliché tipico del Piemonte.
In questo contesto, tuttavia, non va trascu-rato il fatto che un’impresa su cinque denotaparecchia incertezza sulle strategie da attuareper fronteggiare la concorrenza crescente e,più in generale, i mutamenti in atto sui merca-ti internazionali. Criticità in questo senso sonomaggiormente diffuse tra le imprese più pic-cole, mentre tendono a diminuire al cresceredelle dimensioni.
Gli interventi posti in atto per rispondereai mutamenti in corso sui mercati internazio-nali implicano, ovviamente, dei costi per leaziende.
In particolare, il riorientamento verso imercati esteri, o il riposizionamento su que-sti mercati, sia delle vendite così come degliapprovvigionamenti, comporta un impegnoin termini organizzativi e di risorse umane,di cui però, spesso, le imprese non riesconoa cogliere l’entità. In un contesto complessocome quello in cui si muovono le imprese,dove si intrecciano condizionamenti deri-vanti da fattori interni ed esterni all’impre-sa, può risultare difficile porre in relazionele strategie di internazionalizzazione e gli ef-fetti sul sistema organizzativo e sul persona-le. Dove questi effetti sono percepiti, essi sitraducono, sul versante produttivo, in mag-giori esigenze di qualità e certificazione e inmaggiori costi; sul versante del personale, innecessità di riqualificare il personale esisten-te e, secondariamente, di inserire nell’orga-nico nuove figure professionali. In sintesi ilriorientamento richiede un salto qualitativoche coinvolge praticamente tutte le areeaziendali.
In questo difficile processo le imprese simuovono quasi esclusivamente con le proprieforze. Meno di una impresa su dieci ha utiliz-zato servizi e supporti pubblici per trovaresbocchi sui mercati esteri, richiedendo quasiesclusivamente interventi per partecipare aeventi all’estero o servizi di tipo promozionalee informativo. Ancora meno frequente è il ri-corso al supporto pubblico per quanto riguar-da l’attività di acquisto all’estero. La ragionesembra risiedere nella scarsa fiducia ripostadalle imprese in questi servizi.
Larga parte delle imprese, nonsa indicare quali sarebbero iservizi più utili per operare
all’estero
Va comunque anche detto che, non solo viè scarso interesse verso l’offerta pubblica diservizi, ma vi è pure una scarsa abitudine adomandarsi che cosa potrebbe essere utile al-l’azienda per migliorare le performance suimercati esteri e/o risparmiare risorse (finan-ziarie, umane, di tempo, ecc.) Larga parte del-
RICE
RCHE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7120
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 120

le imprese, infatti, non sa indicare quali sareb-bero i servizi più utili per operare all’estero;solo al di sopra della soglia dei 100 addettiemerge una maggiore consapevolezza delleesigenze e una maggiore capacità a individua-re i servizi e le iniziative più utili.
La dimensione, unitamente alla tipologiadella produzione, dunque, gioca un ruolo nontrascurabile su molti aspetti presi in esame inquesto studio e rappresenta una limitazionealle potenzialità di sviluppo delle imprese. Leperformance in termini di occupazione, fattu-
RICE
RCHE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 121
rato, export tendono, infatti, a migliorare alcrescere delle dimensioni, e anche le strategieper la ricerca di nuove opportunità nel merca-to globale sono più diffuse al crescere dellascala dimensionale.
Non va dimenticato, comunque, che sullestrategie e sui risultati delle imprese pesa an-che la congiuntura che caratterizza i diversisettori di attività. Lo studio ha rilevato comepermangano criticità nel settore tessile, men-tre quello delle lavorazioni e dei prodotti inmetallo presenta una buona tenuta.
Giorgio Morandi
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 121

ICT E DISTRETTIINDUSTRIALIRI
CERC
HE
IRES, POLITECNICO
TORINO, ISMB,CERIS-CNR
Questo studio è stato realizzato dietro richiesta della RegionePiemonte nell’ambito delle ricerche promosse
dall’Osservatorio Ict del Piemonte nel quadro del programmaWie-Pie. Suo scopo è quello di fornire un contributo di
conoscenza sull’atteggiamento verso le Ict e l’innovazionedigitale presso le imprese dei distretti industriali piemontesi.
Il lavoro ha messo in luce come le imprese distrettualipresentino, in media, tassi di adozione di banda larga in
particolare, e delle nuove tecnologie in generale, inferiori aquelli del resto delle imprese piemontesi.
In particolare, esso evidenzia come i problemi di ritardo delladiffusione delle ICT nei distretti presi in esame (Biella,
Borgomanero e San Maurizio d’Opagli, Valenza) dipendanosia dalle peculiarità produttive e manageriali delle imprese sia
dalle dinamiche di interazione del distretto. In linea diprincipio, l’organizzazione distrettuale dovrebbe
avvantaggiarsi dall’utilizzazione delle ICT, se non incontrasseostacoli per il loro utilizzo
Nei distretti esaminati si riscontra una situazione variegata per quelche riguarda la dotazione e l’utilizzo delle nuove tecnologie. Leprincipali differenze nell’adozione di nuove tecnologie dipendono
prioritariamente dalle caratteristiche intrinseche del settore di attività e del-la filiera produttiva di appartenenza: esiste cioè una diretta proporzionalitàtra la complessità (lunghezza) della filiera produttiva, basata sul numero diattività necessarie per la realizzazione del prodotto finito, e gli investimentiin ICT.• Le imprese distrettuali del Valenzano, utilizzano le ICT prevalentemen-
te per la gestione dell’attività aziendale. Poche imprese sono dotate disito web e il commercio elettronico è praticamente inesistente. Le inno-
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 P . 1 2 2 - 0 0 0
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 122

vazioni si diffondono soprattutto in rela-zione alla spinta esercitata dai clienti.
• Le imprese distrettuali del Biellese dispon-gono in larga misura di programmi gestio-nali sviluppati ad hoc, per rispondere alleesigenze di una filiera produttiva comples-sa quale quella del tessile. Emerge in parti-colare, un’elevata diffusione di applicativigestionali integrati (ERP – Enterprise Re-source Programming – ad esempio: SAP,Navision, Oracle) nelle imprese a valle del-la filiera. Tale diffusione è stata sostenutadall’esistenza di imprese ICT che, nel corsodel tempo, si sono gradualmente specializ-zate, prima nella fornitura di hardware esistemi gestionali interni per poi assumere,successivamente, un ruolo di veri e propricatalizzatori, anche nei confronti di tutte leimprese della filiera produttiva. Attual-mente si manifestano problemi di intero-perabilità tra i sistemi ICT consolidati e datempo in uso, e le applicazioni dei nuovisistemi ERP.
• Le imprese dei distretti della rubinetteriapresentano percentuali di diffusione di ICT
relativamente più elevate di quelle degli al-tri distretti presi in esame. Sono da segna-lare la diffusione dei sistemi di ERP e diesperienze di e-commerce. Non è da esclu-dere che tali dinamiche siano state favoritesia dalla prossimità del distretto rispetto alcapoluogo lombardo, sia dalla necessità di
RICE
RCHE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 123
migliorare il coordinamento tra le impresedel distretto. Queste ultime, inoltre, a cau-sa della debole interconnessione interna,adottano poco gli strumenti di comunica-zione per integrare a monte la catena delvalore.
Passando all’esame delle imprese per clas-se dimensionale, si rileva una differenziazione,da tempo nota negli studi di settore, nelle stra-tegie di adozione/utilizzo delle ICT a secondadella classe dimensionale dell’impresa.
Le piccole imprese artigianali a conduzio-ne prettamente familiare sono quelle che uti-lizzano meno le ICT. Infatti, sia la natura dellavoro (basato su un’elevata qualità della ma-nualità, specialmente rilevato nel distretto diValenza) sia il numero esiguo di clienti locali eil basso volume produttivo non richiedono disviluppare processi di automazione.
Le piccole imprese artigianali aconduzione prettamentefamiliare sono quelle che
utilizzano meno le ICT
Un approccio, anche se timido, alle nuovetecnologie ICT, come strumento di migliora-mento delle performance produttive, anche
Fig. 1 Domanda potenziale di competenze ICT nei distretti e nel resto del Piemonte
Fonte: elaborazione IRES su dati Censimento Industria e servizi Istat 2001
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0Totale distretti Altri comuni del Piemonte
Addetti totali
Competenze ICT
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 123

se non di riorganizzazione interna, emergeper le piccole imprese del distretto che svol-gono il ruolo di partner e terzisti verso im-prese locali in posizioni intermedie nella filie-ra produttiva.
Esigenze diverse si manifestano nelle im-prese che occupano posizioni intermedie del-la filiera, dove gli effetti della globalizzazionehanno condotto le imprese a dotarsi di appli-cativi ICT evoluti, che tuttavia, si scontranotuttora con le inerzie interne ai cambiamentiorganizzativi. In posizione più avanzata nellefasi di adozione si trovano le grandi impresedei distretti, da anni aperte a mercati interna-zionali e con elevati volumi d’affari. Questeimprese hanno attraversato in passato pesanticambiamenti organizzativi (che hanno porta-to in alcuni casi anche all’abbandono di partedel personale) in concomitanza a scelte diadozione di specifiche nuove tecnologie e dinuove dinamiche comunicative e lavorative. Ilpassaggio, spesso difficile, da una fase di inte-grazione a rete a una di ri-orientamento stra-tegico, ha però portato le imprese ad aprirsi anuove produzioni e nuovi mercati, sviluppan-do anche nuovi business in attività comple-mentari o di nicchia vicine alle proprie corecompetencies.
Nelle imprese che occupanoposizioni intermedie della filiera,
gli effetti della globalizzazionehanno condotto a dotarsi di
applicativi ICT evoluti
Un’ultima interessante categoria da citareè rappresentata da un piccolo ma significativogruppo di imprese di piccole e medie dimen-sioni caratterizzate da un forte orientamentotecnologico, nelle quali si sono manifestatetutte le condizioni favorevoli per l’adozione diICT (sensibilizzazione del management versoInvestimenti in ICT, presenza di personale ICT
esperto che prende parte alle decisioni di in-vestimento, vocazione tecnologica del perso-nale) che, unite alla bassa inerzia al cambia-mento incontrata all’interno (legata alla giova-
ne età media del personale, piccole dimensio-ni aziendali, grande flessibilità del manage-ment), hanno permesso di affrontare gli osta-coli del cambiamento e il riposizionamentostrategico, più velocemente che non nellegrandi imprese locali. Tali imprese, inoltre, sitrovano in una situazione di crescita sia delledimensioni sia delle performance (in aumentoa tassi crescenti). Esse rappresentano la mi-gliore risposta alla minaccia della concorren-za internazionale degli ultimi anni.
Le leve che hanno agevolato l’adozione diICT nelle imprese distrettuali, risultano: • la sensibilizzazione del management verso
le nuove tecnologie;• la presenza, all’interno del distretto, di
agenti catalizzatori di investimenti e nuovetecnologie, qui intesi come enti pubblici oprivati, che si fanno carico della promozio-ne tra le imprese del distretto delle tecno-logie ICT. I catalizzatori rilevati possonoessere:
a. grandi imprese che promuovono progettiinterdistrettuali o le soluzioni implementa-te verso altri attori della filiera, anche peresigenze dirette legate a una maggiore effi-cienza delle loro transazioni;
b. software house locali: motivate dalla diffu-sione del loro standard tecnologico perscopi commerciali ma dal quale non pre-scinde un effettivo miglioramento del be-nessere collettivo delle imprese;
c. associazioni distrettuali, che svolgono unruolo di sensibilizzazione del distretto allatecnologia in un’ottica di sviluppo econo-mico-territoriale.
Dalle analisi effettuate, il modello di cata-lizzatore più efficiente, presente nel distrettodi Biella, corrisponde al tipo b, ma ciò nonesclude la presenza di imprese e associazionidi distretto che abbiano avviato in passato ini-ziative rilevanti. La maggiore efficienza ri-scontrata nel ruolo di catalizzatore per le im-prese informatiche locali rispetto alle impresedella filiera di distretto può essere associata al-l’assenza di concorrenza tra le due tipologie diimprese, che, in caso contrario, tenderebbe aostacolare la diffusione di patrimoni tecnico-conoscitivi ritenuti parte del vantaggio com-petitivo dell’impresa.
RICE
RCHE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7124
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 124

Alcune indicazioni utili a formulare policymirate a favorire la diffusione e un utilizzo piùmaturo delle tecnologie ICT all’interno dei di-stretti industriali possono riassumersi in quan-to segue.
L’obiettivo del decisore pubblico dovreb-be essere volto non solo a un potenziamentodella dotazione informatica media, che di persé non è grado di portare alla creazione divantaggi competitivi, ma anche alla diffusioneall’interno del sistema di governance azienda-le di una sensibilità al tema delle nuove tecno-logie che permetta di sfruttarle come leva stra-tegica.
In particolare, appare importante porre at-tenzione alle specifiche esigenze locali, che ca-ratterizzano la filiera produttiva del distretto,mettendo a punto iniziative integrate e di lun-go periodo.
Un secondo aspetto su cui focalizzare l’a-zione di policy è costituito dalle esigenze di for-mazione interna all’impresa. Tale processo diapprendimento ha carattere verticale in quantocoinvolge l’intera gerarchia aziendale (dal topmanagement al personale impiegatizio). Lospostamento di risorse umane tra aziende ap-
RICE
RCHE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 125
partenenti allo stesso distretto rende in qualchemisura tale innalzamento di competenze un be-ne collettivo all’interno del distretto.
Un’ultima categoria èrappresentata da un piccologruppo di imprese di piccole
e medie dimensionicaratterizzate da un forte
orientamento tecnologico, nellequali si sono manifestate tutte
le condizioni favorevoli perl’adozione di ICT
Infine, l’ultimo aspetto sul quale va postal’attenzione è l’incentivazione alla nascita diopportuni catalizzatori dell’innovazione deldistretto, che, al di là della propria forma isti-tuzionale, siano costantemente stimolati a per-seguire una missione di innovatori e di aggre-gatori di intenti nel distretto.
Fig. 2 Distretti in cui la domanda potenziale di competenze ICT è più elevata
Fonte: elaborazione su dati Censimento Industria e Servizi ISTAT 2001
26,00
24,00
22,00
20,00
0
orafo carta stampa legno alimentare tessile-abbigliamento
metalmeccanico
22,4922,97
23,6524,07
24,7925,20
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 125

COMMERCIO NEI CENTRI URBANI
IL CENTRO COMMERCIALE NATURALE E IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO
RICE
RCHE
FEDERICO BOARIO,LUIGI VARBELLA
Le trasformazioni del commercio in Piemonte (un sistemadistributivo completo ed evoluto come esito di un processo diinternazionalizzazione passiva che ha introdotto tutti i nuovi
formati: dall’hard discount alimentare di modello tedesco,all’ipermercato di modello francese, all’outlet
dell’abbigliamento di modello inglese) hanno evidenziato unindebolimento del tessuto commerciale nei centri storici
urbani.La Regione Piemonte è già intervenuta negli anni scorsi per
promuovere e sostenere varie forme di strumenti finalizzati alrilancio dell’attrattività dei centri storici, sia di modeste sia di
maggiori dimensioni, attraverso il potenziamentocommerciale (PQU, Progetti di Qualificazione Urbana dicomuni medio-grandi, capoluoghi di provincia, in area
metropolitana, intermedi, a vocazione turistica o meno; PIR,Progetti Integrati di Rivitalizzazione urbana di comuni
minori, a vocazione turistica o meno, a rischio didesertificazione commerciale).
Più recentemente sono stati utilizzati strumentimaggiormente evoluti: gli OAI, organismi associati d’impresa.L’IRES ha svolto una ricerca per esaminare alcune esperienze
di quest’ultimo tipo attraverso interviste, basate su unquestionario aperto, ad attori o testimoni privilegiati
La qualificazione, o “riqualificazione”, dei centri urbani, in particola-re di quelli di dimensioni medie e piccole, non può prescindere dal-la valorizzazione del commercio locale. Una ricerca EURISKO per IN-
DICOD (un’organizzazione che raccoglie circa 33.000 aziende industriali edistributive operanti nel settore dei beni di largo consumo) ha messo in evi-denza la relazione fra centro urbano e attese dei cittadini: centro urbano si-
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 P . 1 2 6 - 1 2 9
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 126

gnifica in primis “edifici e monumenti storici”ma non basta. Un centro urbano non è tale semanca di locali, bar, caffè, teatri, negozi, cine-ma e librerie e il commercio è pienamenteconsapevole di questa sorta di identità “se-mantica”. Infatti, all’interno del centro urba-no, inteso più come “agglomerato con resi-denti” che non come vero “centro della città”il commercio, in sede fissa e ambulante, rive-ste un carattere di assoluta necessità. Il ruolodel commercio evolve così da “servizio allapopolazione”, come ad esempio le banche ogli uffici pubblici, ad “attore della qualità ur-bana”.
In questo quadro è opportuno precisareche il Centro Commerciale Naturale non deveessere confuso con la via commerciale inquanto gli esercizi associati forniscono servizipiù articolati e strutturati alla clientela. La Re-gione Piemonte ne ha preso atto per cui nelDcr n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 forni-sce la seguente definizione: “Centro commer-ciale naturale: è una sequenza di esercizi com-merciali e di altre attività di servizio che si af-facciano, in prevalenza, su vie o piazze urba-ne, che abbiano sottoscritto con il comune unpreciso programma unitario di attività promo-zionali. Le autorizzazioni commerciali sonoseparate, indipendenti e non discendono daun unico provvedimento generale. Le conces-sioni o autorizzazioni edilizie sono rilasciateseparatamente e autonomamente a ciascunaunità o complesso immobiliare” (Art. 06, par.3, lettera c).
Il Centro Commerciale Naturalenon deve essere confuso con lavia commerciale in quanto gliesercizi associati forniscono
servizi più articolati e strutturatialla clientela
La creazione di un CCN comporta impegnisia da parte degli associati che da parte delleamministrazioni pubbliche che scaturisce dal-la comune convinzione del rilevante ruolo cheesso può giocare in termini di servizio ai resi-
RICE
RCHE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 127
denti e di elemento di rivitalizzazione del di-stretto urbano in cui opera.
Sulla base di queste considerazioni e degliobiettivi che la Regione Piemonte si è data perla riqualificazione dei centri urbani e del relati-vo tessuto commerciale abbiamo esaminatocinque esempi di CCN operativi in Piemonteper verificarne l’efficacia e trarne suggerimentiper le altre organizzazioni esistenti in Regione eper quelle che saranno sviluppate in futuro.
Nel corso della ricerca sono stati intervi-stati i responsabili dei seguenti Centri:• Centro Commerciale Artigianale Naturale
Campidoglio – Torino• Centro Commerciale naturale “Promo-
SanMauro” – San Mauro Torinese (TO)• Centro Commerciale Naturale “Centrum
Pinerolo” – Pinerolo (TO)• Centro Commerciale Naturale “Il Portico-
ne” – Cuneo• Centro Commerciale Naturale “In Fossa-
no” – Fossano (CN)
La griglia analitica per procedere a unavalutazione delle esperienze associative hapreso in considerazione: i servizi ai clienti;l’offerta commerciale; la storia del Centro; iservizi per i clienti; la carta fedeltà; i rappor-ti con le aree mercatali; i rapporti con le am-ministrazioni e le associazioni dei commer-cianti e le dimensioni e caratteristiche del-l’impegno associativo.
Si è recuperata l’attrattivitàcommerciale del centro storico
Rimandando i lettori interessati al testo in-tegrale della ricerca scaricabile dal sito dell’I-RES, riportiamo qui di seguito le conclusionidell’indagine pubblicate nel “Contributo diricerca” 211/2007.
Il CCN ha catalizzato le attese dei consu-matori evoluti e degli anziani che non erano incondizioni di affrontare lunghi tragitti in autoper raggiungere i centri commerciali della pe-riferia.
Un fenomeno vistoso di crescita urbanache in Piemonte ha trovato esempi eccellenti:
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 127

in particolare il primo CCN “Campidoglio” aTorino a cui sono seguiti molti centri in comu-ni capoluogo di provincia e in città minori.
Si è così recuperata l’attrattività commer-ciale del centro storico, al cittadino è stata of-ferta la possibilità di fare acquisti di qualità nelmassimo confort, in un’area circoscritta e tute-lata, molte volte pedonalizzata, a contatto conla città storica e non più con entità virtuali in-ventate come i grandi centri commerciali dellaperiferia. Sono nati nuovi generatori di traffi-co: manifestazioni, mercatini, bar, ristorazioneveloce, recupero di piccoli musei, recuperodelle agorà cittadine, ritorno del commercioselettivo, ecc., che hanno dato impulso alla di-namica commerciale e creato entusiasmo negliesercenti modernamente orientati. Inoltre,queste iniziative hanno integrato le attività me-no redditizie offrendo anche a loro l’opportu-nità di fruire di un’ampia, nuova, clientela.
I vincoli per le amministrazioni sono so-prattutto nella riorganizzazione delle logisticaurbana e nel rilancio delle aree mercatali, inmancanza dei quali si corre il rischio che ilcommercio di prossimità non riesca da solo asoddisfare le esigenze dei residenti e che quin-di questi ultimi siano costretti comunque a re-carsi frequentemente nei centri commercialidella periferia.
I vincoli per le amministrazionisono soprattutto nella
riorganizzazione delle logisticaurbana e nel rilancio delle aree
mercatali
Il CCN non nasce spontaneamente, ma èfrutto di una associazione di esercenti con pariintenti e marketing condiviso. Ha perciò tuttele necessità strutturali del centro commercialeclassico: la sola differenza sta nel fatto che ilcentro commerciale classico dispone di un ma-nagement e di una direzione operativa che de-vono, sia pure in modo diverso, caratterizzareanche il Centro Commerciale Naturale.
Il ruolo di direzione operativa deve esseresvolto dalla presidenza del Centro Commer-
ciale Naturale o da persona da questa delega-ta e deve agire nel rispetto di progetti e pro-grammi concordati con l’assemblea degli asso-ciati. Ne deriva che la forza del Centro Com-merciale naturale non è nel numero degli eser-centi che vi partecipano ma nella determina-zione della presidenza e nel rispetto delle re-gole da parte di chi vi appartiene.
Il CCN non nascespontaneamente, ma è frutto diuna associazione di esercenticon pari intenti e marketing
condiviso
La presidenza è così responsabile del “pa-trimonio” culturale ed economico degli asso-ciati, dialoga con l’amministrazione locale ediventa il tramite fra questa e i commercianticoinvolti, di fatto deve rispondere delle sue at-tività verso tre distinti “clienti”: il consumato-re residente ed esterno, il commerciante el’amministrazione.La presidenza riceve un pa-trimonio e lo deve gestire e valorizzare neimodi più efficaci, servendosi dei mezzi, per lopiù limitati, a disposizione. E non può tenereconto di tutte le richieste degli esercenti o delpubblico: deve avere capacità decisionali talida consentire interventi anche negativi nei ri-guardi degli associati e delle istituzioni, evi-tando il rischio di coinvolgere il Centro in mo-menti politici ed elettorali, cosa che lo espor-rebbe a considerevoli rischi sia verso i clientiche verso le amministrazioni. Il presidente delCCN diventa così un attore della vita dellacittà, o del quartiere in cui il Centro opera.
Le sue principali qualità sono:• facilità di contatto con interlocutori diver-
si quali i commercianti, le amministrazio-ni, i prestatori di servizi, la clientela, la col-lettività locale;
• capacità di ottenere senza averne il potere;• carisma verso gli associati e le istituzioni;• capacità di “dire no” a chi vorrebbe asso-
ciarsi senza averne le caratteristiche;• una buona capacità di organizzazione e ge-
stione di gruppi;
RICE
RCHE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7128
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 128

• la capacità di ascoltare e mediare le richie-ste altrui.
Queste caratteristiche serviranno per ge-stire il CCN come se si trattasse di un unicumimprenditoriale, ottenere contributi dagli as-sociati e finanziamenti dalle istituzioni, orga-nizzare manifestazioni innovative che attirinoconsumatori anche da aree distanti. Non di-mentichiamo che si tratta di un attore checoncentra il parere e la sensibilità di decine, avolte anche di centinaia, di imprenditori com-merciali locali.
Una missione di primaria importanza checostringe a dedicare all’associazione ore oltreil normale orario di esercizio.
Analogo è l’impegno delle istituzioni loca-li che non possono prescindere dall’esistenzadi una organizzazione di imprenditori associa-ti e cooperativi: nel budget cittadino, ad esem-pio, si devono recepire finanziamenti che con-sentano di organizzare manifestazioni a favoredi un pubblico molto ampio e non solo degliassociati al Centro.
Il rapporto fra istituzioni locali e CCN de-vono avvenire con scadenze predeterminate:
RICE
RCHE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 129
si devono affrontare le problematiche relativealle innovazioni introdotte nella città (a Bor-deaux in occasione dell’introduzione della re-te tranviaria e in previsione dei disagi che i la-vori avrebbero arrecato al commercio locale lamunicipalità ha concordato con gli esercentiinterventi economici e programmazione deilavori).
Ma non basta, dalla ricerca sui centri pie-montesi è emersa la necessità di adeguare i re-golamenti cittadini alla possibilità di realizzareiniziative promozionali sul territorio: in parti-colare a Pinerolo si sono rilevati problemi nel-le manifestazioni cui si potrebbe ovviare conun semplice intervento sul regolamento di ge-stione del suolo pubblico.
Se si considera il CCN sotto il profilo delservizio al cittadino-consumatore, tutti gli in-terventi devono essere funzionali alla sua mi-gliore efficacia che si tradurrà nel tempo in unfattore importante di qualità territoriale. E laqualità territoriale sta sempre più imponendo-si come fattore determinante di qualità urbanain grado di promuoverne la fruizione non soloda parte dei residenti, ma anche da parte diun turismo di qualità.
Apollonio di Giovanni
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 129

MAPPE DI COMUNITÀ:PERCHÉ, QUANDO E COMERI
CERC
HE
MAURIZIO MAGGI,IRES Piemonte
Le “Parish Map” sono nate e si sono diffuse in GranBretagna, come reazione al processo di omologazione dei
luoghi e delle culture locali, dovuto non solo al prevalere diuno stile di vita più aggressivo e acculturante, ma anche allacrisi contemporanea che ha investito molti luoghi e relativi
paesaggi, indebolendone il retroterra sociale.Anche in Italia è stato soprattutto il cedimento del paesaggio
invisibile che ha messo in crisi il carattere e la vivibilità dimolti territori: relazioni sociali, uso consuetudinario dei
luoghi e delle risorse comuni soprattutto territoriali, norme eprassi di convivenza e reciprocità, modalità di comunicazione
inter-generazionali e di trasmissione dei saperi sonolentamente scomparsi per lasciare spazio al territorio
considerato come un semplice supporto logistico sul qualecostruire, produrre, muoversi
In Gran Bretagna le prime riflessioni circa l’opportunità di avviare unarilettura partecipata del paesaggio a partire dalla scala locale, emergonoall’inizio degli anni ottanta promosse da Common Ground, un’orga-
nizzazione non profit fondata da Sue Clifford. Le prime mappe vengonorealizzate a metà del decennio, ma la pratica si diffonde soprattutto nei die-ci anni successivi. Ad oggi le mappe realizzate o in corso di realizzazione so-no tra le 1.000 e le 2.000
L’IRES si è occupato della tematica contribuendo a vari livelli alla diffu-sione delle pratiche concrete di realizzazione e allo studio dei rapporti tral’elaborazione delle mappe di comunità e la teoria e la prassi della pro-grammazione territoriale di area vasta. Un volume, recentemente edito dal-l’istituto, fa il punto sullo stato dell’arte in Italia di questo strumento e for-nisce indicazioni operative per chi volesse accingersi a tale impegno.
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 P . 1 3 0 - 1 3 8
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 130

Oggi in Italia gli esperimenti conclusi dimappe sono circa una decina. Il saggio dell’I-RES pubblica una scheda approfondita di settecasi di cui quattro realizzati in Piemonte. Perogni progetto vengono riassunti le origini e leragioni dell’iniziativa; le caratteristiche delgruppo di lavoro; modalità, tempi e costi;aspettative e ricadute; infine, quali conclusionitrarre dagli insegnamenti del singolo proget-to. Agli studi di caso segue un capitolo dedi-cato a una riflessione complessiva su situazio-ne e prospettive delle mappe e una checklistoperativa. Rimandando al volume che è pub-blicato integralmente sul sito dell’IRES, in que-sta sede appare più utile riassumere le osser-vazioni svolte nel capitolo dedicato alle rica-dute dell’impiego di simili pratiche.
Perché fare una mappa
I primi passi della sperimentazione si sonomossi sulla base di specifiche considerazioni:• importanza di far emergere il “carattere”
peculiare dei territori;• opportunità di dare una impostazione
equilibrata alla questione dell’identità ter-ritoriale;
• necessità e urgenza di attivare processi dicrescita delle leadership locali interessate acreare occasioni di sviluppo a partire dallaricchezza del patrimonio locale.
La conseguenza di queste riflessioni haportato fin dal principio ad affidare alle map-pe partecipate alcuni obiettivi:• caratterizzare i territori;• garantire un percorso equilibrato al tema
delle identità locali;• favorire un processo di appropriazione di
ruolo nel definire il futuro della propriacomunità per facilitare trasformazioni po-sitive dei territori, rurali in primo luogo.
I vantaggi di possedere un “carattere”
La riflessione degli anni più recenti sottolineal’importanza assunta da una identificazione diaree di “carattere”, ossia riconoscibili dalpunto di vista culturale, storico, ambientale e
RICE
RCHE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 131
paesaggistico in senso lato. Si tratta di ele-menti considerati rilevanti per accrescere lacompetitività dei territori e per favorire la coe-sione sociale.
La rivalutazione della cultura locale e deglielementi specifici di un territorio erano anco-ra elementi deboli e poco utilizzati nelle stra-tegie di sviluppo locali a inizio anni novanta.Un decennio più tardi invece, a ridosso deiprimi successi emergenti, si è verificato il fe-nomeno opposto: una eccessiva proliferazionedi iniziative spesso incapaci di mobilitare le ri-sorse del territorio. I processi partecipati dicensimento delle culture locali realizzabili conle mappe di comunità offrono invece l’oppor-tunità di fare emergere le specificità territoria-li e nel contempo di creare le capacità, l’orga-nizzazione sociale e il clima di fiducia recipro-ca necessari per gestirle e questo è stato, findal loro esordio, uno dei punti di forza delmetodo Parish Map.
I processi partecipati dicensimento delle culture locali
realizzabili con le mappe dicomunità offrono l’opportunitàdi fare emergere le specificità
territoriali
L’incoraggiamento a far emergere i trattidistintivi di singoli paesaggi o accentuare lespecificità culturali di parti della società può –se interpretato in senso difensivo – favorire at-teggiamenti di isolamento, a loro volta incom-patibili con il processo di crescita del benes-sere delle comunità, che costituisce l’obiettivoprincipale dei programmi, non solo culturali,che investono sul “locale”. La caratterizzazio-ne dei territori viene così quasi inevitabilmen-te a collidere con la delicata questione dell’i-dentità territoriale.
È necessario mirare a una identità territo-riale inclusiva e partecipata che faccia pernosulla mobilitazione volontaria dei soggetti lo-cali. Solo con la presenza di tali “custodi”(soggetti che si fanno personalmente caricodel riconoscimento e della tutela del patrimo-
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 131

nio) si possono disegnare mappe dinamicheche operano in modo selettivo identificandosoggettivamente gli elementi vitali. In tal mo-do può entrare in gioco la leadership localecome fattore essenziale di successo.
Leadership locale
La presenza di leader locali è un fattore chiaveper il successo di politiche di sviluppo basatesul patrimonio, che presuppongono non solouna profonda comprensione della cultura lo-cale ma anche una conoscenza e una pratica direlazioni non formali con attori istituzionali eimprenditoriali, associazioni e gruppi organiz-zati o cittadini disposti a una mobilitazione in-dividuale.
La presenza di leader locali è unfattore chiave per il successo dipolitiche di sviluppo basate sul
patrimonio
Il loro ruolo è insostituibile nei processi ditrasmissione culturale all’interno di ambiti so-ciali e culturali che si autodefiniscono come“comunità di pratica” e che, seguendo le di-namiche dell’apprendimento cooperativo, uti-lizzano le potenzialità educative dell’interazio-ne tra attori locali, allo scopo di elevare il li-vello complessivo della conoscenza.
In questo contesto le mappe mettono inluce una funzionalità nuova, utile a formareleadership, più attraverso un processo di con-solidamento della rete locale per mezzo dellacondivisione di un punto di vista comune sulpatrimonio culturale del territorio che perquello che producono in termini di conoscen-ze effettive sul territorio stesso. La consape-volezza stessa di determinate carenze registra-ta durante la mappa costituisce un risultatoprezioso in termini di crescita educativa col-lettiva. Si tratta di una prospettiva che chia-ma direttamente in causa il punto più impor-tante: le mappe sono un passo all’interno diuna strategia di trasformazione locale autocentrata.
Dalla memoria al progetto
Tutti i sostenitori delle mappe intese secondol’approccio che si è appena descritto, ossiadella lettura partecipata del paesaggio e delpatrimonio locale come via verso una nuovaappropriazione del territorio da parte dei suoiabitanti, hanno sempre sottolineato come l’a-spetto cruciale risieda soprattutto nelle moda-lità di realizzazione delle mappe, cioè nell’ac-quisizione di competenze e nella creazione dileadership locali. In altre parole il processo (laconoscenza del territorio, la coesione che sicrea fra i partecipanti e nella comunità) è piùimportante del prodotto.
Analogamente si deve forse affermare chenel processo, le dinamiche che seguono la rea-lizzazione di una mappa sono altrettanto senon più importanti di quelle che ne hannoconsentito la nascita. Ne consegue che le map-pe si creano con l’obiettivo di far nascere, met-tere in moto e consolidare forze locali che poidevono trovare un loro ruolo attivo nelle dina-miche di governo del territorio, cercando diindirizzare le inevitabili trasformazioni in mo-do da aumentare il benessere della comunità.
Le mappe si creano conl’obiettivo di far nascere,
mettere in moto e consolidareforze locali che poi devono
trovare un loro ruolo attivo nelledinamiche di governo del
territorio
A tal fine occorre agire su due piani: quel-lo locale e quello sovra-locale. Il primo richie-de un vasto coinvolgimento micro-locale chefaccia partecipi, non necessariamente in mo-do simultaneo ma comunque in un orizzontedi quattro-sei anni, molte comunità di dimen-sioni relativamente piccole. Il secondo richie-de politiche che rendano fra loro coerenti, suun’area necessariamente più vasta, le azionilocali delle diverse comunità
Sul piano locale è dunque di fondamen-tale importanza far emergere una logica di
RICE
RCHE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7132
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 132

trasformazione sostenibile e realistica del ter-ritorio tramite la mappa di comunità. Cometutte le rappresentazioni, anche la mappa do-vrebbe esprimere una tacita valutazione sullostato di cose presenti, sottolineando urgenzee priorità, sia per quanto riguarda la conser-vazione o il recupero di determinati aspetti,materiali o immateriali, del patrimonio loca-le, che per quanto attiene alla loro eventualee desiderata trasformazione. Si tratta di unavalutazione quasi automatica nella sua formaimplicita, ma è bene venga formulata o quan-tomeno conosciuta da chi lavora alla mappaanche in modo esplicito. In questo modosarà più facile considerare e soprattutto uti-lizzare la mappa come un piano di azione enon solo come una fotografia di quel che c’e-ra una volta.
Mappe e pianificazione territoriale
La crescente consapevolezza dell’utilità del-l’approccio tipo “Parish Map” (o comunquedi lettura partecipata del paesaggio e dei suoivalori) si basa principalmente su due conside-razioni, due contributi che, a parere degliesperti, attività di questo tipo, anche a scalalocale, possono fornire alla programmazioneterritoriale su aree vaste.
La prima riguarda la possibilità che azio-ni alla base possano essere efficaci strumentidi ricezione di stimoli ed emergenze specifi-che, risorse considerate disponibili o criticitàesistenti o ancora che possano fare emergereeventuali specificità di cui tener conto, inmodo da facilitare l’applicazione delle proce-dure di tutela in una logica di gestione con-divisa delle regole del Piano paesaggistico. In
RICE
RCHE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 133
altri termini: un ruolo di antenna e sensoresul territorio.
Un secondo aspetto ritenuto utile dai pia-nificatori è quello della formazione di quellaparte del personale pubblico, normalmenteimpreparato a questo tipo di lettura del terri-torio, che deve occuparsi dell’articolazionedei piani regionali alla scala locale. Le iniziati-ve di lettura partecipata del paesaggio posso-no quindi fungere da occasioni di formazione“sul campo”.
L’approccio tipo Parish Map: un ruolo di antenna e sensore
sul territorio
Affinché il raccordo tra area locale e pia-nificazione ufficiale possa sviluppare appienole sue potenzialità è però anche necessario unraccordo con tutti i “piani”, non solo quelliterritoriali e urbanistici. Anche quelli rurali,turistici, dei trasporti, ecc.
Se in qualche ambito locale, a seguito diuna riscoperta dei valori del proprio territo-rio, si decide di dare vita ad azioni che trovinonuove funzioni a determinati elementi paesag-gistici, questo sforzo deve trovare un coerentesostegno in tutti gli ambiti di programmazio-ne, eventualmente attraverso la mediazione diquella territoriale.
Le mappe di comunità potrebbero cosìavere un ulteriore aspetto positivo, oltre a tut-ti quelli ampiamente analizzati in precedenza,diventando una sorta di dichiarazione di inten-ti da parte locale circa finalità, desideri e forzein campo per conservare e modificare i luoghi.
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 133

LA MOBILITÀ IN PIEMONTENEI PRIMI ANNI DEL 2000RI
CERC
HE
SYLVIE OCCELLI,IRES Piemonte
Il lavoro, di cui in queste pagine si offre una sintetica nota,appartiene agli studi sulla mobilità delle persone che, a
partire dal 2004, l’Assessorato Regionale ai Trasporti dellaRegione Piemonte ha avviato nel quadro delle attività di
Osservatorio sulla Mobilità Regionale.Lo studio è diviso in due parti. La prima descrive i
cambiamenti più rilevanti nella regione nello scorso decennio.Essa si sofferma su un confronto delle informazioni relativealla mobilità sistematica, casa-lavoro e casa-studio, rilevate
dagli ultimi censimenti della popolazione.La seconda si sofferma in particolare sulle componenti
relative alla mobilità sistematica (lavoro e studio) e nonsistematica (accompagnamento, acquisti, cura, svago e tempolibero, visita a parenti e amici). Questa parte è basata sulleinformazioni raccolte nell’ambito dell’Indagine individualesulla Mobilità delle Persone (IMP), realizzata nel 2004 da
Regione Piemonte, GTT e IRES. L’IMP è un’indaginecampionaria sulla mobilità sistematica e non sistematica cheregistra anche una serie di valutazioni da parte degli utentisull’uso del trasporto pubblico. L’indagine condotta, che haintervistato circa 47.000 cittadini piemontesi con più di 10anni, è un’estensione di quella che dagli anni ottanta GTT
conduce regolarmente per la provincia di Torino(http://www.comune.torino.it/gtt/download/download.shtml)
Principali aspetti delle dinamiche della mobilità in base ai dati censuari
Alla data dell’ultimo Censimento della Popolazione, la mobilità sistematicain Piemonte è costituita da circa 2 milioni di flussi (spostamenti individua-li giornalieri): meno dell’8% dei flussi censiti per l’intero territorio nazio-
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 P . 1 3 4 - 1 3 9
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 134

nale e il 27% di quelli rilevati nelle aree nor-doccidentali. La mobilità per lavoro, in parti-colare, conta in Piemonte per oltre due terzidei flussi complessivamente generati.
La dinamica della mobilità si caratterizzaper livelli complessivi assoluti relativamentestabili nel tempo anche se manifesta un mode-sto ampliamento del raggio dei flussi. Il tassodi mobilità (rapporto tra flussi in uscita deicomuni e popolazione residente) passa dal19% del 1991 al 22% del 2001. Nel comples-so, a questo riguardo, gli anni novanta vedonoun dinamismo relativamente più marcato (del-la crescita) della mobilità sistematica nelleprovince extra-metropolitane. Nonostante illieve ridimensionamento subito nel periodo1991-2001, i flussi di spostamento della pro-vincia torinese rimangono comunque ancorasignificativamente elevati rappresentando ol-tre il 50% della mobilità piemontese.
RICE
RCHE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 135
La crescita della mobilità sistematica è sta-ta tutta a favore dell’auto. Tra il 1991 e il 2001,gli spostamenti con auto, già prevalenti al1991, aumentano in misura considerevole(+24%), mentre l’uso del mezzo pubblico (sugomma e su ferro), si riduce del 40%. Anchegli spostamenti a piedi subiscono un ridimen-sionamento significativo (-25%). Esso risultarelativamente vistoso nelle province di Biellae del V.C.O. (-33%), più contenuto in quelledi Cuneo e di Asti (-21%).
Al 2001, oltre il 60% dei flussidi mobilità sistematica va in
auto, il 15% va a piedi, l’11%utilizza un mezzo pubblico su
gomma
Tab. 1 Flussi di mobilità in Piemonte nel 2001
NELLO STESSO COMUNE FUORIDI DIMORA ABITUALE DEL COMUNE TORALE % INTRA-COMUNALE
Studio 427,121 194.283 621.404 68,73
Lavoro 743,808 721.145 1.464.953 50,77
Totale 1.170.929 915.428 2.086.357 56,12
Fonte: elaborazione IRES su dati censimento della popolazione al 2001
Fig. 1 Mobilità sistematica in Piemonte pr mezzo di trasporto
Fonte: elaborazione IRES su dati Censimento della popolazione 1991 e 2001
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
01991 2001
Auto
Bus
Ferro
Altro
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 135

In sintesi, al 2001, oltre il 60% dei flussi dimobilità sistematica va in auto, il 15% va apiedi, l’11% utilizza un mezzo pubblico sugomma, l’8% un mezzo diverso e meno del5% fa uso di un mezzo pubblico su ferro. Alconsolidamento del predominio dell’auto e al-la contrazione generalizzata del mezzo collet-tivo, si accompagna una crescita ragguardevo-le (+50%) nell’uso degli altri mezzi, categoriaeterogenea, che include un mix di mezzi pri-vati e pubblici (moto, bici, taxi).
Le dimensioni spaziali dei bacini di pendola-rità casa-lavoroLa crescita dei flussi intercomunali è associa-ta, in generale, a due principali effetti:• un effetto diretto, rappresentato dall’au-
mento delle distanze (complessivamente)percorse;
• un effetto indiretto o secondario, rappre-sentato da un ampliamento (eventuale)dell’area interessata dalla mobilità (il baci-no spaziale).
Nel 2001 in Piemonte la distanza mediapercorsa, 16 km, rimane sostanzialmente inva-riata rispetto al 1991, mentre l’ampiezza me-dia del bacino spaziale della mobilità (30,5km) si riduce lievemente (al 1991 era di 32km). A fronte di tali variazioni che denotanoun sostanziale consolidamento dell’ampiezzacomplessiva dei bacini, la densità media – nu-mero di relazioni intercomunali interessatedalla mobilità – aumenta ulteriormente(+11% nel periodo 1991-2001, rispetto a+38% registrato nel periodo precedente).
In estrema sintesi le altre osservazioni chesi possono trarre dai dati censuari sono:• a) l’aumento della densità delle relazioni
intercomunali che riguarda soprattuttospostamenti di breve/medio raggio, com-presi tra i 15 e i 35 km;
• b) la distanza media percorsa segna alcuniincrementi principalmente per gli sposta-menti il cui tempo di viaggio supera i 45minuti;
• c) i flussi di spostamento generati e attrat-ti dai capoluoghi provinciali percorrononel complesso distanze più lunghe;
• c) a livello provinciale, gli incrementi piùsignificativi si osservano per le province
orientali (V.C.O., Biella, Alessandria, No-vara e Vercelli).
Le centralità dei comuni piemontesiA fronte di una sostanziale invarianza nei livel-li di centralità dei comuni piemontesi (la cen-tralità è il rapporto fra il totale dei flussi en-tranti e il totale di quelli uscenti), a livello su-bregionale si osserva una maggiore uniformitànella sua distribuzione. In altre parole, tra il1991 e il 2001, tutti i comuni regionali guada-gnerebbero un po’ in centralità. Tuttavia, le va-riazioni positive che si registrano parrebberointeressare selettivamente solo alcuni centri.Quelli che hanno saputo avvantaggiarsi dei po-tenziali di accessibilità che si sono consolidatinel corso del tempo, in relazione alla presenzadi assi di comunicazione o di nodi importantidella rete di trasporto o grazie alla vicinanza dipolarità significative nella fornitura di beni e diservizi sono sostanzialmente i principali centridell’armatura urbana della regione, nella coro-na metropolitana più esterna e, in particolare,quelli lungo i principali assi di comunicazioneche hanno il loro attestamento nel capoluogometropolitano.
Al calo di centralità delcapoluogo regionale, si
accompagna un rafforzamento diquella di alcuni comuni dellaprima cintura metropolitana
Alcune tabelle del quaderno tracciano ilquadro dell’evoluzione ripartendo i comuni inbase alla classe dimensionale. Nel primo grup-po, costituito dai comuni più popolosi e conindice di centralità più elevato, si trovano seidei capoluoghi provinciali oltre ad alcuni deinodi dell’armatura urbana del Piemonte. Per icomuni di questo gruppo, pur con alcune ec-cezioni, la variazione dell’indice nel periodointercensuario risulta modesta o addiritturanegativa come nel caso di Torino.
L’ambito metropolitano è certamente unadelle aree nelle quali i cambiamenti sono statipiù significativi. Al calo di centralità del capo-
RICE
RCHE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7136
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 136

luogo regionale, determinato principalmenteda una riduzione, non trascurabile (-10%),dei flussi entranti, si accompagna un rafforza-mento apprezzabile di quello di alcuni comu-ni della prima cintura metropolitana. Le dina-miche rilevate segnalerebbero la formazionedi un core metropolitano, allargato, costituitoda più nuclei. Si sarebbe in presenza, cioè, diprocessi di riorganizzazione, che, diversamen-te dal passato, non dipenderebbero esclusiva-mente da processi espansivi/diffusivi di tipocore-periphery, ma risulterebbero da decisioniinsediative più complesse e articolate. Se taleconfigurazione pare contraddistinguere lamorfologia spaziale di uno stadio maturo dievoluzione metropolitana, essa solleva perònuove domande in termini di organizzazionee di gestione della mobilità.
Le componenti sistemiche della mobilità inPiemonte nell’indagine IMP
A fronte di livelli della mobilità sistematicatendenzialmente stazionari se non decrescen-ti, per quanto caratterizzati da una distribu-zione spazio-temporale dei flussi assai più ar-ticolata che non in passato, i flussi della mobi-lità non sistematica hanno registrato una cre-scita ulteriore (al 2004 supera il 60%) contri-buendo in modo decisivo all’aumento dellamobilità complessiva.
RICE
RCHE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 137
Secondo l’indagine IMP, giornalmente, sieffettuano in Piemonte 9.737.332 spostamentidi cui il 46% circa per il ritorno a casa. Deicirca 5.271.000 spostamenti realizzati, al nettodei ritorni a casa, quelli sistematici, per lavoroe per studio, sono il 34%. Qualora, poi, percoerenza con la natura dell’attività associataallo spostamento, a quelli per lavoro si ag-giungano gli spostamenti per motivi di lavoro,la percentuale della mobilità sistematica nonraggiungerebbe il 40%.
Tra i flussi di mobilità non sistematica, glispostamenti per acquisti costituiscono la quo-ta più significativa, rappresentando ben unquarto degli spostamenti totali, seguiti daquelli per sport e svago, che incidono per il15%. Un’aliquota non disprezzabile è rappre-sentata dagli spostamenti per accompagna-mento, 9%, la quale risulta più elevata diquella relativa agli spostamenti per visita a pa-renti/amici. La larga maggioranza dei flussi(85%) è determinata da un unico motivo dispostamento.
A livello subregionale, la composizionedella mobilità secondo motivi di spostamentorisulta relativamente omogenea, anche seemergono alcuni elementi di differenziazioneche possono essere così sintetizzati:• gli spostamenti per acquisti si rivelano re-
lativamente più importanti per i centri diTorino, Alessandria e Biella; quelli per cu-ra, per Torino, Novara e Cuneo;
Fig. 2 Composizione della mobilità per motivo degli spostamenti nell’IMP (indagine della mobilità dellepersone)
Lavoro 28%
Scopo lavoro 5%
Studio 6%
Acquisti 25%
Accompagnamento 9%
Cura 3%
Sport/svago 15%
Visita parenti 7%
Altro 2%
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 137

• gli spostamenti per studio hanno un’inci-denza maggiore per Novara e Alessandria;quelli per accompagnamento per Vercellie V.C.O.;
• per i centri di Vercelli, Novara e Asti, infi-ne, gli spostamenti per sport/svago sonopercentualmente più numerosi.
La distribuzione della mobilità nell’arco dellagiornataNella fascia mattutina l’80% degli spostamen-ti è costituito da flussi di mobilità sistematica(lavoro, motivi di lavoro e studio). Non ina-spettatamente, la fascia serale vede la preva-lenza degli spostamenti di ritorno. La mobilitànon sistematica si concentra soprattutto nellefasce orarie fuori dei periodi di punta.
Gli spostamenti tra le province risultanomodesti: praticamente per quasi tutte l’aliquo-ta di flussi che ha origine e destinazione all’in-terno del proprio territorio (il cui indice rap-presentativo viene detto indice di auto-conte-nimento) non scende al di sotto del 90%. Ariguardo il volume riporta una matrice e unamappa dei flussi tra le province.
Mobilità e tempi di viaggioTra i molteplici correlati della mobilità chel’IMP permette di investigare, quelli relativi aitempi di viaggio sono sicuramente fra i più in-teressanti, anche perché raramente si ha lapossibilità di disporre di fonti informativeadeguate e sufficientemente estese da permet-tere il calcolo di queste grandezze in modoomogeneo in tutto il territorio regionale.
Qui l’attenzione si è concentrata su un nu-mero limitato di misure dei tempi, riferite allecomponenti della mobilità, alle aree territoria-li e ai mezzi di trasporto.
Mediamente, per un residente piemontese,il tempo necessario per effettuare uno sposta-mento per un qualunque motivo è di 31 mi-nuti, inclusi i rientri a casa. Poiché giornal-mente un residente piemontese compie in me-dia 2,5 spostamenti, allora il tempo complessi-vamente destinato alla mobilità giornaliera sa-rebbe di circa 1 ora e 15 minuti.
Viene fornito un quadro sintetico, ma si-gnificativo dei tempi di spostamento medinelle varie province in base ai motivi. Emergeuna situazione abbastanza variegata, ma la
RICE
RCHE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7138
Fig. 3 Distribuzione degli spostamenti per motivo, per fascia oraria e nell’intera giornata*
* La fascia mattutina va dalle 6.45 alle 8.45; la fascia serale va dalle 17.15 alle 19.15. Il calcolo degli spostamenti è riferitoall’ora di partenza.
200.000
0
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
Altro
Visita
Svag
oCura
Accom
pagnam
ento
Acquist
i
Studio
Moti
vi
di lavo
roLav
oro
Fascia mattutinaFascia seraleResto giornataTotale
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 138

provincia di Torino sembra essere quella cherivela i tempi più elevati, anche se Cuneo eAsti non sono molto dissimili.
Per un residente piemontese, iltempo necessario per effettuare
uno spostamento per unqualunque motivo è di 31 minuti
Infine, un cenno ai tempi per mezzo di tra-sporto. Il tempo medio di spostamento in au-to risulta di circa 21 minuti e quello con mez-
RICE
RCHE
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 139
zo pubblico quasi il doppio, 41 minuti. Glispostamenti a piedi che, peraltro, rappresen-tano una aliquota (23%) non disprezzabiledegli spostamenti totali, superiore comunquea quella con mezzo pubblico, utilizzano me-diamente meno di 15 minuti.
Con riferimento all’auto è interessante farosservare come il tempo di accesso più elevatosi registri nella provincia di Torino, dove, pe-raltro, l’aliquota di spostamenti che utilizzanotale mezzo è relativamente meno elevata diquella osservata nelle altre province e dovel’uso del mezzo pubblico è maggiormenteconsolidato anche per la mobilità non siste-matica.
Giorgio Morandi
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 139

Pietro da Rimini
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 140

CONV
EGNI
, SEM
INAR
I, D
IBAT
TITI
CONVEGNI, SEMINARI, DIBATTITI
Torino7 dicembre
2006 TAVOLA
ROTONDA
Torino13 dicembre
2006PRESENTAZIONE
ICT E SVILUPPO ECONOMICO DEL PIEMONTE. QUALI RELAZIONI?L’ Osservatorio ICT del Piemonte nato nel 2004, è affidato all’IRES Piemonte e vede la par-tecipazione di Regione Piemonte, CSI-Piemonte, CSP, Istituto Superiore Mario Boella ePolitecnico di Torino. Tra le sue funzionalità viene utilizzato dal Programma WI-PIE (giàRUPAR2), che realizzerà entro il 2007 un’infrastruttura a banda larga su tutto il territoriopiemontese.Oggetto prioritario di attenzione dell’Osservatorio sono le innovazioni che possonoessere realizzate tramite le ICT all’interno del sistema piemontese a livello di tessutoeconomico e sociale, relativamente alla sfera individuale e collettiva. Nell’ambito dellesue attività esso organizza annualmente una conferenza per fare il punto sullo sviluppodelle reti e dei servizi telematici in Piemonte. L’edizione di quest’anno è stata introdot-ta da Sergio Crescimanno (Regione Piemonte) e Maria Luigia Gioria (IRES). MarcoCantamessa (Politecnico di Torino) ha svolto la relazione introduttiva riassumendo iprincipali dati su offerta e utilizzo dei servizi ICT in regione. Successivamente, coordi-nata da Roberto Moriondo (Regione Piemonte, WI-PIE), si è svolta la tavola rotondacon la partecipazione di Renzo Rovaris (CSI Piemonte), Giovanni Ferrero (ConsorzioTOP-IX); Pietro Terna (Confindustria Piemonte); Secondo Rolfo (Ceris – CNR);Roberto Strocco (Unioncamere Piemonte) e Filippo Margary (Torino Wireless). I mate-riale integrali del convegno possono essere scaricati dal sito dell’Osservatorio alseguente indirizzo:http://www.sistemapiemonte.it/osservatorioICT/index.php.
TORINO CHE CAMBIA: LA CONFIGURAZIONE SOCIALE DEI DIVERSI AMBITISPAZIALI NELLA CITTÀ
L’IRES ha condotto un complesso di indagini per indagare la struttura sociale del territoriocomunale torinese e, in particolare, per studiare gli squilibri che potevano essere ricono-sciuti riguardo della situazione spaziale di fattori di disagio sociale. L’esigenza conoscitivaderiva dal rapporto tra gli ambiti di intervento del Progetto Periferie e le zone di maggioreintensità del disagio sociale.
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 P . 0 0 0 - 0 0 0
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 141

CONV
EGNI
, SEM
INAR
I, D
IBAT
TITI
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7142
In occasione della presentazione ne hanno discusso: Ilda Curti (Assessore al coordinamen-to delle politiche per l’integrazione del Comune di Torino); Andrea Stara (PresidenteCircoscrizione 2); gli autori della ricerca: Alfredo Mela (Politecnico di Torino) e LucianaConforti (IRES) e Giovanni Magnano (Dirigente del Settore periferie della Comune diTorino).
IL REGIONALISMO ITALIANO IN CERCA DI RIFORMEIl Centro Studi sul Federalismo è stato istituito nel 2000 ed è attualmente composto dallaCompagnia di San Paolo e dalle Università di Milano, Pavia e Torino. L’attività di ricercaverte sui temi storici, filosofici, economici, giuridici, politologici del federalismo. Perdiffondere i risultati delle proprie ricerche organizza convegni e seminari. In tal modo,vuole contribuire al dibattito sulle trasformazioni della società contemporanea verso formedi federalismo sia sovranazionale sia infranazionale. Al convegno sulle riforme possibilidel federalismo italiano hanno partecipato Giorgio Brosio (Università di Torino –Comitato scientifico Centro Studi sul Federalismo e IRES) e Stefano Piperno (IRES) conuna relazione dal titolo “La Regione come livello ‘meso’ di governo: implicazioni per ilfederalismo fiscale”.
FINANZA LOCALE IN ITALIA. RAPPORTO 2006Organizzato dall’ANCI Piemonte, si è svolto dal 19 al 20 marzo il “1° Salone dei Comunidel Piemonte”. Scopo dell’iniziativa è stato sviluppare momenti di dialogo e di confrontotra gli enti locali che consentano di affrontare le problematiche più vicine ai comuni e allepiccole realtà territoriali.Nell’ambito degli eventi organizzati, l’IRES ha presentato la seconda edizione del Rapporto2006 su “La finanza locale in Italia”. Coordinato da Carlo Manacorda (Osservatorio sullaRiforma Amministrativa della Regione Piemonte), si è svolto un dibattito con la parteci-pazione di Sergio Deorsola (Assessore al Federalismo, decentramento e rapporti con entilocali della Regione Piemonte), Alberto Cavaliere (Università degli Studi di Pavia),Renato Cogno (IRES), Federico Feyles (Assessore alle Politiche Finanziarie Economiche edi Bilancio del Comune di Chieri), Marco Moratto (Regione Piemonte), Amalia Neirotti(Presidente ANCI Piemonte e Sindaco del Comune di Rivalta di Torino).
GLI STUDI TERRITORIALI A TORINO E IN PIEMONTEIl 30 e il 31 marzo si è svolto un seminario di studi del gruppo Dupont (Associazionescientifica francese che riunisce i principali geografi economici di lingua francese).L’interesse del gruppo nella riunione di Torino è stato relativo alla conoscenza delle atti-vità di ricerca, in ambito territoriale, dell’IRES e della scuola di geografia economica tori-nese. Il seminario è stato curato da Fiorenzo Ferlaino (IRES) e da Giovanni Rabino(Politecnico di Milano). Sono intervenuti: Paolo Buran su “Gli scenari del Piemonte: sto-ria e prospettive”; Maurizio Maggi “Ecomusei e sviluppo locale”; Sylvie Occelli “I sistemiterritoriali nella società dell’informazione: ICT e modelli conoscitivi”; Enrico Allasino “Leminoranze linguistiche tra Piemonte e Francia”; Marco Bagliani “contabilità ambientale e
Moncalieri9-10 marzo
2007 SEMINARIO
Torino19 marzo 2007 PRESENTAZIONE
Torino30-31 marzo
2007 SEMINARIO
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 142

sostenibilità del territorio”; Paolo Giaccaria (Università di Torino), “Approccio autopoieti-co all’analisi della agglomerazioni produttive. Il caso di Torino”; Fiorenzo Ferlaino “Lacittà come sistema dissipativo”; Paolo Molinari (Università Cattolica) “Federalismo enuova geografia amministrativa regionale”; Egidio Dansero (Università di Torino) “La ter-ritorializzazione dei grandi eventi: un approccio a partire dal caso di Torino 2006”; CarlaLanza Dematteis (Associazione Italiana Insegnanti di Geografia) “L’insegnamento dellaGeografia nelle scuole e la riforma in corso”. La mattinata del 31 marzo è stata dedicata alla visita della “Torino olimpica e post-olimpi-ca” e alla riflessione sulle nuove evenienze in Torino e in Piemonte.
DINAMICHE E PROSPETTIVE DEL TERRITORIO BIELLESE“Per il futuro del Biellese, fatta salva l’esigenza di un salto innovativo trainato dalle suepunte produttive e culturali, soltanto l’attivazione di un motore integrativo finalizzato alladiffusione e al riverbero del cambiamento sull’intero organismo sociale potrà garantireuno sviluppo armonico e durevole”. Questa la riflessione conclusiva del coordinatore dellaricerca sul Biellese Paolo Buran (IRES) che è stata presentata in un convegno organizzatodalla Provincia di Biella e di cui riporteremo una sintesi nel prossimo numero di“Informaires”.Dopo la presentazione di Buran vi è stata una tavola rotonda moderata dal giornalistaFrancesco Antonioli (direttore “Il Sole-24 ore Nord Ovest)” a cui hanno partecipatoRoberto De Battistini dell’Università di Torino, Giuseppe Dematteis, del Politecnico diTorino, Federico Hary vicepresidente dell’Unione Industriale Biellese, Dario Reidell’Università di Torino, Federico Trombini segretario della Cgil di Biella e DavideBazzini assessore della Provincia di Biella.“Cultura, creatività, benessere, oltre a costituire un elemento identitario per la comunità –così il Presidente del consiglio provinciale Azario nelle conclusioni – devono permeare ilsistema industriale, l’artigianato e le produzioni tipiche, valorizzando il loro stretto lega-me con la storia e le qualità delle persone”.
IMMIGRAZIONE IN PIEMONTE. RAPPORTO 2006 Il rapporto 2006 sull’immigrazione in Piemonte viene presentato in altra sezione di questonumero di “Informaires”. I suoi principali contenuti sono stati discussi alla presenza diTeresa Angela Migliasso (Assessore al welfare, lavoro e immigrazione della RegionePiemonte) e di Angelo Pichierri (Presidente IRES). Ne hanno discusso gli autori: EnricoAllasino (IRES), Gianfranco Cattai (CICSENE), Francesco Ciafaloni (Comitato Oltre ilRazzismo), Giuseppe Costa (Università di Torino), Roberto Di Monaco (SRF), FrancoViano (Regione Piemonte).
IL MERCATO E LA QUALITÀ DELLA VITA URBANA: PRESENTE E FUTURO DEI MERCATIOrganizzata dall’Assessorato al commercio del Comune di Asti e dal Conservatoires descuisines méditerraneéennes – Conservatoria del Piemonte, si è svolta la prima edizione di“Asti Mercato d’Europa”. Nell’ambito della manifestazione si è tenuto un convegno sul
CONV
EGNI
, SEM
INAR
I, D
IBAT
TITI
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 143
Biella3 aprile 2007
PRESENTAZIONE
Torino4 aprile 2007
PRESENTAZIONE
Asti13 aprile 2007
CONVEGNO
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 143

CONV
EGNI
, SEM
INAR
I, D
IBAT
TITI
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7144
rapporto fra mercati e qualità della vita nelle città a cui ha partecipato Luigi Varbelladell’IRES con un intervento intitolato “Il contributo del mercato al centro commercialenaturale”. Attese le potenzialità di sviluppo e di rivitalizzazione dei centri storici urbaniche derivano dallo sviluppo degli OAI (Organismi associati d’impresa), nel suo interventoVarbella ha tratteggiato il contributo che possono dare i mercati ambulanti in quanto ele-mento determinante di attrazione per i consumatori. In questo quadro il contributo delricercatore IRES si è concentrato sulle tendenze attuali dei mercati ambulanti e sulle oppor-tunità offerte dalla riqualificazione della loro offerta.
PIÙ ESPERIENZA, PIÙ COMPETENZAALLUNGAMENTO DELLA VITA LAVORATIVA, COMPETITIVITÀ E GESTIONE DELLERISORSE UMANE: VERSO L’INNOVAZIONE
L’età viene a configurarsi nelle società complesse come un fenomeno a più dimensioni, cherichiede di essere analizzato e compreso attraverso più angolature. L’allungamento dellavita, la riduzione delle nascite, il maggior peso delle fasce di età con più di 50 anni, leriforme previdenziali: sono alcuni dei cambiamenti che in Europa stanno trasformando lacultura dell’età rispetto ai percorsi di vita e all’organizzazione stessa del lavoro, prolungan-do la vita attiva. Come rendere possibile un cambiamento così profondo, che rovescia le prospettive rispettoal passato recente, coinvolge campi diversi, pubblici e privati, della vita dei cittadini e del-l’economia?E soprattutto esistono politiche mirate a facilitare la capacità di affrontare una vita attiva eproduttiva degli over 50 di oggi come di quelli di domani?Se ne è discusso in un convegno co-organizzato dall’IRES e dalla Regione Piemonte. Perl’IRES hanno fornito un contributo di riflessione Luciano Abburrà e Elisabetta Donati chehanno illustrato le principali conclusioni di una ricerca recentemente svolta dall’IRES condue relazioni intitolate: “Ageing: il mutamento delle età adulte dagli scenari sociodemo-grafici alle testimonianze dei protagonisti” (L. Abburrà); e “Lavoro e vita familiare, pro-getti e aspettative dei nuovi cinquantenni: una survey su 1.000 piemontesi” (E. Donati).
1° WORKSHOP SULLE FONDAZIONINell’ambito dei seminari di economia pubblica organizzati dalla Facoltà di Economiadell’Università di Torino con la collaborazione dell’IRES, del Coripe e di Hermes (Centrodi Ricerca sul Trasporto Pubblico Locale e sui Servizi Regolamentati) si è tenuto un semi-nario di studio sul ruolo attuale delle Fondazioni in Italia. Ai lavori ha partecipatoStefano Piperno dell’IRES con un contributo intitolato “Fondazioni: sostituibilità o com-plementarietà con l’attività di finanziamento degli enti locali?”. In esso sono stati toccatialcuni tra gli aspetti più significativi e delicati del crescente ruolo e peso delle Fondazione,in specie in Piemonte, nel contribuire alla definizione e allo sviluppo delle politiche pub-bliche.
Torino9 maggio 2007
CONVEGNO
Torino10 maggio 2007
SEMINARIO
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 144

Jacopo di Paolo
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 145

Giulio Cesare Procaccini
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 146

PUBB
LICA
ZIO
NI
PUBBLICAZIONI
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7 P . 1 4 7 - 1 4 8
MAURIZIO MAGGI (A CURA DI)Piemonte Economico Sociale 2006
LUCIANO ABBURRÀ, VALTER CASALE, CARLA NANNI ET AL
Osservatorio Istruzione Piemonte. Rapporto 2006
Osservatorio Culturale del Piemonte 2006
OSSERVATORIO ICT PIEMONTE
Le ICT nella Costruzione della Società dell’Informazionedel Piemonte. Rapporto 2007
ISAE, IRES, IRPET, SRM, IRER
La finanza locale in Italia. Rapporto 2007
Bilancio di Genere della Regione Piemonte 2006
PAOLO BURAN, ANGEL MAZZOCCOLI, FABIO PETTIRINO ET AL.Dinamiche e prospettive del territorio biellese: rapporto
di ricerca novembre 2006
ENRICO ALLASINO, CONSUELO FERRIER, SERGIO SCAMUZZI,TULLIO TELMON
Le lingue del Piemonte“Quaderni di ricerca” n. 113
LUCIANO ABBURRÀ, ELISABETTA DONATI
I nuovi cinquantenni tra occupazione e attività.Transizioni nel corso della vita adulta: comportamenti
individuali e gestioni aziendali“Quaderni di ricerca” n. 114
MARCELLO TADINI
Dotazioni territoriali e performance competitive deisistemi provinciali del Nord-ovest perimetropolitano
“Contributi di ricerca” n. 206
ROSELLA BARBERIS, FLAVIO IANO, RENATO LANZETTI
PMI piemontesi e mercato mondiale: flussi diapprovvigionamento e di fornitura
“Contributi di ricerca” n. 207
VITTORIO FERRERO, RENATO LANZETTI, ALVES MARCHI ET AL.Gli investimenti diretti all’estero delle imprese
piemontesi: tendenze, strategie e risultati“Contributi di ricerca” n. 208
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 147

CRISTINA BARGERO, SYLVIE OCCELLI ET AL.ICT e distretti industriali
“Contributi di ricerca” n. 209
IRES, REGIONE PIEMONTE. DIREZIONE FORMAZIONE
PROFESSIONALE ET AL.Immigrazione in Piemonte. Rapporto 2006
“Contributi di ricerca” n. 210
FEDERICO BOARIO, LUIGI VARBELLA
Commercio nei centri urbani“Contributi di ricerca” n. 211
LUCA DAVICO, LUCA STARICCO
Una nuova figura si affaccia al mercato del lavoro: ilaureati triennali
“Contributi di ricerca” n. 212
ALDO ENRIETTI, RENATO LANZETTI, LUCA SANLORENZO
La componentistica in movimento: le piccole-medieimprese piemontesi negli anni della crisi Fiat
“Contributi di ricerca” n. 213
LUCIANO ABBURRÀ, PAOLA BORRIONE, RENATO COGNO,MARIA CRISTINA MIGLIORE
La qualità dello sviluppo sociale piemontese : uno studiocomparativo attraverso gli indicatori sociali regionali del
sistema Sisreg“Contributi di ricerca” n. 214
VITTORIO FERRERO, SIMONE PELLEGRINO, SANTINO PIAZZA,STEFANO PIPERNO, GILBERTOTURATI
Il modello Ires nell’ambito dei modelli di previsione dellaspesa sanitaria. Analisi dei limiti e proposte di
miglioramento“Contributi di ricerca” n. 215
PUBB
LICA
ZIO
NI
I N F O R M A I R E S , A N N O X V I I I , N . 3 3 , D I C E M B R E 2 0 0 7148
93_152_informaIres_33 13-12-2007 17:07 Pagina 148