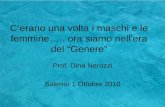di Sebastiano Nerozzi e Giorgio Ricchiuti** 1. Introduzione · Fonte: C. Jona Lasinio e G. Valanti,...
Transcript of di Sebastiano Nerozzi e Giorgio Ricchiuti** 1. Introduzione · Fonte: C. Jona Lasinio e G. Valanti,...
1
Flessibilità, occupazione e produttività: che cosa non ha funzionato?
di Sebastiano Nerozzi* e Giorgio Ricchiuti**
1. Introduzione
Negli ultimi venti anni importanti riforme del mercato del lavoro sono state realizzate
all’insegna della “flessibilità”. Questo fenomeno riguarda non solo il nostro paese, ma tutti i paesi
europei, compresi quelli tradizionalmente più “centralizzati” e “conservatori” dal punto di vista
delle relazioni industriali. Globalizzazione, cambiamento della struttura produttiva delle imprese,
forte tasso di ricambio organizzativo e tecnologico, rapida obsolescenza dei prodotti, sono le
motivazioni normalmente addotte per sostenere la necessità di rendere il lavoro più flessibile1. Il
mondo degli anni sessanta e settanta non esiste più ed occorre oggi, nella società liquida e post-
fordista, migliorare e adattare continuamente l’impiego del fattore lavoro alle mutevoli esigenze
del mercato.
Quando si parla di flessibilità si rischia, tuttavia, di intendere cose diverse: vi è, infatti, una
flessibilità esterna o “numerica” che viene identificata con una maggiore libertà di assumere
(flessibilità in entrata) e di licenziare (flessibilità in uscita); una flessibilità interna o funzionale,
ovvero la libertà di impiegare i lavoratori secondo mansioni e modalità lavorative diverse; una
flessibilità salariale, ovvero la libertà dell’imprenditore di ridurre (aumentare) il salario dei
lavoratori a seguito di shock negativi (positivi) sull’impresa, in termini di costi, prezzi finali, volumi
di affari. Quest’ultimo tipo di flessibilità viene spesso associato ad un assetto maggiormente
“decentralizzato” della contrattazione salariale, nel quale è demandato, in tutto o in parte, a livello
di azienda la contrattazione della struttura salariale.
Generalmente la flessibilità del primo tipo e del terzo tipo vengono chiamate in causa come
fattori essenziali per ridurre la disoccupazione e per spiegare i differenziali che si registrano fra i
tassi di disoccupazione e di occupazione fra diversi sistemi giuridici. Il sistema anglosassone,
connotato da ampia flessibilità in uscita e di contrattazione salariale, viene spesso preso a
Una versione parzialmente riveduta di questo testo è stata pubblicata nel volume di A. Cortesi e G. Paci (a cura di), Alla ricerca del lavoro perduto. Idee sul lavoro che cambia, Firenze, Nerbini 2014. * Università di Palermo.
** Università di Firenze
1 H.P. Blossfeld, S. Buchholz, D. Hofäcker, S. Bertolini, Selective flexibilization and deregulation of the labour market.
The answer of continental and southern Europe, «Stato e Mercato», 96, Dicembre 2012, pp. 363-390.
2
modello, in quanto indurrebbe le imprese non solo ad assumere un maggior volume di lavoratori
ma anche a mitigare l’impatto occupazionale di eventi avversi dell’economia che vengono scaricati
sul costo del lavoro. Secondo molti autori, una maggiore flessibilità (nelle diverse accezioni)
aiuterebbe anche a migliorare l’efficienza del lavoro e dell’economia nel suo complesso. Per citare
alcuni fra i più autorevoli studi internazionali in materia di flessibilità, Stephen Nickell e Richard
Layard, presupponendo omogeneità del lavoro, sottolineano come la flessibilità in uscita possa
favorire la riallocazione della manodopera dai settori a bassa crescita della produttività verso i
settori a più alta crescita2. Altri autori mostrano come i settori più esposti alla competizione estera
e con più alto tasso di innovazione tecnologica hanno per loro stessa natura più bisogno di una
maggiore flessibilità del mercato del lavoro, non necessariamente quella salariale ma piuttosto
quella funzionale e quella in uscita3.
Il tema della flessibilità del lavoro è stato, ed è tutt’oggi, al centro di un acceso dibattito nel
nostro paese. Riforme del mercato del lavoro sono state attuate con l’obiettivo di innalzare
l’occupazione, soprattutto giovanile e aumentare la produttività4. In realtà il rapporto fra
flessibilità, occupazione e produttività appare complesso: non è immediato comprendere quali
siano i nessi di causalità fra questi tre fenomeni e spiegarne la direzione. Scopo di questo saggio è
proprio quello di mettere in luce, sulla base di un’ampia letteratura teorica ed empirica, quali
possono essere state le dinamiche che hanno condizionato la stagnazione della produttività del
nostro paese e, di conseguenza, la bassa crescita del reddito nazionale. Dopo aver analizzato nel
primo paragrafo le dinamiche del mercato del lavoro e della produttività nell’ultimo ventennio,
dedicheremo un secondo paragrafo a evidenziare i principali risultati di recenti analisi
econometriche sul rapporto fra flessibilità, occupazione e produttività. In un terzo paragrafo
vedremo come la teoria economica offra un ricco paniere di possibili modalità con le quali una
maggiore flessibilità può dar luogo ad una minore produttività. Si tratta di un tema che, a nostro
avviso, non può essere compreso concentrandosi esclusivamente sulle dinamiche del mercato del
2 S. Nickell e R. Layard (1999), Labour market institutions and economic performance”, in O. Ashenfelter e D. Card (a
cura di, Handbook of labour economics, vol. 3c.
3 F. Cingano, M. Leonardi, J. Messina, G. Pica (2009), The effect of employment protection legislation and financial
markets imperfections on investments: evidence from firm-level panel of EU countries, «IZA Discussion Papers» 4158, Institute for the Study of Labour (IZA).
4 La produttività del lavoro è definita come il rapporto fra il valore della produzione e il numero di lavoratori o, più
correttamente, le ore medie lavorate. Gli economisti parlano anche della produttività marginale, definita come la quantità prodotta dall’ultimo lavoratore o dall’ultima ora lavorata. Quest’ultima definizione presenta molti problemi, ben esplicitati da Paolo Sylos Labini al quale rinviamo, cfr. P. Sylos Labini, Torniamo ai classici. Produttività del lavoro, progresso tecnico e sviluppo economico, Roma-Bari, Laterza, 2006, pp. 9-12 .
3
lavoro, ma richiede un esame del quadro macroeconomico complessivo. Per questo dedicheremo
il quarto ed ultimo paragrafo a comprendere come questo quadro sia stato condizionato dal più
grande evento economico e politico degli ultimi trent’anni, ovvero l’adozione dell’euro. In
particolare, ci chiediamo quanto il processo di integrazione monetaria abbia spinto il nostro paese
ad adottare riforme del lavoro volte a recuperare competitività5, e quanto allo stesso tempo,
frenando la crescita della domanda estera e della domanda interna, abbia contribuito a ridurre la
produttività delle imprese.
2. Il decennio perduto e le riforme del mercato del lavoro
A partire dagli anni ottanta la mancanza di flessibilità è stata a lungo invocata dagli
economisti come la principale causa dell’alta disoccupazione e della insoddisfacente dinamica
della produttività. E’ a quest’ultimo fenomeno, la stagnazione della produttività del lavoro, che si
attribuisce la responsabilità del “decennio perduto”, ovvero della mancata crescita dell’Italia a
partire dal 2000: essa ha fatto da preludio a una crisi di portata mondiale in cui l’Italia ha lasciato
sul tappeto più reddito di tutti gli altri partner europei, ad eccezione della Grecia .
L’intenso dibattito politico sviluppatosi nel nostro paese in merito all’introduzione di una
maggiore flessibilità , si è concentrato soprattutto sulle fasi di ingresso nel mercato del lavoro.
L’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, anche se riferito solo alle aziende con più di 15
dipendenti, è stato visto come l’ultimo baluardo dei lavoratori nei fatti un tabù collettivo
irriformabile. Le riforme si sono quindi concentrate sull’introduzioni di nuove (a volte fantasiose)
forme contrattuali, che nei fatti hanno ridotto le restrizioni e/o diritti del contratto a tempo
indeterminato nel nome di una maggiore flessibilizzazione del mercato: agli accordi del luglio 1992
e del 1993 che riformavano le modalità di contrattazione e indicizzazione dei salari, sono seguiti il
pacchetto Treu (1997), la riforma dei contratti a tempo determinato (2001), la riforma
dell’apprendistato (2003), il combinato lavoro (2010) e la legge Fornero (2012).
Certamente l’Italia è il paese in cui l’indice di protezione del lavoro (EPL) è sceso più
repentinamente nell’ultimo ventennio. L’introduzione di una maggiore flessibilità in entrata è
5 C. Colesanti Senni e G. Ricchiuti, Sulle strategie di uscita dalla crisi, « Working Paper DISEI », 17, 2013, Università
degli Studi di Firenze.
4
stata presentata come un elemento essenziale per ridurre i forti tassi di disoccupazione giovanile e
far crescere l’efficienza del nostro sistema produttivo.
Fig. 1. Livelli di protezione dell’occupazione (EPL) e altri indicatori istituzionali del mercato del lavoro
Fonte: C. Jona Lasinio e G. Valanti, Reforms, labour market functioning and productivity dynamics: a sectoral analysis of Italy,
«Luiss Lab of European Economics Working Paper Series», n. 93, May 2011, p. 27
La quota dei lavori atipici e a tempo determinato è passata dal 7,3% nel 1995 al 12,3% nel
2005. Oggi sono circa il 12,3%, ai quali devono essere aggiunti il 13% assunti con a tempo parziale.
Il numero degli atipici sta crescendo rapidamente6. Questi contratti però hanno riguardato
essenzialmente la parte anagraficamente più giovane della forza lavoro: nel primo trimestre 2012
fra le nuove assunzioni, il 53% riguardava un lavoro atipico, mentre i contratti a tempo
indeterminato coprivano solo il 31% standard e il 16% standard era destinato a contratti part-
time7.
Molti interpreti attribuiscono alle riforme del mercato del lavoro la discesa dei tassi di
disoccupazione (che passa dal 11,2% nel 1995 al 7,7% nel 2005) e la parallela crescita del tasso di
occupazione (dal 51,8% al 57,5% nello stesso periodo) negli anni precedenti la crisi. Una maggiore
flessibilità in entrata avrebbe, dunque, favorito, a cavallo del nuovo millennio la creazione di posti
di lavoro e l’aumento dell’occupazione. In effetti, rispetto alle sopramenzionate tipologie di
6 Lucidi F., Is there a trade-off between labour flexibility and productivity growth? Some evidence from Italian firms, in
T. Addabbo e G. Solinas (a cura di), Non-Standard employment and quality of work: the case of Italy, Heidelberg: Physica-Verlag 2012, pp. 261-285.
7 Istat, Rapporto annuale 2013. La quota dei lavoratori include anche gli autonomi sia standard che part time.
0 2 4 6 8 10 12 14
EPL (contratti regolari)
EPL (contratti temporanei)
Quota dei contratti temporanei
Indice di centralizzazione della contrattazione
Indice di coordinamento
Ind
icat
ori
isti
tuzi
on
ali d
el m
erca
to d
el la
voro
2001-2007
1993-2000
1987-1992
1980-1986
5
flessibilità, le riforme del lavoro attuate nel nostro paese hanno inciso sulla prima e sulla terza. Gli
accordi del 1992-1993 puntavano a mantenere stabile, in termini di inflazione, il salario
contrattato a livello nazionale e di affidare alla contrattazione generale a livello di azienda, i
guadagni di produttività. Le parti imprenditoriali si impegnarono anche a realizzare investimenti
produttivi che avrebbero dovuto aumentare la produttività del lavoro e dunque consentire un
aumento dei salari in armonia con le esigenze di competitività del paese. I risultati, tuttavia, sono
stati in gran parte deludenti: gli investimenti sono scesi nella seconda metà degli anni novanta, la
produttività è cresciuta pochissimo, il potere d’acquisto dei salari nominali si è eroso per effetto
dell’indicizzazione ancorata all’inflazione programmata, sistematicamente al di sotto di quella
effettiva. Il risultato combinato di queste misure è stata una forte moderazione salariale che ha
visto i salari reali crescere in misura minore alla produttività. L’Italia è stato l’ultimo dei paesi OECD
in quanto a crescita dei salari a partire dal 19928.
Teoricamente la crescita di flessibilità avrebbe dovuto far aumentare le retribuzioni medie,
sia per il suo effetto sulla produttività, sia perché i nuovi lavoratori avrebbero richiesto di essere
compensati della maggiore insicurezza del lavoro con salari più alti (compensating differentials
theory)9. In realtà niente di tutto questo è accaduto. Nel 2012 il salario reale dei lavoratori atipici
risultava mediamente del 25% più basso rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato: a tale
diseguaglianza occorre aggiungere gli effetti cumulativi nel corso del rapporto di lavoro, dato che
per i contratti a termine non sono previsti scatti di anzianità10.
8 A. Brandolini, P. Casadio, P. Cipollone, M. Magnani, A. Rosolia, R. Torrini, Employment growth in Italy in the 1990s:
institutional arrangements and market forces, in N. Acocella e R. Leoni, Social pacts, employment and growth, Heidelberg: Physica-Verlag 2007; L. Tronti, The July protocol and economic growth: the chance missed, in N. Acocella e R. Leoni, op. cit.; M. Zenezini, Il problema salariale in Italia, «Economia e Lavoro», 38, 2004, 2, pp. 147-181.
9 Molte ricerche empiriche mostrano che i lavoratori più flessibili non vengono compensati per la loro maggiore
insicurezza lavorativa, ma ricevano, piuttosto salari considerevolmente più bassi. Si veda la letteratura riportata in F. Lucidi, Is there a trade-off between labour flexibility and productivity?, cit..
10 ISTAT, Rapporto annuale, Giugno 2013, p. 103.
6
Fig. 2. Quota di contratti a tempo determinato (asse di dx) e indeterminato (asse di sx), su totale lavoratori dipendenti
Fonte: Nostre elaborazioni su dati OECD 2012.
Ma soprattutto la maggiore flessibilità della manodopera non si è accompagnata ad una
crescita della produttività. Nel corso dell’ultimo quindicennio si è, anzi, verificata in Italia la
stagnazione della produttività che ha visto l’Italia crescere a ritmi modestissimi, inferiori alla
maggior parte dei paesi OCSE, sia prima che dopo la crisi del 2007-2009 (cfr. fig. 3 e 4).
Fig. 3. - PIL Reale per ora lavorata – Variazione media annua
Fonte: nostre elaborazioni su dati OECD.
84
85
86
87
88
89
90
91
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Lavoro a tempo indeterminato Lavoro a tempo determinato
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
1995-2012
2001-2007
2007-2009
2009-2012
7
Fig. 4. PIL per ora lavorata, dollari, prezzi costanti (PPP 2005)
Fonte: nostre elaborazioni su dati OECD.
Cecilia Jona Lasinio e Giovanni Valanti analizzano l’andamento della produttività dal 1980 al
200811. Il tasso di crescita della produttività è sceso progressivamente, soprattutto dopo il 1994.
Esso è rimasto positivo, ancorché modesto in termini di riallocazione del lavoro da settori a scarsa
crescita della produttività a settori con più forte crescita. Anche all’interno delle singole industrie
la produttività è diminuita negli anni 2000.
La bassa crescita del nostro paese nella prima parte del decennio è stata seguita, con lo
scoppio della crisi finanziaria globale, da una caduta del PIL che dal 2007 al 2013 è stata
complessivamente di oltre 6 punti percentuali e che ha riportato il nostro Pil procapite ai livelli del
1998. Allo stesso tempo la produttività nel periodo 2007-2009 ha avuto una flessione dell’ 1,5%
con una timida crescita negli anni successivi, determinando una forte stagnazione nel periodo
considerato (cfr. fig. 5)12. La disoccupazione è aumentata fino a raggiungere l’11,5% nel Marzo
2013, mentre quella giovanile supera il 37% (cfr. fig. 4). I disoccupati di lunga durata, che cercano
lavoro da oltre 12 mesi, sono circa 653 mila. Per i giovani in cerca di primo impiego la durata
media della ricerca è pari a circa 30 mesi. Ai circa 3 milioni di disoccupati presenti nel nostro paese
11
Fonte: C. Jona Lasinio e G.Valanti, Reforms, labour market functioning and productivity dynamics: a sectoral analysis of Italy, «Luiss Lab of European Economics Working Paper Series», n. 93, May 2011, p. 27
12 Occorre notare che la caduta della ricchezza media degli italiani (-10% di Pil procapite) non abbia colpito tutti allo
stesso modo: essa è stata accompagnata dalla forte crescita delle diseguaglianza nella distribuzione del reddito, dalla crescita della povertà e dell’esclusione sociale nel nostro paese. Rimandiamo nuovamente al Rapporto annuale Istat 2013.
25
30
35
40
45
50
55
60
Francia
Germania
Italia
Regno Unito
Stati Uniti
Area Euro
8
devono essere aggiunti gli oltre 3 milioni di lavoratori “scoraggiati”, che sarebbero disposti ad
accettare un lavoro ma non lo cercano13. Nel complesso circa 6 milioni di lavoratori
potenzialmente impiegabili che restano esclusi dal mercato del lavoro14. Il tasso di occupazione
complessivo è passato dal 59% nel 2008 al 56,8% nel 2012, con una distruzione netta di oltre
600.000 posti di lavoro. Per effetto di questi andamenti il divario fra il tasso di occupazione
dell’Italia e quello medio della UE a 27, già consistente prima del 2008, si è ulteriormente ampliato
raggiungendo circa gli 8 punti percentuali.
Fig. 5. Disoccupazione totale e giovanile (% delle forze di lavoro)
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Eurostat 2013
Di fronte a questo quadro per molti versi drammatico e che non presenta, almeno
nell’immediato, significativi segnali di miglioramento, è lecito chiedersi quale ruolo abbia giocato
la flessibilizzazione del mercato del lavoro, se esso sia stato cioè parte della cura, o, piuttosto
parte del problema.
13
Vengono considerati disoccupati tutti gli individui in età da lavoro che dichiarano di aver ricercato attivamente un lavoro nelle ultime quattro settimane. La stima del tasso di disoccupazione deriva dall’indagine campionaria condotta con interviste individuali da parte dell’ISTAT: fatto 100 il totale della popolazione attiva (che lavora o è in cerca del lavoro), il tasso di disoccupazione permette di stimare il numero totale dei disoccupati. Rimangono esclusi dal calcolo tutti gli individui in età da lavoro che non lavorano o non cercano un lavoro (inattivi): pensionati, casalinghe, studenti, o lavoratori “scoraggiati”, che vorrebbero lavorare, ma non hanno speranza di trovare un lavoro e dunque non lo cercano attivamente. In Italia la percentuale dei lavoratori scoraggiati sulla popolazione inattiva risulta particolarmente elevata e pari a circa 3 volte la media UE.
14 Istat, Rapporto annuale 2013, sintesi, p. 10.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
T1-2
00
7
T2-2
00
7
T3-2
00
7
T4-2
00
7
T1-2
00
8
T2-2
00
8
T3-2
00
8
T4-2
00
8
T1-2
00
9
T2-2
00
9
T3-2
00
9
T4-2
00
9
T1-2
01
0
T2-2
01
0
T3-2
01
0
T4-2
01
0
T1-2
01
1
T2-2
01
1
T3-2
01
1
T4-2
01
1
T1-2
01
2
T2-2
01
2
T3-2
01
2
T4-2
01
2
totale
15-24 anni
9
3. Produttività, occupazione e flessibilità: alcune evidenze empiriche
Recenti analisi econometriche rivelano che mentre gli effetti delle riforme del mercato del
lavoro nel promuovere l’occupazione sono stati assai modesti15 incidendo più sulla composizione
che non sul volume della forza lavoro occupata, gli effetti sulla produttività sono stati, nel
complesso negativi16.
La motivazione addotta da autorevoli economisti come Francesco Daveri appare abbastanza
in linea con il senso comune e le testimonianze che si possono raccogliere da lavoratori e
imprenditori. La flessibilizzazione della manodopera ha indotto gli imprenditori italiani, soprattutto
nelle piccole e medie imprese, ad approfittare delle economie di costo derivanti dal più basso
salario dei lavoratori flessibili, rimandando nel tempo o riducendo gli investimenti volti a realizzare
innovazioni di prodotto e di processo, vero grimaldello per giocare da protagonisti nella fascia alta
della competizione globale. Allo stesso tempo i lavoratori sono stati scoraggiati dall’investire nella
loro formazione (il capitale umano, centrale nelle teorie della crescita più recenti) e ad acquisire
competenze tecniche legate ad un lavoro percepito come precario e destinato, con ogni
probabilità, ad esaurirsi. Secondo Daveri, l’uso distorto dei contratti flessibili sarebbe correlato alla
piccola dimensione delle imprese e alla loro carente struttura manageriale, ancora troppo legata a
forme retrive di “familismo aziendale” che quando non trova nella nuova generazione adeguate
risorse culturali per battere la strada dell’innovazione, si rifiuta di cercarle in figure professionali
esterne all’impresa: le imprese italiane, mediamente piccole, hanno preferito competere sui costi
piuttosto che sull’innovazione, scegliendo manodopera non qualificata piuttosto che ingegneri,
chimici o architetti17. Anche da qui deriva il paradosso dei laureati italiani: contrariamente a molti
luoghi comuni che li vedono come sfaccendati, bamboccioni e schizzinosi i dati del Consorzio
Almalaurea mostrano che i laureati italiani sono pochi (21% della popolazione contro il 42% degli
15
L. Cappellari and M. Leonardi, Riforme del lavoro temporaneo e produttività, in Occupazione e salari in Italia: problemi e prospettive. Studi in Onore di Carlo dell’Arringa, Milano, Vita e Pensiero, 2012; B. Contini e Elisa Grand, Lavoro “usa e getta”, disoccupazione e inoccupazione. Novità importanti dai dati WHIP, «Politica Economica», XXVIII, 2, 2012.
16 F. Daveri e C. Jona Lasinio, Italy’s decline: getting the facts right, «Giornale degli economisti e annali di economia»,
vol. 64(4), pp. 365-410, December 2005; F. Daveri e M. L. Parisi, Temporary workers and seasoned managers as causes of lower productivity, Cesifo Conference, Munich, January 2010; C. Giannetti e M Madia, Work arrangements and firm innovation: is there any relationship?, «Cambridge Journal of Economics» 37, 2013, pp. 273-297; L. Cappellari and M. Leonardi, Riforme del lavoro temporaneo e produttività, in Occupazione e salari in Italia: problemi e prospettive. Studi in Onore di Carlo dell’Arringa, Milano, Vita e Pensiero, 2012.
17 F. Daveri e C. Jona Lasinio, Italy’s decline: getting the facts right, op.cit.. F. Daveri e M.L. Parisi, Temporary workers
and seasoned managers as causes of lower productivity, op. cit.;
10
Stati Uniti), sono disposti a lavorare, ad accettare stage e tirocini fin dagli anni dell’università e,
una volta laureati, a muoversi da una città all’altra18: ciononostante non riescono a trovare lavoro,
e quando lo trovano, spesso non è legato alle loro qualifiche e/o aspirazioni. Non c’è quindi da
stupirsi se le immatricolazioni all’università siano calate del 17% rispetto al 2003. I tagli delle legge
Gelmini agli Atenei, la riduzione delle politiche di sostegno allo studio e gli alti differenziali di costo
degli alloggi fra Nord e Sud del paese, hanno reso l’università italiana una realtà sempre più
elitaria, che non svolge più un ruolo di “ascensore sociale” per le classi meno abbienti, come
ampiamente testimoniato dal rapporto annuale ISTAT 2012.
Alcuni autori fanno notare che in Italia la flessibilizzazione è stata soprattutto
precarizzazione: essa non ha saputo offrire un adeguato percorso di inserimento e non è stata
accompagnata da una parallela riforma degli ammortizzatori sociali in senso universalistico (come
è noto, una delle più gravi pecche del nostro sistema di Welfare); altri sostengono che la riforma è
stata svolta solo in misura modesta, per lo più in entrata, senza toccare il nocciolo duro dei
lavoratori a tempo indeterminato (gli “insiders”) che sarebbero rimasti ipertutelati19, mentre i
giovani (gli “outsiders”) sarebbero costretti a pagare i privilegi dei vecchi. Di fronte agli insuccessi
della flessibilità, in molti rispondono, dunque, che occorre…… più flessibilità!
In realtà, al di là delle limitazioni che possono essere attribuite alle riforme del lavoro attuate
in Italia (e dei miglioramenti che certamente vi si possono apportare soprattutto sul versante degli
ammortizzatori sociali), il legame perverso fra flessibilità e produttività non è un unicum del nostro
paese ma collima con l’esperienza di molti altri paesi20. La flessibilità e la precarizzazione, oltre ad
essere fonte di crescenti diseguaglianze, di alienazione dei lavoratori e di frammentazione sociale,
riducono la produttività del lavoro e hanno effetti quantomeno modesti sull’occupazione21, come
ci ricorda Olivier Blanchard, oggi capo economista del FMI: “le differenze nei regimi di protezione
dell’impiego appaiono largamente incorrelate alle differenze tra i tassi di disoccupazione dei vari
paesi” e Tiziano Treu: “Aspettarsi dalla riforma (del mercato del lavoro) un contributo decisivo per
18
Si vedano Almalaurea, XV rapporto sul profilo dei laureati 2012 (maggio 2013) e il commento di Roberto Ciccarelli, Altro che Choosy, i laureati sono figli di una bolla formativa, www.roars.it/online/?p=24943.
19 Contro questa tesi sembrano andare i risultati dell’indagine condotta da B. Contini e Elisa Grand, Lavoro “usa e
getta”, disoccupazione e inoccupazione. Novità importanti dai dati WHIP, «Politica Economica», XXVIII, 2, 2012.
20 I. Dew-Becker e R. Gordon, The role of labour market changes in the slowdown of European productivity growth,
CEPR Discussion Paper, February 2008.
21 O. Blanchard, “European unemployment: the evolution of facts and ideas”, Economic Policy, CEPR, CES, MSH, vol.
21(45), pp. 5-59; D. Suppa, Appendice Statistica, in E. Brancaccio, Anti-Blanchard. Un approccio comparato allo studio della Macroeconomia, Franco Angeli, Milano 2012, pp. 105-117; T. Boeri e J. Van Ours, Economia dei mercati del lavoro imperfetti, Egea, Milano 2009.
11
la ripresa economica, come si è voluto sostenere, contrasta con tutte le indicazioni provenienti
dall’analisi e dall’esperienza economica”22.
4. Flessibilità, bassi salari e produttività: quali nessi di causalità?
La letteratura economica ci indica almeno quattro canali attraverso i quali una maggiore
flessibilità del lavoro (che determini bassi salari) può indurre un calo della produttività.
Un primo meccanismo è stato messo in luce da David Ricardo e da Karl Marx fin dall’inizio
del XIX secolo: se i salari crescono ad un ritmo che tende ad erodere la quota dei profitti sul valore
della produzione, i capitalisti reagiranno cercando di sostituire i lavoratori con le macchine, ovvero
aumentando il rapporto fra capitale fisico e lavoro; questo processo di sostituzione di uomini con
macchine avrà, da una parte, l’effetto di creare maggiore disoccupazione (aumentando il
cosiddetto “Esercito industriale di riserva”) e, dunque, di riportare i salari verso il basso; dall’altra
di aumentare la produttività del singolo lavoratore occupato (che avrà a sua disposizione più
macchine, verosimilmente più avanzate in termini tecnologici), consentendo all’imprenditore di
tornare ad aumentare i suoi profitti per ogni dato livello del salario. In altre parole gli alti salari
sono un incentivo a sostituire uomini con macchine e a migliorare la tecnologia per aumentare la
produttività del lavoro.
Un secondo meccanismo affonda le sue radici nelle riflessioni di un altro grande protagonista
del pensiero economico moderno, vissuto questa volta nella prima metà del XX secolo: Joseph A.
Schumpeter. Secondo il noto economista austriaco, grande teorico dell’innovazione, il sistema
economico si sviluppa attraverso la sostituzione delle imprese più inefficienti e obsolete con quelle
più efficienti e innovative: solo grazie a questo processo di “distruzione creatrice” la società è
capace di crescere e di svilupparsi in termini non solo quantitativi ma qualitativi, adattandosi
sempre meglio alle mutevoli esigenze del mercato, con guadagni di efficienza, di produttività e di
varietà dei prodotti che vanno a vantaggio della società nel suo complesso. Le idee di Schumpeter
hanno portato molti autori che si collocano nella sua scia a leggere la dinamica dei salari dal punto
di vista degli incentivi che le imprese hanno ad innovare: in un regime di alti salari e di alti costi
del lavoro, le imprese meno efficienti non riescono a “tenere il mercato”, e vanno avanti quelle più
22
O. Blanchard, “European unemployment: the evolution of facts and ideas”, op. cit, pp. 5-59, ivi, p. 20; T. Treu, Flessibilità e tutele nella riforma del lavoro, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona”, 155/2012, p. 7.
12
produttive, così che la produttività media aumenta23. Un regime che favorisce il mantenimento di
bassi salari nel sistema economico, tende, invece, ad avvantaggiare tutte le imprese e, costituisce,
dunque, una sorta di sussidio per le imprese meno efficienti, aiutandole a rimanere sul mercato ed
impedendo un salutare e virtuoso processo di selezione e di innovazione.
Si tratta di un ragionamento che non dovrebbe risultare nuovo nel dibattito italiano: esso,
infatti richiama da vicino uno degli argomenti più in voga negli anni ottanta e novanta per
sostenere l’adesione ad accordi di cambi fissi, come lo SME, e, poi alla moneta unica, ovvero
quello di togliere agli imprenditori la facile via di fuga della “svalutazione competitiva”: legarci ad
un tasso di cambio fisso in termini nominali, avrebbe dovuto infatti privare le imprese meno
efficienti di una facile valvola di sfogo per recuperare competitività, inducendole ad attuare gli
investimenti e le innovazioni necessarie a rilanciare la loro produttività24.
Le misure legislative che tendono a ridurre artificialmente il costo del lavoro (riducendone in
modo più o meno diretto il potere contrattuale dei lavoratori) inducono l’imprenditore ad
adottare un orizzonte di profittabilità a breve termine e relativamente al riparo dal rischio; la
strada dell’investimento e dell’innovazione comporta, invece, costi immediati i cui rendimenti
sono di natura incerta e, in ogni caso, dilazionati nel tempo. Questo filone di letteratura sottolinea
peraltro che, mentre i guadagni di produttività derivanti dall’innovazione e dall’investimento
permettono di raggiungere un aumento dei profitti e dei salari duraturi nel tempo25, il vantaggio
derivante alle imprese dalla “svalutazione interna” del costo del lavoro può rivelarsi di breve
respiro: sia perché una generalizzata riduzione dei salari ha ripercussione sulla domanda di beni e
dunque sulla produzione per addetto, sia perché, come vedremo, il lavoratore potrebbe essere
indotto a ridurre, più o meno intenzionalmente, il suo sforzo lavorativo e di acquisizione di nuove
23
Lucidi F., A. Kleinknecht, Little innovation, many jobs: an econometric analysis of Italian labour productivity, «Cambridge Journal of Economics», (2010) 34 (3), pp. 525-546. A. Kleinknecht, Is labour market flexibility harmful to innovation?, «Cambridge Journal of Economics», 22, 1998, pp. 387-396; A. Kleinknecht, M.N. Oostendorp, M.P. Pradhan, C.W.M. Naastepad, Flexible labour, firm performance and the Dutch job creation miracle, «International Review of Applied Economics», 20(2), 2006: 171-187; C.W.M. Naastepad and A. Kleinknecht, The Dutch productivity slowdown: the culprit at last?, «Structural Change and Economic Dynamics», 15, 2004, pp. 137-163.
24 Non a caso misure volte alla riduzione dei salari e del costo del lavoro vengono spesso denominate “svalutazione
interna”: essa funziona come stimolo alle esportazioni nella misura in cui i minori costi del lavoro si traducono in un abbassamento dei prezzi dei beni finali, o quanto meno, in una minore dinamica dell’inflazione che rende le esportazioni più competitive. Tuttavia, anche in questo caso, il risultato non è automatico e dipende dal verificarsi di molte condizioni e, soprattutto, dal comportamento più o meno opportunistico degli imprenditori che potrebbero decidere di mantenere inalterati i prezzi per lucrare, almeno nel breve periodo, maggiori profitti.
25 P. Ramazzotti, Labour market flexibility and technological innovation or, desperately seeking a trade-off”,
Dipartimento di Istituzioni Economiche e Finanziarie dell’Università di Macerata, «Temi di Discussione», 25, 2005.
13
competenze26. Questi due problemi, costituiscono, in effetti gli altri due canali attraverso cui un
regime di artificiale moderazione dei salari associato ad una maggiore flessibilità può provocare
riduzioni permanenti della capacità produttiva e dunque della crescita di un sistema economico.
La flessibilità del lavoro potrebbe, infatti, indurre una minore produttività del lavoro
attraverso il suo impatto sull’accumulazione di “capitale umano” ovvero della quantità di
conoscenze, competenze e abilità incorporata nei lavoratori. In altre parole, i lavoratori non sono
tutti uguali fra di loro: quelli più scolarizzati, formati e aggiornati sono maggiormente in grado di
gestire operazioni diversificate e complesse, di adattarsi a nuovi processi produttivi, di acquisire
ulteriori conoscenze e competenze che l’impresa richiede per adattarsi all’utilizzo di nuove
tecnologie. A partire dalla metà degli anni ottanta un crescente consenso è emerso fra gli
economisti e fra le istituzioni economiche nazionali e internazionali, circa l’importanza del
“capitale umano” nel determinare i tassi di crescita economica dei paesi. Da qui tutta una serie di
tentativi, soprattutto nei paesi in via di sviluppo ed emergenti, di favorire e migliorare i
programmi pubblici e privati tesi ad assicurare educazione primaria e secondaria, formazione
professionale e training sul posto di lavoro. Ebbene vari studi sottolineano che la flessibilità del
lavoro potrebbe essere un potenziale veleno che induce sia i lavoratori che gli imprenditori a
ridurre i loro sforzi per acquisire e mantenere il capitale umano: se, infatti, il legame fra lavoratore
e azienda è, per sua natura, precario e con un orizzonte temporale molto limitato, gli incentivi alla
formazione (learning by doing) sia da parte del lavoratore che dell’azienda si riducono
drasticamente27.
Infine, un quarto canale, riguarda il clima complessivo dei rapporti di lavoro all’interno
dell’azienda. La flessibilità riduce la cooperazione fra lavoratori e di questi con i datori di lavoro.
Un pessimo clima di fiducia e di collaborazione all’interno dell’impresa, una carenza di
condivisione di competenze e informazioni, aumenta la conflittualità e rende meno efficiente
26
T. Antonucci and M. Pianta, Employment effects of product and process innovation in Europe, «International review of applied economics», 16, 3, 2002, pp. 521-536.
27 Arulampalam and Booth 2008 and Booth et al. 2002. D. Acemoglu and J. Pischke, Beyond Becker: training in
imperfect labour markets, «The Economic Journal», 109, 453, 1999, pp. 112-142; J. Agell, On the benefit from rigid labour markets: norms, market failures and social insurance, «The Economic Journal», 190, 453, 1999, pp. 143-164; M. Bélot, K. Boone e J. Van Ours. Welfare effects of employment protection, CEPR Discussion Paper 3396, 2002; W. Arulampalam e A.L. Booth, Training and labour market flexibility: is there a trade-off?, «British Journal of Industrial Relations», 36, 4, 1998, pp. 521-536.
14
l’organizzazione e la fluidità dei processi di lavoro, deteriorando il capitale sociale aziendale e per
questa via riducendo la produttività del lavoro28.
Tutti i problemi che abbiamo fin qui discussi riguardano fattori di costo o di efficienza, in una
parola, molto cara agli economisti, fattori di “offerta” che limitano la produttività dell’impresa.
Ma, naturalmente, oltre all’offerta il mercato funziona grazie alla domanda. Vi è un complesso
legame che si instaura domanda dei consumatori, estensione della produzione e produttività.
Come vedremo nel prossimo paragrafo la flessibilizzazione della manodopera e la moderazione
salariale, nella misura in cui deprimono la crescita dei redditi da lavoro tendono a restringere il
mercato interno e a ridurre per le imprese l’incentivo ad innovare e investire, con effetti
permanenti sulla capacità produttiva che sacrificano non solo il reddito e l’occupazione attuali, ma
anche quelli futuri.
Fig. 6. Quota Salari Aggiustata (% PIL)
Fonte: Ameco Database 2012, I valori per la Germania prima del 1991 sono quelli della Germania Ovest
28
M. Huselid, The impact of human resource management practices on turnover, productivity and corporate financial performance, «Academy of Management Journal», 38, 1995, pp. 635-670; R. Buchele and J. Christiansen, Labour relations and productivity growth in advanced capitalist economies, «Review of Radical Political Economics», 31, 1999, 1, pp. 87-110; J. Michie and M. Sheehan, Labour market flexibility, human management and corporate performance, «British Journal of Management», 12, 2001, pp. 287-306; C.W.M. Naastepad and S. Storm, The innovating firm in a societal context: productivity, labour relations and real wages, in R. Verburg, Ortt J.R. e W. Dicke (a cura di), Management and technologogy: an introduction, London: Routledge 2005.
40
50
60
70
80
1960 1970 1980 1990 2000 2009
Germania
Francia
Italia
Regno Unito
Stati Uniti
15
5. Quale rapporto fra domanda e produttività?
Per molti economisti teorici la domanda non dovrebbe mai costituire un problema: essa è,
per definizione, sempre capace di assorbire la produzione di un paese, garantendo la piena
occupazione del lavoro e del capitale produttivo. In presenza di un eccesso di merci invendute, di
manodopera e di capitale inutilizzato, la flessibilità dei prezzi e dei salari sarebbe sufficiente a
stimolare il riequilibrio fra domanda e offerta di piena occupazione. Certo, molti economisti
ammettono che una carenza di domanda, nel breve periodo, possa creare disoccupazione e
bloccare il processo di crescita di un paese: essi, tuttavia, imputano la principale responsabilità di
ciò alla rigidità dei salari e dei prezzi che rallentano il ripristino del cosiddetto “equilibrio di lungo
periodo”.
Secondo questa visione, il processo di crescita del PIL e dell’occupazione dipenderebbe, nel
lungo periodo, solo dall’efficienza e dalla capacità produttiva di un paese, mentre la domanda
giocherebbe un ruolo del tutto transitorio, rilevante solo nel breve periodo. Questo schema di
ragionamento nega a priori ogni rapporto di causalità fra crescita della domanda e crescita della
produttività (che sono trattati come due fenomeni distinti e neutrali l’uno rispetto all’altro). In
questo quadro teorico, non stupisce che da parte dei governi dei paesi e delle istituzioni
economiche internazionali si sia insistito molto sulla necessità di aumentare la flessibilità del
lavoro e dei salari per rispondere alla crisi, nonché di tagliare i costi del welfare ponendo del tutto
in secondo piano gli effetti che questi avrebbero avuto sulla domanda e, dunque, sulle prospettive
di mercato per le imprese.
Il complesso legame che si instaura fra estensione del mercato e produttività fu individuato
già dal padre fondatore dell’economia politica, Adam Smith: esso è stato ripreso e formalizzato
matematicamente in questo secolo da Petrus J. Verdoorn (1949), Nicholas Kaldor (1970), Anthony
P. Thirwall e Thomas Dixon (1975)29. Nella letteratura della crescita il legame fra domanda e
produttività è noto come “Legge di Verdoorn”; Paolo Sylos Labini, uno dei più importanti
economisti italiani del XX secolo che ha dedicato pagine fondamentali ai temi della crescita
economica, delle forme di mercato e del progresso tecnico, preferisce parlare di “effetto Smith”30.
29
P. J. Verdoorn, Fattori che regolano lo sviluppo della produttività del lavoro, in «L’Industria», 1949, 1, pp. 45-53; N. Kaldor, The Case for Regional Policies, «Scottish Journal of Political Economy», Vol. 18, 1970 pp. 337-348; R. Dixon e A. P. Thirwall, A model of regional growth-rate differences on Kaldorian lines, «Oxford Economic Papers», vol. 27, n. 2, 1975, pp. 201-214.
30 P. Sylos Labini, The forces of economic growth, Cambridge, MA, MIT University Press, 1984; ID., Progresso tecnico e
sviluppo ciclico, Bari, Laterza, 1993. Occorre ricordare come Sylos Labini ritenesse necessaria, nei primi anni novanta,
16
Secondo questa visione è soprattutto la dimensione del mercato che consente alle imprese di
attuare metodi produttivi più complessi e sofisticati, di realizzare economie di scala o di attuare
innovazioni che derivano dalla domanda di nuovi consumatori (demand-pull innovation),
innescando un circolo virtuoso che innalza la capacità competitiva e la produttività delle imprese31.
Se invece le imprese vedono i loro mercati di sbocco restringersi diventa più difficile e meno
conveniente attuare gli investimenti necessari per aumentare la produttività e l’impresa tende a
“procedere a vista”, accorciando l’orizzonte temporale delle sue scelte e cercando di realizzare
profitti a breve termine, talvolta anche di natura speculativa. La carenza e l’incertezza della
domanda possono, dunque, indurre le imprese ad una drammatica rincorsa della liquidità, del
profitto a breve termine, scoraggiandole dall’attuare investimenti, miglioramenti tecnologici e
organizzativi, e/o assumere personale qualificato, che avrebbero evidenti e duraturi effetti sulla
produttività, l’efficienza e la competitività.
Un’analisi condotta su 24 paesi del Mediterraneo mostra come vi sia, nei paesi a più alto
reddito, una relazione empirica significativa fra dinamiche della domanda e andamento della
produttività32. Considerando le voci della spesa autonoma (spesa pubblica, esportazioni,
importazioni, investimenti) e altre variabili quali la qualità delle istituzioni, gli investimenti diretti
esteri, la percentuale di popolazione urbana, gli autori stimano quanto una variazione di ciascuna
di esse sia correlata con una variazione della produttività dopo un intervallo rispettivamente di 1,
3 e 5 anni. Così, per esempio, un aumento dell’1% delle esportazioni in un anno è associato a un
incremento della produttività dello 0,14% dopo 1 anno, dello 0,15% dopo 3 anni e dello 0,18%
dopo 5 anni. Riportiamo nella figura 7 le principali evidenze per i paesi avanzati (Fig. 7a)33. Mentre
le importazioni giocano un ruolo negativo, simmetrico a quello delle esportazioni, spesa pubblica e
investimenti sono positivamente associati all’andamento della produttività. Da notare come gli
l’introduzione di un certo grado di flessibilità nel mercato del lavoro. Nel complesso egli riteneva, tuttavia, che: “quando i mercati del lavoro sono troppo rigidi essi creano problemi, ma problemi di diversa natura possono sorgere quando la flessibilità è senza limite. Anche qui si pone il problema di raggiungere un livello ottimale”, cfr. P. Sylos Labini, The employment issue: investment, flexibility and the competition of developing countries, «BNL Quarterly Review», 210, 1999, pp. 257-280, ivi, p. 265. 31
E. Brouwer e A. Kleinknecht, Keynes plus? Effective demand and changes in firm-level R&D: an empirical study, «Cambridge Journal of Economics», 23, 1999, pp. 385-391.; J. Schmookler 1966, Invention and economic growth. Cambridge, MA: Harvard University Press.
32 S. Nerozzi, S. Rosignoli, V. Pipitone, Le determinanti della produttività. Fattori di offerta e fattori di domanda, in P.
Malanima (a cura di), Rapporto sulle Economie del Mediterraneo, Bologna, Il Mulino 2014.
33 Si tratta di un modello di regressione per dati panel utilizzando una specificazione sulle differenze prime, terze e
quinte della variabile dipendente e delle esplicative, mentre la componente residuale è stata inserita sotto ipotesi di random effect. Nel grafico sono stati riportati solo i dati che superano i test di significatività.
17
investimenti presentino un impatto molto significativo che cresce al passare del tempo: ciò è
spiegabile con il fatto che gli investimenti agiscono sia come fattore che stimola la domanda
interna di un paese che come fattore di offerta, che migliora la disponibilità di capitale per
lavoratore e, presumibilmente, anche il livello tecnologico dei processi produttivi. La bassa
significatività e importanza degli altri fattori di offerta è comprensibile tenendo conto che l’analisi
di Nerozzi, Rosignoli e Pipitone riguarda la dinamica della produttività all’interno di uno stesso
paese, dove le variazioni di questi fattori sono molto limitate da un anno all’altro. Ciò non toglie
che, come mostrato da un’ampia letteratura, nel confronto fra paesi questi fattori rivestano un
ruolo importante sia per i livelli che per i tassi di crescita della produttività. Passando poi ad
esaminare le economie a più basso reddito l’analisi mostra la perdita di importanza dei fattori di
domanda e il crescente peso di quelli di offerta (in modo particolare dei processi di
urbanizzazione)(Fig. 7b). Il ruolo positivo delle importazioni in questo gruppo di paesi può
collegarsi con il fatto che essi tendono ad importare la maggior parte dei beni capitali e ad alta
intensità tecnologica, con effetti positivi sull’efficienza dei processi produttivi.
Fig. 7a. Determinanti della produttività nel Mediterraneo
(1985-2012): 12 paesi a reddito medio-alto.
Fig. 7b. Determinanti della produttività nel Mediterraneo
(1985-2012): 12 paesi a reddito medio-basso.
Fonte: Nerozzi, Rosignoli, Pipitone 2014.
Per quanto, più specificatamente, riguarda il nostro paese il ruolo della domanda nel frenare
la crescita della produttività non può essere ignorato. Secondo uno studio di Paolo Piacentini e
Stefano Prezioso, che analizza l’andamento della produttività del settore privato nei paesi OCSE
nel periodo 1980-2003, fattori di offerta e fattori di domanda interagiscono fra di loro, provocando
-0,2
-0,15
-0,1
-0,05
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
1 anno 3 anni 5 anni
00,020,040,060,08
0,10,120,140,160,18
1 anno 3 anni 5 anni
18
una progressiva perdita di efficienza del nostro sistema34. Alla base del rallentamento della
produttività vi sarebbe, fin dagli anni ottanta, una difficoltà del nostro paese a mantenere il passo
con gli altri in termini di innovazioni di prodotto e agganciarsi, dunque, alle diverse ondate di
crescita della domanda mondiale nel campo dei nuovi prodotti. In quel decennio la riduzione della
produttività sarebbe stata, tuttavia, contrastata dalla crescita della domanda interna (trainata da
un regime salariale e di spesa pubblica espansivo) e dalle svalutazioni del tasso di cambio. E’ a
partire dai anni novanta che il ruolo della domanda diventa prevalente nel determinare i
differenziali di produttività: il nuovo regime di politica fiscale inaugurato dal Trattato di Maastricht
(e preceduto dalla politica di alti tassi tedesca scelta dalla Germania per finanziare il processo di
riunificazione) provoca un rallentamento della domanda pubblica. Ad essa si associa una
redistribuzione dei redditi promossa dall’accordo fra le parti sociali del luglio 1993 che penalizza i
salari frenando la crescita dei consumi. Questi fattori provocano una riduzione della domanda
proveniente sia dai consumi interni che dai partner commerciali europei, secondo una tendenza
che verrà nettamente rafforzata con l’avvio della moneta unica. Ancor prima dell’avvio del nuovo
millennio la rinuncia al tradizionale strumento del tasso di cambio (che permette di recuperare
competitività in presenza di differenziali di inflazione), la subordinazione ad una politica monetaria
nettamente restrittiva (che frena la creazione di credito e spinge in alto il tasso di cambio euro-
dollaro penalizzando le nostre esportazioni) e la stagnazione dei salari (fermi in termini reali e
declinanti come quota del reddito complessivo, cfr. fig. 7) hanno determinato una ulteriore
riduzione della domanda interna ed estera per le nostre imprese. Questa contrazione della
domanda ha contribuito in modo decisivo alla stagnazione della produttività e dell’occupazione nel
nostro paese35.
La crisi finanziaria globale del 2007-2008, come già quella del 1929, ha le sue radici da un
gigantesco ammanco di domanda, derivante soprattutto, come ci ricordano Jean Paul Fitoussi e
Joseph Stiglitz, da un drastico aumento delle diseguaglianze negli Stati Uniti e nel resto del mondo,
a lungo occultato dal susseguirsi di bolle finanziarie e, nell’ultima fase, dall’indebitamento dei
34
P. Piacentini e S. Prezioso, Differenziali di crescita e di produttività. L’interazione fra fattori di domanda ed offerta nel caso italiano, «Rivista Italiana degli economisti», XII, aprile 2007, pp. 3-41. Un’analisi empirica in linea con questa linea teorica è offerta da F. Lucidi in Is there a trade-off between labour flexibility and productivity growth?, op. cit.. e P. Tridico, Italy: From economic decline to the current crisis, mimeo, 2012.
35 Sul ruolo delle politiche di austerity e degli squilibri nella distribuzione dei redditi nella crisi europea vi è un ampia
letteratura. Si rimanda per brevità alla letteratura citata da Emiliano Brancaccio e Marco Passarella in L’austerità è di destra (Milano, Il saggiatore, 2012), con alcune interessanti proposte soprattutto per quanto l’istituzione di uno “standard retributivo europeo”.
19
consumatori36. Essa si è manifestata come un drastico crollo della domanda dei consumatori che,
grazie alla stretta interconnessione dei mercati internazionali, ha fatto diminuire la produzione
beni e servizi in tutto il mondo.
La risposta dei principali paesi industrializzati sembrava inizialmente andare nella direzione
giusta: nell’aprile del 2009 i paesi del G20 si sono impegnati ad attuare in modo coordinato
massicce manovre espansive sia sul fronte della spesa pubblica che della politica monetaria, in
modo da contrastare la contrazione della domanda globale ed evitare una nuova grande
depressione. In quell’occasione i leader mondiali sembrarono far tesoro della drammatica
esperienza degli anni trenta, durante i quali le politiche di austerity condotte dai singoli paesi unite
alle rigidità di una sistema di relazioni internazionali ancorato rigidamente all’oro (Gold standard),
avevano fatto precipitare la produzione industriale e l’occupazione a livelli eccezionalmente bassi,
gettando le premesse per lo scoppio del secondo conflitto mondiale.
La strategia dei G20 per una espansione coordinata dei redditi e dell’occupazione sancita a
Londra nel 2009 si è mostrata capace di innescare un consistente processo di ripresa già nel 2010
ma ha avuto vita assai breve: la crisi dei debiti sovrani ha portato ad una radicale svolta delle
politiche dei paesi dell’eurozona. Le ricette della Commissione europea, della BCE e del Fondo
monetario, centrate sulla sicurezza dei conti pubblici e sulle riforme di pensioni e mercato del
lavoro hanno avviato quella strategia di “austerity” che ha bloccato, già nel 2011 le prospettive di
ripresa. Nel frattempo la Germania e pochi altri paesi dell’eurozona, che avevano sviluppato sin
dall’inizio del nuovo secolo una politica di moderazione salariale e di compressione della domanda
interna, nonché di una oggettiva capacità di realizzare beni industriali ad alto valore aggiunto,
ottengono surplus commerciali rilevanti (pari a oltre il 6% del PIL nel caso della Germania) ai danni
prevalentemente delle nazioni mediterranee dell’unione: questi ultimi vedevano ridurre la
domanda per le proprie esportazioni, e aggravarsi ulteriormente il peso dei loro debiti a fronte di
un reddito nazionale che non riusciva a crescere. Come già era accaduto negli anni trenta, le
politiche di austerità e di competizione mercantile (questa volta non nell’ambito di un tasso di
cambio fissato in oro, ma, addirittura, di una moneta unica) hanno frenato la crescita di tutti i
36
Su questi aspetti si rimanda alla bibliografia citata in E. Brancaccio e M. Passarella, op. cit., pp. 141-143. In particolare si vedano J.P. Fitoussi and J.E. Stiglitz, The ways out of the crisis and the building of a more cohesive world, The Shadow GN, Chair’s summary, Luiss Guido Carli, Rome, 6-7 Maggio, 2009; J.P. Fitoussi e F. Saraceno, Inequality and Macroeconomic performance, document de travail de l’Ofce, n. 13, 6 luglio 2010. Sugli argomenti economici a favore di una maggiore equità nella distribuzione del reddito e delle opportunità, si veda il testo del premio Nobel Joseph E. Stiglitz, Il prezzo della diseguaglianza. Come la società divisa di oggi minaccia il nostro futuro, Einaudi, Torino 2013 e J. Stiglitz e M. Gallegati, Se l'1% detta legge, «Micromega», 2013, 3.
20
partner commerciali, non solo europei, allontanando in tutto il mondo le prospettive di una
robusta crescita del reddito e dell’occupazione.
Il drammatico crollo della domanda globale ha portato, in effetti, a una riduzione non solo
dell’occupazione ma anche della produttività. Si tratta, tuttavia, per molti economisti, di un mero
effetto statistico destinato a scomparire con la fine della recessione e la ripresa delle vendite e
della produzione. In altre parole, una volta terminata la crisi, i nostri paesi ritorneranno sui loro
sentieri di crescita come se niente fosse accaduto. Abbiamo visto sopra come questa speranza
potrebbe rivelarsi del tutto illusoria.
Conclusioni
Le riforme del mercato del lavoro attuate in Italia hanno deluso in gran parte le aspettative: i
modesti risultati in termini di creazione di posti di lavoro (che si sono concentrati soprattutto nei
settori a più bassa crescita della domanda nazionale e estera) sono stati accompagnati da una
drammatica stagnazione della produttività che ha finito per impoverire i lavoratori e indebolire le
imprese italiane. La mancanza di un sistema di welfare autenticamente universalistico e il
dualismo fra lavoratori a tempo indeterminato e le diverse tipologie di lavoratori atipici, con
regimi di protezione molto diversi, ha alimentato la crescente marginalizzazione di una classe di
donne e uomini (prioritariamente giovani) ai quali viene, di fatto, imposto, indipendentemente
dalle loro qualifiche e capacità, un lavoro precario, malpagato e senza diritti.
Naturalmente la scarsa produttività in Italia non può essere interamente addebitata ai
processi di flessibilizzazione che hanno riguardato il mondo del lavoro. Altre ragioni devono essere
richiamate: la burocrazia inefficiente, la lentezza della giustizia civile, la corruzione, il peso della
“casta”, l’alto costo dell’energia, le infrastrutture carenti, la debole concorrenza che vige ancora in
molti mercati e professioni, la scarsità e il costo del credito aggravati dagli spread e dalle
sofferenze del sistema bancario, nonché la mancanza di una vera politica industriale di respiro
strategico. Tutti questi problemi costituiscono un fardello senza dubbio molto pesante non solo
per la crescita della produttività e dunque del reddito, ma, anche e soprattutto, per la crescita
dell’occupazione.
Vi è tuttavia, in molte analisi una macroscopica assenza: tutti i problemi che abbiamo sopra
citato riguardano, infatti, fattori di costo o di efficienza, in una parola, molto cara agli economisti,
fattori di “offerta”. Ma, naturalmente, oltre all’offerta il mercato funziona grazie alla domanda.
21
Perché un’azienda viva, lavori e cresca non basta che sappia fare bene e a prezzi competitivi beni e
servizi specifici: occorre che vi sia una domanda per quanto produce. Questo principio, che vale
per la singola azienda, vale anche per l’economia di un paese, e, allargando il ragionamento, anche
per l’insieme dei paesi che interagiscono all’interno del mercato unico europeo e del mondo
globalizzato.
Il problema dell’occupazione della produttività in Italia e in Europa dipende non solo e non
tanto dalle riforme che certamente si possono e si devono attuare per rendere più efficiente la
macchina pubblica e il sistema produttivo, quanto, in primo luogo, dalla capacità di superare i
vincoli di natura istituzionale e politica che, in Europa, impediscono l’attuazione di una
lungimirante politica di investimenti pubblici, di promozione dell’innovazione e della ricerca, di
tutela dei diritti sociali e di riduzione delle diseguaglianze.