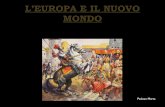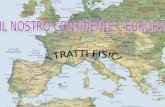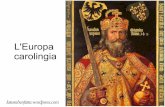De Gaulle e l'Europa
description
Transcript of De Gaulle e l'Europa

Università degli Studi di PalermoFacoltà di Scienze Politiche
Corso di Laurea Specialistica in Studi Europei
De Gaulle e l’Europa
Tesi di laurea di:Nicola Palilla
Relatore:Ch.mo Prof.
Anno Accademico 2007/2008
1

PREMESSA
Per via della gran mole di documenti e testimonianze che sul tema – come per
molti altri – egli stesso ha prodotto, affrontare la visione dell’Europa di Charles De Gaulle
potrebbe sembrare semplice. Si tratta per lo più di dichiarazioni alla stampa, memorie e atti
ufficiali di governo che ci forniscono con immediatezza come il Generale concepisse, in un
mondo diviso in blocchi ideologici e militari contrapposti, il ruolo della Francia ed il modo
in cui l’Europa avrebbe dovuto organizzarsi per essere uno spazio estraneo alla contesa
planetaria e ai pericoli di una guerra atomica; oltre che una regione in cui la potenza
francese potesse rinnovarsi e ritrovarsi. In realtà, l’elaborazione del tema appare complesso
per le medesime ragioni per le quali può apparire semplice, poiché non è sempre agevole
districarsi nella “selva” costituita dall’insieme di tali fonti cognitive, data la complessità
dell’ordito in cui l’ardua trama del Generale fu ricamata. Di De Gaulle non può certo
parlarsi come di un pensatore o del fondatore di una dottrina politica, poiché egli fu sempre
e soltanto un uomo d’azione con un solo, chiaro, solido scopo; uno scopo in funzione del
quale ogni mezzo, per quanto incoerente e contraddittorio rispetto a quelli usati in
precedenza e a quelli che sarebbero stati usati successivamente, sarebbe stato buono se
fosse servito ad assicurarlo: la grandeur della Francia. Inoltre, va considerato che, nel
momento storico in cui fu concepito, il suo ambizioso disegno politico non poteva non
tener conto di quanto fosse indispensabile – per una nazione europea che voleva mantenere
un rango di potenza planetaria – adottare una coraggiosa ed ampia visione strategica nella
quale, inevitabilmente, gli aspetti economici, politici e militari dell’Europa e del Mondo
risultassero concatenati e confusi da non consentirne quasi più la distinzione.
Il problema della conciliazione tra questa aspirazione nazionale e la consapevolezza
dell’ineludibilità dell’unità europea è l’oggetto di questo lavoro. Vi è un filo conduttore
che, attraverso cinque capitoli e delle conclusioni, si è cercato di dipanare durante tutta
2

l’opera, ossia la domanda se può esserci stata in De Gaulle una reale e sincera volontà di
realizzare l’unità europea.
Basandoci sulle feroci critiche con cui apostrofò le Comunità e gli assertori del
metodo funzionalista e considerati gli analoghi rilievi furono mossi allo stesso indirizzo dai
federalisti, potremmo anche cedere alla tentazione di farci l’idea che De Gaulle volesse
lealmente opporre una visione decisamente più romantica dell’Europa a quella “grigia”
che, invece, andava concretizzandosi. Ora, se questo può accadere quando limitiamo la
nostra ricerca ad esplorare l’universo delle sue parole, nel momento in cui ci caliamo nel
contesto della sua prassi politica, non possiamo fare a meno di riscontrare il sostanziale
atteggiamento di indisponibilità del Generale per l’Europa, se questa avesse dovuto
significare il sacrificio della grandezza della Francia.
Convinti che il grado, l’intensità e la qualità della democrazia si riducano
all’aumentare della distanza tra i governati ed i governanti; persuasi che le “forme” della
democrazia nazionale, una volta applicate ad un contesto continentale, diverrebbero pure
“formalità” democratiche, dobbiamo ammettere di essere stati, inizialmente, inclini a
cedere a quella tentazione. Tuttavia, pensiamo, che la ricerca che abbiamo condotto ci
abbia portati a valutare le cose secondo le giuste misure.
Il primo capitolo, che ha anche una veste introduttiva, ha lo scopo di dipingere il
quadro storico in cui l’azione di Charles De Gaulle si collocò e tal fine presenta la
situazione di divisione in cui l’Europa venne a trovarsi alla conclusione della seconda
guerra mondiale. Illustrate le problematiche che da tale condizione scaturirono, la sezione
si concentra sul processo di formazione delle Comunità europee e illustra tanto le tre tesi
che animarono il dibattito sull’unificazione europea nel secondo dopoguerra, quanto le
caratteristiche del progetto gollista di unione politica dei primi anni Sessanta: il Piano
Fouchet.
3

Il secondo capitolo tratta delle concezioni politiche di Charles De Gaulle mettendo
una particolare attenzione sui temi del nazionalismo e della legittimità. Inoltre, mostrando
come anche per De Gaulle l’unità europea fosse inevitabile, torna a parlare del piano
Fouchet e ne traccia un primo bilancio.
Il terzo capitolo espone le argomentazioni che De Gaulle utilizzò per porre in
evidenza gli aspetti critici del processo d’integrazione europea a partire dalla fondazione
del Consiglio d’Europa. Il capitolo non comprende la questione della CED perché abbiamo
ritenuto opportuno, per omogeneità tematica, “spostarla” nel capitolo successivo, il quarto,
riguardante l’importante tema dell’indipendenza dell’Europa dagli Stati Uniti. In
quest’ultimo capitolo trova collocazione anche la questione dell’adesione della Gran
Bretagna al Mercato Comune, da noi considerata “strategica” e pertanto più consona alla
trattazione di quest’ultima partizione che a quella precedente.
Il capitolo “Al vaglio della critica dei federalisti”, il quinto, espone le critiche che al
Generale furono rivolte dai federalisti tanto in riguardo al suo progetto d’unione politica,
quanto alla sua condotta nelle sedi comunitarie e internazionali. Il capitolo, che molto si
basa sui giudizi espressi dai membri del Movimento federalista europeo sulle pagine dei
loro organi di stampa, si conclude ponendo in evidenza la sostanziale giustezza delle tesi
“demolitorie” di De Gaulle a proposito del principio della sopranazionalità e
dell’insufficienza delle Comunità.
Chiudono il lavoro alcune osservazioni che cercano di fare il punto definitivo sulla
visione che Charles De Gaulle ebbe dell’Europa, ponendo in evidenza come, forse, vi sia
stato un conflitto in quest’uomo tra la sua aspirazione a fare davvero dell’Europa un’entità
politica indipendente, e la necessità di non sacrificare mai gli interessi vitali della Francia e
della sua grandeur. La risposta alla domanda che costituisce il filo conduttore della ricerca
è chiara; tuttavia, non ci si è astenuti dall’accennare al fatto che gli ostacoli sulla strada
della definitiva unità europea possono anche trovarsi al di là di Charles De Gaulle.
4

CAPITOLO I
L’EUROPA SI ORGANIZZA
1. L’Europa divisa
Il più grande problema lasciato in eredità dalla guerra all’Europa fu la questione
tedesca. Saltati presto gli accordi presi a Yalta e a Potsdam, in Germania fu ricostituita la
sovranità nella forma della Repubblica federale tedesca, ad occidente (maggio 1949), e
della Repubblica democratica tedesca, ad oriente (ottobre 1949). Nonostante i timori che
evocasse la ricostituzione dello Stato in Germania, quella decisione s’era resa necessaria
per questioni strategiche, potendo una Germania riarmata e ammessa legittimamente nella
cerchia delle democrazie occidentali, prestarsi bene ad avanguardia del fronte atlantico
contro la più temuta avanzata sovietica1. Il maggiore disaggio, però, fu quello provato dalla
Francia, alla quale ricomparvero gli spettri della potenza industriale e militare tedesca.
1 A proposito degli inizi della guerra fredda, P. VIOLA, Storia moderna e contemporanea, Il Novecento, Torino, Einaudi, 2000, pp.255-259: ‹‹Lo scontro più pericoloso avvenne in Germania, dove le tre zone d’occupazione occidentali si andavano progressivamente integrando, mentre quella sovietica stava diventando un paese autonomo e separato. La “cortina di ferro” tagliava in due l’Europa e in particolare la Germania e questa realtà imprevista alterava completamente lo spirito della collaborazione fra gli ex alleati. Tutti in Europa avevano ragione di temere il risorgere del fascismo tedesco, ma le democrazie occidentali oramai temevano molto di più il comunismo sovietico, e una Germania troppo debole avrebbe costituito un pericoloso vuoto al centro del continente europeo. Agli americani sembrava più prudente integrare una Germania democratica in un sistema difensivo occidentale. Anche se la nuova situazione europea spingeva di nuovo gli occidentale a fare della Germania un baluardo contro il comunismo, gli accordi di Yalta e di Potsdam avevano però previsto il disarmo e la deindustrializzazione del paese, oltre che la divisione in quattro diverse entità politiche. Inoltre, l’Unione Sovietica aveva pagato un prezzo talmente alto alla guerra contro il nazismo, che qualunque rafforzamento tedesco le appariva non solo estremamente pericoloso, ma un vero tradimento degli accordi presi. In risposta alla nuova politica degli americani per la Germania, l’URSS decise di scacciare gli ex alleati da Berlino, che costituiva un’isola all’interno della zona d’occupazione sovietica. Nel giugno 1948 l’Armata Rossa chiuse le vie d’accesso tra Berlino e la Germania occidentale[…] Si inaugurò un copione che divenne classico: ciascuna delle due superpotenze sapeva che la guerra mondiale era impraticabile, ma si serviva della minaccia rappresentata dall’avversario per rafforzare il proprio dominio sui paesi alleati[…]Dalla crisi di Berlino in poi, la Germania rapidamente si costituì in due diverse entità statali: una, la Repubblica federale tedesca, occidentale e capitalista con capitale Bonn; e un’altra, la Repubblica democratica, comunista, con capitale a Berlino Est. Nell’aprile del 1949, mentre Berlino era ancora assediata dalle truppe sovietiche, i paesi occidentali costituirono un’alleanza antisovietica: la NATO […] In pochissimi anni si era così realizzato un rivolgimento molto significativo e molto veloce. Per gli Stati Uniti, la Germania da avversaria sconfitta era diventata alleata, mentre l’Unione Sovietica vittoriosa e alleata era diventata invece nemica››
5

Visti gli ultimi precedenti, s’era diffusa l’opinione che in Europa non ci sarebbe stata
alcuna pace durata senza un perpetuo accordo tra Francia e Germania.
Il confine tra i due paesi era un’autentica polveriera: una nuova scintilla, nel
contesto internazionale e con due superpotenze armate di congegni atomici, avrebbe potuto
accendere la miccia della terza guerra mondiale, il conflitto più prossimo all’apocalisse. Se
non l’apocalisse medesima. Per gli Stati e i popoli europei, un tale conflitto sarebbe stato
insostenibile.
Oltre che di una grande civiltà, quella europea è anche la storia di sanguinose
guerre. Per varie ragioni combattute, le guerre europee hanno visto protagoniste tutte le
monarchie, le repubbliche e gli eserciti d’Europa: così – l’affermazione può apparire ovvia
– per quanto la Germania con le sue ambizioni fosse stata la causa dei due più recenti
conflitti, non era in quella terra che doveva trovarsi l’origine del dissidio sul Vecchio
Continente. Tuttavia, la ricostituzione della sovranità in Germania, benché bipartita,
provocava non poche preoccupazioni, soprattutto alla Francia. Dopo il maggio del 1949, il
problema dei rapporti franco-tedeschi divenne di capitale importanza; conseguentemente, il
dibattito sulla necessità dell’unificazione europea, iniziato subito dopo la guerra ma fino a
quel momento sterile di risultati concreti, uscì dalla mera speculazione intellettuale per
divenire oggetto della particolare attenzione del governo francese .
2. L’Europa dal Consiglio d’Europa alle Comunità
Quando fu presa coscienza del fatto che l’unificazione degli Stati europei non fosse
più differibile, solo due governi avrebbero potuto davvero farsi carico di questa storica
impresa: quello inglese e quello francese. Mentre l’Inghilterra, però, per via delle fortunate
vicende belliche aveva grandemente accresciuto il suo prestigio nazionale, la Francia,
benché riconosciuta vincitrice, si trovava in enormi difficoltà. Le situazioni dei due paesi
erano agli antipodi. La prima poteva vantarsi non solo di aver condotto la guerra alla
6

Germania nazista dall’inizio alla fine delle ostilità senza mai tentennare, ma anche di non
aver subito negativi contraccolpi sul suo sistema politico. La seconda, invece, era piombata
nella vergogna della resa e della collaborazione, che il moto rappresentato dalla coraggiosa
azione del generale De Gaulle non aveva in pieno riscattato; oltretutto, all’indomani della
guerra, s’era data l’ennesima e malferma costituzione repubblicana2. Presto risultò
evidente come Londra fosse disinteressata a seri propositi europeistici: così, dopo una
prima fase in cui sembrò volesse dettare le direttrici del prossimo futuro unitario europeo,
fu infine la Francia che diede l’impulso decisivo affinché i paesi del Vecchio Continente
iniziassero a praticare una credibile e fruttuosa integrazione.
Costituito a Londra il 5 maggio 1949 con l’obiettivo di far raggiungere ai propri
membri una maggiore integrazione sulla base di un patrimonio di tradizioni comuni – tra
cui la libertà politica – il Consiglio d’Europa fu la prima organizzazione europea del
secondo dopoguerra; tuttavia, esso fu ben lungi dal soddisfare le aspettative di chi voleva
che si realizzasse una vera unità continentale: l’articolo 1 dello statuto si limitava ad
esprimere in modo generico l’obiettivo di ‹‹una più larga unità tra i suoi membri allo scopo
di salvaguardare e di realizzare gli ideali e i principi di una comune eredità e di facilitare il
progresso economico e sociale››3. Seguendo lo statuto, il Consiglio d’Europa si sarebbe
costituito di due organi: l’Assemblea consultiva ed il Comitato dei ministri. L’Assemblea,
formata da membri designati dai governi, avrebbe avuto l’attribuzione di discutere e
presentare raccomandazioni al Comitato dei ministri, organo costituito dai ministri degli
Esteri dei paesi membri; il Comitato dei ministri avrebbe deliberato all’unanimità dei
votanti e a maggioranza dei suoi membri, dopo che i governi nazionali fossero stati
2 Nel referendum confermativo, la Costituzione della Quarta repubblica veniva approvata con 9.297.000 voti, mentre i contrari furono 8.165.000 e gli astenuti 8.520.000 ‹‹[…] il che farà dire a De Gaulle che la costituzione era stata approvata perché un terzo dei francesi vi si era rassegnato, mentre un altro terzo l’aveva respinta e un terzo l’aveva ignorata››. Citazione in G. MAMMARELLA, Storia d’Europa dal 1945 ad oggi, Roma-Bari, Laterza, 1980, p. 71. 3 ivi., pp.172-173.
7

investiti della questione per il tramite dei loro stessi ministri degli Esteri. Il Consiglio
d’Europa, quindi, si caratterizzava per il fatto di negare recisamente la fusione degli Stati e
dei popoli europei e di favorire fra di essi solo blande forme di cooperazione,
conservandone completamente integra la sovranità e, quindi, la libertà d’azione. Il
Consiglio d’Europa nasceva pertanto ‹‹come un foro di dibattito e un organo di
consultazione sotto lo stretto controllo dei governi ed era ben lontano dal costituire, sia
pure in nuce, il nucleo di un governo europeo››4.
Il cammino verso l’unità europea ebbe inizio con la dichiarazione Schuman del 9
maggio 1950. Ispirata direttamente da Jean Monnet, l’iniziativa del Ministro degli Esteri
francese Robert Schuman proponeva che Francia e Germania, insieme con qualunque altro
Stato avesse voluto parteciparvi, mettessero in comune tutta la loro produzione carbo-
siderurgica per sottoporla all’autorità di un’amministrazione sopranazionale. Visto che,
praticamente, tutta la produzione di carbone e d’acciaio dei due paesi trovava collocazione
lungo quel confine per la presenza, ivi, di enormi giacimenti carboniferi, l’iniziativa di
Schuman si presentava come la migliore soluzione dei contenziosi tra Francia e Germania
ed era salutata con entusiasmo dall’intera Europa occidentale democratica e molto
positivamente dagli Stati Uniti d’America5.
Il successo della proposta Schuman portò, il 18 aprile 1951, alla firma a Parigi del
trattato istitutivo della Comunità europea per il carbone e l’acciaio (CECA) con, oltre alla
4 ibid. 5 In L. LEVI, U. MORELLI, L’unificazione europea. Cinquant’anni di storia,Torino, Celid, 1994, pag. 43 gli autori riportano un passo di Una vita per l’Europa di R. COUDENHOVE-KALERGI in cui il presidente Truman esprime viva condivisione dell’idea di unificare l’Europa:‹‹Un giorno Creel domandò a Truman che cosa pensasse degli Stati Uniti d’Europa “E′ un’ottima idea!” fu la risposta spontanea di Truman […] A metà del 1946 tutta l’America, dalla Casa Bianca al Dipartimento di Stato e dal Congresso fino alla opinione pubblica, era pronta a sostenere l’idea degli Stati Uniti d’Europa, premesso che gli europei stessi desiderassero questa unione. Perché gli americani non volevano imporre a un’Europa recalcitrante il proprio sistema››. Sull’argomento può vedersi anche G. MAMMARELLA, op.cit., pag. 158 dove si riporta che il 22 marzo 1947 il Congresso statunitense approvava la risoluzione del senatore Fulbright in cui si affermava che ‹‹Il Congresso degli Stati Uniti favorisce la creazione degli Stati Uniti d’Europa››
8

Francia e alla Germania occidentale, l’adesione di Italia, Belgio, Paesi Bassi e
Lussemburgo. Il tratto distintivo della CECA fu la sopranazionalità, ossia il fatto che gli
Stati accettavano di riconoscere, limitatamente al settore carbo-siderurgico e al di sopra
della propria, l’autorità di un organismo sopranazionale costituito da un’Alta Autorità, un
Consiglio dei ministri, un’Assemblea e una Corte di giustizia. Mentre l’Assemblea,
formata per cooptazione dei parlamenti nazionali, non aveva che poteri consultivi, il centro
del sistema era l’Alta Autorità, l’esecutivo dell’organizzazione che, seppur costituita da
membri nominati dagli Stati, era da questi ultimi, in buona sostanza, indipendente. Il
Consiglio dei ministri, in cui sedevano i membri dei governi nazionali, svolgeva le
funzioni di organo decisionale.
La CECA fu un esperimento decisamente riuscito: non solo mostrò in Europa che la
pace fosse possibile, ma anche che davvero la prospettiva di addivenire, infine, ad un
governo federale non fosse poi così lontana. A dimostrazione di ciò, il 25 marzo del 1957,
si arrivò alla firma, a Roma, dei trattati istitutivi della Comunità economica europea (CEE)
e della Comunità europea per l’energia atomica (CEEA, più nota come Euratom). Una
particolare attenzione merita il primo dei due trattati. Pur essendo caratterizzata da una
minore sopranazionalità rispetto alle altre, la Comunità economica aveva un maggiore
ambito di competenza, essendo, infatti, deputata all’edificazione di un Mercato Comune
che regolasse, potenzialmente, il complesso degli scambi commerciali tra i paesi membri.
In breve tempo, i suoi organismi, ed in particolare la Commissione (cioè il vertice della
CEE, analogamente all’Alta Autorità per la CECA) forte del carisma e della personalità del
suo presidente – il tedesco Walter Hallstein – presero a considerarsi, seppur ancora in
forma embrionale, il governo dell’Europa unita.
9

Tutto questo, però, fu inviso al generale De Gaulle il quale, nel corso del 1958 e in
conseguenza dei drammatici fatti d’Algeri6, aveva preso il potere a Parigi. Deciso ad
invertire la rotta del processo d’integrazione europea, onde condurlo dal sistema delle
comunità a quello degli Stati legati in un qualche vincolo confederale, durante il lungo
periodo in cui fu alla presidenza della repubblica francese, De Gaulle polemizzò con le
istituzioni di Bruxelles ed in particolare con la Commissione CEE, contestando la
legittimità politica che essa sosteneva d’avere e che gli altri Stati membri, difatti, le
accordavano. Nel quadro di tale politica, agli inizi degli anni Sessanta De Gaulle propose il
cosiddetto “Piano Fouchet”.
3. Il problema della sicurezza: nascita della NATO e fallimento della CED
Oltre che organizzandosi sul fronte economico, per garantirsi la pace ed il
progresso in un clima di fiducia e di ottimismo, l’Europa doveva curarsi della propria
sicurezza contro il pericolo sovietico. La fine della guerra, oltre che in macerie e in una
profonda crisi morale, consegnò alla storia un’Europa politicamente ed ideologicamente
divisa in due, con la parte occidentale legata agli Stati Uniti d’America, all’economia di
mercato e alla democrazia parlamentare, e con quella orientale, al contrario, sotto il giogo
del totalitarismo sovietico. Benché originariamente, facendo affidamento anche sulla
propria superiorità tecnologica, gli Stati Uniti pensassero di poter controllare l’espansione
6 Dopo aver guidato le organizzazioni “France libre” e “France combattante” durante la guerra, De Gaulle era stato riconosciuto dagli alleati quale legittimo capo del governo francese, malgrado che fino al giugno del 1943 quello del regime di Vichy, agli occhi tanto degli americani quanto dei sovietici, apparisse come il solo governo francese ufficiale. Fu soprattutto Churchill a volere che a De Gaulle fosse attribuita tale dignità. Lasciato il governo in polemica con i partiti politici nel gennaio del 1946, De Gaulle continuò ad essere coinvolto nella vita pubblica ispirando la nascita del Rassemblement du peuples français (RPF) ma rifiutando di assumervi incarichi. Tornò al potere nel giugno del 1958, richiamato per fronteggiare la degenerazione del conflitto con la popolazione araba dell’Algeria, ormai considerata alla stregua di un comune dipartimento benché fuori dal territorio metropolitano. Nel 1956, quella che era iniziata come una rivolta due anni prima, aveva preso le sembianze di una vera e propria guerriglia alla quale i governi francesi non sapevano porre rimedio. Quando nel ’58 De Gaulle fu richiamato al potere, pare che la Francia fosse minacciata da un colpo di Stato che aveva la sua mente proprio in Algeria. Chiamato a fronteggiare questo pericolo, De Gaulle condizionò la sua investitura alla redazione di una nuova costituzione repubblicana con chiari tratti di presidenzialismo. Sulla vita di De Gaulle e gli episodi di Algeri sono consultabili: D. COOK, De Gaulle, Milano, Dall’Oglio, 1987; C. WILLIAMS, De Gaulle, Milano, Mondadori, 1997; R. BRIZZI, M. MARCHI, Charles de Gaulle, Bologna, Il Mulino, 2008
1

sovietica grazie al fatto d’aver delineato l’ordine mondiale post-bellico con l’accordo
dell’attuale avversario, presto l’Unione Sovietica palesò di poter rappresentare una
pericolosa minaccia per l’intero continente europeo. Ne seguì che gli Stati Uniti dovettero
assumersi il gravoso compito di tutelare la sicurezza dell’Europa occidentale. Il 1949 fu,
così, importante per un altro fondamentale evento: la costituzione dell’Alleanza Atlantica
e, con esso, della NATO7. Scopo dell’Alleanza Atlantica era di rafforzare la stabilità e la
crescita del benessere e della libertà dei paesi membri per mezzo di un sistema di sicurezza
collettiva. In altre parole, l’organizzazione era stata creata per garantire l’Europa
occidentale contro la minaccia di un’eventuale aggressione sovietica. L’adesione alla
NATO implicava, per effetto del principio dell’integrazione che ne costituiva la colonna
vertebrale, la rinuncia da parte dei suoi membri di consistenti prerogative in materia di
difesa, dato il carattere preminente che nell’organizzazione assumevano i vertici militari
statunitensi. Fu proprio nel quadro della riorganizzazione della difesa europea che gli Stati
Uniti avevano preso a giudicare indispensabile che la Germania, nella sua parte
occidentale, fosse ricostituita e riarmata. Non deve, quindi, passare inosservato che la
creazione della NATO, la costituzione del Consiglio d’Europa e la fondazione della
Repubblica federale tedesca sono stati eventi accaduti nel giro di due mesi. Così come non
può passare inosservato il fatto che l’iniziativa inglese di costituire il Consiglio d’Europa,
quindi la sua stessa iniziale vocazione europeistica, è stata connessa alle scelte strategiche
americane. A proposito della fondazione del Consiglio d’Europa può, dunque, dirsi che
l’iniziativa inglese facesse parte di un più ampio disegno strategico di fattura americana. In
altre parole, la mossa del governo di Londra, che – come si dimostrò presto – non era
affatto appassionata al dibattito europeo, fu volta a favorire una “certa sistemazione” del
Vecchio Continente. La Gran Bretagna si disponeva a far ciò sulla base di un sistema di
7 Ne fecero parte: Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Stati Uniti d’America. La Grecia e la Turchia furono ammesse nell’alleanza nel 1952, la Repubblica Federale Tedesca nel 1955. Fonte: Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati
1

“relazioni speciali” con gli Stati Uniti che stava cominciando, allora, a delinearsi e che non
pochi problemi comporterà ad entrambi quando De Gaulle tornò al potere.
Proprio la specialità di detti rapporti saranno, tra le altre, la causa del fallimento
europeo di darsi una propria difesa. Proposta all’indomani della proclamazione della
Repubblica federale, la Comunità europea di difesa (CED) si prefiggeva di mettere in
comune la difesa dei Sei – ma s’intendeva estenderla anche alla Gran Bretagna – mediante
la costituzione di un esercito europeo. In verità, scopo del piano non era tanto
l’organizzazione della difesa dei Sei, bensì consentire alla Francia, che lo propose, di
controllare il riarmo della Germania ed impedirle l’adesione alla NATO. L’ingresso della
Germania nell’Alleanza Atlantica era particolarmente osteggiata dalla Francia per il timore
che gli Stati Uniti avrebbero finito per apprezzare la Germania come un alleato ben più
importante, essendo la sua posizione geografica maggiormente strategica nel contrasto
all’Unione Sovietica8. Poiché il Piano Pleven (il progetto che sta a monte della CED e che
prende il nome dal presidente del Consiglio francese che lo propose) ‹‹prevedeva la
costituzione di un esercito europeo composto da sei divisioni, con uno stato maggiore
internazionale agli ordini del comandante in capo delle forze atlantiche, il tutto posto sotto
il controllo di un ministro della Difesa europeo e di un’autorità politica da nominare
contestualmente››9, la Comunità di difesa implicava la reiterazione della formula
sopranazionale già definita per la CECA; e siccome ‹‹l’esercito è il fondamento stesso
della sovranità; una politica militare non ha senso, se non in servizio di una determinata
politica estera, l’una e l’altra sottoposte a controllo parlamentare e decise da organi
democraticamente legittimi››10, naturale corollario dell’esercito comune non poteva che
8 Sulle finalità della politica estera francese si vedano G..MAMMARELLA, op.cit., p.181; B.OLIVI, L’Europa difficile. Storia politica dell’integrazione europea 1948-1998, Bologna, Il Mulino, 1998, pp.41-45 e G. MAMMARELLA, P. CACACE, Storia e politica dell’Unione Europea, Roma-Bari, Laterza, 1999, pp.56-659 G. MAMMARELLA – P. CACACE, op.cit., p.6110 M. ALBERTINI, A. CHITI BATELLI, G. PETRILLI, Storia del federalismo europeo, Torino, 1973 , p.243
1

essere l’istituzione di un’autorità politica europea. Quest’ultima implicazione, nonché il
rifiuto inglese di aderirvi, provocarono il fallimento del progetto della nuova Comunità11.
4. De Gaulle, l’Inghilterra, gli Stati Uniti
Una volta tornato al potere, contestando che la Francia, benché anch’essa vincitrice
e, cosa più importante, grande potenza per storia e tradizione non fosse considerata dagli
Stati Uniti un alleato alla pari, De Gaulle si concentrò sulla costruzione dell’unità
dell’Europa per creare un contrappeso, sì, al colosso americano in seno al mondo
occidentale, ma anche un credibile mezzo con cui la Francia avrebbe potuto recuperare una
certa libertà d’azione e condurre la sua politica di grandeur. Secondo lui, l’Europa, seppur
alleata degli Stati Uniti, doveva essere in grado di determinare la propria politica e la
propria posizione nel sistema delle relazioni internazionali da sé stessa, nonché cercare di
massimizzare la sua posizione strategica al centro delle due superpotenze col fare da ago
della bilancia degli equilibri planetari; quest’Europa, infine, avrebbe dovuto comprendere
anche i paesi comunisti dell’Est. Il tutto, secondo la formula da lui stesso prospettata di
un’Europa “europea”.
Per tale scopo raggiungere, la prima cosa da fare sarebbe stata attribuire, non già ad
una potenza “straniera” la difesa del continente, ma ad una nazione europea. Chiaro che
questa nazione non poteva essere che la Francia. A cagione di ciò, De Gaulle volle a tutti
costi che il suo paese disponesse di un proprio arsenale nucleare – la cosiddetta force de
frappe – del quale poter disporre indipendentemente dagli Stati Uniti (nel 1966 la Francia
uscirà dall’organizzazione militare della NATO).
11 Alla base del diniego del parlamento francese di ratificare il trattato CED vi fu il diffuso timore che la costituzione di un esercito comune avrebbe inevitabilmente impedito alla Francia, impegnata in guerre coloniali, di difendere il proprio impero. Il fallimento della CED portò gli inglesi a promuovere la ben più vaga Unione europea occidentale (UEO) nel 1955. Sull’argomento può consultarsi E. GUCCIONE, Il fallimento della CED e l’idea di federalizzazione in Carl Joachim Friedrich, Torino, Giappichelli, 2007. Si veda anche B.OLIVI, op. cit., p.45
1

Una circostanza che palesò grandemente il suo netto di rifiuto a che la leadership
francese sul Vecchio Continente potesse essere contestata, fu quella in cui De Gaulle pose
clamorosamente il veto all’ingresso britannico nel Mercato Comune. La vicenda è piuttosto
complessa, poiché mostra come per De Gaulle non ci fosse soluzione di continuità tra la
politica europea e quella internazionale. In questo senso, possiamo affermare che De
Gaulle non ebbe mai una politica europeistica, neppure quando sostenne il piano Fouchet,
ma solo una politica europea quale sottobranca di quella internazionale.
Convinta di potere ancora giocare un ruolo internazionale di primaria importanza,
alla fine della guerra la Gran Bretagna guardò con diffidenza al processo d’integrazione
economica che stava avendo corso nell’Europa occidentale. Presto ridimensionata nei suoi
propositi di mantenere uno status da grande potenza tanto politico-militare quanto
economica, la Gran Bretagna cominciò a volgere il suo sguardo al Vecchio Continente,
proponendo, in luogo di un’unione doganale e di istituzioni sopranazionali, una blanda area
di libero scambio, la quale, non trovando fortuna presso i Sei, si concretizzò in seguito con
la costituzione dell’EFTA12. L’insuccesso dell’iniziativa – che, in definitiva, mirava a
mettere pressione sui membri della CEE affinché accettassero di scendere a compromessi
con lei soprattutto in riguardo ai vantaggi che le provenivano dal Commonwealth, ma che
alla fine non riuscì nel suo scopo – spinse subito la Gran Bretagna a chiedere l’adesione
alla CEE. Adesione che, infine, fu respinta per merito della Francia, oltre che per ragioni
economiche – la Francia temeva che si scardinasse la politica agricola comune –
soprattutto per questioni politiche.
Dietro la richiesta d’adesione britannica alla CEE, infatti, De Gaulle vedeva il
tentativo di controllare la poderosa ripresa economica europea ad opera degli Stati Uniti,
la cui bilancia dei pagamenti, per diretta conseguenza della ripresa europea, era oramai
pericolosamente inclinata negativamente. Proprio i problemi di bilancio americani avevano 12 European Free Trade Association nel luglio 1959 con Svezia, Svizzera, Norvegia, Danimarca, Austria, Portogallo.
1

condotto all’abbandono della strategia della “rappresaglia massiccia”, fondata in primo
luogo sulle forme convenzionali di guerra e solo secondariamente sull’impiego dell’arma
atomica, a favore della “risposta flessibile” che, invece, si basava sull’immediata risposta
atomica contro eventuali atti d’aggressione sovietica. Se negli anni Sessanta fu interesse
degli americani richiamare le proprie truppe in patria, tale interesse chiamava
necessariamente a nuove responsabilità i partners europei degli Stati Uniti. Fu sulla base di
queste considerazioni, quindi, che il presidente Kennedy propose, col discorso del 4 luglio
1962, di ristabilire su base più egualitaria i rapporti tra gli Stati Uniti e l’Europa mediante
due strumenti: la formula della “inter-indipendenza” – che mirava a creare una grande
comunità atlantica (per dirla con le parole di De Gaulle) fondata sul libero scambio; il
progetto della “Forza multilaterale” – con la quale, per esempio, anche la Germania di
Adenauer avrebbe avuto armi atomiche (da usarsi, però, sempre e solo per decisione
americana).
Le parole del presidente americano, che in quel discorso si augurò che presto la
Gran Bretagna aderisse alla Mercato Comune, unitamente al fatto che nel dicembre
successivo Londra acquistasse missili atomici Polaris proprio dagli Stati Uniti,
dimostrarono a De Gaulle che fra i due paesi vi era chiaramente un accordo strategico di
fondo che spingeva definitivamente la Francia ai margini delle decisioni strategiche
mondiali. Stando così le cose, De Gaulle non ebbe esitazioni a denunciare il tutto
pubblicamente e, inevitabilmente, ad annunciare il veto della Francia alla domanda
inglese13.
13 La proposta americana, nota come “Gran Design”, destò una forte impressione in Europa. De Gaulle comprese subito che con la sua iniziativa, specie in materia commerciale, Kennedy stava appoggiando la candidatura della Gran Bretagna nella CEE. Un passaggio importante del discorso del 4 luglio 1962 fu quello in cui si esortava l’Europa “ad organizzarsi e a prendere le proprie decisioni”, alludendo, appunto, all’ingresso britannico nella CEE e alla possibilità che, avvenuto ciò, i rapporti tra le due sponde dell’Atlantico si sarebbero fatti più intensi. De Gaulle comprese le intenzioni americane e si fece certo dell’esistenza di un accordo tra Usa e Gran Bretagna per emarginare la Francia e per porre l’economia e la politica europea sotto il controllo anglosassone. Per approfondimenti, si veda G. MAMMARELLA, P. CACACE, op. cit., pp.116-117
1

5. Le tre vie dell’unità europea
Pur avendo radici lontane nel tempo, un dibattito serio sull’unità europea si ebbe
solo alla fine della seconda guerra mondiale, alla fine della quale gli Stati del Vecchio
Continente si ritrovarono non solo materialmente e moralmente distrutti, ma anche in grave
pericolo per l’emergere della potenza sovietica. Tale dibattito fu alimentato,
sostanzialmente, da tre diverse tesi.
Il pensiero federalista non propagandava un mero principio di organizzazione del
potere, ma si presentava come una vera e propria teoria politica rivoluzionaria. Per i suoi
più convinti sostenitori, il federalismo costituiva un’istanza di rinnovamento dei popoli e
delle loro relazioni sulla base del pacifismo e della loro comune volontà di darsi una nuova
identità e di perseguire, oltre che quello materiale, il progresso sociale14. Tutto questo
perché, a loro giudizio, lo Stato nazionale aveva esaurito la sua funzione e ragione storica
per divenire un perfido strumento di oppressione e di guerra. L’idea federalista, quindi,
aveva come obbiettivo la creazione di una federazione europea, ossia il superamento dello
Stato nazionale tramite l’istituzione di organi legislativi, esecutivi e giudiziari europei con
competenze in materia di politica estera, di difesa, di moneta, di imposizione e riscossione
dei tributi. Pur essendo sostenuto da una considerevole spinta popolare15, il federalismo, la
più risolutiva tra le idee in questione, aveva il suo punto debole della completa estraneità
all’establishment degli Stati. Tra i maggiori sostenitori di questa tesi vi fu Altiero Spinelli.
14 A proposito del carattere del federalismo ci sembra utile riportare quanto segue: ‹‹Un'Europa libera e unita è premessa necessaria del potenziamento della civiltà moderna, di cui l'era totalitaria rappresenta un arresto. La fine di questa era sarà riprendere immediatamente in pieno il processo storico contro la disuguaglianza ed i privilegi sociali. Tutte le vecchie istituzioni conservatrici che ne impedivano l'attuazione, saranno crollanti o crollate, e questa loro crisi dovrà essere sfruttata con coraggio e decisione. La rivoluzione europea, per rispondere alle nostre esigenze, dovrà essere socialista, cioè dovrà proporsi l'emancipazione delle classi lavoratrici e la creazione per esse di condizioni più umane di vita››. A. SPINELLI., E.COLORNI, E. ROSSI, Manifesto di Ventotene, 1941, in: www.freeweb.supereva.com 15 I sostenitori del federalismo, che si organizzarono sia a livello nazionale (in Italia nel Movimento federalista europeo) che a livello europeo nella Unione Europea dei Federalisti, chiesero che l’unità europea si compisse mediante una procedura democratica, cioè, l’elezione di un’assemblea costituente al suffragio universale. Si veda al riguardo S.PISTONE, L’integrazione europea. Uno schizzo storico, Torino, UTET, 1999, pp.11-16
1

La tesi funzionalista, a differenza del federalismo, non fu – ci permettiamo di dirlo
in riferimento al federalismo – un’ideologia, bensì più propriamente un metodo. Muovendo
dalla consapevolezza di quanto fosse difficile, malgrado tutto, unire Stati con diversi e
contrastanti connotati e pur prefigurando in un orizzonte più lontano la nascita di un
governo federale, i suoi sostenitori si accontentavano, pur di cominciare ad unire l’Europa
ed i suoi popoli, di procedere per integrazioni settoriali nella convinzione che la
conseguente rimozione dei conflitti tra i diversi interessi nazionali, soprattutto economici,
avrebbe portato all’istituzione di un governo federale. La forza di questa tesi, che
contrariamente a quella federalista non era sostenuta da alcun movimento popolare, era nel
fatto che si conciliava bene con l’interesse degli Stati di perpetuarsi il più a lungo possibile,
non implicando, infatti, repentine e complete cessioni di sovranità, ma solo quanto sarebbe
bastato ad assicurare efficacia alle amministrazioni sopranazionali, nella sostanza
indipendenti dagli Stati, che si sarebbero dovute occupare del governo del settore da
integrare16. Jean Monnet fu, tra i maggiori sostenitori di questa tesi, colui che riuscì più
degli altri a lasciare la sua impronta nella storia.
La tesi confederale, infine, sostenendo che lo Stato nazionale continuasse ad essere
la migliore incarnazione dei popoli, delle loro identità e della loro vocazione, proponeva
che l’unità europea si facesse col rispetto delle nazionalità e degli Stati, così che le
istituzioni, che si sarebbero create per agevolare l’adozione di forme strette di
cooperazione, non potessero privare gli Stati delle loro prerogative sovrane. Per i
sostenitori della confederazione, quindi, non poteva avvenire che la sovranità nazionale
fosse interamente ceduta ad un governo federale e nemmeno che essa fosse parzialmente e
16 Sulle prospettive di lungo periodo dell’integrazione settoriale può essere interessante considerare B. OLIVI, op.cit., p.28: ‹‹Per i più convinti ed ottimisti assertori della “sopranazionalità settoriale” il metodo funzionale contiene “in nuce” la soluzione globale asserita dai federalisti: invero è inevitabile che lo sviluppo graduale dell’integrazione in settori o funzioni limitate provochi nel tempo un uguale processo per settori contigui condizionanti le funzioni stesse. Per esempio, le integrazioni settoriali di taluni segmenti della vita economica e sociale imporranno forme d’integrazione politica e con esse fatalmente l’indebolimento e persino lo svuotamento delle sovranità nazionali››
1

progressivamente trasferita a organi tecnici sopranazionali. I meccanismi che dovevano
istituirsi tra gli Stati, invece, sarebbero stati di tipo intergovernativo, ossia tali da
consentire ai governi nazionali ‹‹di raggiungere decisioni concordate in alcune materie di
comune interesse››17. La tesi confederale si caratterizzava per una certa contraddittorietà,
giacché, da un lato sosteneva la necessità, viste le dimensioni crescenti dei problemi, di
superare i tradizionali metodi della politica internazionale, dall’altro ribadiva l’intangibilità
della sovranità nazionale. Essendo funzionale alla conservazione degli Stati, dei loro
interessi e delle loro ambizioni, la proposta confederale fu, tra gli altri e non a caso,
sostenuta da due statisti provenienti da grandi ed orgogliose nazioni: Winston Churchill e
Charles De Gaulle.
Non vi possono essere dubbi, allora, sul fatto che, se il piano Fouchet fosse stato
approvato, l’unità europea si sarebbe fatta sul modello della confederazione.
6. Il piano Fouchet
Nei primi anni Sessanta Charles De Gaulle meravigliò l’intera Europa portando
avanti, con vigore e convinzione, un progetto di cooperazione politica tra i Sei che,
sebbene in un orizzonte più lontano, avrebbe dovuto traghettarli dalle Comunità ad una
forma d’organizzazione di tipo confederale. Il progetto prendeva il nome di “Piano
Fouchet” dal nome, Christian Fouchet, del presidente della commissione incaricata dalla
conferenza di Bonn del 18 luglio 1961 di elaborare una bozza di trattato sulla “unione
politica” tra i sei paesi già aderenti alle Comunità. Sebbene la commissione fosse
formalmente indipendente dagli Stati che l’avevano espressa, le conclusioni che essa
sottopose all’approvazione dei Sei corrisposero in pieno alle idee che in materia De Gaulle
aveva ripetutamente espresse. L’impegno profuso dal Presidente in questa occasione, però,
17 S.PISTONE, op.cit, p.19
1

non impedì che lo storico tentativo di unire finalmente l’Europa, anche nell’ambito politico
e strategico, culminasse in un colossale fallimento.
A monte del negoziato per l’unione politica vi fu la speciale relazione che, fin dal
suo ritorno al potere, il presidente De Gaulle volle instaurare con la Germania e
personalmente con il suo cancelliere, Conrad Adenauer. Per grandi linee, infatti, il progetto
per una stretta cooperazione tra gli Stati – e non già l’istituzione di una nuova comunità –
fu deciso nei vari incontri che i due statisti ebbero, a partire da quello di Rambouillet del
29 luglio 196018.
Per quanto se ne parli al singolare, del piano Fouchet furono presentate tre diverse
bozze. Tutte, però, esordivano istituendo un’unione indissolubile di Stati e di popoli:
Il est institué par le présent traité une Union d'État, ci-après désignée par
le terme « l’Union ». L’Union est fondée sur le respect de la personnalité
des peuples et de États membres : égalité des droits et des obligations.
Elle est indissoluble19
Solo la prima bozza, quella del novembre 1961, garantiva, però, al paragrafo 5 del
preambolo, il rispetto delle istituzioni comunitarie – limitando le competenze delle nuove
istituzioni alla politica estera, agli affari culturali e alla difesa, e non facendo accenno
alcuno alla politica economica – e la lealtà atlantica. Secondo la bozza, organi dell’Unione
sarebbero stati: un Consiglio composto dai capi di Stato e di governo degli stati membri;
un’Assemblea parlamentare europea; una Commissione esecutiva. Il Consiglio si sarebbe
riunito ogni quattro mesi e almeno tre volte all’anno deliberando all’unanimità; nessuna
decisione, tuttavia, che non fosse stata condivisa da uno dei suoi membri avrebbe
comportato, per detto membro, l’assunzione di un qualunque obbligo e al contempo
18 I due s’incontrarono la prima volta a Colombey-Les-Deux-Églises il 15 settembre 1958. Altri incontri importanti furono quelli del successivo 26 novembre a Bad-Kreuznach, del 9 dicembre 1961 a Parigi, del settembre 1962 in Germania. In tutti questi incontri De Gaulle e Adenauer cercarono un’intesa soprattutto su questioni politiche, strategiche ed economiche, tra le quali: i modi dell’unità europea; la natura del MEC e delle istituzioni comunitarie; la riforma della NATO; gli armamenti atomici; lo status della RFT; i rapporti Est-Ovest. 19 Quello riportato è l’articolo 1 in tutte le versioni. Fonte: www.gaullisme.org
1

impedito agli altri di approfondire la loro cooperazione. All’Assemblea veniva riconosciuta
la facoltà di sottoporre interrogazioni e raccomandazioni al Consiglio, il quale, nel primo
caso, avrebbe dovuto rispondere entro due mesi, mentre nel secondo avrebbe dovuto
riferire di avervi dato seguito nella successiva riunione. La Commissione esecutiva,
costituita da funzionari designati dagli Stati, avrebbe preparato le deliberazioni del
Consiglio e vegliato sulla loro esecuzione. L’articolo 16 prevedeva che, dopo tre anni dalla
sua entrata in vigore, il trattato sarebbe stato sottoposto a revisione al fine di rafforzare
l’Unione e far incamminare definitivamente l’Europa verso una confederazione20.
In buona sostanza, il piano Fouchet prevedeva un Consiglio con poteri deliberativi,
irresponsabile sì di fronte ad un’Assemblea decisamente impotente, ma legittimato dal
fatto che i suoi membri sedessero nei governi nazionali, nonché una Commissione politica
che, in quanto formata da funzionari legati agli Stati di nomina, non sarebbe stata affatto
indipendente da questi. Non è sbagliato affermare che, pur conservandosi i nomi già
adottati dalle strutture comunitarie, l’unione politica non sarebbe consistita che nel rendere
istituzionale la prassi degli incontri al vertice che, sotto il poderoso impulso del governo
francese, si era in verità già affermata. Pur essendo accolta come una buona bozza da cui
cominciare a lavorare, non mancarono le rimostranze dei paesi – soprattutto Paesi Bassi e
Belgio – che constatavano con amarezza l’intento francese di annullare la logica della
sopranazionalità21.
20 D. CAVIGLIA, De Gaulle e il tentativo di spostare l’asse politico europeo: il piano Fouchet, CEDAM, 2000, riporta così al p.194 il contenuto dell’art.16: “Tre anni dopo l’entrata in vigore del trattato ‹‹celui-ci sera soumit à une révision générale, qui aura pour objet l’examen des mesures propres à renforcer l’Union, compte tenu des progrès accomplis››. Era, inoltre, specificato che la revisione avesse ‹‹pour objectifs principaux l’établissement d’une politique étrangère unifiée et la constitution progressive d’une organisation centralisant, au sein de l’Union, les communautés européennes mentionnées dans le préambule du présent traité″. Oltre che D. CAVIGLIA, sul Piano Fouchet si vedano anche: B. OLIVI, op.cit. pp.73-75; G.MAMMARELLA, op.cit, pp 306-309; G.MAMMARELLA, P. CACACE, op.cit, pp.109-115.21 Cfr. D. CAVIGLIA, op.cit., p.195. Per i due paesi, infatti, il piano francese rappresentava non già una soluzione definitiva, ma un accettabile punto di partenza al quale era necessario apportare modifiche che andassero nel senso della sopranazionalità.
2

Presentato come il necessario completamento politico delle istituzioni economiche
già esistenti e come uno strumento di rafforzamento della NATO22, il piano Fouchet, in
realtà, non era affatto in continuità con il processo comunitario inaugurato con la CECA e
proseguito nel 1957 con la firma dei trattati di Roma, concernenti la fondazione della CEE
e dell’Euratom. La mente di De Gaulle aveva lavorato affinché l’Europa fosse uno
strumento di grandezza della sua venerata Francia e affinché la sua posizione egemonica
sul Vecchio Continente, basata anche sull’accordo strategico con Bonn, conferisse al suo
paese – o forse più precisamente allo stesso Generale – l’autorità di esprimere il proprio
punto di vista sugli equilibri mondiali a nome di tutta l’Europa democratica. Europa che,
secondo De Gaulle, aveva il dovere di riconquistare la centralità perduta negli equilibri
planetari e sbarazzarsi da quella indecorosa condizione di subalternità agli Stati Uniti
d’America dovuta alla presenza dell’Alleanza Atlantica.
L’idea più volte manifestata, e nuovamente confermata col piano Fouchet, di
promuovere una confederazione non sarebbe stata di per sé cattiva, se non fosse stato per il
fatto che l’unione politica di De Gaulle somigliasse più ad un sistema di relazioni
internazionali tra Stati europei facente perno su Parigi e sulla sua alleanza privilegiata con
la Germania occidentale, che ad una vera confederazione europea. Detta alleanza,
sfruttando il suo stesso peso negli equilibri del Continente, nonché il fatto che la Germania
di Adenauer fosse molto limitata nei suoi movimenti, mirava chiaramente ad assicurare
una guida francese all’Europa. É proprio sulla base di questa intesa che De Gaulle, d’altra
parte, diede probabilmente dimostrazione della sua concezione pratica dell’unità europea,
ad esempio quando impose l’agricoltura tra gli ambiti di competenza del Mercato Comune
22 Cfr., ivi, pp. 117-118. De Gaulle spiegò che il necessario completamento politico delle istituzioni economiche già esistenti non avrebbe intaccato la sostanza dei trattati di Roma e, per ragioni diverse, avrebbe assunto i contorni di una cooperazione intergovernativa senza carattere sopranazionale. Anche la collaborazione in materia di politica estera e di difesa non avrebbe dato luogo a frizioni con gli americani ma, al contrario, avrebbe contribuito al rafforzamento della NATO attraverso l’organizzazione di paesi europei più coscienti dei propri interessi.
2

e regolò in anticipo e privatamente con il suo partner privilegiato le grandi linee
dell’unione politica e le modifiche al piano Fouchet, lasciando ai rimanenti Quattro, in tal
modo, la sola facoltà di accettare23.
De Gaulle confidava che la sola legge dei grandi numeri avrebbe fatto pendere
verso Parigi la bilancia del potere europeo; dopo che le due bozze successive, però,
intesero estendere l’ambito di applicazione dell’unione anche all’economia – di fatto
annullando la CEE – e cancellare ogni riferimento alla NATO, l’adozione del piano
Fouchet fu compromessa per la ferma opposizione del Belgio e dei Paesi Bassi. Così, dopo
solo un anno e mezzo, nell’aprile del 1962 il negoziato sull’Unione politica era già
miseramente fallito.
23 La seconda e la terza bozza datano, rispettivamente, 18 gennaio e 20 febbraio 1962. La seconda ometteva qualunque riferimento alle strutture previste dai Trattati di Roma e all’Alleanza Atlantica. Inoltre, all’Assemblea parlamentare venivano attribuiti poteri molto più ridotti. La terza versione, che fu solo un estremo tentativo di compromesso, fu definita in seguito all’incontro del 15 febbraio con il Cancelliere Adenaeur a Baden-Baden, nel corso del quale il presidente della Repubblica francese accettava nuovamente di modificare il testo su due punti: il preambolo del trattato avrebbe contenuto un riferimento al Patto Atlantico e l’articolo relativo alle competenze delle nuove istituzioni avrebbe specificato che il Consiglio non avrebbe potuto discutere dei problemi economici che nel rispetto delle istituzioni esistenti. Si vedano G.MAMMARELLA, P.CACACE, op.cit., p.114 e B. OLIVI, op.cit., p.76
2

CAPITOLO II
CHARLES DE GAULLE TRA LA NAZIONE E L’EUROPA
1. Nazionalismo e legittimità
A Saint-Cyr – sede dell’accademia militare presso la quale s’era formato – nel
corso dei seminari da lui tenuti che culmineranno, in seguito, nella scrittura di Le fil de
l’épée, De Gaulle trattò l’argomento del carisma che un capo deve avere, esprimendo una
notevole ammirazione per le “personalità unificanti”, ossia coloro che, grazie al coraggio
di contravvenire all’occorrenza agli ordini dei superiori, riescono a plasmare gli eventi con
la loro azione. Meglio: a cambiare il corso della storia con un semplice atto della loro
volontà. Così, se è vero che:
C’è un unico tema nella vita di Charles de Gaulle, e questo tema è il potere.
La sua grande e tormentata devozione per la Francia, i suoi sogni e le sue
esortazioni alla grandezza avrebbero significato poco più di un super-
2

patriottismo filosofico da intellettuale militante, se egli non fosse stato
capace di tradurli in un costante esercizio di potere […] Senza dubbio nella
sua vita ci furono alti e bassi, ma non vi fu alcuna diversione da questa
univoca fissazione mentale per il potere24,
è altrettanto certo che pochi uomini nella storia hanno saputo fare ciò che è riuscito a De
Gaulle, specie dalla definitiva affermazione dell’antieroico ordine politico e sociale
borghese.
De Gaulle era convinto di possedere tutte le qualità delle personalità eccezionali e
proprio tale convinzione lo sorresse nella sua opera – il cui esito era tutt’altro che scontato
– di radunare i francesi durante uno dei loro peggiori momenti storici e, infine, ricondurli
tra i vincitori della guerra; nonché accorrere in loro soccorso una seconda volta e stabilire,
questa volta sì, il suo “regno” al pari di un Alessandro, di un Cesare, di un Napoleone.
Fu senz’altro un nazionalista, ma sarebbe un gravissimo errore pensare di
ricondurre De Gaulle nelle categorie politiche tradizionali. Pur non costituendo scopo di
codesto lavoro indagare circa la natura del nazionalismo di Charles De Gaulle, si ritiene
essenziale, a questo punto giunti, svolgervi comunque qualche considerazione. Il
nazionalismo di De Gaulle può definirsi:
una concezione politica che non limita i suoi insegnamenti alla nazione
francese nella quale si è sviluppato, ma costituisce nella storia delle idee
politiche nazionali, il ritorno alla moderazione, a un patriottismo che si
libera dall’influenza del nazionalismo ideologico estremo25.
Si tratta, quindi, di un nazionalismo di tipo ottocentesco, non militarista, che tende
ad essere universalizzato26. Così, anche se lo Stato nazionale è un fenomeno organizzativo
24 D. COOK, op.cit., p.925 J.L. CHABOT, Il nazionalismo, Milano, Mondatori, 1995, p. 13726 ‹‹La caratteristica saliente del nazionalismo gollista [...] è quella di proporre un sistema ideale aperto, sincretico e non esclusivo, e che per di più volontariamente rinuncia a darsi confini insormontabili sia nella dimensione dello spazio che in quella del tempo. In tal senso, va innanzitutto ribadito il carattere cosmopolita del nazionalismo gollista. Elemento che può essere apprezzato da due diversi punti di vista: il primo riguarda specificamente la Francia; l’altro assume un significato universale›› in G. QUAGLIARIELLO, De Gaulle e il gollismo, Bologna, Il Mulino, 2003, p 29.
2

moderno, nella romantica visione di De Gaulle le nazioni esistono da sempre e da sempre
combattono per la loro affermazione. Non può esistere, quindi, alcuna realtà alternativa a
quella degli Stati nazionali; nel contesto mondiale, poi, ciascuno Stato deve giocare il ruolo
che gli deriva dalla sua storia, dalla sua forza, dalla sua posizione geografica, dalla sua
ambizione, dal suo genio. Brevemente, ogni nazione deve svolgere, sulla base della
condivisione del principio di nazionalità da parte di tutti, la propria missione.
Questo nazionalismo, inoltre, non è ideologico, di “destra”, ma è il tentativo di
unificare i francesi, lacerati dalla competizione partitica e dalle ideologie, nonché la stessa
Francia, divisa tra l’Ancien Régime, la Rivoluzione, la Grande Guerra27. Per De Gaulle,
l’ideologia è solo un fenomeno culturale transitorio inidoneo a fornire una corretta
rappresentazione della realtà e, di conseguenza, alla lunga destinato a dimostrarsi incapace
di guidare una nazione. All’ideologia De Gaulle contrappone le nazioni, il primato delle
circostanze e l’azione morale28, mentre i partiti politici sono considerati fattori di disunione
e di rovina:
Au caractère fractionnel des partis, qui les frappe d’infirmité, s’ajoute
leur propre décadence. Celle-ci se cache encore sous la phraséologie.
Mais la passion doctrinale, qui fut jadis la source, l’attrait, la grandeur
des partis, ne saurait se maintenir intacte en cette époque de
matérialisme indifférente aux idéals [...] Si le pouvoirs retombe à lors
discrétion, il est certain que leurs dirigeants, leurs délégués, leurs
militants, se mueront en professionnels faisant carrière dans la politique.
La conquête des fonctions publiques, des postes d’influence, des
emplois administratifs, absorbera désormais les partis, au point que leur
activité se déploiera essentiellement dans ce qu’ils nomment la tactique
et qui n’est que la pratique du compromis, parfois du reniement29
Solo dalla nazione, quindi, può derivare la legittimità del potere. La concezione di
De Gaulle si fa, a questo punto, piuttosto originale, poiché egli ritiene che tale legittimità si
27 Cfr .J.L. CHABOT, op.cit., p. 14028 Cfr. QUAGLIARIELLO, op.cit, p. 31 e p. 6429 C. DE GAULLE, Mémoires de guerre - Le Salut,Paris, Plon,1959, pp. 286-287
2

affermi nel momento in cui la patria è in pericolo e nelle mani di chi la conduce alla
salvezza. Sulla base di ciò, De Gaulle giustifica la sua presa del potere tanto durante la
guerra quanto nel corso della crisi d’Algeria30e, chiaramente, la legittima:
Nécessité vitale, qui en cas de péril publique s’impose tôt ou tard à la
collectivité! Dés lors, pour un pouvoir, la légitimité procède du sentiment
qu’il inspire et qu’il a d’incorporer l’unité et la continuité nationales
quand la patrie est en danger31
Esercizio legittimo del potere e sovranità, però, non coincidono: se è l’eccezionalità
dell’uomo, la sua azione storica e morale a conferirgli quel potere atto a garantire
l’indipendenza della Nazione, la sovranità – ossia la facoltà di scegliere – non può non
appartenere che al popolo. Lo Stato e le sue istituzioni sono, quindi, solo gli strumenti
tramite cui il popolo esercita la sua sovranità, mentre nell’autorità legittima s’incontrano e
si fondono la sovranità e la “volontà generale” della nazione. Pur non essendo uno
strumento d’aggressione, lo Stato non può essere debole, frammentato e lacerato dalle
dispute tra i partiti:
Or, si j’étais convaincu que la souveraineté appartient au peule dés lors qu’il
exprime directement et dans son ensemble, je n’admettais pas qu’elle put être
morcelée entre les intérêts différents représentés par les partis. Certes, ceux-
ci devaient suivant moi contribuer à l’expression des opinions, et par suite, à
l’élection des députés […] Mais pour que l’Etat soit, comme il faut,
l’instrument de l’unité française, de l’intérêt supérieur du pays, de la
continuité dans l’action nationale, je tenais pour nécessaire que le
Gouvernement procédât, non point du Parlement, autrement dit des partis,
mais, au-dessus d’eux, d’une tête directement mandatée par l’ensemble de la
nation et mise à même de vouloir, de décider et d’agir32.
Non è nemmeno possibile che la sovranità venga anche solo parzialmente ceduta
all’esterno.
30 Nel corso della quale dichiarò, prima ancora d’essere invitato dal presidente Coty a costituire il nuovo governo, d’avere iniziato ‹‹il regolare processo necessario alla formazione di un nuovo governo repubblicano capace di assicurare l’unità e l’indipendenza del paese››. C. DE GAULLE, Memorie della speranza, Milano, Rizzoli, 1970,p. 2431 C. DE GAULLE, Mémoires d’espoir, Paris, Plon, 1970, p.1332 ivi, p. 15
2

2. De Gaulle, un patriota
Compreso che il nazionalismo di De Gaulle, per quanto ispirato dalla grandeur
della Francia, non è militarista e si richiama ai concetti di sovranità e di indipendenza
secondo i loro significati più genuini; considerando, inoltre, che, in quanto uomo d’azione
e non teorico della politica, De Gaulle non ha mai fondato una propria e coerente
dottrina33, possiamo azzardare a spiegare come De Gaulle concepisse il suo tempo.
A suo modo di vedere, il secondo conflitto mondiale era stata una guerra che si era
combattuta per far conseguire ad alcune nazioni, e fra queste la Francia, l’indipendenza
dall’impero che li opprimeva: il Terzo Reich tedesco. La fine del conflitto, però, se aveva
definitivamente ridimensionato le ambizioni della Germania, non aveva condotto tali
nazioni alla loro completa liberazione, giacché due nuovi grandi imperi – di cui uno era la
solita Russia (étérnélle, avrebbe detto lui), perché l’Unione Sovietica è solo una
momentanea infatuazione per il comunismo – stringono in una morsa non solo gli Stati
europei, ma l’intero pianeta. In tale scenario De Gaulle si vestì degli indumenti del
patriota, la cui missione “provvidenziale” non poteva non essere che combattere contro
tutte le forme di oppressione, ovunque esse fossero state, per la libertà delle nazioni.
Le polemiche e le soventi tensioni che hanno caratterizzato i rapporti con gli Stati
Uniti durante tutto il periodo della sua presidenza (ma per quanto riguarda solo le
polemiche, possiamo risalire anche a tutto il periodo della Quarta repubblica) scaturirono
dal rifiuto dell’integrazione indotta dalla NATO, ossia, dal rifiuto che la Francia potesse
vedersi compromessa nella sua l’indipendenza – la sua libertà d’azione – nello scenario
33 In riguardo a tale questione alcuni autori, piuttosto che di “gollismo”, preferiscono parlare di “gollismi”. Sull’argomento possono consultarsi: R. RÉMOND, La destra in Francia, Torino, U. Mursia & C., 1970, pp. 298-330; G. QUAGLIARIELLO, op.cit, pp. 17-50 e 683-732; J. SOUSTELLE, Gollismo. Ventotto anni di regime, Milano, Edizioni del Borghese, 1969. I primi due autori trattano della natura dei “gollismi” alla luce delle diverse ascendenze del pensiero di De Gaulle; il terzo, invece, durante tutta l’opera parla di due diverse e contraddittorie forme di gollismo (gollismo e neo-gollismo) assumendo il ritorno al potere di De Gaulle quale spartiacque tra le due concezioni.
2

strategico internazionale (scenario che, a dispetto dei tentativi di razionalizzazione esperiti
dalla creazione di organizzazioni internazionali, prima fra tutte l’ONU, era ed è
notoriamente anarchico). In ambito europeo, invece, l’arma brandita dal Presidente per
screditare il processo comunitario e logorare dal loro interno le istituzioni ispirate da
Monnet, nonché usata, al contrario, per edificare una diversa Europa, fu la difesa della
sovranità.
3. L’inevitabile unità europea
A sorreggerlo, Charles De Gaulle ebbe sempre una vivace intellettualità e una
rigorosa moralità che, piegandosi solo alla ragion di Stato, furono ben aliene
dall’opportunismo e dall’ipocrisia dei partiti, dei loro uomini e delle loro clientele34. A
proposito di ragion di Stato, sembra doveroso sottolineare come, invero, solo il federalismo
assunse di fare l’Europa spogliando gli Stati di tali ragioni: se il federalismo al di là della
retorica non ha mai trionfato, evidentemente, ci deve essere una ragione che va oltre
l’azione di Charles De Gaulle35.
Nel 1948 a Marsiglia il Generale ebbe a dire:
Presque tout le monde admet qu’il faut organiser les peuples libres de
l’Europe en un tout économique et stratégique, que ce tout pourrait
comprendre un jour une confédération d’États allemands mais non pas un
quatrième Reich, qu’il devrait être lié aux États-Unis d’Amérique sous 34 Per quanto riguarda gli aspetti della moralità di De Gaulle: ‹‹È la storia a fare gli uomini o sono gli uomini a fare la storia? Il generale De Gaulle appartenne indiscutibilmente ed energicamente alla seconda categoria. Combatté costantemente per imporsi agli eventi e fece la storia della Francia al massimo livello. Fu un uomo da prendere in blocco e c’è una sorta di totalità nella sua personalità, che gli derivava dal modo in cui aveva posto ogni aspetto del suo carattere al servizio della sua pertinente ricerca del potere. La sua rigorosa dirittura morale divenne in qualche modo la spina dorsale della Francia che, in quanto a moralità, non aveva mai goduto di una grandissima reputazione›› in D.COOK, op.cit, p.15; ‹‹É una morale cristiana che si rivolge a una persona umana libera nelle sue scelte, malgrado la contingenza e le circostanze, e volitiva dei suoi atti. Il senso dello sforzo, dell’ardore, della riparazione dei torti, della disciplina lascia trasparire quanto il mestiere del militare vi abbia aggiunto, autorizzando come il caso dell’esercito, il trasferimento alla collettività morale di qualità simili e di virtù possibili›› J.L.CHABOT, op.cit, p.14235 A sottolineare l’elemento conservatore e nazionale del funzionalismo sono B.OLIVI, op.cit., pp.32-45, S.ROMANO, Europa storia di un’idea, dall’Impero all’Unione, Milano, Longanesi, 2004, pp.175-179 e M. ALBERTINI, A. CHITI BATELLI, G. PETRILLI, op.cit, pp 265-277
2

forme de garantie réciproque, et que c’est à la France qu’il appartient de
prendre la tête de cette vaste entreprise 36.
Dal suo Manifesto e dalla sua azione, impariamo che per Altiero Spinelli l’esigenza
della federazione europea sorgeva dalla constatazione che lo Stato nazionale si era
mostrato storicamente incapace di assicurare pace e progresso ai popoli europei, perché
fisiologicamente espressione delle classi titolari di quei grandi interessi che infine
muovono gli Stati a farsi guerra37.
Secondo De Gaulle, invece, ‹‹l’Europe, elle, n’a pas les promesses de la vie
éternélle››38: l’Europa, dunque, non deve farsi secondo una qualche ideologia, perché nulla
può esistere al di sopra delle nazioni e degli Stati ‹‹en dehors naturellement des mythes,
des fictions, des parades››39. L’Europa deve farsi per ragioni strategiche: perché è
opportuno porre sotto tutela la Germania, assicurandola all’Occidente e in modo
particolare alla Francia; perché è utile che gli Stati europei cooperino in più campi, specie
in quello economico, al fine di potersi presto emancipare dagli Stati Uniti e liberarsi dalla
scomoda morsa strettavi attorno da nordamericani e sovietici. Pur consapevole che
l’Europa non fosse più il centro del mondo40, De Gaulle attribuiva al centro dell’Europa un
ruolo molto importante nei fragili equilibri del dopoguerra, facendo dipendere la pace
mondiale dal rapporto tra i due popoli che maggiormente si erano confrontati nel corso dei
secoli sul Vecchio Continente: i Galli e i Germanici. Per De Gaulle non vi potevano essere
né la pace né l’Europa senza l’amicizia tra queste due nazioni:
Il y aura ou il n’y aura pas d’Europe, suivant qu’un accord sans
intermédiaire sera, ou non, possible entre Germains et Gaulois. 41 36 Discorso pronunciato a Marsiglia il 18 aprile 1948.Fonte: www.gaullisme.org 37 A.SPINELLI, E. ROSSI, E. COLORNI, op.cit.38 C. DE GAULLE, Mémoires d’espoir, cit., p.15439 Conferenza stampa del 15 maggio 1962 in Discours et messages, Paris, Plon, 197140 A tal proposito: ‹‹Notiamo subito che De Gaulle – del quale troppo spesso si è detto avere la formazione mentale di un uomo pre-1914 – non credeva affatto che l’equilibrio intraeuropeo fosse il problema capitale della nostra epoca. Anzi, egli aveva visto benissimo che i centri del potere si erano trasferiti a Washington e a Mosca, e che un giorno forse se ne sarebbe creato un terzo a Pechino›› B.OLIVI, op.cit., p.6541 Discorso pronunciato a Bordeaux il 25 settembre 1949.
2

Effettivamente, la questione tedesca era uno dei fronti più caldi della guerra fredda
tanto per le quotidiane tensioni che caratterizzavano la gestione di Berlino quanto per il
fatto che proprio sul suolo tedesco, a due passi da Parigi, ci si attendeva che avrebbe avuto
luogo la resa dei conti definitiva tra USA e URSS 42. La bontà dell’intuizione di De Gaulle
di costruire l’Europa a partire da un solido legame tra il suo paese ed il potente vicino,
d’altra parte, sarà confermata dal successo del piano Schuman (con questo non si vuole
affermare che De Gaulle ne sia stato un ispiratore; infatti: Presque tout le monde admet
…).
E ovviamente, nessuna visione che De Gaulle ebbe per l’Europa poteva non vedere
alla sua testa la Francia, uscita dalla guerra intatta ‹‹dans ses frontières et dans son unité››
ed unica nazione europea, occidentale e continentale, a potersi fregiare del rango di
vincitrice43.
4. Il piano Fouchet: un primo bilancio
I giudizi che si formularono nei confronti della politica europea del presidente
francese non furono univoci. Tra quelli negativi, vi fu l’accusa di volere il ritorno alla
concezione ottocentesca della sovranità nazionale, foriera di nuovi disumani conflitti. Da
questo punto di vista, l’Europa di De Gaulle consisteva nello scadimento dell’ideale
unitario europeo – proprio la Francia aveva giocato un ruolo fondamentale nella
fondazione delle Comunità – nella brama egemonica di una nazione decadente e la
riduzione delle istituzioni comunitarie in un’arena in cui mercanteggiare vantaggi e diritti.
42 « Charles de Gaulle déclare le 27 juillet 1947 dans un discours prononcé à Rennes que la frontière du bloc soviétique n’est séparée de la nôtre que par 500 kilomètres, soit à peine la longueur de deux étapes du tour de France cycliste ! ». in www.gaullisme.org 43 C.DE GAULLE, Mémoires d’espoir, cit., p.132 . Al riguardo possono consultarsi anche il discorso di chiusura del Consiglio nazionale del R.P.F., Saint-Maur, 6 luglio 1952 in Discours et messages, cit, e la dichiarazione del 17 agosto 1950 in www.gaullisme.org
3

Nondimeno, non può dirsi che il Generale non avesse una reale visione dell’Europa.
Nemmeno può dirsi che la sua visione fosse interamente da rigettare.
Il punto di vista del Generale appare per molti aspetti non condivisibile a causa del
cinismo con cui usò le istituzioni comunitarie per porre la Francia al di sopra di tutti e
tutto in Europa e nel mondo. È chiaro che, in un contesto già avviato di progressiva
integrazione, la proposta di fare una “Europa delle patrie” appare difficilmente un
progresso sulla strada per l’unità politica. Tuttavia, non può contestarsi a De Gaulle
alcunché in riguardo alla sua concezione, nel senso che, rappresentando, quella, una delle
“tesi” del dibattito sull’unità europea, essa è legittima e quanto meno condivisibile.
Malgrado le accuse, quindi, che gli furono rivolte, se una virtù può essergli riconosciuta,
quella è la capacità, ancora al tempo della meccanizzazione esasperata44, di sapere vedere
il mondo alla maniera dei romantici, cioè tendendo allo Spirito piuttosto che alla cassa, di
vedere comunque e sempre la politica al di sopra di tutto45. Così dicendo, non si intende
collocare nell’Ottocento una mitica “Età dell’Oro” della politica europea, ma sgomberarsi
il campo da facili semplificazioni per cui il piano Fouchet sarebbe stato solo un delirio
nazionalistico. De Gaulle, infatti, comprese chiaramente la necessità che l’Europa parlasse
44 De Gaulle ebbe sensibilità per i cambiamenti sociali e culturali indotti dalla macchina. In Mémoires d’espoir, cit., p.111 scrisse ‹‹Cependant, depuis longtemps, je suis convaincu qu’il manque à la société mécanique moderne un ressort humain qui assure son équilibre. Le système social qui relègue le travailleur – fut-il convenablement rémunéré – au rang d’instrument et d’engrenage est, suivant moi, en contradiction avec la nature de notre espèce, voire avec l’esprit d’une saine productivité››, contestando in tal modo tanto il capitalismo, quanto il comunismo (nel seguito del passo: une tyrannie odieuse). In generale, però, egli sottolineò le connessioni tra la macchina ed il dispotismo celato dietro l’uniformazione,come in Mémoires de guerre-L’appel, Paris, Plon, 1954, p.402: «Il faut convenir que dans l’époque moderne, la transformation des conditions de vie, l’agrégation croissante des masses et le gigantesque conformisme collectif qui en sont les conséquences battent en branche les libertés de chacun […] Il se produit une sorte de mécanisation générale, dans la quelle, sans un grand effort de sauvegarde, l’individu ne peut manque d’être écrasé […] Or, c’est dans ces tendances nouvelles que les dictateurs ont cherché et trouvé le succès de leurs doctrines et de leurs rites. Assurément, ils ont réussi d’abord parmi les peuples qui, dans l’espoir de saisir la domination sur les autres, ont adopté d’enthousiasme l’organisation des termitières». 45 Assunto il governo durante la guerra, a voler sottolineare la priorità da lui accordata alle questioni squisitamente politiche, pare che De Gaulle abbia detto: ‹‹L’intendance suit››. Nel corso dell’intervista a Michel Droit del 14 dicembre 1965 negherà di aver pronunziato tale frase.
3

con una sola voce e che cooperasse su vari fronti, non solo quello economico, per le
dimensioni ormai raggiunti dai problemi. Proprio per questo contestò il sistema delle
Comunità, il quale, se da un lato stava favorendo l’avvicinamento sul terreno economico
degli Stati e dei popoli europei occidentali, dall’altro, confidando sul fatto che fossero gli
Stati Uniti a dettarne gli indirizzi politico-strategici, rimandava ad un momento troppo
imprecisato il tempo in cui l’Europa, sovrana e indipendente, sarebbe divenuta una realtà
politica negli equilibri internazionali. È per questo – lo si vedrà in seguito – che la visione
di De Gaulle può considerarsi più avanzata di quella che ebbero i suoi colleghi europei, al
contrario soddisfatti di quanto si andava facendo e, comunque, incapaci di opporre al
disegno gollista una proposta decisamente federale (anche questo punto sarà toccato in
seguito). Che sia condivisibile o no, l’Europa di De Gaulle fu una visione dell’Europa,
manifestata al mondo intero mediante atti, scritti e dichiarazioni: tanto dopo la guerra
quanto già nel suo decorso; sia al governo che durante la “traversata nel deserto”.
I maggiori dubbi circa l’Europa che sarebbe scaturita dall’accettazione del piano
Fouchet consistevano nell’abbandono, da parte di detto progetto, della sopranazionalità.
Rifiutando la sopranazionalità, De Gaulle chiarì di rifiutare l’intero sistema delle
Comunità. Al di là di qualunque argomentazione ufficiale che il Presidente usò per
screditare tale principio – lo scippo della sovranità, l’impotenza esecutiva della
Commissione, l’inconsistenza giuridica e politica dell’Assemblea, che saranno tutte
affrontate in seguito – invero la sopranazionalità fu bruscamente rigettata da De Gaulle per
l’incompatibilità di questo principio con la sua “visione delle cose”. Con tale espressione
vogliamo riferirci al suo modo “totalizzante” di concepire la realtà, un modo per il quale la
Francia è in sé stessa una potente nazione, lo è in Europa, lo è nel mondo e lui, Charles De
Gaulle, ne incarna lo Spirito; una visione per la quale l’Europa serve alla grandezza della
Francia e la Francia è a sua volta indispensabile per ristabilire un’Europa sovrana e
indipendente; una concezione per cui ogni successo ottenuto in patria e a Bruxelles è
3

destinata a modificare gli equilibri del pianeta; infine, una visione per cui lo Spirito forgia
la Materia e a fare la storia e gli uomini sono il pensiero e l’azione – sommamente la
politica e l’esercizio del potere – non già la macchina e i commerci46.
CAPITOLO III
L’EUROPA DELLE PATRIE
1. Contro il Consiglio d’Europa
Col senno del poi possiamo affermare che, con la creazione del Consiglio d’Europa,
nella storia dell’unificazione europea nulla di più simile alla visione del Generale fu mai
46 Da parte nostra si è cercato di esprimere il significato di questo modo “totalizzante” di vedere la realtà facendo riferimento al “groviglio” costituito dalle strategie golliste e alla luce della sua concezione romantica della realtà. Ma, meglio di noi si spiega il filosofo francese H. BERGSON, citato da D. COOK, op,cit, p. 39: ‹‹Da cosa riconosciamo normalmente l’uomo d’azione che lascia un segno sugli eventi nei quali il fato lo ha gettato? Non è perché egli abbraccia una successione più o meno lunga di quegli eventi in una visione istantanea? Più grande è la parte di passato che egli include nel suo presente, più forte è il peso con cui spinge il futuro in modo da premere sugli eventi che vanno preparandosi: la sua azione, come una freccia, si muove in avanti con una forza proporzionale a quella con cui la sua immaginazione si era spinta all’indietro››. Ovviamente, Bergson non si riferiva certo a De Gaulle, ma la citazione che ne fa Cook ci sembra coglierne in pieno la visione. D’altra parte, tanto R. RÉMOND, op.cit, quanto G. QUAGLIARIELLO, op.cit., trovano in Bergson una delle più importanti ispirazioni del Generale.
3

proposto. Ciononostante, De Gaulle fu tra i maggiori oppositori del Consiglio d’Europa. In
un comunicato del 7 agosto 1949 alla direzione del RPF, De Gaulle espose le ragioni della
sua contrarietà, criticando che nulla si fosse proposto sul piano dell’unificazione
economica e strategica, nonché il ricorso al voto all’unanimità, l’inconsistenza dei poteri
dell’Assemblea, l’assenza di democrazia. Analoghe critiche furono ribadite, tra le altre
occasioni, anche a Bordeaux il 25 settembre 1949, al Palais d’Orsay il 14 novembre 1949,
a Bagattelle il primo maggio 1950, alla United Press nel 10 luglio 1950 e ancora il 17
agosto 1950. In questa fase del dibattito sulla federazione, De Gaulle sembrò accettare il
principio della sopranazionalità al fine di consentire la formazione di una federazione o di
una confederazione con potestà sull’ambito nella difesa terrestre, navale e aerea; sul
coordinamento delle produzioni industriali; sulla liberalizzazione degli scambi
commerciali; sulla moneta; sulla cultura e sullo sviluppo scientifico47.
Sul piano economico e strategico, quelli in cui De Gaulle riteneva indispensabile che
si facesse l’unione, il Consiglio d’Europa non aveva alcuna competenza. Nei limitati
ambiti definiti dal suo statuto, la sua capacità di decidere risultava piuttosto circoscritta a
causa dell’unanimità dei voti che in suo seno era richiesta per gli affari essenziali, essendo,
invece, la maggioranza semplice riservata solo per questioni di procedura. Il Comitato dei
Ministri degli Esteri non era altro che una conferenza di ambasciatori. L’assemblea
consultiva non era una realtà politica, poiché, oltre a non avere alcun potere di decisione,
non aveva legami con i popoli europei48. Il Consiglio d’Europa, proseguiva De Gaulle, non
poteva realizzare l’unità d’Europa, non aveva e non poteva avere alcun potere, perché
privo della legittimità che solo il popolo europeo poteva dargli mediante il referendum, che
a sua volta doveva anche delineare i tratti delle istituzioni continentali: nessun popolo,
infatti, può vedersi sottratta, quasi scippata, la propria sovranità49. In definitiva, così
47 Cfr. Comunicato del consiglio di direzione del R.P.F. del 7 agosto 1949 in Discours et messages, cit.48 Cfr. Dichiarazione del 17 agosto 1950 in www.gaullisme.org 49 Cfr. Discorso pronunciato presso la « Pelouse » di Bagatelle, 1 maggio 1950
3

strutturato, il Consiglio d’Europa poteva ambire solo ad essere un organo tecnico, un
gruppo di studio che agevolasse la cooperazione tra gli Stati50.
Due furono le domande che De Gaulle si pose: come può un’istituzione così priva di
reali possibilità d’azione, nonché di legittimità politica e democratica assumere un compito
così gravoso che è l’unità europea? Come possono gli europei organizzare la propria difesa
se continueranno a delegare al Patto Atlantico, cioè allo straniero, tale materia strategica?
In riguardo a quest’ultima domanda, la risposta di De Gaulle, con evidente allusione tanto
alla Gran Bretagna quanto agli Stati Uniti, era che solo la Francia, forte della sua storia e
del suo rango, poteva ricondurre l’Europa sulla giusta strada 51.
Secondo De Gaulle, in definitiva, con la creazione del Consiglio d’Europa si era
soltanto inteso far credere che fosse iniziata l’unificazione del Continente: chi l’aveva
promossa, infatti, non solo non aveva inteso unire l’Europa, nemmeno ne aveva gettato
almeno le fondamenta lasciando che, poi, la maturità dei tempi e l’azione dei popoli
europei si occupassero del resto. Il Consiglio d’Europa, insomma, era una falsa partenza e
non conduceva ad alcuna parte :
Comme on n’a pas réalisé la Confédération, qu’on ne l’a même pas
essayée, comme, cependant, on voulait paraître faire quelque chose, on a
fait une caricature, c’est le Conseil de l’Europe. Ce Conseil laisse
indifférentes les masses européennes et n’aboutit à rien52.
2. De Gaulle federalista?
Dopo la firma del trattato istitutivo della CECA, De Gaulle dovette esprimere con
più precisione i suoi propositi per l’Europa:
Nous sommes pour la Fédération européenne. C’est-à-dire que nous
sommes pour un accord qui lie entre eux, d’une manière positive, sur des
50 Cfr. Conferenza stampa tenuta al Palais d’Orsay il 14 novembre 1949.51 Cfr. Discorso pronunziato a Bordeaux il 25 settembre 1949; Sul tema può anche vedersi l’intervista a M. Bradford dell’agenzia United Press, 10 luglio 1950.52 Conferenza stampa del 21 dicembre 1951
3

sujets positifs, notamment l’économie, la défense, la culture, les États de
l’Europe qui le veulent53.
Già nel corso del 1951, tornato sul tema delle istituzioni da dare all’Europa, De
Gaulle sembrò modificare il suo verbo, pronunziandosi non più per una federazione, bensì
a chiare lettere per una confederazione tra Stati, la quale, dovendo perseguire l’obiettivo di
unire l’Europa nei campi dell’economia, della difesa e della cultura, dovrà necessariamente
comportare la cessione, da parte degli Stati, di parti della propria sovranità:
Comment faire l’Europe ? Que doit-elle être ? Vous savez quelle est à ce
sujet la position de celui qui vous parle. Depuis des années je pense, avec
beaucoup d'autres d’ailleurs, que la communauté européenne doit être une
Confédération. Oui, une confédération d’États constituant entre eux un
pouvoir confédéral commun, auquel chacun délègue une part de sa
souveraineté. Ceci particulièrement dans la matière économique, dans la
matière de la défense et dans la matière de la culture […] Oui, une
confédération d’États constituant entre eux un pouvoir confédéral
commun, auquel chacun délègue une part de sa souveraineté54.
Sembra che il Generale abbia proposto, nel giro di pochi mesi, due cose diverse:
nondimeno, argomentando una volta a favore del federalismo, l’altra a favore della
confederazione, De Gaulle non si contraddisse affatto. Pur adoperando due parole dal
diverso significato egli intese esprimere il medesimo concetto: non la fusione degli Stati
nazionali in un’unica entità, bensì una loro stretta cooperazione negli ambiti
dell’economia, della difesa e della cultura. È possibile affermare ciò con certezza, visto che
la medesima confusione dei termini “federazione” e “confederazione” fu presente nelle sue
parole anche a proposito della Germania, in riguardo alla quale l’idea del Generale, al di là
della terminologia variamente impiegata, fu chiaro fin dalla guerra: l’unità tedesca – che
egli indicò sempre e soltanto con la parola “Reich” – non può essere ricostituita55. Così,
53 Conferenza stampa tenuta al Palais d’Orsay il 22 giugno 1951 in Discours et messages, cit.54 Conferenza stampa al Palais d’Orsay, 21 dicembre 1951 in Discours et messages, cit.55 Sul tema della Germania e della sua unità, De Gaulle si espresse nel discorso conclusivo della seconda Assise nazionale del R.P.F., Lille, 12 febbraio 1949 e nel discorso del 18 aprile 1948, entrambi in Discours et messages, cit.
3

che si chiamasse federazione o confederazione, l’unità dell’Europa non poteva farsi per
fusione degli Stati.
Malgrado si possa pensare che, tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio dei
Cinquanta, De Gaulle fosse favorevole a costruire l’unità europea mediante la cessione
della sovranità nazionale ad una qualche forma d’organizzazione continentale – tanto da
parlare di una “parentesi sopranazionale”56 – non possono esserci dubbi – anche col senno
del poi – sul fatto che per De Gaulle non potesse esistere altra prospettiva che una “Europa
delle patrie”.
3. De Gaulle contro la Quarta Repubblica
Per quanto frequentemente non la pensassero esattamente come lui e per quanto lo
stesso De Gaulle fosse dai più di questi inviso, gli uomini di stato e i politici francesi, al
pari del Generale, continuavano a serbare l’ambizione o la speranza che, finita la guerra
con l’ennesima sconfitta della Germania, la Francia sarebbe tornata, forte del suo Impero
interamente conservato, a recitare il ruolo di grande potenza mondiale e di arbitro
indiscusso della politica europea. Non fu il nazionalismo ad alimentare tale speranza, bensì
l’abitudine, che i francesi avevano appreso nel corso della storia, di guardare alla propria
patria come ad un grande paese, un’inesauribile fonte di civiltà universale, una guida per
tutti i popoli europei e non. In fondo, malgrado possano talvolta apparire di cattivo
carattere, come dar torto a questi francesi: hanno davvero avuto per secoli una potente
monarchia, affermato la cultura illuministica, decapitato un re, messo fine all’Ancien
Régime, enunciato la triade: liberté, égalité, fraternité, quasi unificato il continente con
Napoleone, diffuso un nuovo diritto civile e una nuova cultura politica, conquistato il
secondo Impero coloniale del pianeta, vinta una sacrificante guerra mondiale, riconquistato
un ruolo internazionale di primo piano nonostante le vicende negative della guerra al
56 Così si esprime il sito internet: www.gaullisme.org .
3

nazismo57. Solo ad una grande nazione è concesso vivere così a lungo e tra così tante e
gravose difficoltà58.
Per quanto si possa discutere sulla loro origine, natura e forma, gli Stati derivano
necessariamente la loro attuale condizione dal loro passato, ciò implicando che anche le
direttive della loro politica estera e militare – vale a dire la loro volontà di potenza –
scaturiscono dalla storia. Tali direttive, se non permanentemente, ne contrassegnano
senz’altro a lungo l’esistenza (la “missione”), a prescindere dalla transitorietà della vita
umana. Lo statista oculato di una qualunque nazione dal considerevole passato non può
non raccogliere l’eredità della storia del suo paese e non essere gravato dell’enorme
responsabilità di non contravvenire allo suo “Spirito”. Meno enfaticamente e più
57 In R. RÉMOND, La Francia e l’Europa, ‹‹Comunità Europee››, anno IX, n°12 del Dicembre 1963, quanto da noi scritto sulla concezione della Francia da parte dei francesi è espresso in modo molto più dettagliato: ‹‹Non vi è da stupirsi se il concetto di un’Europa a carattere sopranazionale non abbia incontrato in Francia, a tutta prima, un’accoglienza unanimemente favorevole. […] oggi ancora la Francia ha lo sguardo rivolto tanto verso l’Africa che verso l’Europa, e vivo ha il senso delle sue responsabilità pressanti nei riguardi dei popoli che a lungo furono alle sue dipendenze e tuttora rimangono suoi associati. Né questo orientamento verso altri orizzonti viene esercitato a scapito dell’Europa, poiché esso è sempre stato un fattore dell’espansione civilizzatrice di questo continente, diffondendo nel mondo, attraverso l’azione della Francia, i valori della civiltà europea. […] in primo luogo, ciò che può essere definito come il “nazionalismo francese” fu raramente xenofobo, ripiegato su sé stesso; se si escludono i rari momenti in cui l’opinione francese sofferse di un complesso di paura, il suo desiderio di mantenere in Europa il suo posto fu quasi sempre inseparabile dalla volontà di lavorare per tutti i popoli. Questa aspirazione all’universalità è una componente fondamentale del patriottismo francese […] anche ciò che a prima vista nella storia francese sembra essere il comportamento meno europeo, concorre invece a suo modo all’edificazione di una nuova Europa […] è la monarchia francese che rimette in auge il concetto di stato sovrano e subordina i vari corpi all’autorità di un potere centrale, al servizio dell’interesse generale […] con la Rivoluzione del 1789 la Francia ha forse fornito al mondo il suo apporto più sostanziale. Essa non si è limitata a vivere una singolare esperienza, ma ha inteso enunciare dei principi di portata universale ed indicare un esempio da imitare […] La Francia è stata la prima società a fondare l’ordinamento politico e l’autorità del potere sul consenso dei cittadini [...] la Francia ha per primo concepito la visione d’insieme della democrazia […] la Francia ha servito la civiltà europea anche in altro modo, diffondendola in altre parti del globo con la sua presenza, con l’irradiamento ed il prestigio della sua opera di colonizzazione […] essa ha potentemente contribuito all’avvento di una civiltà universale che trae appunto dall’Europa l’essenziale delle sue nozioni e dei suoi valori […] ››58 C. DE GAULLE, Mémoires d’espoir, cit, p. 13, esprime tale idea come segue « La guerre fait naître et mourir les Etats. Dans l’intervalle, elle ne cesse pas de planer sur leur existence. Pour nous, Français, depuis 1815 et jusqu’à 1870, ce qu’il est advenu de notre vie nationale, de nos régimes politiques, de notre situation dans le monde, a été déterminé par la coalition hostile qui unissait les Etats de l’Europe contre la Révolution […] Après quoi et au cours des quarante-quatre ans que dura la « paix armée », c’est notre défaite, le sourd désire de la réparer, mais aussi la crainte que l’Allemagne unifiée ne nous en inflige une nouvelle, qui dominèrent notre comportement intérieur et extérieur […] A présent et en conséquence du dernier conflit où elle faillit périr, d’après quelles données la nation française peut-elle régler sa marche et son action ? De ces données, la première est, qu’en dépit de tout, esse est vivante souveraine et victorieuse. Il y a là, certes, un prodige »
3

concretamente, egli non può non tener conto di tutto quel complesso di interessi politici,
militari, economici che si è venuto a creare nel corso dei secoli solo perché è animato da
una qualche ideologia o da una visione diversa delle cose. Non rispettando le aspettative e
gli interessi che in modo del tutto legittimo i cittadini, i gruppi di pressione, gli apparati,
etc.., hanno imparato ad assumere nel corso del tempo, egli non sarebbe un buon
governante. Di che mondo è mondo, da un governante – a prescindere dal suo carattere
democratico o autoritario – ci si attende sempre che soddisfi degli interessi collettivi.
L’europeismo connesso alla tutela e alla promozione degli interessi nazionali non fu solo
un atteggiamento del governo di De Gaulle: perché la Gran Bretagna, unica vera vincitrice
europea della guerra alla Germania nazista, unica vera potenza mondiale d’Europa (forte
dei suoi rapporti privilegiati con gli Stati Uniti), unica credibile candidata alla guida del
processo d’integrazione europea, nel 1949 decide di non impegnarsi nella causa del
Vecchio Continente? Perché ancora oggi i britannici sono tiepidi nei confronti degli
obblighi europei? La storia e la geografica delle isole britanniche le portano naturalmente a
vedere i propri interessi altrove: perché la Gran Bretagna, poi, dovrebbe legarsi ad un club
di vinti59 che le sarebbe solo da zavorra?60
Nessun governante francese avrebbe potuto e voluto rinunciare ai vantaggi che
derivavano al suo paese dal disinteresse inglese per l’Europa e dalla sconfitta tedesca.
Seppur con mezzi diversi rispetto a quelli auspicati da De Gaulle e comunque con
grandissima moderazione e discrezione, gli uomini della Quarta Repubblica non
perseguirono che l’interesse della Francia: ben consci dell’impossibilità di rivaleggiare con
Stati Uniti e Unione Sovietica o semplicemente di poter provvedere da sé alla garanzia dei
59 L’espressione è in B. OLIVI, op.cit., p.5760 In P.QUARONI, L’Europa al bivio, Milano, Ferro, 1965, p.91 si può leggere: ‹‹Fin dall’inizio, la posizione dell’Inghilterra nei riguardi della costruzione europea è stata sostanzialmente negativa. Non è né facile né necessario cercare di analizzare qui le ragioni del rifiuto inglese, che sono più di una: l’illusione di avere ancora la possibilità di una funzione autonoma, nazionale, nel mondo; una certa diffidenza per la mentalità europea e per le combinazioni continentali; l’attrazione di un mondo più vasto, rappresentato da un impero che, alla fine della guerra, copriva ancora una parte considerevole dell’orbe››
3

propri confini, quei uomini optarono per una strategia di basso profilo ma efficace. Solo in
tal modo può spiegarsi la disponibilità del governo francese ad accettare la proposta di
Monnet e di creare una comunità del carbone e dell’acciaio61.
Anche se l’iniziativa del governo francese, coronata da rapido successo, avrebbe
messo nelle mani di Parigi la leadership dell’Europa che andava integrandosi, De Gaulle
considerò fallimentare l’esperienza della Quarta repubblica ed il suo approccio alla
questione dell’unità del continente62.
Il problema essenziale sollevato da De Gaulle riguardo alle conseguenze della
guerra e della contrapposizione politico-ideologica tra Stati Uniti ed Unione Sovietica fu
quello dell’indipendenza dell’Europa nel suo complesso e degli Stati europei nel
particolare. Secondo De Gaulle, era chiaro che fosse l’indipendenza della Francia a
rappresentare il punto più critico del problema ed è possibile affermare che nel linguaggio
di De Gaulle la perdita dell’indipendenza significhi incamminarsi lungo il sentiero della
decadenza: così, delegando la propria difesa e la propria sicurezza alla NATO, l’Europa, e
con essa la Francia, si erano arrese alla décadence in quanto non avrebbero avuto più la
61 Perseguendo l’obiettivo di mantenere per la Francia uno status di potenza mondiale, la Quarta Repubblica cercò in tutti i modi di mantenere in vita l’Impero, prima riformandolo con l’istituzione di una “Unione francese”, poi impegnandosi sul fronte militare in dispendiosissime campagne in Indocina e in Algeria; si oppose strenuamente all’unificazione delle aree d’occupazione occidentali della Germania e alla sua stessa ricostituzione in stato unitario. Inoltre, è possibile ricondurre la dichiarazione Schuman, così come le altre iniziative francesi per l’integrazione europea, a precise esigenze di politica estera della Francia. Sotto questo profilo la proposta Schuman va vista come un’abilissima iniziativa diplomatica francese, che senza dubbio permise alla Francia di iniziare la ricostituzione di una zona di influenza con nuovi mezzi. Sulla questione: S. ROMANO, op.cit., p.178, G. MAMMARELLA, P. CACACE, op.cit., pp. 45-49, B. OLIVI, op.cit., pp. 39-40;62 Un pessimo giudizio sulla Quarta repubblica è espresso in C. DE GAULLE, Memorie della speranza, cit., p.13‹‹Quello che io avevo realizzato a costo di aspri sforzi per l’indipendenza, il rango e gli interessi della Francia, fu ben presto compromesso. Venuta meno l’energia grazie alla quale ci si teneva in piedi, il regime s’industriava soprattutto a soddisfare gli altri, trovando, beninteso, per coprire questa resa, le ideologie opportune: l’una che liquidava in nome dell’unità europea i vantaggi procuratici dalla vittoria; l’altra che sottometteva la Francia all’egemonia anglosassone col pretesto della solidarietà atlantica. Così venne accettato, nonostante l’assenza di valide garanzie, il ristabilimento di un potere centrale tedesco nelle zone occidentali. Così veniva istituita la “Comunità europea del carbone e dell’acciaio”, che, senza dare alle nostre miniere distrutte i mezzi per riprendere a funzionare, dispensava i tedeschi dal fornirci gli indennizzi di combustibili e procurava agli italiani il necessario perché si dotassero di una grande siderurgia. Così veniva abbandonata l’assimilazione alla Francia dell’economia della Sarre e il mantenimento in questo territorio dello Stato autonomo che era stato creato Così si approvava la creazione di una “Comunità europea di difesa” che avrebbe tolto alla Francia vittoriosa il diritto di avere un esercito […] per rimettere il comando di questo insieme apatride agli Stati Uniti d’America››.
4

possibilità di provvedere alla propria sicurezza e in quanto sarebbero state dipendenti dalle
strategie difensive degli anglo-americani nel caso di un’iniziativa sovietica improvvisa.
Senza contare che, nel caso in gli americani avessero giudicato più saggio, onde
scongiurare un conflitto atomico apocalittico, non reagire affatto, l’Europa sarebbe stata
totalmente indifesa. Dal suo punto di vista, la Francia della Quarta repubblica commetteva
un gravissimo errore a partecipare in modo disciplinato, ossia senza chiedere di essere
trattata alla pari, all’Alleanza Atlantica; tuttavia, vista la drammatica situazione economica
e militare francese – come di tutta l’Europa d’allora – anche De Gaulle si rendeva conto,
almeno per il momento, di quanto fosse necessaria quell’alleanza63. Proseguendo con la
stessa argomentazione, De Gaulle giudicò negativamente l’istituzione della CECA, in
quanto basata sul principio per cui gli Stati debbono cedere una parte della loro sovranità
ad un organismo internazionale che, per quanto europeo, ha il difetto genetico di essere
stato costituito senza previamente consultare i popoli interessati.
4. Contro la CECA
Frutto dell’applicazione delle idee funzionaliste, la CECA, al fine di risolvere i
problemi e sminuire le paure francesi dell’epoca, secondo De Gaulle non fu né una
soluzione politicamente buona né economicamente equilibrata. Politicamente, essa non fu
buona in quanto implicava per gli Stati e per i popoli europei la perdita della sovranità
(seppur parziale). A questa prospettiva De Gaulle opponeva l’idea della confederazione,
cioè, della definizione di istituzioni di carattere non sopranazionale, investite dai popoli e
di tal fattura da non ledere l’indipendenza e la sovranità di ciascuno Stato partecipante64.
Solo attraverso simili istituzioni, egli pensa, la questione dei rapporti con la Germania
63 Cfr. C. DE GAULLE, Memorie della speranza, cit., p.18364 Cfr. Conferenza stampa del 21 dicembre 1951 in Discours et messages, cit.
4

potrà trovare una buona soluzione, malgrado che, per la venuta in esistenza della
Germania, la sua idea originaria sulla confederazione non sia più perfettamente applicabile:
Vous me demandez d’abord si je conçois que l’Allemagne sous la forme d’un
Reich puisse entrer dans une Confédération européenne. Vous savez que j’ai
dit, en effet, depuis la fin de la guerre, et même avant, que la paix serait plus
probable et l’Europe plus facile à faire si l’Allemagne ne reparaissait pas sous
la forme d’un Reich. Combien de questions, en particulier celle de la Rhur et
celle de la Sarre, eussent été beaucoup plus simples si on n’avait pas, par les
absurdes accords de Londres, malgré moi et contre moi, restauré le Reich
allemand. […] A présent je suis obligé comme tout le monde, de prendre les
choses comme elles sont65.
Per De Gaulle si era operata una scissione tra la questione della Germania e quella
dell’unità europea che, invece, non avrebbe dovuto consumarsi. Il Generale, assumendo il
presupposto che il problema tedesco fosse esso stesso il problema europeo, proponeva in
primo luogo un accordo storico tra francesi e tedeschi e che il mantenimento della
divisione della Germania nei suoi stati tradizionali fosse riassorbito all’interno di un
vincolo confederale europeo, il solo nel quale gli stati tedeschi avrebbero potuto conoscere
di nuovo una qualche forma di legame. Con la confederazione, le risorse della Rhur e della
Sarre non sarebbero state messe in comune ed il loro sfruttamento regolato da un’autorità
amministrativa internazionale, bensì messe a disposizione dell’intera confederazione e
finalizzate a rendere l’Europa di nuovo indipendente66. La ricostituzione della Germania
con piena sovranità sulla Rhur e sulla Sarre (invero, in questo caso solo a partire dal 1957),
pur snaturando il progetto originario, non fece quindi cambiare idea a De Gaulle circa
l’opportunità di una confederazione.
65 Ibid.66 Parlando della Rhur e della Sarre, De Gaulle manifestava il timore che la Germania potesse sfruttarle per tornare ad essere una minaccia militare e per questo proponeva di legare i tedeschi alla Francia, per mezzo dell’Europa: ‹‹Les Allemands doivent renaître comme des hommes associés à l’effort commun de l’humanité pour sa reconstruction, et spécialement à l’effort commun de l’Europe, mais jamais plus ils ne doivent retrouver les moyens de redevenir une menace ». La citazione è tratta dalla conferenza stampa del 12 novembre 1947 in www.gaullisme.org. Un altro discorso degno di nota trattante la Rhur e la Sarre è quello pronunciato a Vincennes 22 maggio 1949 disponibile nello stesso sito.
4

Non solo la decisione di fondare la CECA non fu politicamente buona (si tralascia
di sottolineare il fatto che, per il suo carattere settoriale, la CECA in sé stessa non poteva
fare l’Europa), ma tale soluzione non fu nemmeno equilibrata in ambito economico perché,
a dire di De Gaulle, pur ammettendosi la necessità dello sfruttamento in comune del
carbone e dell’acciaio, la CECA finiva per favorire tutti i membri fuorché la Francia, la
quale avrebbe avuto tutto l’interesse ad integrare in una comunità europea anche settori
economici in cui la sua superiorità, rispetto ai partners, fosse palese come nel caso
dell’agricoltura:
En outre, pourquoi traiter séparément pour le charbon et l’acier, domaine sur
lequel, comme par hasard, nous nous trouvons en état d’infériorité ? pourquoi
ne pas traiter en même temps en d’autres domaines économiques où nous
avons, au contraire, l’avantage, comme par exemple les produits agricoles
[…]? Quant au cas spécial du pool charbon-acier, il est évident qu’il y a un
intérêt européen à ce que le charbon et l’acier soit exploités en commun. Je ne
sais pas si vous vous rappelez qu’il y à quelques années, quand j’étais au
Gouvernement, mon plan était de faire en sorte que la Ruhr fit, en tant que
telle, partie intégrante de la Confédération européenne que je projetais. Ainsi
son charbon et son coke auraient pu être utilisés par tous les confédérés. Après
de moi, bien entendu, on a renoncé à cette idée. On l’a remplacée par une
caricature qui s’appelait l’autorité de la Ruhr, la quelle autorité devait être
qualifiée pour fournir à la France le coke indispensable à sa métallurgie […]
Or, parmi les quatre contractants du pool, la France se trouve, comme un
hasard, la seule qui soit désavantagée67
L’argomento adoperato da De Gaulle, in realtà, è piuttosto controverso e – ci
azzardiamo a dire – originale. Egli sostiene che dall’associarsi ad altri paesi nel settore
carbo-siderurgico la Germania, avendo così tanto carbone e ferro da estrarre, avrebbe
ricevuto solo vantaggi per la convenienza a cederli; che l’Italia avrebbe avuto tutto da
guadagnarvi per via della povertà del suo sottosuolo; che i paesi del Benelux sarebbero
stati sostanzialmente indifferenti in quanto già soddisfatti dalla propria produzione. La
67 Conferenza stampa del 21dicembre 1951in Discours et messages, cit.
4

Francia, invece, ‹‹qui, elle, a du fer, mais peu de charbon et peu de coke››68, sarebbe stata
in balia delle decisioni dell’Alta Autorità per quanto riguardava i sui approvvigionamenti.
L’argomento è originale per la domanda che spontaneamente ispira: perché la Germania,
ricostituita (parzialmente) nella sua sovranità statale, dovrebbe accettare di condividere con
altri la sua ricchezza? perché il Benelux dovrebbe associarsi ad un’organizzazione alla
quale è indifferente? perché l’Italia, anch’essa dipendente dalle decisioni dell’Alta
Autorità, avrebbe più da guadagnarvi che la Francia? La verità è che, al di là di tutte le
particolari argomentazioni – peraltro discutibili – nel sistema di pensiero di De Gaulle tutto
prima o poi deve ricondurre alla politica e alla ragion di stato. Il vero motivo della sua
opposizione alla CECA, quindi, non fu di natura tecnica, ma squisitamente politico: il
rifiuto della sopranazionalità.
Fin dall’inizio De Gaulle avversò l’applicazione di tale principio perché limitante
dell’indipendenza e della sovranità dello Stato. Cosa avrebbe comportato, infatti,
l’applicazione di detto principio e la messa in funzione dell’Alta Autorità? Che il governo
francese non avrebbe più avuto il controllo sulle decisioni relative ad una materia di così
grande importanza sia industriale che militare, e, inoltre, che si sarebbe dovuto
sottomettere alle decisioni di un potere, per costituzione, incurante degli interessi nazionali
e particolarmente di quelli francesi. Senza carbone e acciaio, insomma, non c’è possibilità
alcuna di grandeur. Dato che la federazione tanto ambiguamente da lui proposta in
alternativa alla Comunità avrebbe comunque comportato delle cessioni di sovranità, è
lecito chiedersi cosa proponesse, davvero, De Gaulle.
La polemica condotta contro la CECA mise fortemente in luce i limiti della
proposta del Generale, evidentemente ponendolo in un qualche disagio: non a caso – e in
tal modo ci ricolleghiamo, chiudendola del tutto, alla questione della “parentesi
sopranazionale” – questo dibattito lo indusse ad abbandonare in modo definitivo ‹‹le vaghe
68 ibid.
4

aspirazioni federative›› fin lì manifestate e a contrapporre ‹‹un’Europa di nazioni
confederate a un’Europa sopranazionale, dominata dai tecnocrati e ispirata direttamente
dagli anglosassoni, desiderosi di tutelare i loro interessi››69. Da questo momento, De
Gaulle comincerà a chiarire le sue idee, parlando sempre meno finanche di confederazione
e iniziando a promuovere, invece, una qualche forma di “associazione” o di “unione” degli
Stati.
5. Un’Europa franco-tedesca
Dopo la clamorosa firma del trattato istitutivo della Comunità Economica Europea,
ci si cominciava a rassegnare all’idea che esso sarebbe rimasto lettera morta per l’inatteso
ritorno al potere in Francia di Charles De Gaulle in conseguenza dei drammatici fatti
d’Algeri. Praticamente da ogni parte si dava per certo che il trattato, ancora in attesa di
essere applicato da Parigi, sarebbe stato presto denunciato dal nuovo governo, il quale non
nascondeva, oltre alla sua ostilità al principio sopranazionale, che ‹‹l’esprit et les termes››70
dello stesso trattato non corrispondessero agli interessi del paese. Ciò era soprattutto
dovuto alla vaghezza con cui si trattava della materia agricola, la cui regolamentazione in
sede comunitaria doveva essere assolutamente indispensabile, anche a costo di liquidare il
Mercato Comune71. In effetti, per De Gaulle bisognava cambiare tutto quanto s’era fatto in
Europa dalla fine della guerra, giacché egli non vincolava il suo ritorno al governo alla sola
risoluzione della crisi d’Algeria. Per lui si sarebbe trattato di imporre un cambiamento
radicale alla politica francese e agli equilibri internazionali. In breve, la storia doveva
essere riscritta.
69 G. QUAGLIARIELLO, op.cit., p.19170 C. DE GAULLE, Mémoires d’espoir,cit, p.14671 Cfr. ibid.
4

Il ritorno di De Gaulle, sopra gli altri, inquietava la Germania e personalmente il
cancelliere Adenauer, contro il quale il Generale si era violentemente scagliato nel 1953
per la sua dedizione alla causa comunitaria:
Monsieur Adenauer veut être européen. Il souhaite qu’on fasse l’Europe. Fort
bien ! Mais croit-il que ce soit faire l’Europe, n’est-ce pas plutôt la tuer, que
de fabriquer, à grand renfort d’interventions américaines, ce monstre artificiel,
ce robot, ce Frankenstein, que, pour tromper le monde, on appelle la
Communauté? Monsieur Adenauer ne croit-il pas qu’il y aurait beaucoup
mieux à faire? 72
Per realismo De Gaulle s’era fatto tosto una ragione che la Germania fosse stata
ricostituita, nonostante seguitasse a vedere negli eventi del 1949 qualcosa che invero
aggravava il problema dei fragili equilibri europei. La costituzione delle due repubbliche,
oltre che rendere ufficiale la totale incomunicabilità dei due blocchi – malgrado l’ONU e la
consapevolezza che una deflagrazione nucleare avrebbe potuto distruggere l’intera umanità
– riportava in auge il fattore d’instabilità che aveva condotto l’Europa al dramma: la
riapparizione di una Germania sovrana e militarizzata al confine con la Francia.
Nondimeno, il primo atto di politica estera del nuovo governo francese fu
improntato a stabilire rapporti d’amicizia e di collaborazione tra i due paesi, nella
prospettiva di costituire un vero e proprio asse su cui far ruotare i nuovi indirizzi della
politica estera francesi e di rendere reale il disegno di un’Europa indipendente da entrambi
i blocchi in concorrenza. L’occasione fu l’incontro dei due leaders di governo presso
Colombey-Les-Deux-Eglises, residenza privata di Charles De Gaulle73. Così operando, De
Gaulle mostrò la sua intenzione di essere coerente a quanto lungamente dichiarato durante
gli anni precedenti, ossia di ritenere indispensabile un accordo politico globale e generale
tra la Francia e la Germania, in luogo di quelle insufficienti intese settoriali volte solo a
72 Conferenza stampa tenuta all’Hotel Continental il 12 novembre 1953 in Discours et messages, cit..73 Per un resoconto dell’incontro: C. DE GAULLE, Mémoires d’espoir, cit, pp.139-143
4

creare organi burocratici e annientare la politica. La prima preoccupazione del Presidente
è, però, che la Germania non debba più rappresentare una minaccia per la Francia:
Au coeur du problème et au centre du continent, il y a l’Allemagne. C’est
son destin que rien ne peut être bâti sans elle et que rien, plus que ses
méfaits, n’a déchiré l’Ancien Monde […]Désormais, toutes précautions
doivent être prises pour prévenir le retour en force des mauvais démons
germaniques74
A tal riguardo, quindi, non poteva astenersi dal dettare le sue condizioni alla
Germania: l’accettazione del fatto compiuto per quanto riguardava le frontiere, un
atteggiamento che mostrasse buona volontà per i rapporti con l’Est, una rinuncia completa
agli armamenti atomici, una grande pazienza per la riunificazione75.
Per De Gaulle questa alleanza privilegiata, cioè, questo accordo politico generale
con la Germania doveva servire a modificare, dapprima, gli equilibri continentali e, in
seguito, finanche quelli mondiali. Più precisamente, il suo obbiettivo era di sostituire ad
una “Europa atlantica” una “Europa europea” tramite il distacco della Germania
dall’alleanza atlantica o, quanto meno, l’attenuazione dei suoi legami con gli Stati Uniti.
Per un accordo politico generale, De Gaulle intendeva ciò che poi sarà disposto nel trattato
franco-tedesco del 22 gennaio 1963 e vale a dire, essenzialmente, un “metodo” per
affrontare e risolvere insieme i problemi del Continente76.
In sostanza, la riconciliazione tra la Francia e la Germania, per De Gaulle, non
doveva essere importante in quanto premessa necessaria per l’unificazione dell’Europa
(che per lui – lo si ricorda – non fu mai un fine, bensì un mezzo), ‹‹ma nel senso che
74 C. DE GAULLE, ivi, cit., p.13875 Cfr. C. DE GAULLE, ivi,cit., pp. 147-14876 Il 22 gennaio 1963 De Gaulle e Adenauer firmarono il trattato sulla cooperazione franco-tedesca col quale, sancirono ufficialmente la riconciliazione franco-tedesca e fissarono le regole della consultazione periodica tra Capi di Stato e di governo, ministri degli esteri, della difesa della pubblica istruzione. Con tale accordo, De Gaulle pensò di aver costituito, in Europa, il contrappeso all’alleanza privilegiata tra Stati Uniti e Inghilterra. Il trattato, però, aveva anche la funzione di stabilire una sorta di direttorio europeo per consentire al meglio il funzionamento delle Comunità. Quest’asse, comunque già esistente ufficiosamente prima del 22 gennaio 1963, aveva lo scopo di preparare le decisioni più importanti del Consiglio dei ministri e dei vertici di capi di governo e a definire l’indirizzo della politica comunitaria. Per approfondimenti si possono consultare L.LEVI, U. MORELLI, op.cit., p.155 e P. QUARONI, op.cit, pp. 109-113.
4

Francia e Germania erano le due sole Potenze autorevoli e che, una volta d’accordo loro,
gli altri dovevano semplicemente seguirle››77. L’alleanza privilegiata con la Germania
federale e gli stretti rapporti personali stabiliti con il cancelliere Adenauer costituiranno la
base solida su cui il presidente De Gaulle vorrà edificare la propria azione in Europa.
Il rapporto personale instauratosi tra De Gaulle e Adenaeur sorprende solo in
apparenza. I motivi possibili d’attrito tra i due furono gli stessi che ne permisero
l’amicizia: entrambi volevano che la propria nazione recitasse una parte da protagonista in
Europa e nel mondo. In fondo, è stata proprio l’opportunità di far riabilitare politicamente
la Germania e di farla tornare una grande potenza economica ad aver spinto Adenauer a
sostenere l’Europa delle Comunità; quindi, non l’intento di annullare l’identità tedesca in
quella europea, ma la volontà opposta di far rinascere la Germania grazie all’Europa78.
Comprese ed assecondate le vere intenzioni del collega tedesco, De Gaulle poté
agevolmente fondare sulla loro intesa – una sorta di direttorio o forse un duumvirato – la
proposta di avviare il negoziato sull’unione politica79.
La premessa dell’accordo tra i due uomini di governo era che l’Europa poteva farsi
solo per associazione degli Stati e non già richiedendone la liquidazione. Questa premessa
era in sé stessa la ricusazione della “apatride” Europa di Monnet:
Per Adenauer, come per me, è da escludere che i nostri popoli, con i loro
Stati e le loro leggi, possano scomparire all’interno di una qualche
costruzione apatride, sebbene egli ammetta di aver tratto a profitto della
Germania solidi vantaggi dalla mistica dell’integrazione […]80
77 P. QUARONI, op.cit., p.10978 Ciò che pensava Adenaeur dell’Europa è bene espresso in P.QUARONI, op.cit., pp.110-111: ‹‹L’orientamento di De Gaulle ha trovato un’eco più che favorevole in Adenauer. Adenauer è indubbiamente un grandissimo personaggio: è l’uomo che ha preso in mano la Germania ridotta a un mucchio di rovine e a un paria nella comunità internazionale, e in pochi anni l’ha trasformata in alleata dei vincitori […] La riconciliazione con la Francia era lo scopo numero uno della su politica; e l’Europa non un fine, ma soltanto un mezzo per realizzare questa riconciliazione. Egli conosceva abbastanza bene la situazione politica francese interna e le sue complesse reazioni. Sapeva che non era possibile imbastire una riconciliazione tramite rapporti diretti: ci voleva qualcosa di più vasto, un ideale comune, degli altri partecipanti: ci voleva l’Europa›› 79 Si ricorda che l’avvio del negoziato fu deciso nel corso dell’incontro di Rambouillet del 29 luglio 196080 C. DE GAULLE, Memorie della speranza, cit.,p.161
4

L’accordo con la Germania federale, però, non doveva servire solo a preparare il
progetto di unione politica, essendo tale accordo ritenuto necessario anche per iniziare da
subito a praticare la “Europa delle patrie”, mediante l’introduzione, nella prassi di
Bruxelles, di un nuovo spirito. Le istituzioni comunitarie e i suoi sostenitori avrebbero
dovuto arrendersi all’evidenza che l’Europa poteva farsi solo assumendo gli Stati quali
suoi fondamenti, giacché, in ultima analisi e nonostante l’impegno della Commissione
Hallstein, i governi nazionali erano effettivamente gli unici responsabili dell’esecuzione
dei trattati nel rispetto della loro autorità e della sovranità popolare. Le differenze dovute
alla loro propria storia, alla loro lingua, alle loro ambizioni, al loro genio, non dovevano
essere visti come degli ostacoli:
Construire l’Europe, c’est-à-dire l’unir, c’est évidemment quelque chose
d’essentiel […]or, quelle sont les réalités de l’Europe? Quels sont les
piliers sue lesquelles on peut la bâtir ? en vérité, ce sont des états qui sont,
certes, très différents les uns des autres, qui ont chacun son âme à soi, son
Histoire à soi, sa langue à soi, ses malheurs, ses gloires, ses ambitions à
soi, mais des Etats qui sont les seules entités qui aient le droit d’ordonner
et l’autorité pour agir. Se figurer qu’on peut bâtir quelque chose qui soit
efficace pour l’action et qui soit approuvé par les peuples en dehors et au-
dessus des états, c’est une chimère81
La prima pratica conseguenza dell’accordo tra De Gaulle e Adenauer fu l’appoggio
che il secondo diede al primo nella battaglia intrapresa da quest’ultimo per ottenere
l’inclusione dell’agricoltura nel Mercato Comune, secondo modalità che alterarono
definitivamente lo spirito comunitario, in precedenza alieno al concetto della reciprocità
tipico dei rapporti tradizionali tra gli Stati82. Per De Gaulle, però, questo non era un
problema visto che il trattato CEE, piuttosto che quella sorta di costituzione che era nella
mente degli europeisti, era solo un semplice ‹‹traité de commerce facilitant les échanges et
81 Conferenza stampa tenuta al palazzo dell’Eliseo il 5 settembre 196082 Cfr. B. OLIVI, op.cit., p.87
4

obligeant notre industrie à se moderniser›› 83, il quale, in quanto tale, se non rispondente
agli interessi economici del suo paese, poteva e doveva naturalmente essere modificato
come un qualunque altro trattato, pena, in questo caso, la definitiva rovina del Mercato
Comune.
Il fatto che un interesse così vitale per la Francia non fosse stato seriamente preso in
considerazione da coloro che avevano negoziato il trattato costituiva una dimostrazione in
più che questo non rispondeva alle sue necessità e, conseguentemente, che anche gli organi
previsti dal trattato, in primis la Commissione, non ne assecondassero le esigenze.
6. All’attacco della CEE
Dall’entrata in vigore del Mercato comune e dal suo ampliamento ai prodotti
agricoli, la Francia aveva guadagnato molto. Considerando tali successi come il frutto della
sua azione riformatrice, De Gaulle si sentì nel giusto a seguitare nella sua politica di
demolizione delle Comunità. In modo particolare, fu contro la Commissione della
Comunità Economica guidata da Walter Hallstein che si scagliò violentemente, perché
accusata di volersi accreditare come un governo federale portando alle estreme
conseguenze l’applicazione della sopranazionalità (d’altra parte, era proprio questo
l’auspicio dei sostenitori del metodo funzionalista).
De Gaulle manifestò costantemente la sua avversione per la sopranazionalità
mediante le sue numerose pubbliche dichiarazioni, la pratica delle istituzioni comunitarie e
le mosse di politica estera del suo governo. Benché cercasse, allo stesso tempo,
energicamente e gradualmente di imporre all’Europa la sua visione chiedendo a gran voce
l’apertura di un negoziato per la cooperazione politica e, contemporaneamente, logorando
le Comunità dal loro interno, vi fu un evento in cui De Gaulle fece toccare il punto più
83 Nota al Primo Ministro M. Debré a proposito della politica europea, 27 febbraio 1961 in Lettres, notes et carnets 1961-1963, Paris, Plon, 1986, pp.48-49
5

elevato e drammatico del suo dissidio con la Commissione Hallstein: la cosiddetta “crisi
della sedia vuota”84.
De Gaulle non aveva mai nascosto la sua profonda irritazione per l’attivismo del
presidente Hallstein, reo di attribuirsi i crismi della sovranità e di mirare a creare un super-
Stato europeo85. Alla base di questo dissidio, però, non bisogna vedere solo un conflitto tra
due centri di poteri per la leadership dell’Europa, ma la concorrenza tra due visioni
antitetiche, di cui una, quella del francese, si preoccupava di garantire che lo Stato, e in
ultima analisi il popolo che ne elegge il governo rappresentativo, non fosse spogliato delle
sue prerogative sovrane per favorire l’avvento, secondo l’impostazione del tedesco e in
attesa che la Commissione diventi per davvero il governo federale d’Europa, di una
“tecnocrazia apatride” politicamente irresponsabile. La giusta dimensione della
Commissione Economica deve essere quella di facilitare la cooperazione tra gli Stati
84 La crisi della sedia vuota fu il rifiuto della Francia di far partecipare i propri rappresentanti alle riunioni del Consiglio e della Commissione, dal 30 giugno 1965 al 29 gennaio 1966, per protestare contro la proposta della Commissione Hallstein di attribuire risorse proprie alla Comunità Economica. Poiché s’avvicinava la data della completa liberalizzazione degli scambi commerciali – il 1°gennaio 1967 – la Commissione Hallstein, col solo voto dei due commissari francesi, aveva proposto che si dotasse la Comunità Economica di risorse proprie attraverso la costituzione di una “cassa comune” costituita dai proventi dei diritti doganali e dei prelievi agricoli. La proposta della Commissione non si esauriva solo nella richiesta di risorse proprie, poiché ne erano naturali corollari l’attribuzione sia di un enorme budget finanziario alla Commissione che di reali poteri di bilancio all’Assemblea parlamentare. In sé la proposta era più che sensata ed opportuna, giacché, diversamente da come era stata disegnata nel trattato di Roma, la Commissione si trovava adesso a dover sovrintendere ad una dispendiosissima opera: la politica agricola. Fu, dunque, per ironia della sorte (ma non troppo!), proprio l’ostinazione di De Gaulle di voler “violentare” la Comunità Economica ed affermare, allo stesso tempo, il primato della politica sulla mera amministrazione dei tecnici, ad indurre la Commissione a reagire come fece. La proposta, si è detto, era più che sensata ed opportuna, da un lato perché mirava, sotto questo profilo, ad omogeneizzare la CECA e la CEE, visto che la prima dispose fin dall’inizio di risorse proprie (e tornato al potere De Gaulle non sembra che contestò la cosa, accanendosi invece solo contro la Commissione Hallstein); dall’altro, perché essa s’innestava perfettamente nella logica e nel metodo della “sincronizzazione” – ossia la pratica che ogni concessione fatta ad un paese dovesse adesso avvenire in condizione di reciprocità – inaugurato proprio all’indomani della “maratona agricola”. Va notato, infine, che la proposta proveniva da un profondo sostenitore delle tesi di Monnet, ossia quel Walter Hallstein che, al pari del francese, riteneva che la Comunità fosse un complesso di strumenti giuridici atti a “forzare la storia”, onde addivenire alla federazione europea. 85 ‹‹ Walter Hallstein est le Président de la Commission. Il épouse ardemment la thèse du super-Etat et emploie toute son habile activité à obtenir que la Communauté en prenne le caractère et la figure. De Bruxelles, où il réside, il a fait comme sa capitale. Il est là, revêtu des aspects de la souveraineté, dirigeant ses collègues entre lesquels il répartit les attributions […] Ces raisons n’altèrent pas l’estime et la considération que je porte à Walter Hallstein mais font que les buts que je poursuis pour la France sont incompatibles avec de tels projets›› in C. DE GAULLE, Mémoires d’espoir, cit.,p.147
5

mediante lo svolgimento di soli compiti tecnici e di supporto a quelle decisioni finali che
solo gli Stati sono legittimati a prendere e capaci di far eseguire86.
L’azione politica attuata nelle Comunità, in definitiva, fu molto ambigua (ma non
priva di logica). Da un lato De Gaulle cercò di sfruttare al massimo le vantaggiose
possibilità economiche che il trattato offriva, disponendovisi favorevolmente al suo
ritorno al potere nel 1958 e finanche inducendo la Francia ‹‹al sacrificio della delega della
sovranità [solo] nella misura in cui questo apriva i mercati dei Sei ai suoi prodotti
agricoli››87. Dall’altro, cercò in ogni modo di stancarne lo spirito originario e di alterarne
le meccaniche di funzionamento in modo da poter affermare il primato della politica sulla
“tecnocrazia” in attesa che l’unione politica si compisse.
7. L’Europa dei popoli
Nel concepire i modi con cui raggiungere l’unità europea, è interessante osservare
come De Gaulle abbia proposto le medesime soluzioni applicate in patria per la
“riunificazione” della Francia e dei francesi. Per il Generale, quanto per il Presidente, non
poteva esistere alcuna Europa senza i caratteri della sovranità e dell’indipendenza. Ora, se
la sovranità appartiene al popolo, l’Europa unita non può farsi senza il diretto
coinvolgimento dei popoli europei. Allo stesso tempo, non può costituirsi alcuna autorità
legittima se, posto che l’Europa è in pericolo, una personalità eccezionale non provveda a
farsi carico della sua salvezza.
Per De Gaulle il referendum, oltre ad essere uno strumento strategico per aggirare
l’opposizione di un parlamento dominato da “corpi intermedi”, era il miglior mezzo per
fare direttamente partecipare i cittadini alle grandi scelte nazionali. Esso, però, era anche il
miglior strumento per esplicitare l’unione “mistica” tra un popolo ed il suo capo e la
86 Conferenza stampa del 31 janvier 1964 in Discours et messages, cit.
87 B. OLIVI, op. cit., p.100
5

costanza di quel rapporto fiduciario che, in ultima analisi, conferiva solo al capo la
rappresentanza nazionale.
Tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio dei Cinquanta, De Gaulle aveva avanzato
l’idea del referendum da tenersi in contemporanea in tutti gli Stati interessati, in modo da
conferire un carattere democratico e popolare alla costruzione europea. In particolare, egli
sosteneva che bisognasse porre tre domande ai popoli europei:
Voulez-vous qu’on fasse l’unité de l’Europe, notamment au point de vue
de son économie, de sa culture et de sa défense ? Voulez-vous que l’on
constitue un organe confédératif des peuples de l’Europe pour gérer cette
unité? Pour élaborer les institutions européennes, voulez-vous nommer
une Assemblée? 88
La proposta di De Gaulle, quindi, era che i popoli europei venissero interpellati per
decidere non solo sulla vaga idea di realizzare una qualche forma di unione, ma anche sulla
necessità di eleggere un’assemblea costituente per definire le istituzione di questa unione.
Inoltre, pensando che tale referendum avrebbe dovuto svolgersi anche nei paesi comunisti,
si faceva certo di trascinare anche tali paesi nell’unità di tutto il continente, e non già della
sola parte occidentale. Il ricorso allo strumento referendario fu caldeggiato soprattutto
prima del suo ritorno al potere; tuttavia, anche da presidente De Gaulle non abbandonò
completamente tale idea, pensando che le istituzioni confederali da dare all’Europa
dovessero fondarsi su di un regolare concerto dei governi responsabili e sul lavoro di
organismi specializzati nel trattare le materie poste in comune, nonché su di un’assemblea
periodicamente convocata e chiamata a deliberare, infine, su di ‹‹un solennel référendum
européen, de manière à donner à ce démarrage de l’Europe le caractère d’adhésion et de
conviction populaire qui lui est indispensable›› 89.
88 Conferenza stampa tenuta al Palais d’Orsay il 14 novembre 1949 in www.gaullisme.org. L’idea del referendum sarà ribadita anche all’Hotel Continental il 25 febbraio 1953 (il discorso è consultabile in Discours et messages, cit.) 89 Conferenza stampa tenuta al palazzo dell’Eliseo il 5 settembre 1960 in Discours et messages, cit.
5

Frequentemente si parla del sistema di governo istituito in Francia da De Gaulle
come di un nuovo bonapartismo, se non addirittura della versione presentabile di un regime
fascista; nondimeno, facendo lo sforzo di andare oltre certe categorie tradizionali – e
comunque tenendo in debito conto che effettivamente De Gaulle forzasse più di una volta
la sua stessa costituzione, attribuendosi sempre maggiori prerogative90– è possibile vedere
nelle concezioni istituzionali di De Gaulle il tentativo di dare vita ad una forma diretta di
democrazia nazionale. Questo può essere affermato, in primo luogo, perché ‹‹sarebbe un
grave errore ignorare come il fatto di rendere possibile il contatto diretto tra il vertice dello
Stato e la sovranità popolare abbia rappresentato una preoccupazione di fondo del
gollismo››91; in un secondo luogo, perché, malgrado la costituzione e la prassi politica
concentrassero grandi poteri nelle sue mani De Gaulle ‹‹non ha revocato la Repubblica,
non ha ricostituito la dinastia, neppure una di diversa natura››92. Infine perché,
appoggiandosi al popolo, consultato nella sua totalità contro le assemblee di rappresentanti,
‹‹il gollismo incarnava una certa concezione della democrazia diretta, che trovava la sua
applicazione nella pratica del referendum››93. Nonostante queste premesse, nel piano
Fouchet non vi fu nessuna traccia di istituzioni democratiche.
Infine, era opinione di De Gaulle che per unire un popolo come quello europeo, al
pari di quanto era avvenuto in Francia, ci sarebbe voluta l’affermazione di un’autorità
legittima, un fédérateur. Ora, De Gaulle non vedeva alcuna simile figura in Europa,
giacché, per la refrattarietà delle nazioni a fondersi in una sola, fallirono nell’impresa, a
loro tempo, i vari Cesare, Carlo Magno, Ottone, Carlo V, Napoleone e, più di recente,
Hitler94. Solo gli Stati Uniti potrebbero riuscirvi (infatti: ‹‹Il y aurait peut-être un 90 A tal proposito J. SOUSTELLE, Gollismo. Ventotto anni di regime, Milano, Edizioni del Borghese, 1969, op. cit., p.168 ‹‹Ho già mostrato che la sovversione della legge costituzionale cominciò fin dal primo giorno del nuovo regime, con ritocchi insensibili e invisibili al pubblico, grazie alla complicità del Primo Ministro Michel Debré›› 91 G. QUAGLIARIELLO, op.cit., p.3992 J.L. CHABOT, op.cit., p.13893 R.RÉMOND, op.cit, p.30994 Cfr. Conferenza stampa all’Eliseo del 15 maggio 1962. Dello stesso tenore è la conferenza stampa all’Eliseo del 9 settembre 1965. Entrambe sono state tratte da
5

fédérateur, mais il ne serait pas Européen95››) ma a quel punto l’Europa avrebbe perduto la
sua identità. Inoltre, tanto era nota l’impossibilità di unire l’Europa, che chi vi aveva per
ultimo provato aveva dovuto affidare l’Europa a dei burocrati. A qualunque idea di
fusione, De Gaulle contrappose sempre quella che gli Stati dovessero imparare a
cooperare. E, seguendo questo metodo, egli non aveva alcun dubbio che, se non proprio la
parte del fédérateur, la Francia sarebbe riuscita a recitare quella di sapiente guida
dell’Europa.
Discours et messages, cit.95 Conferenza stampa del 15 maggio 1962.
5

CAPITOLO IV
L’EUROPA “EUROPEA”
1. Contro la CED
Per De Gaulle la Francia non può essere se stessa se non è grande:
nella sua idea trasfigurata, la Francia è simile a ‹‹la princesse des contes
ou la madone aux fresques des murs›› e dalla Provvidenza è destinata
ad essere autrice di grandi successi come anche ad essere colpita da
immani sciagure. Questo, però, è il prezzo che la Francia deve pagare
per essere la prima nazione al mondo96. Non può esserci grandezza,
però, per una nazione se questa non dispone della completa
indipendenza e della piena capacità di determinare le propria politica in
autonomia.
Agli inizi degli anni Cinquanta per De Gaulle la parola grandeur
voleva dire conservare l’Impero coloniale, quello stesso Impero che da
Brazzaville97 aveva sanzionato il ritorno in guerra, dal lato della civiltà,
della Francia éternelle. La bocciatura della CED al parlamento francese
evidenzierà come la preoccupazione del Generale fosse diffusamente
condivisa. Dichiarazioni del tipo: La France doit rester en Indochine
98ovvero:
96 Cfr. C. DE GAULLE, Mémoires de guerre- L’appel, cit, p.797 Il 27 ottobre 1940, De Gaulle costituì il “Conseil de défense de l’Empire” per dirigere la guerra della Francia contro la Germania dalle colonie. Nel Manifesto politico pubblicato lo stesso giorno, De Gaulle parla della volontà degli Alleati di “contribuer à restaurer l’indépendance et la grandeur de la France” 98 Discorso del 14 novembre 1949, cit.
5

Action impérial? Parce que nous fumes capable d’ouvrir au
progrès moderne des contrées qui, auparavant végétaient
dans les abus, la misère, l’anarchie, parce que nous avons
assumés sans les rejeter dans le trouble ou les livrer aux
ambitions des autres, parce qu’en les perdant nous
perdrions notre rang de grande puissance, nous avons,
vis-à-vis du monde entier, le droit et le devoir de faire
vivre et de développer l’union Française que nous avons
proclamée au pire moment de la pire des guerres99,
che dimostrano come, oltre che per i vantaggi economici e politici,
avere un Impero coloniale era considerato importante per la missione di
civilizzazione che ivi la Francia andava esercitando, non lasciano dubbio
alcuno sul fatto che De Gaulle considerasse in quel momento più
importante conservare la libertà di manovra necessaria per difendere
l’Impero che curarsi della difesa della Germania, per la quale comunque
avrebbe garantito la NATO. Nessuna libertà di manovra, infatti sarebbe
stata appannaggio della Francia se questa avesse rinunciato al proprio
esercito, giacché – prevedibilmente – nessuno dei suoi cinque partners
l’avrebbe seguita nelle sue dispendiose guerre coloniali.
La questione dell’indipendenza non riguardava solo i rapporti tra
la Francia e le altre democrazie dell’Europa occidentale, ma
coinvolgeva anche gli Stati Uniti, tenuto conto che, pur costituendo
l’esercito europeo, in ultima analisi la CED gliene affidava la direzione.
La CED, quindi, non soltanto avrebbe costretto la Francia a patteggiare
con gli altri europei la propria politica estera, ma – ancor più grave –
avrebbe spogliato l’intera Europa della possibilità di definire una propria
politica estera100. È, però, ovvio che quello dell’indipendenza fosse
99 ibidem100 Il commento contenuto in M. ALBERTINI, A. CHITI BATELLI, G. PETRILLI, op.cit., p.244 a proposito della CED chiarisce quale rapporto si sarebbe stabilito tra l’Europa e gli
5

concretamente avvertito come un problema solo dalla Francia, in
quanto solo la Francia aveva un Impero coloniale da difendere oltre che
un rango di potenza mondiale: il resto d’Europa era composto da piccoli
Stati o da grandi nazioni sconfitte e non ancora pienamente riabilitate
sul piano morale per le dittature che le hanno guidate nel loro recente
passato.
Ecco come De Gaulle esprimeva tutto il suo malessere per la
Comunità di difesa:
Quelle atmosphère étrange, quel malaise indéfinissable, pèsent
aujourd’hui sur notre pays dès qu’on évoque sa défense! C’est que, dans
la situation où se trouve actuellement la France et qui est caractérisée par
une profonde dépression nationale et par l’inconsistance extrême de
l’Etat, une certaine équipe est à l’œuvre pour faire admettre aux pouvoirs
publics ce qu’elle appelle: l’armée européenne et où l’instinct national
aperçoit un renoncement qui pourrait être définitif 101.
De Gaulle considerava la ratifica del trattato CED come la catastrofe
ultima della Francia, come a voler dire che ciò che le guerre non erano
riuscite a fare, ossia annientarla, era invece lo scopo della Quarta
Repubblica ed in modo particolare di coloro che volevano che la Francia
fosse uno strumento militare e politico in mano a potenza straniere, tra i
quali spiccava Jean Monnet, l’inspirateur di quello spirito d’abbandono
tipico della Quarta repubblica102
Stati Uniti e i limiti, a tal riguardo, della comunità in questione: ‹‹L’autorità militare da crearsi non avrebbe avuto alcun potere di prendere decisioni fondamentali concernenti l’Esercito europeo: queste sarebbero rimaste di competenza degli Stati nazionali, che le avrebbero esercitate all’unanimità. E restava l’impressione che, poiché questa unanimità sarebbe stata difficile da raggiungere su problemi così delicati, tali competenze sarebbero state di fatto svolte dal supremo comando atlantico, entro il quale la CED avrebbe dovuto essere strettamente inclusa e subordinata: e cioè dal soverchiante alleato americano. Il progetto era realmente insufficiente, giacché senza un governo europeo non può esistere un esercito europeo››.101 Conferenza stampa del 25 febbraio 1953, cit102 Ibid.
5

Per De Gaulle, però, la questione dell’indipendenza non era
soltanto un fatto di prestigio nazionale, ma un fatto pratico, giacché se
era vero che la Francia non era ancora in grado di difendersi da sola,
non era affatto certo che le esigenze difensive americane sarebbero
corrisposte sempre a quelle europee e, soprattutto, della Francia. Per
cui se l’Europa fosse stata attaccata, non solo la Francia non avrebbe
avuto un esercito per tutelarsi, ma avrebbe potuto anche non poter
contare sugli stessi alleati atlantici:
On dit aussi: il s’agit d’assurer à la France un puissant
concours américain sans compromettre son
indépendance. Or, le traité subordonne à la stratégie
américaine sans nous garantir aucunement que la France
serait défendue103.
L’opinione di De Gaulle era che la CED non realizzasse affatto un
esercito europeo104. Sostenendo, inoltre – e sul punto fu in buona
compagnia105 – che non poteva esistere un esercito europeo senza un
governo dell’Europa, De Gaulle argomentava la sostanziale natura
menzognera della retorica europeista, convinta che dall’integrazione per
settori potrà e dovrà scaturire un giorno l’unità del Continente:
Je viens de dire que le nom donné à l’armée dite « européenne » est un titre
fallacieux. Pour qu’il y ait l’armée européenne, c’est-à-dire l’armée de
l’Europe, il faut d’abord que l’Europe existe, en tant qu’entité politique,
économique, financière, administrative et, par-dessus tout, morale, que cette
entité soit assez vivante, établie, reconnue, pour obtenir le loyalisme
congénital de ses sujets, pour avoir une politique qui lui soit propre et, pour
que, le cas échéant, des millions d’hommes veuillent mourir pour elle. Est-ce
le cas ? Pas un homme sérieux n’oserait répondre oui 106
103 Ibid.104 Ibid. 105 L’argomentazione è infatti tipica dei federalisti106 Conferenza stampa del 25 febbraio 1953, cit
5

In ogni modo, anche se l’Europa fosse organizzata come uno
Stato, secondo il trattato CED non potrebbe disporre del suo esercito,
perché la partecipazione alla NATO fa sì che il suo impiego venga deciso
dal vertice supremo dell’Alleanza secondo l’indirizzo della politica estera
e di difesa americana e non già secondo le esigenze difensive degli Stati
europei107. Questa particolare critica tocca il nervo scoperto dell’alleanza
difensiva occidentale mettendola in luce per quella che è davvero,
secondo De Gaulle, vale a dire un sistema difensivo dell’America su
territorio europeo. La CED, quindi, non era altro che una parvenza
d’unità in materia di difesa e di politica estera, finalizzata a consegnare
alla NATO la tutela dei Sei; ma essendo la stessa NATO uno strumento
non efficace di difesa dell’Europa, la sua inidoneità avrebbe finito per
travolgere inevitabilmente anche la CED108. Non potendo più il governo
francese nemmeno istruire, formare, ricompensare o punire i propri
soldati, De Gaulle temeva pure possibile che truppe straniere venissero
messe a protezione Parigi:
C’est ainsi que, s’il paraissait bon au commandant en chef
de mettre les Allemands en garnison à Strasbourg, à
Colmar, à Paris, au lieu des Français, il suffirait
littéralement qu’il obtint l’accord du Chancelier Adenauer.
Quant au Gouvernement français – ou ce qui oserait
encore porter ce nom – il n’aurait rigoureusement rien à
dire. Le commandant en chef américain peut encore
refuser au Gouvernement français d’envoyer outre-mer
aucune fraction des contingents que celui-ci livrés […]
107 Cfr. ibid.108 Va detto che la CED prevedeva solo la costituzione di un esercito comune, e non già anche di una flotta navale e di una aerea comuni; così come non aveva alcun potere in riguardo a questioni di fondamentale importanza come le comunicazioni, gli approvvigionamenti e gli equipaggiamenti.
6

Mais, lors même qu’ils y réussiraient, le traité n’en tuerait
pas moins l’Union Française109.
L’opposizione di De Gaulle alla CED non fu alimentata solo dalle
sue preoccupazioni in riguardo all’indipendenza della Francia, al
mantenimento del suo impero coloniale e, con esso, del suo prestigio
mondiale. Per De Gaulle, la sopranazionalità della CED era un’assurdità
perché pretendeva che i Commissari nominati dai Sei governi nazionali
e i ministri riuniti in Consiglio si dimenticassero temporaneamente della
loro provenienza al fine di servire solo la causa europea, per poi tornare
nuovamente dei fedeli servitori dei loro Stati d’origine, e dei loro
interessi, una volta tornati alle loro tradizionali mansioni. La regola
dell’unanimità rendeva impossibili le decisioni importanti. Infine, la
mancanza di una qualunque forma di legittimazione democratica
restringeva lo spazio per l’iniziativa politica e rendeva l’intera
costruzione del tutto irrealistica, concentrandosi il potere nelle mani di
un’oscura burocrazia comunitaria110.
De Gaulle non ebbe, però, solo critiche da esprimere. Messo in
evidenza come l’Europa non potesse organizzare la propria difesa senza
dotarsi di una qualche forma unitaria, egli ribadì la sua proposta
confederale, basata sulla necessità che l’Europa non può farsi sulla base
delle parole degli ‹‹illusionnistes››111, ma a partire da ciò che caratterizza
la realtà del Continente, ossia gli Stati e le Nazioni:
Or, la réalité, c’est qu’actuellement l’Europe se compose
de nations. C’est à partir de ces nations qu’il faut
organiser l’Europe et, s’il y a lieu, la défendre. Au lieu 109 Conferenza stampa del 25 febbraio 1953, cit. 110 Cfr. ibid. 111 Ibid.
6

d’une fusion intolérable et impraticable, pratiquons
l’association112 ,
l’association non essendo altro che il nome più idoneo a descrivere il
vincolo confederale immaginato da De Gaulle. Infatti, cosa propone De
Gaulle? Non un’intollerabile ed impraticabile fusione, ma una stretta
alleanza tra nazioni libere ed eguali con il suo cuore politico e strategico
in un Consiglio dei capi di governo ed il suo supporto tecnico in una
Commissione senza ambizione alcuna di sovranità:
Au lieu d’une fusion intolérable et impraticable, pratiquons l’association.
En poursuivant des chimères, on a déjà perdu des années. Commençons
par faire l’alliance des Etats libre de l’Europe. Il y faut une direction : ce
sera le Conseil des Chefs de gouvernements réunis d’une manière
organique et périodique. A cette direction, il faut un instrument de travail
et d’exécution. Ce sera l’Etat major combiné, si l’on veut le
Commissariat, mais un Commissariat qui n’aura pas le front de se
proclamer souverain […]Ainsi, seront fusionnées tous les services qui
doivent l’être : infra structure, communications, ravitaillement,
fabrications d’armements, etc…113
2. La NATO e l’egemonia americana
L’indipendenza – non certo per importanza, ma solo nell’ambito della nostra
esposizione – è l’ultimo fondamento della visione gollista dell’Europa. Anche la richiesta
d’indipendenza per l’Europa, in realtà, fu solo un mezzo per far recuperare alla Francia la
sua indipendenza, poiché De Gaulle sapeva benissimo che, senza un’Europa capace di
darsi un indirizzo unitario in politica estera e di assicurare da sé la propria sicurezza, la
stessa Francia avrebbe avuto nessuna possibilità di condurre la propria politica di prestigio
e di grandezza. Infatti, non essendo più quella grande potenza militare che era stata fino a
112 Ibid. 113 Ibid. Sempre sul tema della confederazione si possono vedere il discorso pronunciato a Nîmes il 7 gennaio 1951; il discorso di chiusura della quarta Assise nazionale del R.P.F, Nancy, 25 novembre 1951, quello del 12 novembre 1953 da Discours et messages, cit ; la dichiarazione del 6 giugno 1952 in www.gaullisme.org
6

prima del secondo conflitto mondiale, la Francia, malgrado le pretese di De Gaulle, non
avrebbe potuto nemmeno difendere sé stessa in caso d’aggressione sovietica. Per il
Generale, dunque, la Francia, al pari degli Stati Uniti, aveva bisogno di un sistema
difensivo che, in primo luogo, ne assicurasse la sicurezza propria e che, in secondo,
costituisse una valida difesa anche per il resto dell’Europa. Un aspetto fondamentale della
“Europa europea” di De Gaulle è costituito dall’opposizione alla NATO.
De Gaulle aveva una pessima opinione della NATO, principalmente perché la
considerava come il sistema difensivo europeo degli Stati Uniti, non già come il sistema
difensivo americano dell’Europa. Ciò che potrebbe sembrare un gioco (nostro) di parole, in
realtà, coglie bene l’opinione di De Gaulle, il quale temeva che, nel caso di un conflitto, gli
Stati Uniti avrebbero potuto effettivamente non difendere l’Europa in conseguenza di un
calcolo politico-strategico. De Gaulle dubitava fortemente del fatto che, in caso
d’aggressione sovietica, gli Stati Uniti sarebbero intervenuti in Europa. Tale dubbio gli
veniva ispirato dalle vicende di entrambe le guerre mondiali, nel corso delle quali gli
americani entrarono in causa solo a conflitto iniziato e, soprattutto, dopo che la Francia
aveva già subito considerevoli perdite114.
De Gaulle, inoltre, era contrario all’integrazione dei paesi europei nella NATO,
perché questa avrebbe costretto l’Europa ad accettare una permanente limitazione della
propria indipendenza politica e militare a favore degli Stati Uniti. Secondo lui, gli Stati
Uniti sarebbero stati i veri federatori dell’Europa, perché la dipendenza politica
dell’Europa da quelli si sarebbe rinsaldata con l’integrazione militare. Gli europei, quindi,
avevano delegato alla NATO una parte della loro sovranità e in cambio avevano ottenuto
che gli Stati Uniti ponessero in posizione di soggezione l’intera Europa occidentale115.
114 C. DE GAULLE Memorie della speranza, cit, p.196115 G. MAMMARELLA, op.cit., p.302
6

Egli trovava infamante che una potenza come la Francia – riconosciuta vincitrice
della guerra, socio fondatore dell’ONU, membro del Consiglio di Sicurezza con diritto di
veto – fossa trattata al pari di paesi sconfitti o privi di una rispettabile storia militare, ossia
come un mero strumento di difesa degli Stati Uniti; altresì, riteneva impossibile per
principio che la Francia rinunciasse ad un proprio sistema difensivo. Per tutte queste
ragioni, De Gaulle chiese continuamente una profonda riforma della NATO, giungendo, a
modo di provocazione, ad uscirne nel corso degli anni Sessanta116.
Nelle strategie americane la NATO, oltre che un’alleanza militare, doveva essere
anche un compatto blocco politico ed economico finalizzato al contenimento della
diffusione del socialismo. Coerentemente con tale scopo, con l’obiettivo di permettere la
ripresa economica e sociale dell’Europa occidentale e promuoverne la coesione nel quadro
dell’avversione al comunismo sovietico, contemporaneamente all’istituzione della NATO,
gli Stati Uniti varavano il Piano Marshall e, per la sua efficace applicazione, creavano la
OECE, la prima organizzazione volta a realizzare la cooperazione economica tra gli Stati
europei. Negli stessi anni la Gran Bretagna favoriva la nascita del Consiglio d’Europa e,
dopo il fallimento della CED, la UEO.
Accertato che dietro le forme iniziali della cooperazione europea si celavano
sempre gli Stati Uniti e le loro strategie, De Gaulle vedeva anche dietro Jean Monnet e la
sua Europa la longa manus del governo americano117. Si può capire come per De Gaulle
l’indipendenza dell’Europa – quella qualità che l’avrebbe fatta in grado di mediare tra i due
blocchi e di non farsi, eventualmente, coinvolgere nella terza guerra mondiale, nonché di
tornare ad esprimere la sua civiltà nel mondo – passasse attraverso la liquidazione delle
116 Gli scopi della politica estera di De Gaulle sono ben presentati in D. CAVIGLIA, op.cit.,p.4: ‹‹Per M.Couve de Murville, ministro degli esteri durante il governo Debré, la preoccupazione principale della politica gollista risiedeva nel cambiamento dei rapporti di forza con gli anglo-americani, passando attraverso la creazione non istituzionalizzata di un direttorio a tre e la riforma dell’Alleanza Atlantica›› 117 Tale opinione trovò espressione della già citata (a proposito della CED) conferenza stampa del 25 febbraio 1953
6

Comunità, la creazione di una force de frappe, l’allargamento dell’Europa ai paesi dell’Est,
nonché il rifiuto dell’adesione inglese al Mercato comune.
3. La “force de frappe” e la prematura fine dell’Euratom
De Gaulle considerava essenziale che la Francia si dotasse di un arsenale atomico –
la cosiddetta force de frappe – perché solo acquistando gli stessi mezzi di deterrenza di
Stati Uniti, Unione Sovietica e Gran Bretagna, essa avrebbe potuto recuperare, oltre che il
suo prestigio, una certa libertà di manovra sulla scena internazionale. Per De Gaulle la
disponibilità di un armamento atomico doveva essere uno dei fondamenti irrinunciabili
della politica francese, il necessario presupposto alla sua indipendenza. All’obiezione che
gli veniva mossa, per la quale la Francia non sarebbe mai stata in grado di rappresentare
una minaccia credibile per l’Unione Sovietica, De Gaulle rispondeva dimostrando di
attenersi alla logica della risposta flessibile, ossia che era sufficiente poter minacciare in
qualsiasi momento l’avversario anche con un solo missile per poterlo intimorire. Quindi
quello che la Francia otteneva (e non era poco) era, in caso di un’aggressione sovietica, il
diritto di decidere da sé l’impiego dell’arma atomica sul Continente, a propria tutela e a
tutela dell’intera Europa. Tale opinione era rafforzata dalla convinzione che ‹‹gli Stati Uniti,
essendo ormai esposti al pericolo di distruzione in caso di guerra totale, avrebbero fatto ricorso al
proprio deterrente nucleare solo se attaccati direttamente sul proprio territorio››118 e non anche in
caso di aggressione all’Europa. Impegnandosi, quindi, a perseguire una propria politica
nucleare al fine di ottenere l’ordigno esplosivo, De Gaulle dichiarò conclusa sul nascere la
cooperazione europea in materia di energia atomica, liquidando così l’appena nata
Euratom:
En même temps, pour l’Euratom, apparaît irréductible l’opposition entre la
situation de la France, déjà dotée depuis quelque quinze ans d’un actif
Commissariat à l’énergie atomique, pourvue d’installations multiples,
118 G. MAMMARELLA, op.cit., p.306
6

appliquée à mettre en œuvre des programmes précis et étendus de
rechercher et de développement, et celle des autres pays qui, n’ayant rien
fait par eux-mêmes, voudraient que les crédits du budget commun servent à
leur procurer ce qui leur manque en passant les commandes aux
fournisseurs américains119.
Diversamente che la CEE, quindi, l’esistenza dell’Euratom fu segnata fin dall’inizio
dalla tenace volontà di De Gaulle di dotare la Francia di un armamento atomico. Poiché
non incontrò presso i partners la volontà di attribuire alla Comunità un importanza militare,
già nel 1958, egli informò ‹‹il governo tedesco e quello italiano che questa collaborazione
atomica, appena imbastita, non esisteva più e che la Francia avrebbe realizzato da sola il
suo programma nucleare››120
4. L’Europa" dall’Atlantico agli Urali”
Se la battaglia contro la NATO veniva condotta per assicurare l’indipendenza
dell’Europa sul versante occidentale, su quello orientale era sintetizzata nella formula
dell’Europa “dall’Atlantico agli Urali”. In realtà, però, tale idea rimase sempre alquanto
nebulosa.
Benché De Gaulle si adoperasse per l’Europa allargata ad Est solo nella seconda
metà degli anni Sessanta, cioè dopo il fallimento del piano Fouchet, la crisi della sedia
vuota e la sua rielezione, l’idea che l’Europa fosse, malgrado la frattura ideologica, un
tutt’uno lo aveva sempre caratterizzato (De Gaulle – si è già visto – considerava l’ideologia
un fenomeno momentaneo, destinato inevitabilmente a cedere il posto al ritorno delle
nazionalità).
Interpretando la morte di Stalin e l’apertura di squarci di libertà nei paesi satelliti
come il segno che il comunismo fosse sulla via di regredire, De Gaulle si risolse a
promuovere attivamente questa nuova formula con numerosi viaggi e dichiarazioni. Il
119 DE GAULLE C, Mémoires d’espoir, cit., p.145.120 P. QUARONI, op.cit., p.79
6

Generale aveva manifestato per la prima volta questa concezione nel 1950 in termini molto
vaghi:
Je suis convaincu que si la France, une fois debout et conduite, prenait
l’initiative d’appeler l’Europe à se faire, en particulier avec le concours des
Allemands, toute l’atmosphère européenne serait changée de l’Atlantique à
l’Oural et même les hommes en place de l’autre côté du rideau de fer en
éprouveraient les conséquences. C’est en Europe qu’est la clef de la
Libération de l’Europe 121.
Più che un progetto politico, infatti, sembrò che con quell’espressione si riferisse ad
uno “spirito europeo”, ad una comunità di uomini accomunati dal fatto di aver scritto
insieme la storia del continente. Comunque, questa idea ‹‹esclude una comunità legata da
un nesso federale: sarebbe al più una giustapposizione di stati sovrani, decisi a vivere in
pace fra loro e a risolvere, d’accordo, certe questioni di interesse comune››122.
Per realizzare tale obbiettivo, che sarebbe servito anche ad allontanare il rischio
che la resa dei conti definitiva tra le due superpotenze avesse luogo proprio sul suo già
martoriato territorio, De Gaulle invocò per gli Stati satelliti dell’URSS l’autonomia
necessaria affinché questi potessero partecipare alla rinascita dell’Europa e della sua
civilizzazione, ossia la caduta del comunismo:
Il s’agit que la Russie évolue de telle façon qu’elle voie son avenir, non
plus dans la contrainte totalitaire imposée chez elle et chez les autres, mais
dans le progrès accompli en commun par des hommes et par des peuples
libres. Il s’agit que les nations dont elle a fait des satellites puissent jouer
leur rôle dans une Europe renouvelée […] Il s’agit que l’Europe, mère de
la civilisation moderne, s’établisse de l’Atlantique à l’Oural dans la
concorde et dans la coopération en vue du développement de ses
immenses ressources et de manière à jouer, conjointement avec
121 Conferenza stampa tenuta al Palais d’Orsay il 16 marzo 1950 in www.gaullisme.org 122 P. QUARONI, op.cit., p.167
6

l’Amérique sa fille, le rôle qui lui revient quant au progrès de deux
milliards d’hommes qui en ont terriblement besoin123
Infine, quest’Europa avrebbe inevitabilmente implicato la riunificazione tedesca e
fatto sparire uno dei fronti più caldi della guerra fredda dato che, nel contesto dell’unità
europea, la divisione della Germania non avrebbe avuto più alcun senso:
[…] j’estime nécessaire que la République fédérale fasse partie intégrante
de la coopération organisée des États, à laquelle je vise pour l’ensemble
de notre continent. Ainsi serait garantie la sécurité de tous, entre
l’Atlantique et l’Oural et créé dans la situation des choses, des esprits et
des rapports un changement tel que la réunion des trois tronçons du
peuple allemand y trouverait sans doute sa chance124
La politica d’apertura all’Est si interruppe bruscamente, non senza qualche disagio,
quando tutto il mondo prese coscienza che il sistema sovietico non sarebbe crollato a
breve125.
5. Il veto all’Inghilterra
Nel disegno gollista di un’Europa dall’Atlantico agli Urali vi era posto anche per la
Gran Bretagna; tuttavia, nessun allargamento della CEE si sarebbe potuto fare fin tanto che
essa fosse stata il cavallo di Troia degli Stati Uniti d’America. In primo luogo, ciò che De
Gaulle temeva era che l’Inghilterra sarebbe stato un fattore di disunione e che, volendo
salvaguardare e promuovere i suoi interessi, avrebbe messo a dura prova l’integrazione già
conseguita dai Sei. Inoltre, viste le relazioni speciali intercorrenti con gli Stati Uniti,
l’Inghilterra avrebbe condotto l’Europa sempre più sotto i controllo degli americani:
123 Conferenza stampa tenuta al palazzo dell’Eliseo il 4 febbraio 1965 in Discours et messages, cit.124 C. DE GAULLE, Mémoires d’Espoir, cit., p. 183.125 L’evento fu l’invasione sovietica della Cecoslovacchia. Dato che s’era fatto convinto dell’imminente caduta del comunismo e che confidava nella sua capacità di alimentare il nazionalismo represso dalla dittatura comunista, De Gaulle aveva intrapreso una politica d’amicizia con i paesi dell’Est. Gli eventi cecoslovacchi, dimostrando la totale infondatezza di quelle convinzioni, misero in un certo disagio il presidente. Si veda J. SOUSTELLE, op. cit., p.279-287
6

Il est à prévoir que la cohésion de tous ses membres, qui seraient très
nombreux, très fiers, n’y résisterait pas longtemps et, qu’en définitive,
il apparaîtrait une Communauté atlantique colossale sous dépendance et
direction américaine et qui aurait tôt fait d’absorber la Communauté
européenne126
Gli interessi inglesi di cui De Gaulle temeva la concorrenza erano legati alla natura
insulare della Gran Bretagna, natura per la quale questo paese aveva la vocazione a legarsi
molto più facilmente sugli oceani che sulla terraferma e a trovare il soddisfacimento dei
suoi interessi ben lungi che all’interno del sistema delle Comunità 127.
Originariamente, però, De Gaulle non fu contrario a che l’Inghilterra entrasse nel
sistema comunitario. A monte di questa non contrarietà che De Gaulle accordò, vi fu la
preoccupazione che il negoziato per la regolamentazione dell’agricoltura, al quale tanto
egli teneva, potesse fallire. In quel tempo De Gaulle si era mostrato possibilista, se non
addirittura entusiasta, per la partecipazione della Gran Bretagna al processo d’integrazione
europea. Così, malgrado la difficoltà dei problemi connessi a questa adesione, egli la
salutava con molto favore:
De tout temps, les participants au Marché commun, qui sont six, ont
souhaité que d’autres, et en particulier la Grande Bretagne, se joignent au
traité de Rome, qu’ils en assument les obligations et que je pense, ils en
reçoivent les avantages. Nous savons très bien quelle est la complexité du
problème, mais il semble que tout porte maintenant à l’aborder et, pour ma
part, je n’ai qu’à m’en féliciter, non seulement au point de vue de mon
pays, mais je crois aussi au point de vue de l’Europe et, du même coup, au
point de vue du monde 128.
Quando, però, il negoziato per la politica agricola andò favorevolmente in porto, la
vera opinione di De Gaulle si manifestò compiutamente: gli interessi che l’Inghilterra
avrebbe salvaguardato e posto all’attenzione dei suoi partners, pensava non a torto,
126 Conferenza stampa del 14 gennaio 1963 in Discours et messages, cit.127 Cfr. ibid128 Ibid.
6

sarebbero stati quelli connessi alle produzioni agricole del Commonwealth, i quali
avrebbero finito per far perdere alla Francia i vantaggi di quella politica agricola comune,
per la quale tanto si era speso da minacciare il fallimento del Mercato Comune. L’ingresso
della Gran Bretagna nel Mercato Comune, quindi, avrebbe rivoluzionato gli equilibri della
Comunità e sostituito a quell’asse tra la Francia e la Germania che le era stato benefico, la
rivalità tra la Francia e la Gran Bretagna che, inevitabilmente, per la maggiore disposizione
degli europei nei confronti della copertura atlantica che verso la force de frappe francese,
avrebbe potuto agevolmente soffiare a Parigi la leadership continentale e
conseguentemente consegnare l’Europa – e con questa anche la Francia – ai nordamericani:
Il est évident qu’un marché commun à sept ou à dix ne rassemblera en
rien au marché commun primitif. L’équilibre politique y sera modifié du
tout au tout. La primauté de l’influence française ne pourra être
maintenue. A la conjonction franco-allemande qui à été jusqu’à présent
pratiquée se substituera au mieux une rivalité franco-anglaise […] Il n’est
pas douteux qu’une fois le marché commun élargi, on en riviendrait
rapidement à la prépondérance de Washington et de Londres129
I motivi che indussero De Gaulle a rifiutare l’ingresso della Gran Bretagna nel
Mercato comune furono clamorosamente resi noti nel corso della conferenza stampa del 14
gennaio 1963, nel corso della quale, sì, manifestò le sue preoccupazioni in riguardo ai temi
economici, ma fece anche presente come vi fossero ragioni politiche più importanti a
motivare tale decisione. Si trattava dell’incompatibilità non già tra due visioni dell’Europa,
dato che tanto la Francia della Quinta repubblica quanto l’Inghilterra erano contrarie alla
sopranazionalità, bensì tra due leaderships. De Gaulle si rendeva conto che l’Inghilterra,
legata da “relazioni speciali” agli Stati Uniti, non avrebbe mai abbandonato il suo alleato
per aderire ad una velleitaria politica antiamericana e, inoltre, che l’influenza inglese
avrebbe impedito che gli altri paesi europei lo seguissero nella sua polemica contro gli
129 Relazione sull’adesione dell’Inghilterra al Mercato Comune, Parigi 28/08/61 in D. CAVIGLIA, op.cit., p.234
7

americani. ‹‹L’Inghilterra era, in altre parole, come un intruso, spinto dalla pretesa di
cacciare nelle terre che la Francia considerava come una sua riserva: bisognava metterla
fuori per rimettere l’ordine del pollaio››130.
Stigmatizzando i comportamenti ripetutamente tenuti dagli inglesi nei confronti
dell’integrazione europea, De Gaulle si era convinto che Londra volesse soltanto sabotare
l’integrazione dei Sei e gli sforzi da questi sostenuti per l’approfondimento della loro
cooperazione. De Gaulle non ebbe dubbi nel ricondurre l’ispirazione di questa politica
britannica negli interessi di Washington e nella sua visione atlantica dell’Europa. Non fu
affatto una casualità che De Gaulle annunciasse quel veto dopo il discorso del presidente
americano Kennedy del 4 luglio 1962 e dopo che Washington, nel dicembre successivo,
acconsentì a fornire missili atomici Polaris al governo di Londra.
L’Europa, per essere autenticamente europea, non poteva e non doveva aprirsi a chi
non avrebbe voluto farla capace di costituirsi come un soggetto indipendente e potente, in
grado anche di porsi alla pari con gli Stati Uniti:
L’union des Six, une fois réalisée et, à plus forte raison, si elle venait à se
compléter d’adhésions et d’associations européennes nouvelles, peut et
doit être, vis-à-vis des États-Unis, un partenaire valable en tous domaines,
je veux dire puissant et indépendant 131
Espresso nel gennaio del ’63, è possibile che il veto all’Inghilterra fosse già stato
deciso da De Gaulle già durante l’estate del 1962132, per la ragione che dietro al fallimento
del piano Fouchet della primavera del 1962, De Gaulle vedeva chiaramente i risultati delle
pressioni esercitate dal governo inglese su quelli olandese e belga al fine di fermare quella
cooperazione politica europea che, se anche non avesse dato vita ad una “Europa europea”,
sicuramente avrebbe realizzato una “Europa francese”.
130 P. QUARONI, op. cit., p.98131 Conferenza stampa tenuta all’Eliseo il 21 febbraio 1966 in Discours et messages, cit.132 B. OLIVI, op.cit., p.79 : ‹‹Sembra storicamente attendibile che il veto francese fu deciso dopo la tornata di luglio-agosto 1962 dei negoziati britannici, e forse anche qualche settimana prima, mentre l’episodio di Nassau ne ebbe a costituire l’atteso detonatore››
7

Ancora una volta, De Gaulle ribadì che solo alla Francia sarebbe spettata la
leadership dell’Europa democratica. L’unica nazione che poteva legittimamente pensare
di unire l’Europa e di farla indipendente, europea – facendo così, anche in questo caso, se
non proprio la parte del fédérateur, quanto meno quella della sapiente guida – era la
Francia, la sola nazione europea davvero arbitra di sé stessa e con i mezzi, la volontà, la
vocazione necessari:
En attendant que le ciel se découvre, la France poursuit par ses propres
moyens ce que peut et doit être une politique européenne et indépendante.
Le fait est que, partout, les peuples s’en félicitent et qu’elle-même ne s’en
trouve pas mal […] En voulant et en proposant l’organisation d’une
Europe ayant sa propre politique, la France est certaine de servir
l’équilibre, la paix et le progrès de l’univers133
[…] la France, sans renier aucunement l’amitié qu’elle
porte aux nations anglo-saxonnes, mais rompant avec le
conformisme absurde et périmé de l’effacement, prenne
une position proprement française au sujet de la guerre du
Viêt-nam, ou du conflit au Moyen-Orient, ou de la
construction d’une Europe qui soit européenne, ou du
bouleversement qu’entraînerait, pour la Communauté des
Six, l’admission de l’Angleterre et de quatre ou cinq autres
États, ou des rapports avec l’Est, ou de la question
monétaire internationale […]134
133 Conferenza stampa all’Eliseo del 23 luglio 1964 in Discours et messages, cit. 134 Allocuzione radio e teletrasmessa del 10 agosto 1967 in www.gaullisme.org. In quest’occasione De Gaulle si riferisce alla svalutazione della sterlina che, avvenuta nella seconda metà degli anni Sessanta su decisione unilateralmente del governo di Londra, aveva provocato non poche ripercussioni sull’economia dei Sei. L’evento è degno di nota in quanto porterà De Gaulle ad annunciare un secondo veto quando, con il governo Wilson, l’Inghilterra farà nuovamente richiesta di partecipare al MEC.
7

CAPITOLO V
AL VAGLIO DELLA CRITICA FEDERALISTA
1. Il rifiuto del nazionalismo e dell’autoritarismo
Si è più volte sottolineato nel corso dell’opera come lo scopo primo ed ultimo di De
Gaulle sia sempre stato il prestigio e la grandezza della Francia e che, conseguentemente,
l’indipendenza politica, militare ed economica dell’Europa fossero da lui considerati solo
dei mezzi per servire detto scopo. Tanto tenacemente ha combattuto contro le istituzioni
comunitarie, che De Gaulle ha ispirato nei suoi contemporanei – non solo presso Capi di
stato e di governo europei, ma anche presso l’opinione pubblica – l’idea che egli volesse
soltanto distruggere l’integrazione che fin lì aveva avuto luogo, senza voler in alcun modo
costruire qualcosa di davvero alternativo. Malgrado la complessità e l’ambiguità della sua
azione di governo, la copiosità e la verbosità delle sue dichiarazioni, De Gaulle, invero,
ebbe solo poche ma fisse, quasi ossessive, idee durante tutta la sua vita. Così, se è possibile
ricavare da questa abbondanza cosa egli non volesse fosse fatto in Europa, più difficile
appare comprendere, al contrario, cosa davvero volesse. Certo è che, anche alla luce dei
successivi passi dell’integrazione europea, le critiche e le domande che egli sollevò non
7

furono mai pretestuose. Quanto alle risposte, è chiaro come la sua irriducibile volontà di
affermare la Francia e i suoi interessi al di sopra di tutti e tutto finisse puntualmente per
screditare da sé stessa qualunque proposta che egli facesse.
Il rifiuto del nazionalismo e delle sciagure da questo provocate nel recente passato
fu la fondamentale causa d’opposizione alla politica di De Gaulle e a quella visione che vi
faceva da ispiratrice. Quando il Generale tornò al potere per i fatti d’Algeria, pressoché
unanime fu presso le cancellerie europee ed i sostenitori della federazione europea il
timore che il processo d’integrazione del lato occidentale del continente si sarebbe presto
arrestato: erano, infatti, già note le sue opinioni sull’Europa, le quali, lungi dal collocarsi in
continuità con quelle di Monnet, intendevano la cooperazione europea solo come un mezzo
per rilanciare la potenza francese nel continente e nel mondo.
Dato lo spirito con cui la strategia comunitaria era stata adottata dai Sei (compresa la
Francia della Quarta repubblica), il ritorno del nazionalismo preoccupava enormemente sia
per l’approccio che la Francia avrebbe avuto da quel momento in poi nelle Comunità, che
per l’influenza politica che un paese come quello non poteva non esercitare sugli altri. In
particolare, il ritorno al potere di De Gaulle era vista come una soluzione ‹‹ catastrofica per
l’avvenire perché basata su di un nazionalismo oltranzista, militarista, orgoglioso,
presuntuoso nel credersi ed affermarsi padrone della sua sorte››135, che inevitabilmente
avrebbe spinto la Francia all’autarchia e influenzato le altre nazioni europee a fare lo
stesso. Ossia, tornare a chiudersi in sé stesse e porsi in contrapposizione prima sul fronte
economico, e poi su quello militare.
Secondo i suoi oppositori, le conseguenze della politica gollista furono
essenzialmente due: la prima, una volta rotta l’armonia e l’accordo tra i Sei, fu quella di
spingere gli Stati verso la riedizione di quel ‹‹gioco politico delle alleanze, delle
controalleanze, dei ricatti, dei boicottaggi, delle ripicche›› che nei secoli tanto male aveva
135 F. SÉRUSCLAT, Il pericolo De Gaulle, ‹‹Popolo europeo››, anno I, n°5, maggio 1958, p.4
7

provocato all’Europa e particolarmente ai suoi devastati popoli; la seconda che,
contrariamente ai suoi disegni, la politica del Generale stava accentuando l’egemonia
americana sull’Europa, perché ‹‹in assenza di un’autorità politica europea, la sola autorità
sopranazionale esistente era quella americana, alla quale ci si rivolgeva perché offriva
maggiori garanzie di sicurezza e di pace››136. Ora, se era pur vero che, in mancanza di un
governo federale con legittima autorità su tutta l’Europa dei Sei, sarebbe stato opportuno
che si colmasse il vuoto politico generato dal carattere tecnocratico e burocratico delle
Comunità, la pretesa francese di adempiere a tale opera non poteva essere condivisa per
l’assenza presso la Francia dei requisiti necessari per tenere unita l’Europa, la ragione di
ciò essendo il fatto che nessuno Stato europeo avrebbe accettato ‹‹ in una confederazione la
leadership francese, perché la guerra d’Algeria e la decomposizione crescente delle
istituzioni e del costume democratico le hanno tolto qualsiasi prestigio morale››137.
In particolare, furono i membri del Movimento federalista europeo, per la loro
tradizione politica democratica, a vedere nel nazionalismo e nelle sue tendenza autoritarie
il principale ostacolo a fare della Francia la guida dell’Europa unita138 e a smascherare –
proprio loro che erano accusati da De Gaulle di propagandare una nuova cattiva ideologia
– il carattere a sua volta ideologico della visione gollista139. Secondo i federalisti i progetti
di De Gaulle non potevano essere credibili per la semplice ragione che questi non potevano
avere un carattere democratico e popolare, coerentemente con l’ordinamento politico della
Quinta repubblica: infatti, se è vero che vi è contraddizione tra gli esecutivi forti e la
136 A. CABELLA in La truffa dell’Europa delle Patrie, ‹‹Popolo Europeo››, anno V, n°4, aprile 1962, p.1137 A. SPINELLI in Le proposte di De Gaulle, ‹‹Popolo europeo››, anno III, n°10, ottobre 1960, p.1-2138 A. CABELLA , cit.139 Per avere un’idea di come l’ideologia nazionale di De Gaulle era denunciata: ibid. ‹‹ Che poi questa concezione di entità nazionali pure, assolute, intangibili, sia frutto di una ideologia romantica ottocentesca, quella appunto della nazione come figurazione metafisica animistica che si è sovrapposta alla concezione democratica ed illuministica dello stato costituzionale, questo de Gaulle non lo sospetta, o non lo interessa perché nella Nazione francese lui crede, e crede in sé come sacerdote della Patria. […] l’ideologismo nefasto è per De Gaulle l’europeismo, in quanto produce l’idea di un’organizzazione statale europea sopranazionale, un’entità puramente tecnocratica, burocratica e anonima, di una economicità priva di eticità e spiritualità ››
7

democrazia, i progetti di De Gaulle sottendevano l’auspicio che l’Europa si uniformasse e
si modellasse sulle strutture sempre meno democratiche e autoritarie francesi, con la
concentrazione delle supreme decisioni prese al vertice nelle mani pochi uomini investiti di
tutto il potere140.
Nonostante ciò, parve che a De Gaulle stesse riuscendo di fare l’Europa
confederale, a dimostrazione di come tra i paesi europei il vento del nazionalismo fosse
tornato a soffiare pericolosamente. De Gaulle ebbe buon gioco nell’apparire lo strenuo
difensore della causa europea, perché si mostrava abile nel nascondere il suo atteggiamento
profondamente ‹‹nazionalista, antieuropeo ed egemonico›› sotto una maschera europeistica
che si presentava esteriormente coi connotati della gradualità, del realismo, della difesa
della Comunità a Sei, ma che, in verità, celava il disegno di soffocare l’Europa con una
unione politica fatta di consultazione periodiche fra i capi di Stato e di governo e
istituzionalizzata in una segreteria permanente, nonché di legarne l’economia ad una
visione chiusa e conservatrice141. Sfruttando questa abilità, De Gaulle poté affermare di
avversare l’ingresso della Gran Bretagna per il rischio che la sua presenza dissolvesse la
Comunità originaria ed i suoi consolidati equilibri, piegandone al contempo le strutture
fino a renderla nient’altro che una zona di libero scambio. Così, pur volendo soltanto
tutelare la posizione e gli interessi della Francia, De Gaulle poteva presentarsi e farsi
scambiare per il custode dei trattati di Roma del 1957.
Quei trattati, però, erano completamente snaturati. Data l’inconsistenza giuridica
del principio della sopranazionalità, solo la buona volontà e la fiducia reciproca dei governi
avrebbero potuto preservare quanto fatto e incoraggiato quanto ancora da fare: De Gaulle
minò questa fiducia ed impose, obbligando la Commissione alla “sincronizzazione”, il
ritorno della logica per cui ogni concessione tra gli Stati dovesse essere coperta da vantaggi
140 Cfr. M. ALBERTINI, A. CHITI BATELLI, G. PETRILLI, op.cit, p 286 141 Cfr. M. ALBERTINI, A. CHITI BATELLI, G. PETRILLI, op.cit., p.288
7

reciproci. De Gaulle, da parte sua, applicò questa pratica negoziale di ritorno ricorrendo
sempre più frequentemente agli strumenti più spregiudicati: con il ricatto e l’ultimatum ha
imposto il suo punto di vista con metodi presi dalla politica di potenza. De Gaulle veniva
accusato di far leva sullo spirito europeo e comunitario per, infine, ucciderlo con il
nazionalismo, una volta liberato quest’ultimo da quella sorta di “vaso di Pandora” in cui
era stato celato.
La sua azione politica di tutela ad oltranza della sovranità e dell’indipendenza della
Francia infliggeva continuamente colpi al processo d’unificazione europea, direttamente ed
indirettamente, cioè sia mediante il logoramento delle istituzioni comunitarie dal loro
interno, che influenzando negativamente le richieste ed i comportamenti dei cinque
partners, oramai anche loro votati alla difesa delle proprie ragioni politiche, economiche e
di sicurezza, oltre al fatto che dubbi si sollevavano sui futuri progressi dell’integrazione
europea, visto che era chiaro come il suo disegno fosse di usare le Comunità per fare della
Francia una potenza atomica e far divenire l’Europa un’economia chiusa e protezionistica,
tale da richiamare alla mente finanche Napoleone ed il suo blocco continentale142.
2. Le critiche al piano Fouchet
In riferimento alla questione delle istituzioni e della cooperazione politica, il
giudizio su De Gaulle già allora si mostrava meno severo, soprattutto perché,
contrariamente a quanto avveniva a proposito del suo ideale nazionale, su questo
argomento fu possibile scorgere una certa e comunque non superficiale sensibilità verso i
problemi organizzativi dell’Europa. Anzi, considerato che i federalisti hanno costituito una
voce nel deserto fin dall’inizio della storia dell’europeismo, è da ammettere che De Gaulle
ebbe quanto meno il merito di proporre un piano organico, un modello possibile di Europa
politica. 142 Cfr. anonimo, Spirito comunitario e nazionalismo, ‹‹Popolo europeo››, anno VI, n°4, aprile 1963, p.3
7

Spinelli in persona ha potuto apprezzare come le proposte del generale De Gaulle
sull’organizzazione dell’Europa avessero talune notevoli qualità: in primo luogo, esse
furono il tentativo di rispondere al problema reale dell’assenza di unità; in secondo luogo,
si connotarono per una notevole coerenza logica143. Ora, mentre la prima è piuttosto
scontata, la seconda merita un po’ d’attenzione. La coerenza di De Gaulle è nel fatto che la
sua proposta di confederazione è del tutto in linea con l’ambizione egemonica della
Francia, giacché, mentre una federazione toglie agli stati membri la loro sovranità e ‹‹li
riduce a organi amministrativi e non può funzionare che nella misura in cui trasferisce certi
loro poteri ad un governo federale››, una confederazione riconosce la sovranità dei suoi
membri e riesce perciò a tenerli uniti solo se uno di essi possiede una certa preponderanza ,
incontestata ed incontestabile sugli altri. Una confederazione che non abbia nel suo seno
una potenza leader è votata all’impotenza e al fallimento:
Se la Francia potesse realmente essere la potenza predominante dell’Europa
occidentale, si potrebbe deplorare l’abbandono del cammino delle istituzioni
federali, ma si dovrebbe riconoscere che la formula confederale sarebbe
vitale144
Confermata la correttezza delle questioni sollevate dal Presidente, Spinelli, però,
condannò l’Europa che sarebbe scaturita dal piano Fouchet, definita ‹‹una ridicola assise di
capi di governo››145. Il piano Fouchet rifletteva bene la concezione confederale dell’unità
europea propria del Generale: non mirava alla fusione degli Stati, ma all’affermazione
della supremazia del momento politico e dell’analisi globale dei problemi del Continente
contro ogni forma di sopranazionalità e di delega di poteri decisionali ad organi settoriali e
tecnici; inoltre, estendendosi anche alla materia culturale, pur in una prospettiva
143 A. SPINELLI Le proposte di De Gaulle, cit.144 Ibid.145 A. SPINELLI, Adenaeur, De Gaulle e la democrazia europea, in Popolo europeo, anno V, n°5, ottobre 1962, p.1 e 5
7

progressiva e necessariamente non breve, il piano voleva raggiungere l’obiettivo di “far
apprendere” ai popoli europei i modi della convivenza pacifica e fruttuosa.
Il progetto, però, per i suoi oppositori non rispondeva affatto alle necessità
dell’Europa, specialmente nella sua seconda versione, tanto per la mancanza di una
prospettiva integrazionista - data la cancellazione della clausola, presente in quella
originaria, per la quale alla fine dei tre anni il trattato sarebbe stato modificabile per
stabilire nuove e più approfondite forme di cooperazione – quanto perché estendeva le
competenze del Consiglio – organo decisamente intergovernativo nel quale le decisioni
sarebbero state prese all’unanimità – anche alle questione economiche, omettendosi
qualunque riferimento all’esistenza della CEE e, conseguentemente, alla sopranazionalità e
al voto maggioritario. Infine, perché instaurava tra le due sponde dell’Atlantico un
potenziale ed inopportuno conflitto. Tuttavia, non si escludeva che, per la incapacità della
classe politica europea di avere una visione democratica e per la sua mancanza di
consapevolezza del problema europeo, la concezione di De Gaulle infine avrebbe
trionfato146.
Possono farsi almeno cinque critiche al piano Fouchet. Innanzitutto, esso tendeva
da subito a cristallizzare l’unione, riducendola ad una semplice giustapposizione di Stati
sovrani e rifiutandone, anche in un futuro remoto, un’evoluzione in senso federale.
Un’altra critica era che il piano non prendeva in una qualche degna considerazione la
funzione della rappresentanza parlamentare europea, funzione che, invece, gli altri membri
ritenevano necessaria. Il vero problema non era tanto avere l’elezione a suffragio diretto
dei membri dell’assemblea, fermo che tali elezioni avrebbero potuto avere una grande
importanza per propagandare l’idea europea nei Sei. Il fatto di essere chiamati ad eleggere
dei deputati al parlamento europeo avrebbe certamente portato la massa degli elettori a
rendersi conto che l’idea di Europa non era qualche cosa di astratto, ma una realtà
146 Ibid.
7

concreta. Il problema reale era, però, quello dei poteri. Se questi non fossero stati effettivi,
il suo peso negli affari europei non sarebbe stato molto importante147. Già durante la crisi
della sedia vuota, De Gaulle aveva obiettato che senza un vero governo europeo non
poteva esservi un parlamento propriamente detto: ‹‹d’altra parte, come si poteva pensare
che il governo francese, che a casa sua aveva ridotto a ben poca cosa i poteri del proprio
parlamento, consentisse a rafforzare l’autorità di un parlamento europeo, su cui fra l’altro
non avrebbe avuto nessun controllo? ››148
La terza critica riguardava il fatto che il piano Fouchet spostava il cuore delle
istituzioni europee dagli organi sopranazionali al Consiglio, organo, al contrario,
decisamente intergovernativo. La conseguenza di tale fatto sarebbe stato che nessuna
decisione sarebbe stata presa se non all’unanimità e questo, inevitabilmente, avrebbe reso
molto difficile addivenire a soluzioni condivise sui problemi comuni. Effettivamente, però,
‹‹piano Fouchet o no, la decisione suprema restava sempre nelle mani dei governi›› 149.
Così, la quarta obbiezione non poteva che contestare il fatto che il piano Fouchet,
offrendo soltanto un sistema di procedure per consentire o promuovere la discussione sui
due punti cruciali dell’unione - la politica estera e la politica di difesa – non assicurava
meccanismi decisionali adeguati all’interno della stessa, in tal modo costringendo gli Stati
a trovare da sé e per sé, quindi al di fuori dell’unione, le soluzioni specifiche ai singoli
problemi. In tal modo, forte del peso del suo regime e del suo armamento atomico, la
Francia sarebbe stata in tale unione ‹‹più uguale degli altri ed avrebbe esercitato di fatto
un’influenza egemonica sugli altri cinque, in concorrenza ed in alternativa agli Stati
Uniti››150.
147 M. ALBERTINI, A. CHITI BATELLI, G. PETRILLI, op.cit, p.288.148 P. QUARONI, op.cit,,p.124149 ivi, p.122150 M. ALBERTINI, A. CHITI BATELLI, G. PETRILLI, op.cit., p.288. Questa critica è comune a più autori, per esempio è presente in J.P. GOUZY, De Gaulle, il piano e la bomba, in Popolo europeo, anno VI, n°4, aprile 1963, p.1: ‹‹L’Europa degli uomini di stato che ragionano in termini nazionali, sufficientemente abili nel manovrare nell’ambito delle alleanze, la celebrazione delle solidarietà equilibrate, delle amicizie concertate, l’esaltazione della potenza nazionale: questa è la visione politica di De Gaulle››. Può vedersi
8

3. I giudizi sull’indipendenza “à la De Gaulle”
La quinta critica al piano Fouchet, connessa con la seconda conseguenza della
politica gollista di cui si diceva poc’anzi, riguarda la questione dei rapporti con gli Stati
Uniti e, quindi, l’indipendenza dell’Europa. Nella politica gollista tale questione passava
necessariamente attraverso la NATO.
Che l’Europa avesse bisogno di darsi una posizione autonoma e responsabile nei
confronti del mondo – in particolare nei confronti degli Stati Uniti – che la facesse uscire
dallo stato di puro satellite atlantico, appariva evidente a tutti. Nondimeno, questo avrebbe
dovuto realizzarsi non già col rafforzamento della sovranità nazionale e col recupero della
libertà d’azione dei singoli Stati, bensì attraverso la creazione della federazione europea.
Innanzitutto, questa avrebbe dovuto pensare a rafforzare al suo interno il regime
democratico e solo in seguito, e non per una velleità di irrazionale e pretenzioso
nazionalismo europeo, avrebbe potuto non solo darsi una propria politica estera e militare
ed un proprio esercito, ma anche dotarsi di un proprio credibile armamento nucleare, dato
che una potenza come la federazione europea non potrebbe precludersi in avvenire il diritto
di darsi un proprio armamento atomico151. Il progetto della force de frappe francese era
giudicato più formale che sostanziale e connesso ai rischi di disseminazione indiscriminata
delle armi nucleari e di indebolimento della solidarietà atlantica. Fin quando non sarà
davvero unita, quindi, l’Europa non potrà fare a meno dell’Alleanza Atlantica e
dell’integrazione, tanto più che a garantire che gli americani difenderanno l’Europa in caso
d’aggressione sovietica saranno ‹‹alcune centinaia di migliaia dei suoi soldati schierati
sulla prima linea di difesa delle frontiere dell’Europa››152.
anche P.QUARONI, op.cit., p.128, p.1151 Cfr. M. ALBERTINI, A. CHITI BATELLI, G. PETRILLI, op.cit, 294-295152 P. QUARONI, op.cit., p126
8

La Francia, invece, malgrado il da farsi di De Gaulle, non rappresentava
un’alternativa credibile agli occhi degli altri cinque153. De Gaulle avrebbe voluto creare
un’Europa indipendente rigettando l’integrazione delle forze armate e la tutela americana,
considerati nocivi per la sopravvivenza della Francia, esattamente nello stesso modo in cui
i suoi partners, invece, consideravano tali due fattori essenziali alla loro sopravvivenza.
Nell’idea di Europa “europea” l’arma atomica era necessaria, ma era implicito che essa
dovesse essere solo francese. De Gaulle avrebbe voluto, in pratica, che la politica estera
dell’Europa si conformasse alla sua personale concezione dei rapporti internazionali, col
risultato che questa politica estera europea si sarebbe realizzata ‹‹soltanto previa
accettazione integrale delle tesi francesi››154.
Se il progetto di un’Europa “europea”, per quanto evocativa, per gli oppositori di
De Gaulle doveva intendersi come un’Europa “francese”, non diversa fu la sorte dell’idea
dell’Europa “dall’Atlantico agli Urali”. La realizzazione di questo progetto, il quale
similmente che il precedente non comportava alcuna organizzazione federale degli Stati
compresi tra questi due limiti naturali, presupponeva due elementi: che le nazioni dell’Est
europeo fossero liberate dall’ideologia comunista e dall’influenza russa; che l’espansione
sovietica, sia sotto il profilo ideologico che militare, si arrestasse in modo definitivo. Con
la morte di Stalin, De Gaulle s’era talmente fatto convinto dell’imminenza del crollo del
comunismo che, tra il biasimo degli altri membri dell’Europa comunitaria e dell’Alleanza
Atlantica, pensava di poter da sé fissare la rotta della politica mondiale di distensione, cioè
anche contro il parere dei suoi alleati, in particolare quelli europei. Ora, se è vero che uno
dei futuri possibili compiti che la federazione europea dovrà darsi sarà il “recupero” dei
paesi dell’Est, nel presente e invocando per sé e per la Francia libertà di movimento, De
Gaulle non poteva che mettere a repentaglio la sicurezza dell’Europa facendo il gioco dei
sovietici, perché se era vero che l’Unione Sovietica voleva evitare il conflitto con gli Stati 153 ivi, p. 175154 ivi p.128
8

Uniti, lo era altrettanto il fatto che non aveva alcuna intenzione di allentare, sia pur di
poco, i vincoli che imponeva alle nazioni vicine. L’URSS voleva certamente che il sistema
atlantico si disgregasse e a tal fine vedeva di buon occhio la politica di De Gaulle quando
questi bloccava qualsiasi sviluppo dell’organizzazione europea e prendeva le distanze dagli
Stati Uniti; accoglieva, però, freddamente i suoi sforzi nell’esortare alcuni paesi dell’Est a
deviare un poco fuori dall’orbita sovietica155. Stabilire un equilibrio tra la Francia e
l’Unione Sovietica – entrambe dotate di armi atomiche – in un’Europa senza forze più
americane, sarebbe stato forse la realizzazione di quell’ idea di Europa “dall’Atlantico agli
Urali”; tuttavia, lecito era chiedersi se non sarebbero stati più probabilmente i Soviet sino
all’Atlantico156.
4. I giudizi quanto meno non negativi di oggi
È naturale che il trascorrere del tempo permetta la riconsiderazione a mente fredda
degli eventi remoti, cioè, di vederli senza la fisiologica interferenza del coinvolgimento
indotto dalla contemporaneità. Sulla base di tale considerazione, si può spiegare perché
oggi, venuto meno il confronto tra due sistemi ideologici e, conseguentemente, molte delle
ipocrisie “statali” del passato, l’azione del Generale in favore dell’Europa è stata
riconsiderata in senso quanto meno non negativo. Non manca chi sostiene che, malgrado il
nazionalismo, il suo progetto di cooperazione politica fosse più avanzato di quello dei
sostenitori del Mercato comune157. Col senno del poi, né possiamo dire che De Gaulle – lo
abbiamo argomentato – sia stato un fanatico nazionalista militarista, e nemmeno che la sua
155 Cfr. J. SOUSTELLE, op. cit., p. 321.156 Cfr. M. ALBERTINI, A. CHITI BATELLI, G. PETRILLI, op.cit., p 323157 In L. LEVI – U. MORELLI, op.cit, p.148 troviamo scritto quanto segue: ‹‹De Gaulle era un nazionalista. Sosteneva i primato e l’ineliminabilità delle realtà nazionali. Tuttavia, siccome viveva nell’epoca della crisi dello Stato nazionale, (il corsivo è nostro) era diventato europeista […] con il suo piano De Gaulle proponeva comunque un approfondimento dell’integrazione europea e si poneva su un terreno più avanzato dei sostenitori del Mercato comune››
8

associazione di Stati potesse segnare la dissoluzione dell’Europa – anche se sicuramente
non possiamo cosa sarebbe stata nel concreto tale associazione.
Malgrado il suo nazionalismo, non appare impossibile che il Generale abbia potuto
avere una certa condivisile concezione dell’Europa: un’Europa confederale con una guida
politica propria che estendesse le sue competenze anche all’ambito economico – quello
delle Comunità sopranazionali – oltre che a quello militare e culturale. Inoltre, nonostante
gli evidenti limiti dello strumento, è possibile giudicare positivamente la proposta gollista
del referendum europeo che, più volte ribadita, doveva far aderire le masse popolari alla
costruzione europea e legittimarla158; così come possono apprezzarsi le critiche rivolte agli
organi delle Comunità che, nonostante il loro carattere tecnico e l’assenza di legittimità
democratica, tendevano a considerarsi, seppure in forma embrionale, il governo
dell’Europa.
Oltre che per le questioni inerenti le istituzioni, l’azione di De Gaulle è giudicata
quanto meno non negativa perché, se è vero ch’essa fu orientata a preservare e promuovere
gli interessi francesi, in effetti fu questa azione che difese e favorì l’integrazione europea,
che mise un punto fermo sulla riconciliazione con la Germania – elemento, quest’ultimo,
tanto fondamentale per De Gaulle da essere stato reso ufficiale ed istituzionale con il
trattato franco-tedesco del 1963 – che diede un impulso decisivo all’istituzione del Mercato
comune e che, infine, difese la stabilità e gli equilibri raggiunti dai Sei con il veto
all’Inghilterra, rea di non aver ancora operato una scelta definitiva e chiara per l’Europa e
la sua emancipazione dagli Stati Uniti159. Anche sul fronte dell’indipendenza dell’Europa
la politica di De Gaulle appare oggi degna di considerazione perché rispondente agli
interessi dell’Europa, in quanto è evidente che l’unità politica europea era ed è la sola
alternativa all’atlantismo e che in assenza di un governo federale, ‹‹era inevitabile che la
158 Cfr. ibid.159 Cfr. S. PISTONE, I movimenti per l’unità europea, Università di Pavia, 1996, p.12
8

Francia, lo Stato più libero e forte, svolgesse un ruolo di potenza guida››160. Stando così le
cose, è forse corretto vedere la ripresa del nazionalismo che si manifestò in quegli anni, in
Francia e negli altri paesi europei, come ‹‹una malattia di crescita dell’europeismo›› 161.
Ovviamente i fatti rimangono più che le parole: così, non vi è dubbio che
concretamente De Gaulle bloccò qualunque sviluppo istituzionale di tipo sopranazionale –
l’unico al quale i suoi partners erano disposti – impedendo l’elezione diretta
dell’Assemblea parlamentare, il passaggio a un bilancio comunitario alimentato da risorse
proprie e al voto a maggioranza in seno al Consiglio dei ministri e perseguendo altresì con
successo l’indebolimento del ruolo delle Commissioni europee. I fatti, però, dicono pure
che i suoi avversari non proposero nulla d’alternativo e di credibile; e quando ciò avvenne,
scatenando la “crisi della sedia vuota”, paradossalmente fu proprio De Gaulle che riuscì a
trarne maggior vantaggio, imponendo il suo punto di vista con l’accordo del Lussemburgo.
5. De Gaulle non aveva tutti i torti
Tenendo conto che ‹‹gli europeisti di stretta osservanza continuavano a non vedere
con grande favore l’ingresso dell’Inghilterra nel Mercato Comune››162, si può ritenere la
vicenda del veto all’Inghilterra emblematica di quanto le “distruttive” tesi golliste, per
quanto apparissero le bordate antieuropeistiche di un nazionalista, fossero testimonianza di
una notevole sensibilità di De Gaulle per i problemi dell’Europa e di come potessero
coincidere, in fondo, con le critiche che anche i federalisti inviavano allo stesso indirizzo.
De Gaulle fu in buona compagnia nel denunciare la sopranazionalità.
Innanzitutto, si può rilevare che al termine “sopranazionale”, termine coniato da
Robert Schuman nel 1950, non corrispondesse alcun valore giuridico, volendo, il termine,
soltanto indicare la “posizione” delle istituzioni comunitarie rispetto agli Stati. Chiarito che
160 ibid161 L. LEVI – U. MORELLI, op.cit, p.116162 P. QUARONI, op.cit., p. 99
8

la sopranazionalità non poteva essere invocata come un principio giuridico su cui costruire
l’Europa, tale considerazione sarebbe stata di per sé sufficiente a screditare l’intera
organizzazione dell’integrazione europea in un sol colpo163. Essendo, poi, il difetto delle
Comunità europee ‹‹detto paradossalmente in una sola parola [era ed è, come si è già
accennato] quello di non essere affatto sovrannazionali››164 trovava fondamento anche
l’argomentazione di De Gaulle secondo cui queste fossero il frutto e, al contempo, mezzi di
propaganda165. Il centro della decisione politica, di fatti, non poteva essere la
Commissione, ma il Consiglio dei Ministri, che a norma dei trattati assumeva le decisioni
all’unanimità (almeno fino alla conclusione della seconda fase d’attuazione dei trattati); e
poiché l’applicazione delle decisioni sarebbe sempre spettata solo agli Stati, anche il voto a
maggioranza avrebbe potuto non significare molto:
Ogni paese, si tratti della Germania o del Lussemburgo, ha dunque il diritto
di veto. E non è una questione puramente teorica […] è molto dubbio se, e
fino a che punto, sia possibile obbligare un Paese sovrano ad accettare una
decisione contraria ai suoi interessi, veri o presunti, solo perché la
maggioranza degli altri vuole così […] Qualsiasi cosa sia stata scritta nei
trattati, non esistono mezzi effettivi per imporre a uno Stato che non intenda
accettarle, delle decisioni prese dagli altri, seppure a maggioranza166
Ora, poiché l’Europa sopranazionale non era (e non è) che un modo, in fin dei
conti, per mascherare il riaffermarsi degli Stati nazionali e dei loro interessi167, nessuna
Commissione potendo qualificarsi come un esecutivo europeo ed il cosiddetto Parlamento
non essendo altro che un’assemblea consultiva, si veniva a dimostrare che, in fondo, De
163 P. FOSSI, Charles de Gaulle o la fede nello Spirito, Milano, Marzorati editore, 1973, p.239 (in nota) racconta l’episodio come segue: ‹‹ (Davanti all’Assemblea Nazionale, il 25 luglio 1950) Egli diceva: “L’essenziale è di creare l’autorità sopranazionale che sia espressione della solidarietà fra i paesi e alla quale sarà conferita una parcella dei poteri di ciascuno di questi paesi”[…] è stato questo errore di dottrina politica, errore involontario e fatto con le migliori intenzioni, che ha sviato e condotto in un vicolo cieco l’azione per la unificazione europea. In esso si sono gettati gran parte degli uomini politici europei, in buona e meno candida fede ›› 164 M. ALBERTINI, A. CHITI BATELLI, G. PETRILLI, op. cit., p.255165 Cfr. ivi, 259166 P. QUARONI, op.cit., p.120167 Ibid.
8

Gaulle avesse torto solo nella fase construens del suo discorso (in realtà non è poco!),
fermo che quella destruens fosse comunque condivisile.
Invero, i federalisti non negavano che l’Europa potesse dotarsi di un arsenale
atomico, che potesse recitare un ruolo, in futuro, di grande e ritrovata potenza mondiale in
grado di competere, su tutti i fronti, con Stati Uniti ed Unione Sovietica168. Inoltre, ( a
modo di riepilogo) essi sostenevano che l’integrazione settoriale non rispondesse
esaurientemente agli interessi e alle aspirazioni europee, che gli esecutivi delle comunità
non avessero le caratteristiche tecniche e di legittimità per ergersi a governo europeo, che
l’assemblea parlamentare non fosse un vero parlamento, che la sopranazionalità fosse un
principio privo di contenuto giuridico, che le istituzioni comunitarie arretrassero per
necessità quando i governi nazionali tenevano troppo ai loro interessi. In breve, essi non
negavano che quelle che De Gaulle considerava delle finzioni, dei miti, delle chimere
fossero davvero tali169. Per loro, il Mercato Comune era senz’altro un’esperienza positiva
per l’Europa, sia sul piano dell’integrazione e dello sviluppo economico che su quello
dello spirito della cooperazione sopranazionale. Questo, però, non poteva considerarsi la
forma definitiva dell’Europa, anche per la sua evidente debolezza di fronte alla visione
dell’Europa delle Patrie di De Gaulle. A quest’ultimo progetto andava necessariamente
contrapposto un modello davvero europeo, avanzato e democratico. De Gaulle, in fondo,
non aveva fatto altro che toccare il punto debole della costruzione sopranazionale, ossia
che, fino a quando gli Stati avranno la volontà di applicare i trattati, questi funzioneranno;
ma nel momento in cui la congiuntura economica cambierà, se lo sviluppo del Mercato
comune lederà un paese o qualche gruppo politicamente rilevante al suo interno, potendo
giungere alla conclusione che per loro è più conveniente sottrarsi agli impegni assunti,
questi Stati faranno andare la Comunità in pezzi. Essi, però, negavano che la risposta di
168 Sull’argomento può vedersi M. ALBERTINI, A. CHITI BATELLI, G. PETRILLI, op.cit, 294-295169 Sulle debolezze istituzionali delle Comunità: A. CABELLA, cit ; A. SPINELLI, Le proposte di De Gaulle, cit.; G. MAMMARELLA, P. CACACE, op.cit, p.100
8

De Gaulle fosse adeguata, perché la loro opinione era che lo Stato nazionale avesse
esaurito la sua funzione storica.
Quando sollevò la domanda di chi sarebbe stato il “federatore” dell’Europa, De
Gaulle pose una domanda corretta, sì, ma rispose “male” perché vedeva solo gli Stati
nazionali170. Eppure, egli era ben consapevole che più che un “federatore” in carne ed
ossa, all’Europa sarebbe servita un’ispirazione ‹‹un principio ideale animatore, una
missione in cui credere, una ragione comune d’esistenza››171.. Solo che egli pensava di
poterlo trovare ricreando in Europa una sorta di atmosfera romantica, deteriore per
necessità, ma pur sempre animata da uno slancio dello Spirito e non dalla mediocrità
affaristica borghese.
CONCLUSIONI
Benché dalla fine della guerra De Gaulle avesse parlato molto anche d’Europa, sul
tema della sua unità egli uscì dall’ambiguità solo negli anni Sessanta. Prima del suo
ritorno al potere, nella sua condizione di semplice generale in pensione, aveva, sì, espresso
l’opinione per cui quest’unità europea aveva da farsi non per fusione degli Stati, ma nel
rispetto delle loro sovranità; tuttavia, abbiamo visto come egli parlasse anche di
federazione e accennasse a possibili deleghe di sovranità. Fu tornando al potere, posto di
fronte alle Comunità e alla necessità di far si che la Francia fosse grande nel mondo, che,
mediante la sua condotta politica, De Gaulle chiarì la sua visione sull’Europa, spiegando
cosa accettasse di quella integrazione a Sei e cosa, invece, rifiutasse. Nel voler chiarire in
modo definitivo quale fosse la sua idea dell’Europa, però, ci si accorge presto che tale
visione va desunta da tutti i rifiuti che De Gaulle oppose alle Comunità.
170 Cfr. A. SPINELLI, Adenaeur, De Gaulle e la democrazia europea,cit.171 A. CABELLA , cit.
8

Innanzitutto, riconosciuto come essenziale che l’Europa sia unita, per De Gaulle è
indispensabile che essa si fondi su qualcosa di reale, come sono gli Stati. L’Europa
sopranazionale, invece, s’illude di mettere insieme popoli diversi, senza tener conto delle
loro differenze di storia, di lingua, di genio ed altro ancora. Evidentemente, solo gli Stati
sono le realtà su cui può farsi l’Europa, perché solo gli Stati sono le entità che hanno il
diritto e l’autorità d’agire in nome e per conto dei popoli: pensare che si possa costruire
qualcosa al di sopra dello Stato, che abbia la capacità di decidere e di applicare le
decisioni prese, è una chimère. Solo lo Stato incarna lo Spirito di un popolo e solo al suo
interno possono esistere la politica e la legittimità172.
Sul piano istituzionale, il rifiuto di De Gaulle del sistema delle Comunità è netto,
poiché tale sistema tradisce i principi della cultura politica europea: le Commissioni (gli
“esecutivi”) si proclamano indipendenti, ma i loro membri sono nominati e pagati dagli
Stati, non hanno alcun legame con i popoli e non vi rispondono del loro operato;
l’Assemblea riunisce membri cooptati dai parlamenti nazionali a cui nessuno, però, ha mai
conferito un mandato europeo. Per il fatto di configurare un governo di tecnocrati, vale a
dire un governo senza responsabilità politica e legittimato solo dalla competenza tecnica,
queste istituzioni hanno la tendenza ad annullare la democrazia perché, oltre tutto,
svuotano progressivamente di prerogative i governi nazionali, rendendo in tal modo
illusoria la sovranità popolare anche dentro gli Stati. Questo “furto” della sovranità
nazionale si completa con la previsione del voto a maggioranza in seno al Consiglio,
saggiamente evitato con l’accordo del Lussemburgo173, che ha l’effetto di costringere uno
172 Sull’argomento possono consultarsi i seguenti documenti : Conferenza stampa del 5 settembre 1960 ; Conferenza stampa del 23 luglio 1964 ; Seconda intervista radio e teletrasmessa con Michel Droit, 14 dicembre 1965. Tutti sono disponibili in Discours et messages, cit.173 L’articolo 1 del compromesso di Lussemburgo, che chiuse la “crisi della sedia vuota”, sanciva quanto segue: ‹‹ Quando, nel caso di decisioni che possono essere prese a maggioranza su proposta della Commissione, sono in gioco interessi molto importanti di uno o più partners, i membri del Consiglio si adopreranno a trovare, in un ragionevole lasso di tempo, soluzioni che possano essere adottate da tutti i membri del Consiglio, nel rispetto dei loro interessi e di quelli della Comunità, conformemente all’art. 2 del Trattato›› L’articolo 2 proseguiva così: ‹‹Per quanto riguarda il paragrafo precedente, la delegazione francese ritiene che, quando si tratta di interessi molto
8

Stato ad accettare le decisioni altrui e che impedisce, mediante lunghi ma ragionevoli
negoziati, che si possa giungere ad assumere decisioni condivise ed eque174. Il voto a
maggioranza è semplicemente impraticabile, perché ‹‹il n’y a pas moyen, à l’heure qui est,
de faire en sorte qu’une majorité étrangère puisse contraindre des nations
récalcitrantes››175. Dunque, piuttosto che farla, il voto a maggioranza rischia di romperla
l’Europa. La regola delle decisioni deve essere indiscutibilemente l’unanimità. L’unica
soluzione alternativa ad un ‹‹aréopage technocratique, apatride et irresponsabile›› è dunque
la confederazione176. La sopranazionalità, oltre tutto, è un principio illusorio perché, gli
esecutivi comunitari si dimostrano del tutto incapaci di decidere sulle questioni più
importanti, in occasioni delle quali, è il tradizionale lavoro della diplomazia a consentire di
giungere a conclusione177.
È andando oltre i fatti organizzativi, però, che troviamo finalmente una concezione
“positiva”, ossia affermata senza contrapporsi a qualcuno. Più che un’opinione, però, è un
sentimento. De Gaulle ritiene che l’Europa sia soprattutto un’unica grande civiltà che si
fonda su di ‹‹une comune maniére di vivre, un meme droit des gens›› e che ha dominato il
mondo ‹‹par sa richesse, sa puissance, son rayonnement››178; che, dopo l’infatuazione
ideologica e i drammatici recenti eventi bellici, deve ricostituirsi ‹‹unie par l’esprit de
liberté et de réelle démocratie, groupée en vue du progrés économique, social et culturel
commun››179. Finanche i più grandi letterati, per De Gaulle, appartengono al patrimonio
importanti, la discussione dovrà essere proseguita sino al raggiungimento di un accordo unanime››. La fonte è L. LEVI, U. MORELLI, op.cit, p.162174 Cfr. Conferenza stampa all’Eliseo, 21 febbraio 1966, Discours et messages, cit.175 Conferenza stampa all’Eliseo, 15 maggio 1962, cit.176 Cfr. Conferenza stampa del 9 settembre 1965, in Discours et messages, cit.177 La preponderanza dei governi nazionali nel procedimento decisionale comunitario è ben espressa in C. DE GAULLE, Mémoires d’espoir,cit., p.145 ‹‹Ainsi doit-on remarquer que les soi-disant « exécutifs » installé à la tête des organismes communes en vertu des illusions d’intégration qui sévissaient avant mon retour, se trouvent impuissants dés lors qu’il faut trancher et imposer, que seuls les Gouvernements sont en mesure de le faire et qu’eux-mêmes n’y parviennent qu’au prix de négociations en bonne et due forme entre ministres ou ambassadeurs›› 178 Discorso pronunciato a Strasburgo, 7 aprile 1947 in Discours et messages, cit. 179 Allocuzione pronunciata all’associazione della stampa anglo-americana, 9 luglio 1947 in www.gaullisme.org
9

culturale europeo, per quanto siano legati alla propria tradizione nazionale e alla propria
lingua:
Dante, Gœthe, Chateaubriand, appartiennent à toute l’Europe dans la mesure même
où ils étaient respectivement Italien, Allemand et Français. Ils n’auraient pas
beaucoup servi l’Europe s’ils avaient été des apatrides et s’ils avaient pensé, écrit en
quelque « espéranto » ou « volapük » intégré […]›› 180.
Fu proprio in virtù di queste considerazioni che De Gaulle volle che tra le materie
della sua unione politica vi fosse pure la cultura.
Infine, quest’Europa deve poter affermare la propria identità nel
mondo e pesare negli equilibri internazionali. Intesa come una sorta di
comunità continentale di uomini liberi e di Stati indipendenti
organizzati, l’Europa deve essere in grado di contenere le pretese
egemoniche che provengono sia da Ovest che da Est e stabilire, tra le
due “masse rivali”, un fattore d’equilibrio da cui scaturirà la pace. Ma
per ottenere questo risultato, è necessario che l’Europa riesca a darsi
una politica autenticamente europea, ossia che operi il superamento di
quella sopranazionalità la quale, affidando il governo alla tecnocrazia e
annullando il momento della scelta politica, finisce per favorire l’assorbimento
“atlantico” dell’Europa. Solo l’istituzione della cooperazione politica,
economica e strategica degli Stati, quindi, può portare l’Europa, ormai
sazia di conquiste e maturata nella consapevolezza che ogni popolo
della Terra ha il diritto di decidere del proprio destino, ad affermarsi
come una delle tre potenze planetarie e permettere che un giorno
quest’Europa unita potrà finanche arbitrare tra i due avversari e
garantire, finalmente, le condizioni per una pace duratura: ‹‹Y aurait-il
eut une guerre en Asie, y en aurait-il une en Orient, si notre continent
180 Conferenza stampa all’Eliseo, 15 maggio 1962,cit.
9

avait organisé sa coopération ? Y aurait-il eu une guerre du Viêt-nam si
l’Europe était unie ?››181
È lecito chiedersi, a questo punto, come sarebbe stata questa confederazione
vagheggiata da De Gaulle. Posto di fronte al rischio di vedere fallire la sua proposta di
unione politica, il 15 maggio 1962 De Gaulle dichiarava:
Qu’est-ce que la France propose à ses cinq partenaires? Je le répète
une fois de plus. Pour nous organiser politiquement, commençons
par le commencement. Organisons notre coopération. Réunissons
périodiquement nos Chefs d’Etat ou de Gouvernement pour qu’ils
examinent en commun les problèmes qui sont les nôtres et pour
qu’ils prennent à leur égard des décisions qui seront celles de
l’Europe. Formons une commission politique, une commission de
défense et une commission culturelle, de même que nous avons déjà
une commission économique à Bruxelles qui étudie les questions
communes et qui prépare les décisions des six Gouvernement 182.
Per quanto riguarda le sue forme, in realtà, l’Europa di De Gaulle è tutta qui. Ciò
che si evince con grande chiarezza è come egli faccia la distinzione tra il ruolo della
politica e quello dei tecnici, parlando, sì, della necessità di costituire varie commissioni
per i diversi aspetti della cooperazione da approfondire – la politica, la difesa, la cultura –
ma sottolineando come l’ambito della decisione debba sempre essere riservato ai capi di
Stato e di governo, rimanendo alle Commissioni solo il compito di fungere da “strumenti”
per facilitare la cooperazione. In altri termini, tale confederazione era ‹‹un patto di
consultazione a più livelli, che allontanava indefinitamente la prospettiva di un’Europa
integrata e sopranazionale››183. Il piano Fouchet rispecchiava in pieno quest’ultima logica.
181 Si vedano : conferenza stampa tenuta al palazzo dell’eliseo, 23 luglio 1964; conferenza stampa tenuta al Palazzo dell’Eliseo, 28 octobre 1966; Conferenza stampa tenuta al Palazzo dell’Eliseo, 9 settembre 1968 in Discours et messages, cit; discorso pronunciato a Lille, 29 giugno 1947; discorso pronunciato al parlamento polacco, 11 settembre 1967 in www.gaullisme.org 182 Conferenza stampa del 15 Maggio 1962183 G. MAMMARELLA, op.cit., p.308.
9

Ciò che mancò del tutto nel piano Fouchet furono i contenuti democratici. Dalla
sua adozione sarebbero potuti conseguire effetti positivi per l’Europa, giacché è
prevedibile che l’istituzione della cooperazione politica, ponendo attorno ad un tavolo i
governi europei per la trattazione di questioni diverse da quelle economiche, avrebbe
potuto permettere il superamento di quella convinzione per la quale nessuna forma, se non
vaga, di idealismo poteva unire l’Europa meglio che il business. Benché in un certo senso
lungimirante184, tale impostazione non era affatto soddisfacente. Sostenere che con la
pratica intergovernativa si faceva salva la sovranità popolare, infatti, era azzardato, visto
che, in ultima analisi, non era nemmeno nei governi rappresentativi degli Stati che si
sarebbero concentrano i poteri decisionali, ma nelle mani di pochi uomini.
Tale incoerenza era in rebus. Riconducendo, De Gaulle, la legittimazione
dell’autorità politica non già nel popolo, ma nella nazione, nelle “personalità eccezionali”,
o semplicemente nella Provvidenza, e ricorrendo al popolo solo per fondare e rigenerare
di volta in volta il “patto sociale”: come si poteva pensare che proprio De Gaulle avrebbe
potuto proporre istituzioni democratiche per l’Europa, secondo le consuete formule
parlamentari? Dal suo punto di vista, la democrazia, così come qualunque forma di
governo, non ha alcuna importanza, avendo rilevanza solo la legittimità del potere. Fu sul
tema della legittimità, infatti, che De Gaulle attaccò l’Europa, non già su quello della
democrazia. Con il suo piano Fouchet, sul terreno istituzionale, De Gaulle mirava solo a
creare un sistema europeo legittimo. Stabilito che De Gaulle, malgrado la sua concezione
del potere, non fosse un fautore di eventi bellici, ma anzi proponeva per l’Europa la pace
e, in qualche modo, l’unità, non può dirsi che le sue intenzioni non fossero condivisibili.
184 S’intende dire che secondo noi è possibile affermare che l’Europa uscita da Maastricht assomigli molto più a quella auspicata dal generale che non a quella perseguita dai federalisti. Inoltre, ci sembra che vi sia una notevole corrispondenza tra l’Europa attuale e quella dall’Atlantico agli Urali. L’avallo a questa intuizione è fornita da G. MAMMARELLA, P. CACACE, op.cit., p.122 e da G. QUAGLIARIELLO, op.cit., p. 728
9

Usciti dall’ambito delle idee ed entrando in quello della politica di governo, ossia
della ragion di Stato, si deve, però, osservare in De Gaulle un comportamento
prevalentemente distruttivo. Lo stesso piano Fouchet ne è un esempio. Una domanda è
rimasta insoluta nel corso di questo lavoro: perché De Gaulle modificò la bozza sulla quale
ci sarebbe stato, probabilmente, l’accordo con i cinque partners? La risposta, a nostro
giudizio, è che il piano Fouchet, in vero, costituisse “un’esca” al fine d’ottenere che
l’agricoltura entrasse prepotentemente nel Mercato Comune, essendo tale settore
considerato di vitale importanza per l’economia francese. È vero che De Gaulle cercasse
fin dall’inizio di mettere à leur place, le comunità per tutte le ragioni ampiamente
esposte185; tuttavia, è chiaro che, quando comprese che non sarebbe mai riuscito a separare
i cinque partners dagli Stati Uniti d’America, egli pensò soltanto di ottenere dai trattati
tutti i vantaggi possibili, usando tutti i mezzi che, dentro o al limite della legalità e dello
spirito di questi trattati, potevano essere utili all’esclusivo interesse francese. Per affermare
ciò è sufficiente la considerazione che, svolgendosi in parallelo i negoziati per
l’agricoltura, per l’unione politica e per l’ingresso dell’Inghilterra nel Mercato Comune,
egli affrettò il più possibile l’accordo sul primo negoziato, per poter, ottenuto il suo scopo,
modificare le condizioni del secondo e, infine, poter invocare l’incompatibilità tra le regole
dell’agricoltura comunitarie e il Commonwealth britannico onde neutralizzare il terzo. In
questo senso, quindi, la “generosità” della prima bozza Fouchet va vista solo come la
contropartita promessa ai partners in cambio dell’agricoltura. Solo che, una volta
soddisfatto l’interesse francese, non ci fu alcuna contropartita.
Ora, fatto certo che De Gaulle non avrebbe mai realizzato una reale unità europea e
che la sua visione dell’Europa fosse, più che altro, quella di una comunità umana con il
185 Ci sembra importante riportare un’indicazione che il Generale diede al suo primo ministro M.Debré, tratta da Lettres, Notes et Carnets 1958-1960, p 399, in cui manifesta che la sua vera intenzione nel promuovere l’unione politica è il completo superamento del sistema comunitario : « Si nous parvenons à faire naître l’Europe de la coopération des États, les Communautés sont ipso facto mises à leur place. C’est seulement si nous ne parvenions pas à faire naître l’Europe politique que nous en viendrons à nous en prendre directement aux premiers fruits de l’intégration. »
9

compito, per una necessità storica e morale, di organizzarsi al fine di recuperare il suo
ruolo di dispensatrice di civiltà universale, la sua politica avrebbe dovuto indurre i suoi
oppositori a contrapporgli seriamente il progetto di una federazione.
Il fatto che, a distanza di anni dall’uscita di scena del Generale, l’Europa non si sia
ancora data un assetto federale, per quanto da tutti considerato indispensabile, potrebbe
dimostrare che se la ragion di Stato è venuta e continua ad essere un ostacolo all’unità, tale
ostacolo non risponde necessariamente al nome di Charles De Gaulle.
BIBLIOGRAFIA
C. DE GAULLE, Mémoires de guerre – L’appel: 1940-1942, Paris, Plon, 1999
– L’unité: 1942-1944, Paris, Plon, 1999
9

– Le salut : 1944-1946, Paris, Plon, 1999
C. DE GAULLE, Lettres, notes et carnets 1961-1963,Paris, Plon, 1986
C. DE GAULLE, Mémoires d’espoir, Paris, Plon ,1970
C. DE GAULLE, Memorie della speranza, Milano, Rizzoli, 1970
Discorsi di CHARLES DE GAULLE in: Discours et messages, Paris, Plon, 1971 e dal sito
internet www.gallisme.org:
Dichiarazione del 7 aprile 1947
Dichiarazione del 9 luglio 1947
Dichiarazione del 12 novembre 1947
Discorso di chiusura della prima assise nazionale del R.P.F a Marsiglia,
18 aprile 1948
Conferenza stampa tenuta alla “Maison de la Résistance allie”, 1 ottobre 1948
Discorso di chiusura della seconda assise nazionale del R.P.F., Lille,
12 febbraio 1949
Conferenza stampa tenuta al Palais d’Orsay, 29 marzo 1949
Comunicato del consiglio di direzione del R.P.F., 7 agosto 1949
Discorso pronunciato a Bordeaux il 25 settembre 1949
Conferenza stampa tenuta al Palazzo d’Orsay, 14 novembre 1949
Conferenza stampa tenuta al Palais d’Orsay, 16 marzo 1950
Dichiarazione del 17 aprile 1950
Discorso di chiusura pronunciato alla “pelouse” de Bagatelle, 1
maggio 1950.
Intervista a M. Bradfort dell’agenzia “United Press”, 10 luglio 1950
Conferenza stampa tenuta al Palais d’Orsay, 22 giugno 1951
Conferenza stampa tenuta al Palais d’Orsay, 21 dicembre 1951
9

Discorso del 6 giugno 1952
Discorso del 6 luglio 1952
Conferenza stampa tenuta all’Hotel Continental, 25 febbraio 1953
Conferenza stampa tenuta all’Hotel Continental, 12 novembre 1953
Conferenza stampa tenuta al Palazzo dell’Eliseo, 5 settembre 1960
Allocuzione radio e tele trasmessa pronunciata al Palazzo dell’Eliseo,
5 febbraio 1962
Conferenza stampa tenuta al Palazzo dell’Eliseo, 15 mai 1962
Conferenza stampa tenuta al Palazzo dell’Eliseo, 14 gennaio 1963
Conferenza stampa tenuta al Palazzo dell’Eliseo, 31 gennaio 1964
Allocuzione radio e teletrasmessa pronunciata al Palazzo dell’Eliseo,
16 aprile 1964
Conferenza stampa tenuta al Palazzo dell’Eliseo, 23 luglio 1964
Discorso pronunciato a Strasburgo, 22 novembre 1964
Conferenza stampa tenuta al Palazzo dell’Eliseo, 4 febbraio 1965
Conferenza stampa tenuta al Palazzo dell’Eliseo, 9 settembre 1965
Seconda intervista radio e teletrasmessa con M. Droit, 14 dicembre
1965
Conferenza stampa tenuta al Palazzo dell’Eliseo, 21 febbraio 1966
Conferenza stampa tenuta al Palazzo dell’Eliseo, 28 ottobre 1966
Conferenza stampa tenuta al Palazzo dell’Eliseo, 16 maggio 1967
Discorso pronunciato al parlamento polacco, 11 settembre1967
Conferenza stampa tenuta al Palazzo dell’Eliseo, 9 settembre 1968
9

M. ALBERTINI, A. CHITI BATELLI, G. PETRILLI, Storia del federalismo europeo, Torino,
UTET, 1973
R. BRIZZI, M. MARCHI, Charles De Gaulle, Bologna, Il Mulino, 2008
D. CAVIGLIA, De Gaulle e il tentativo di spostare l’asse politico europeo: il piano
Fouchet, Padova, CEDAM, 2000
J.L. CHABOT, Il nazionalismo, Milano, Mondadori, 1995
D. COOK, De Gaulle, Milano, Dall’Oglio, 1987
P. FOSSI, Charles De Gaulle o la fede nello spirito, Milano, Marzorati editore, 1973
E. GUCCIONE, Il fallimento della CED e l’idea di federalizzazione in Carl Joachim
Friedrich, Torino, Giappichelli, 2007
L. LEVI, U. MORELLI, L’unificazione europea. Cinquant’anni di storia,Torino, Celid, 1994
G. MAMMARELLA, Storia d’Europa dal 1945 ad oggi, Roma-Bari, Laterza, 1980
G. MAMMARELLA, P. CACACE, Storia e politica dell’Unione Europea, Roma-Bari,Laterza,
1999
B. OLIVI, L’Europa difficile. Storia politica dell’integrazione europea 1948-1998,
Bologna, Il Mulino,1998
S. PISTONE, I movimenti per l’unità europea, Università di Pavia, 1996
S.PISTONE, L’integrazione europea, Torino, UTET, 1999
G. QUAGLIARIELLO, De Gaulle e il gollismo, Bologna, Il Mulino, 2003
P. QUARONI, L’Europa al bivio, Milano, Ferro, 1965
R. RÉMOND, La destra in Francia, Torino, U. Mursia & C., 1970
S. ROMANO, Europa storia di un’idea, dall’Impero all’Unione, Milano, Longanesi, 2004
J. SOUSTELLE, Gollismo. Ventotto anni di regime, Milano, Edizioni del Borghese, 1969
A.SPINELLI, E.ROSSI, E.COLORNI, Manifesto di Ventotene, 1941, in:
www.freeweb.supereva.com
P. VIOLA, Storia moderna e contemporanea, Il Novecento, Einaudi, 2000
9

C. WILLIAMS, De Gaulle, Milano, Mondadori, 1997
Enciclopedia Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation.
EMEROTECA
F. SÉRUSCLAT, Il pericolo De Gaulle, in ‹‹Popolo europeo››, anno I, n°5, maggio 1958
A. SPINELLI, Le proposte di De Gaulle, in ‹‹Popolo europeo››, anno III, n°10, ottobre1960
A. SPINELLI, Adenaeur, De Gaulle e la democrazia europea, in ‹‹Popolo europeo››, anno
V, n°5, ottobre 1962
A. CABELLA, La truffa dell’Europa delle Patrie, in ‹‹Popolo europeo››, anno V, n°4, aprile
1962
J.P. GOUZY, De Gaulle, il piano e la bomba, in ‹‹Popolo europeo››, anno VI, n°4, aprile
1963
R. RÉMOND, La Francia e l’Europa, in ‹‹Comunità europee››, anno, IX, n°12, dicembre
1963
9