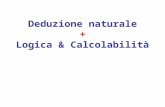De Gaetano Lessico 2 STdef cartonata...
Transcript of De Gaetano Lessico 2 STdef cartonata...
CčėĎĘęĎĆē UěĆ
STORIA
Esterno tramonto. Due uomini in abiti ottocenteschi si inoltra-no su un sentiero avvicinandosi allo scheletro in cemento armato di un moderno edifi cio in costruzione dove trovare riparo per la notte. Sono Domenico, aristocratico con una tradizione giacobina alle spalle, e Saverio, fi glio di un suo amico di gioventù di origini contadine. Entrambi sono diretti in Aspromonte per unirsi ad una formazione armata che dovrà incontrare Giuseppe Garibaldi.
È il 1862 e l’Italia è appena stata “fatta”: è l’alba della nazione.Si tratta di un frammento di Noi credevamo, il fi lm di Mario
Martone uscito in sala nel 2010 e riproposto l’anno successivo in occasione del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, ma altresì a poco più di cento anni da La presa di Roma (1905) di Filoteo Alberini, primo fi lm italiano a soggetto di carattere stori-co (anche in questo caso risorgimentale) ed opera fondativa di un fi lone mirato ad attingere al patrimonio di miti, eroi, codici dell’I-talia postunitaria per rifl ettere sull’idea di nazione.
Collocata in una temperie lontana cronologicamente ma so-prattutto culturalmente dal breve fi lm di Alberini, l’opera di Mar-tone si confi gura di fatto come un “laboratorio” in cui è proprio la nozione di fi lm storico ad essere problematizzata, almeno quella comune, vaga e limitata, di genere cinematografi co contraddistin-to da precise regole e stereotipi riguardanti qualsiasi opera che non sia ambientata nel presente, ossia che lo spettatore non possa col-locare nella dimensione contemporanea dell’attualità.
Contrariamente a tale canone, in Noi credevamo si segnala in-fatti, come attesta la scena sopra evocata, la disseminazione di una serie crescente di tracce del presente – inizialmente quasi invisibili, poi sempre più invadenti in coincidenza di un rapporto narrativo con la contemporaneità maggiormente stringente – volte a inten-sifi care quella componente dell’esperienza spettatoriale, generata
164 Lessico del cinema italiano
da qualsiasi fi lm di carattere storico, per cui «solo a condizione di lasciarsi prendere dall’anacronismo, di vivere quel fi lm come “suo contemporaneo” [il pubblico] può davvero riandare, attraverso di esso, al passato»1.
È proprio l’anacronismo, in eơ etti, la cifra adottata e radicalizza-ta con consapevolezza da Martone laddove la sua visione “eversiva” della storia intende sfruttare a pieno titolo lo «straordinario mon-taggio di tempi eterogenei»2 di cui parla Georges Didi-Huberman a proposito della statutaria capacità di qualsiasi immagine (a mag-gior ragione di quella cinematografi ca) di produrre un’incessante riconfi gurazione di presente e passato.
Ecco allora che il romanzo di Anna Banti al quale il fi lm è ispi-rato, in ragione della «radicalità repubblicana»3 di cui è pervaso soprattutto tramite la fi gura di uno dei protagonisti, il mazziniano Domenico Lopresti, diventa l’occasione ideale per dare sfogo all’i-stanza da cui Martone dichiara di essere partito:
Non pensavo tanto al passato, alla storia d’Italia, che in fondo non conoscevo aơ atto, ma, rifl ettendo sul rapporto fi siologico fra terrori-smo e lotta per l’identità nazionale, mi chiedevo: com’è possibile […] che la storia d’Italia sia stata soltanto una storia di grandi battaglie, gesti eroici e abilissime diplomazie, senza quel fatale e pesantissimo contrappeso che l’impegno di una lotta del genere comporta?4
Attraverso la ricerca di una deliberata “aberrazione storica” – contestualizzata in una ricostruzione per il resto fi lologicamente ineccepibile quanto inedita – Noi credevamo estremizza quindi, in maniera esemplare, quel processo di intrusione di un’epoca nell’altra – o, per dirla con Nicole Loraux, di confi gurazione di un «tempo fuori dai suoi cardini»5 – fermamente condannato, in am-
1 P. Ortoleva, Cinema e storia. Scene dal passato, Loescher, Torino 1991, p. 61.
2 G. Didi-Huberman, Storia dell’arte e anacronismo delle immagini, Bollati Boringhieri, Torino 2007, p. 19 [ed. or. Devant le temps. Histoire de l’art et anachronisme des images, Les Éditions de Minuit, Paris 2000].
3 M. Martone, Noi credevamo, Bompiani, Milano 2010, p. X.4 Ivi, p. VIII.5 Loraux impiega tale locuzione parafrasando lo shakespeariano «tempo
fuor di sesto» («time out of joint») dell’Amleto (Atto 1, Scena 5). Cfr. N. Loraux, Éloge de l’anachronisme en histoire, in Les voies traversières de
Storia Christian Uva 165
bito storiografi co, da Lucien Febvre proprio in quanto pericolosa forma di anacronismo e sostenuto invece da Marc Bloch, l’altro pa-dre della scuola delle “Annales”, come fattore strutturale con cui lo studioso deve necessariamente fare i conti visto che, per dirla con Jacques Rancière, «la molteplicità delle linee di temporalità, del senso stesso di tempo incluso in uno “stesso” tempo, è la condizio-ne dell’agire storico»6.
A dimostrare come tale assunto – al di là dei casi più estremi (quale quello di Martone) – sia a maggior ragione attribuibile tout
court all’agire cinematografi co è lo stesso, menzionato, terminus a
quo del rapporto tra storia e cinema italiano, quella sorta di attua-lità ricostruita ma anche, già, di spettacolo mitizzante rappresen-tato da La presa di Roma, narrazione in sette quadri (della durata originaria di dieci minuti circa) che, proiettata il 20 settembre del 1905 su un grande schermo piazzato proprio dinanzi alla Breccia di Porta Pia a Roma, immerge la retorica nazionalistica del tempo nella miscela tra realismo della ricostruzione storica e spettacola-rità delle scene, aprendo la strada, dal punto di vista sia formale che tematico, ai kolossal degli anni a venire.
La fedeltà alla realtà (in questo caso storica) è per il suo autore un imperativo categorico mutuato dalla fi losofi a che allora perva-de la tecnologia di riproduzione delle immagini: anche per Alberi-ni il cinema è infatti «fotografi a animata», per impiegare la famosa locuzione con cui BolesÏaw Matuszewski esalta nel 1898, con tutta l’enfasi positivista tipica dell’epoca, il «carattere di autenticità, di esattezza, di precisione che appartiene solo a essa», candidando-la ad assurgere «per eccellenza» al ruolo di «testimone veridico e infallibile»,7 ovvero, secondo la defi nizione che ne darà David Wark Griƥ th, di vero e proprio strumento di «scrittura storica»8.
Nicole Loraux. Une helléniste à la croisée des sciences sociales, numéro unique d’“EspacesTemps Les Cahiers”, n. 87-88, e “CLIO, Histoire, Femmes et Sociétés” (2005), p. 129.
6 J. Rancière, Le concept d’anachronisme et la vérité de l’historien, in “L’Inac-tuel”, n. 6 (1996), pp. 67-68.
7 B. Matuszewski, Une Nouvelle Source de l’Histoire du cinéma (Création
d’un Dépot de Cinématographie Historique), Noizette et cie., Paris 1898, p. 9.
8 Cfr. Materiali e atti del convegno L’America attraverso i fi lm di D.W. Grif-
fi th, in “Griƥ thiana”, n. 9-11 (1982) e A. Pisanti, Periodici cinematografi ci in
USA (1910-1939), La Biennale di Venezia, Venezia 1975.
166 Lessico del cinema italiano
Eppure, contemporaneamente (e grazie) al perseguimento di tale scopo, le immagini di La presa di Roma non possono fare a meno di utilizzare il passato per riconfi gurare il presente, facen-dosi tipicamente specchio della cultura istituzionale di un’epoca che vorrebbe segnare la fi ne del processo di costruzione politica ed economica della nazione iniziato proprio col Risorgimento.
Anche il fi lm di Alberini insomma, analogamente a quello di Martone, intende lavorare su un aspetto cruciale nell’orizzonte discorsivo oggetto di questo lemma: la memoria, ossia quella dimensione «che non è il tempo delle date»9 e che piuttosto depura il passato dalla sua esattezza riconfi gurando incessan-temente la storia.
Se tuttavia Noi credevamo lavora sulla memoria con fi nalità critiche e problematiche (la tesi principale, opposta a qualsiasi concezione unitaria, è quella che siano esistiti “due Risorgimenti” completamente antitetici, uno monarchico e l’altro repubblicano), La presa di Roma, al contrario, fa di essa l’oggetto di una costruzio-ne dalle fi nalità pubbliche ben precise, essendo il fi lm di Alberini il frutto della strategia comunicativa attuata dai governi giolittiani di inizio Novecento funzionale a edifi care un robusto sentimento di unità nazionale.
L’ansiosa costruzione di un’identità
I due esempi fi lmici presi in considerazione quali estremi di un lungo e complesso percorso hanno permesso di anticipare alcune nevralgiche questioni intorno alle quali è necessario articolare qualsiasi discorso mirato a indagare la specifi ca visione storica espressa di volta in volta, nel corso della sua vicenda, dal cinema italiano in funzione dei modi in cui la società ha tentato di fare fronte al “problema” dell’identità nazionale in quanto dimensio-ne fondamentalmente non riconciliata.
Se infatti qualsiasi sguardo sul passato implica inevitabil-mente una rif lessione più generale su tale cruciale aspetto, ecco allora che le relazioni emergenti tra cinema e storia nel
9 M. Bloch, Apologia della storia o Mestiere di storico, Einaudi, Torino 1998, p. 35 [ed. or. Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, Armand Colin, Paris 1949].
Storia Christian Uva 167
peculiare contesto italiano appaiono essenzialmente mirate alla spasmodica e tormentata ricerca di una tradizione nazio-nale in cui trova collocazione il tema dell’italianità quale ten-tativo di rintracciare un epos ideale.
Tale dinamica trova una sua immediata quanto lampante dimostrazione, come accennato, già all’indomani della nascita del cinematografo quando, nel corso dei primi del Novecento, il processo di nazionalizzazione condotto dai governi italiani dell’epoca – poi ripreso, in forma autoritaria, dal regime fasci-sta – rende per la prima volta rilevante sul piano culturale la tematica dell’identità e del carattere italiani. In tale situazione il cinema, insieme a tutta un’altra serie di sistemi mediatici ca-paci di incidere sul sentire comune (dalla stampa alla radio alla letteratura popolare), finisce inevitabilmente per incarnare il ruolo di dispositivo ideale per dare seguito, almeno sul piano dell’immaginario, alla famosa istanza attribuita a Massimo D’Azeglio: quella di fare gli Italiani.
È la «necessità di forgiare e rendere unita una popolazione disomogenea e con una scarsa consapevolezza di sé»10 a stimo-lare la nascita del filone storico italiano di cui, come ricordato, La presa di Roma è il capostipite. Molti sono i titoli che si sus-seguono su tale traccia: da Gli ultimi giorni di Pompei (1908) di Arturo Ambrosio e Luigi Maggi a La caduta di Troia (1911) di Giovanni Pastrone e Luigi Romano Borgnetto, da Beatrice Cenci (1909) di Mario Caserini a Beatrice d’Este (1912) di Ugo Falena e Augusto Genina. Film meno interessati a raccontare lo spaccato storico rappresentato e ben più indicativi, invece, dell’“Italietta” giolittiana di cui sono il frutto, come attesta il caso paradigmatico di Cabiria (1914) di Piero Fosco (pseudo-nimo di Giovanni Pastrone) che chiude (nella sua prima fase) la fortunata parabola del filone storico italiano. Tale opera, in ragione della magniloquenza del suo impianto storico-ideo-logico (accentuata dalla retorica delle didascalie di Gabriele D’Annunzio) e soprattutto di un avanguardistico linguaggio cinematografico funzionale ad una nuova dimensione spetta-colare, appare infatti connotata da un’intonazione epica che
10 S. Patriarca, Italianità. La costruzione del carattere nazionale, Laterza, Roma-Bari 2010, p. XVI.
168 Lessico del cinema italiano
risulterà del tutto congeniale, qualche anno più tardi, al regime fascista, il quale nel 1931 sonorizzerà il fi lm accentuandone in chia-ve coloniale le sezioni “antiafricane”, sfruttando in particolare la fi gura muscolosa del Maciste interpretato da Bartolomeo Pagano per celebrare quella del duce.
Al di là del Medioevo e del Rinascimento che fanno da sfondo scenografi co a fi lm più propriamente “in costume” che storici, è soprattutto il contesto politico e visuale della Roma antica ad oơ rire referenti forti e convincenti all’ideologia nazionalista che permea all’epoca questo tipo di cinema. Sarebbe anzi da evidenziare che in un simile panorama è quasi totalmente as-sente la rievocazione della Grecia antica, e ciò probabilmente in ragione di una temperie culturale contrassegnata da un gusto tipicamente liberty e dannunziano da cui scaturiscono fi gure divistiche diƥ cilmente assimilabili all’immagine di compostez-za e armonia tipica del modello classico.
Da un lato, insomma, c’è il Risorgimento di La presa di Roma, ma anche di altri titoli come Garibaldi (1908), Amore e libertà (1910) e Il dottor Antonio (1910) di Mario Caserini, Il piccolo pa-triota (1911) di Giuseppe De Liguoro e O Roma o morte! (1913) di Aldo Molinari; dall’altro, personaggi dell’antichità romana che danno il titolo a fi lm come Nerone (1909) di Luigi Maggi, Giu-lio Cesare (1909) di Giovanni Pastrone, Bruto (1911) di Enrico Guazzoni. Si rievocano cioè due periodi storici estremamente distanti eppure accomunati dalla possibilità di oơ rirsi quali occasioni ideali per «ricostruire sbarchi e battaglie, che sono rimasti tra le più memorabili di quei tempi e che non senza trepida commozione si vedranno riprodotti sullo schermo del cinematografo» (queste le parole di Guazzoni, tra i primi artefi -ci del cinema “romano”, riferite al suo Marcantonio e Cleopatra del 191311).
Questa missione politica di cui viene investito il cinema ita-liano dei primi decenni del secolo scorso, d’altra parte, si sposa in modo ideale con l’urgenza di conferire al nuovo medium una patente di nobiltà e di legittimità artistica che sola può giunger-
11 E. Guazzoni, in “Giornale d’Italia”, 4 novembre 1913, ora in G. De Vincenti, Il kolossal storico-romano nell’immaginario del primo Novecento, in “Bianco e Nero”, n. 1 (1988), p. 18.
Storia Christian Uva 169
gli da tutta la cultura umanistica tradizionale e, principalmen-te, proprio dalla memoria storica nazionale (con particolare ri-guardo per il mondo classico).
I molteplici condizionamenti con cui dunque il fi lm stori-co, punta di diamante della produzione italiana di tale perio-do, guarda al passato evidenziano immediatamente la profonda problematicità insita nello statuto di tale fi lone che, del resto, eredita le criticità già proprie del romanzo storico rimarcate da Alessandro Manzoni nel suo famoso trattato12: la contesa tra storia e verità da un lato e invenzione e fantasia dall’altro è la medesima, ragione per cui, di fronte a ciò che si racconta sul-la carta come sullo schermo, capita sovente che «alcuni» si la-mentino perché «il vero positivo non sia ben distinto dalle cose inventate, e che venga, per conseguenza, a mancare uno degli eơ etti principalissimi d’un tal componimento, come è quello di dare una rappresentazione vera della storia»13.
Ecco allora che negli anni dell’Italia giolittiana il vero storico, oggetto cruciale della rifl essione manzoniana, comincia ad esse-re prepotentemente piegato ad una serie di esigenze di carattere squisitamente ideologico, facendo sì che il cinema, già a partire da «tutta la breve, ma esaltante parabola dell’avventura produttiva tra il 1909 e la guerra [diventi] un “luogo della memoria”, un iperluo-go, un collettore di più sistemi culturali, iconologici e ideologici anteriori»14. Il topos privilegiato, insomma, all’interno del quale convergono, per essere ostentati orgogliosamente, alcuni signifi -cativi simboli dell’identità nazionale.
Il cinema permane del resto l’“arma più forte” (secondo il fa-moso slogan lanciato da Mussolini sulla scorta di una massima di Lenin riferita all’elettrifi cazione delle ferrovie) a maggior ragione nell’era della dittatura. La sua missione, cioè, deve continuare ad essere quella di creare, alimentare, rinvigorire la serie di miti radi-cati nelle cruciali epoche storiche di cui si è servita la produzione cinematografi ca precedente.
12 A. Manzoni, Del romanzo storico e, in genere, de’ componimenti misti di storia e d’invenzione, Centro Nazionale di Studi Manzoniani, Milano 2000.
13 Ivi, p. 1.14 G.P. Brunetta, Il cinema muto italiano. Da “La presa di Roma” a “Sole” 1905-
1929, Laterza, Roma-Bari 2008, p. 52.
170 Lessico del cinema italiano
Se tuttavia l’antica Roma, insieme al Risorgimento, resta in epo-ca mussoliniana uno dei principali poli d’attrazione per il fi lone storico, essa diventa ora un orizzonte che assume una connota-zione ideologicamente diversa rispetto a quella fornita dal cine-ma prefascista: al mondo arcaico, pagano e corrotto destinato ad essere letteralmente seppellito dall’“eruzione” della nuova civiltà cristiana (come simbolicamente suggeriscono le varie versio-ni di un cult dell’epoca quale Gli ultimi giorni di Pompei), si so-stituisce una dimensione esemplare in cui «il Mare Nostrum, la Magna Grecia, l’Impero Romano, la Latinità, la Cristianità e l’I-talicità» sono appunto nozioni “maiuscole” che servono ad ali-mentare la «costruzione retorica e ideologica di una unità e iden-tità contemporanea»15.
L’immaginario sociale del regime risulta d’altronde condizio-nato fortemente dalla politica culturale voluta da Luigi Freddi e ancorata in particolare ad un topos ideologico fondamentale quale, appunto, l’identifi cazione nella nazione e nella sua storia. L’esaltazione delle imprese mussoliniane, presente in maniera più o meno diretta in alcune opere chiave dell’epoca, si inserisce così in un più generale processo di valorizzazione dell’italianità intesa, ora più che mai, come idea di un’identità nazionale fon-data sull’obbedienza al “capo”.
Ciò non autorizza comunque ad etichettare tutta la produzio-ne fi lmica del Ventennio come “cinema fascista” in ragione di una serie di questioni che fondamentalmente testimoniano la varietà di strade battute e la multiformità di proposte lanciate dai cine-asti di questo periodo.
Di qui i tanti elementi in controtendenza rispetto ai diktat del totalitarismo che si annidano tra le pieghe delle opere più rap-presentative di quest’epoca, ma che rispondono pur sempre agli obiettivi di quella propaganda indiretta propugnata dallo stesso Freddi e associata al “modello americano”, con il suo alto tasso di spettacolarità unito ad una eƥ cacia narrativa del tutto unica.
In tale scenario è senz’altro la commedia a ricoprire un ruolo di primo piano, dunque un genere che, ritagliato sul modello della
15 I. Schenk, Il “peplum” italiano. Perché il fi lm storico-monumentale fu “in-ventato” in Italia, ovvero: Da “Cabiria” a Mussolini, in “Fotogenia”, n. 4-5 (1999), p. 63.
Storia Christian Uva 171
sophisticated comedy d’oltreoceano, si distanzia profondamente dal fi lone storico, non per questo assumendo una funzione meno determinante nell’elaborazione di un presente storico nazionale in cui al mito del passato si sostituisce quello della modernità. Qui si predispone l’enorme bacino di aspettative, speranze, illusioni di un Paese che, mentre si proietta anima e corpo sulla strada del progresso industriale ed economico, si avvia sul cammino suicida del secondo confl itto mondiale.
Automobili, velocità, fabbriche, fi ere, beni di consumo, denaro, mass media: è questo, per dirla con Pierre Sorlin, il visibile16 dell’e-poca veicolato dalla commedia degli anni trenta che, con un’acu-tezza a tratti paragonabile a quella del coevo cinema americano, costituisce un interessante laboratorio in cui forma e stile fi lmi-co riescono ad accogliere organicamente un lucido discorso cri-tico sulle forme e gli stili di vita italiani alle prese con un’esaltante quanto soơ erta modernizzazione.
Maggiormente problematico si rende il discorso quando si trat-ta di fare i conti con gli elementi più esplicitamente ideologici che fondano il regime. Poiché il racconto propagandistico dell’attua-lità viene delegato perlopiù ad altri media come la radio oppure a diơ erenti forme audiovisive, come i cinegiornali del LUCE, pochi sono di fatto gli esempi fi lmici che si occupano di esaltare il fa-scismo quale specifi co fenomeno politico, con i suoi costumi e le sue scenografi e. È il caso paradigmatico di Camicia nera (1933) di Giovacchino Forzano, fondato su una miscela di materiali docu-mentari del LUCE e di scene di fi nzione mirata a esaltare il mito di Mussolini retrodatandone tuttavia l’origine al periodo del primo confl itto mondiale, sfruttando così il nodo della Grande guerra quale momento di connessione tra Risorgimento e fascismo. La forzatura evidente, fondata sulla sutura di elementi eterogenei tra passato e presente, è la conseguenza della concezione determini-stica della storia strumentale all’ideologia di un regime che deve a tutti i costi accreditarsi come il frutto più pieno e maturo di un passato glorioso segnato dalle gesta di altrettanti “duci” impegnati nella costruzione di una robusta identità nazionale.
16 P. Sorlin, Sociologia del cinema, Garzanti, Milano 1979, pp. 277-278 [ed. or. Sociologie du cinéma, Aubier-Montaigne, Paris 1977].
172 Lessico del cinema italiano
Altro esempio rilevante in tale ambito è quello di Vecchia guardia (1934) di Alessandro Blasetti. Rappresentando, secon-do le stesse parole dell’autore, l’«apologia di un ordine sociale che era seguito ad un disordine sociale»17, anche quest’opera è inseribile nella categoria del fi lm storico in quanto ambientata nei mesi che precedono la Marcia su Roma del 28 ottobre 1922, quindi in una situazione che lo spettatore non può propriamen-te situare nella dimensione dell’attualità. Quella raccontata da Blasetti vuole in eơ etti assumere le fattezze di una fase politica già storicizzata della quale si esalta nostalgicamente la vena-tura, ormai abbandonata, di un fascismo «cosiddetto “di sini-stra”, populista, strapaesano e culturalmente antiborghese, che è poi lo spirito che attraversa tutti i fi lm del regista negli anni trenta»18.
Il passato dunque, che sia prossimo o remoto, si prospet-ta quale occasione ideale per aggirare le trappole insite nella messa in scena del presente, oơ rendosi come orizzonte in cui collocare un discorso ideologico sostanziato da una forma di propaganda indiretta.
Opere come il kolossal di Carmine Gallone Scipione l’Africa-no e Condottieri di Luigi Trenker, entrambe realizzate nel 1937 grazie al concorso delle «unità delle forze armate dello Stato» (come si legge nei titoli di testa), sfruttando l’orizzonte stori-co della romanità il primo, quello del Rinascimento il secondo, contribuiscono a nobilitare e reinventare una tradizione che trova il suo sbocco naturale nell’era fascista, focalizzando l’at-tenzione su fi gure che incarnano pienamente il tentativo di for-nire, almeno sul piano dell’immaginario, una risposta alla crisi della funzione paterna cui fa capo, secondo Suzanne Stewart-Steinberg, lo stesso problema della creazione di un soggetto italiano19.
17 A. Blasetti, Il cinema che ho vissuto, a cura di F. Prono, Dedalo, Bari 1993, p. 11.
18 V. Zagarrio, Cinema e fascismo. Film, modelli, immaginari, Marsilio, Venezia 2004, p. 184.
19 Cfr. S. Stewart-Steinberg, L’eơ etto Pinocchio. Italia 1861-1922. La costruzio-ne di una complessa modernità, Elliot, Roma 2011, p. 14 [ed. or. The Pinoc-chio Eơ ect. On Making Italians (1860-1920), University of Chicago Press, Chicago 2008].
Storia Christian Uva 173
L’ansiosa ricerca di una tradizione nazionale che pervade la pro-duzione di questi anni connota anche un’opera chiave, per tornare a Blasetti, come il risorgimentale 1860 (1934), un testo di riferi-mento per l’identifi cazione delle relazioni tra il cinema e la storia nel pieno del regime mussoliniano in virtù del dialettico rapporto da esso instaurato con il proprio tempo e con l’ideologia che in esso alligna.
Quest’opera, infatti, nasce senza dubbio come un vero e proprio fi lm politico con cui si vuole
evocare l’atmosfera del 1860 per molti aspetti simile a quella del 1920-1922 […]. Nuclei isolati di patrioti e di ribelli muti, decisi, votati alla morte resistono nella fi ducia di un Uomo che convoglierà le loro forze e altre ne attirerà fatalmente quando porterà la realtà politica attuale dal campo della discussione a quello dell’azione20.
Tali aspetti risultano particolarmente amplifi cati se si pensa al fi lm nella sua forma originaria, quella con il fi nale (rimosso poi nella versione del 1951 per volontà dello stesso regista, entrato in contrasto con il regime a partire dalla guerra in Etiopia) in cui si vedono autentici superstiti garibaldini assistere a una parata di ca-micie nere presso la Farnesina.
Si tratta nuovamente dell’“intromissione” di un’epoca nell’altra che, mettendo in gioco un’ulteriore variante di anacronismo, deter-mina un’ibridazione storica dalla valenza politica particolarmente evidente. Il passaggio di consegne tra “camicie” di diverso colore in-vera infatti sullo schermo, per l’ennesima volta, la mitologia costruita dal fascismo che individua in Mussolini e nel suo regime lo sbocco naturale del processo storico messo in atto dall’unifi cazione d’Italia.
Malgrado ciò, anche considerando il carattere palesemente po-sticcio di un simile fi nale, vi è molto altro tra le pieghe del grande aơ resco dipinto da Blasetti, a partire dall’emergere prepotente del-le forme di vita di una comunità di uomini e donne sulle cui micro-storie si soơ erma, “preneorealisticamente”, la macchina da presa del regista con una programmatica «intenzione di andare al vero»21
20 A. Blasetti, Confi denze di Blasetti, in “La Stampa”, 23 maggio 1933.21 A. Blasetti, in F. Savio, Cinecittà anni Trenta. Parlano 116 protagonisti del
secondo cinema italiano (1930-1943), a cura di T. Kezich, Bulzoni, Roma 1979, p. 153.
174 Lessico del cinema italiano
che esalta le fi sionomie italiche, mettendone in rilievo (sfi dando l’opposizione del regime all’uso dei dialetti) le rispettive specifi cità idiomatiche e vernacolari, al punto che l’Italia «viene fatta più da questo puzzle linguistico che dalla bandiera e baionette fi nali che prefi gurano Vecchia guardia»22.
L’impostazione dialettica propria della poetica blasettiana pro-duce insomma, anche in 1860, un continuo incontro-scontro tra istanze diơ erenti che, riverberandosi sul piano narrativo-formale, comprova la presenza di più di un’incrinatura all’interno di un impianto ideologico solo apparentemente granitico. Ecco allora i contrasti tra gli ariosi ed epici esterni del paesaggio siciliano della prima parte e i più claustrofobici interni della seconda; oppure le portentose carrellate, come quella nel fi nale sul campo di battaglia disseminato di cadaveri, alle quali si contrappuntano i piani ravvi-cinati degli uomini e delle donne sul cui ordito microstorico si co-stituisce la trama della grande storia: un tessuto che, visto appunto da vicino, approssimando cioè l’obiettivo alle forme di vita di cui si compone, rivela tutti i suoi difetti, determinando in un attimo la dissoluzione di qualsiasi retorica. Si tratta dell’emersione di una sorta di barthesiano “senso ottuso” da rintracciarsi in quel «certo modo di leggere la “vita” e dunque il “reale” stesso»23, al di là della fi nzione, proposto da Blasetti mediante il parziale utilizzo di attori non professionisti tra i quali spicca il Giuseppe Gulino interprete del protagonista Carmeliddu. È questa genuina fi gura (in cui si in-carna il dramma del popolo italiano che aspetta in silenzio la libe-razione) a pronunciare nel fi nale, rivolta alla fi danzata Gesuzza, la battuta («Garibaldi ha detto che amu fattu l’Italia») dalla quale si evince la totale negazione di qualsiasi reale consapevolezza popo-lare di quanto accaduto sopra le teste dell’“italica gente”.
La produzione blasettiana, come ne testimonia anche la decli-nazione più tradizionalista e nostalgica di Sole (1929) e Terra ma-dre (1931), rimettendo costantemente in discussione la concezione complessiva del processo storico, propone in defi nitiva una visione personale della realtà italiana da cui emerge un quadro fondamen-talmente discontinuo ed eterogeneo, sintomo delle concrete dif-
22 V. Zagarrio, Cinema e fascismo, cit., p. 184.23 R. Barthes, L’ovvio e l’ottuso. Saggi critici III, Einaudi, Torino 2001, p. 54
[ed. or. L’obvie et l’obtus. Essais critiques III, Éditions du Seuil, Paris 1982].
Storia Christian Uva 175
fi coltà del cinema dell’epoca di proporre sullo schermo immagini identitarie davvero solide e compatte.
A tale proposito, si pensi nuovamente alla commedia degli anni trenta e a quanto la prospettiva di un’identità scissa e pro-blematica si traduca ossessivamente nel tema del “doppio” e nel meccanismo ricorrente della sostituzione di persona che, rispon-dendo all’«allucinatoria alternativa alla condizione sociale di par-tenza», determina una vera e propria «deriva dell’identità»24. Ne sono un esempio Dora Nelson (1940) di Mario Soldati o Il signor Max (1937) di Mario Camerini, ma anche, restando alla produzio-ne di quest’ultimo, Gli uomini, che mascalzoni… (1932) e I grandi magazzini (1939) nei quali l’incerto, “pinocchiesco”, statuto del-lo stesso soggetto italiano25 sembra essere evocato, nel secondo, dalla simbolica presenza di bambole meccaniche o manichini antropomorfi ci e, nel primo, tramite uno dei travestimenti del personaggio interpretato da Vittorio De Sica quando, alla Fiera di Milano, durante la vendita di una macchina idraulica, il suo Bruno diventa proprio «una sorta di buơ o burattino, a metà tra un Pinocchio e un Pulcinella novecentesco»26.
La forzata modernizzazione di quegli anni coincide dunque con l’illusione di un rapido movimento della storia che produce a sua volta il miraggio di un (fi nalmente) possibile dinamismo tra classi sociali: quello dei ceti medi che, come dimostrano i tanti protago-nisti delle commedie dell’epoca (perlopiù appartenenti alla picco-la borghesia), sognano e simulano l’ingresso nei livelli sociali più elevati, salvo poi accorgersi di restare imprigionati in un orizzonte immutabile, compressi come sono tra aristocrazia e popolo.
Ne deriva, come avviene nella commedia americana della De-pressione, un’inquietudine collettiva che – tralignando nella fi l-mografi a nostrana, non di rado, in una vera e propria angoscia
24 M. Grande, La commedia all’italiana, a cura di O. Caldiron, Bulzoni, Roma 2003, p. 194.
25 Quello di una nazione che, né bambina né adulta, né marionetta né sog-getto autonomo, come il burattino di Collodi, non riesce a trovare una sua identità, restando condizionata da infl uenze esterne e prigioniera di una sorta di sindrome adolescenziale. Cfr. S. Stewart-Steinberg, L’eơ etto Pinoc-chio, cit.
26 A. Farassino, Il signor Vittorio, in De Sica: autore, regista, attore, a cura di L. Miccichè, Marsilio, Venezia 1992, p. 107.
176 Lessico del cinema italiano
esistenziale – ripropone eƥ cacemente un discorso sulla specifi cità italiana quale indecidibile, “schizofrenica” condizione a metà tra modernità e arretratezza27.
Dall’illusione retrospettiva al disinganno del presente
Il cinema dell’era fascista sembra insomma confi gurare in modi diversi l’inquietudine connessa al tentativo di dare vita ad un sog-getto nazionale così come essa si aơ erma in special modo nell’arco dei cruciali sessant’anni compresi tra la fondazione della monar-chia costituzionale nel 1861 e l’ascesa del fascismo nel 1922.
La fi lmografi a degli anni a cavallo tra la fi ne del regime e il dopo-guerra conferma il ruolo nevralgico del cinema all’interno di una pro-duzione culturale impegnata a portare avanti un discorso estrema-mente raƥ nato sull’ansia esistenziale propria del soggetto moderno post-liberale, a maggior ragione nel momento in cui il contesto di ri-ferimento diventa quello della deriva del secondo confl itto mondiale e quindi delle macerie umane e materiali da esso prodotte28.
Ora l’urgenza diventa soprattutto quella di guardarsi dentro come in una sorta di esame di coscienza volto a contrastare l’eccesso di re-torica profuso dal regime fascista e, di conseguenza, quel certo senti-mentalismo che, sul fronte letterario, Francesco De Sanctis individua come correlativo di una forma di insincerità29. Guardarsi dentro, se-condo De Sanctis, signifi ca perciò tentare di rinforzare una propria interiorità opponendo alla coscienza artifi ciale e instabile una visione chiara, priva di veli, concreta. In una parola realista30.
All’“illusione retrospettiva”31, con cui il fascismo aveva tenta-to di risolvere il problema dell’identità nazionale, il neorealismo non può quindi che opporre la concretezza di un presente ancora
27 Cfr. G. Bollati, L’italiano. Il carattere nazionale come storia e come inven-zione, Einaudi, Torino 2011, p. 118.
28 Cfr. V.F. Rocchio, Cinema of Anxiety. A Psychoanalysis of Italian Neoreal-ism, University of Texas Press, Austin 1999.
29 Cfr. F. De Sanctis, Storia della letteratura italiana, Einaudi, Torino 1996, p. 758.
30 Cfr. ivi, p. 814.31 Cfr. M. Landy, Italian Film, Cambridge University Press, Cambridge 2000,
p. 48.
Storia Christian Uva 177
sanguinante di cui tuttavia si vogliono indagare le forme di vita in contrapposizione ai «cadaveri» (secondo la famosa espressione di Luchino Visconti32) che hanno popolato il cinema precedente.
Si aơ erma così l’urgenza, per usare le parole di Cesare Zavatti-ni, di conoscere il «proprio tempo con i mezzi specifi ci del cine-ma»: un cinema che «sta alle calcagna del tempo per raccontare ciò che accade», preferendo il concetto di storia (quanto mai da intendersi nel duplice signifi cato di processo e di narrazione) a quello di intreccio33.
Trionfa in tal modo una visione della storia su scala ridotta, ov-vero il principio microstorico secondo cui le forze più signifi cative si rivelano in ciò che è piccolo e apparentemente banale. Lo scena-rio mitico nel quale il cinema fascista aveva tentato di rifondare il concetto di italianità è pertanto destinato ad una fatale dissoluzio-ne o, quantomeno, ad una mutazione di segno, come accade em-blematicamente in Roma città aperta (1945) di Roberto Rossellini, manifesto fi lmico di un Paese
alla ricerca di una nuova identità che, come tutti i miti di rifonda-zione, viene costruita su un sacrifi cio cruento: i martiri della guerra, Pina, don Pietro e Manfredi, sono i capri espiatori ai quali la società italiana del dopoguerra aƥ da prima la sua palingenesi istituzionale e, subito dopo, la sua monumentalizzazione uƥ ciale34.
In breve tempo, tuttavia, è lo stesso Rossellini ad abbandonare questa volontà e capacità di stare dentro alla storia per approdare ad una forma di cinema in cui va profi landosi un’atmosfera mag-giormente rarefatta ed una dimensione a suo modo astorica. Tale cambiamento di atteggiamento coincide con l’urgenza di riportare l’uomo all’interno dell’ordine della natura, contrastando in questo modo l’azione della storia in quanto “agente corruttore” della vita e della natura stesse.
Il tema della guerra con i suoi orrori – comune denominatore della trilogia della “guerra fascista” (La nave bianca, 1941; Un pilota ritorna, 1942; L’uomo dalla croce, 1943) e di quella “antifascista”
32 Cfr. L. Visconti, Cadaveri, in “Cinema”, n. 119 (1941).33 C. Zavattini, Neorealismo ecc., Bompiani, Milano 1979, pp. 113, 74-75.34 S. Parigi, Neorealismo. Il nuovo cinema del dopoguerra, Marsilio, Venezia
2014, pp. 53-54.
178 Lessico del cinema italiano
(Roma città aperta; Paisà, 1946; Germania anno zero, 1948) – rap-presenta il motivo che spinge progressivamente il Rossellini dei primi anni cinquanta ad immergere lo sguardo nell’orizzonte asto-rico che gli appare come l’ultima chance per far recuperare all’indi-viduo la sua “forza primigenia” e la sua dimensione vitale.
Ecco allora la terza trilogia, quella della “solitudine” (Stromboli - Terra di Dio, 1950; Europa ’51, 1952; Viaggio in Italia, 1954), in cui torna in campo l’irrisolta dialettica tra natura e modernizzazione già al centro di molto cinema fascista, ma che ora – alla luce del di-sastro della guerra (a suo modo intesa come aberrazione di quelle stesse istanze di progresso) – assume i connotati più defi nitivi di un confl itto quanto mai angoscioso e inquietante. Ne è un esem-pio in Europa ’51 la scena ambientata nel cinema in cui la Irene di Ingrid Bergman – manifestazione di un Femminile che, come già in Stromboli, fa tutt’uno con l’idea di una Grande Madre Natura – si ritrova di fronte alle immagini di un documentario industria-le: nel mostrare i prodigi del progresso nella costruzione di una diga, la sequenza termina con l’immagine di un gorgo d’acqua che tutto sembra risucchiare, simboleggiando in maniera lampante la razionalizzazione moderna35 e quel suo «carattere seccamente immunitario»36.
La contrapposizione vita-morte che innerva tutta la wel-tanshauung di Rossellini produce così, in questa specifi ca fase del suo cinema, una concezione tendenzialmente ferale della storia culminante in una serie di immagini in cui essa appare letteral-mente mummifi cata, fossilizzata, come attestano alcuni tratti di Viaggio in Italia nei quali il passato viene associato puntualmente ad immagini di morte e di imbalsamazione: si pensi ai teschi del cimitero delle Fontanelle o, ancor più, ai calchi in gesso dei due corpi sorpresi dall’eruzione del Vesuvio rinvenuti presso gli scavi di Pompei, vera e propria visualizzazione di quella «congiunzione
35 Tale aspetto è presente anche nella scena in cui Irene si cala nelle vesti dell’operaia alle prese con l’alienazione del lavoro in fabbrica.
36 L’espressione è di Roberto Esposito ed è riferita alla visione leopardiana, emergente in particolare dallo Zibaldone, del rapporto tra natura e storia. R. Esposito, Pensiero vivente. Origine e attualità della fi losofi a italiana, Einaudi, Torino 2010, p. 113.
Storia Christian Uva 179
tra mito, mummifi cazione e relazione col passato»37 che fonda il
concetto stesso di storicità secondo André Bazin.
Rossellini tornerà ad un recupero della dimensione storica,
nel suo senso più letterale, a partire dalla fi ne degli anni cin-
quanta, andando via via esplicitando, soprattutto con l’approdo
alla televisione, l’intento pedagogico che marca in fondo tut-
to il suo cinema e che, specialmente nell’ultima fase della sua
produzione, sembra rispondere a quel ruolo di mediazione tra
cultura alta e cultura popolare invocato da intellettuali come De
Sanctis quale ulteriore arma per contrastare la falsa coscienza
degli italiani.
Quando, avvalendosi dei modi di produzione e delle tecnologie
televisive, il regista tornerà a ricondurre l’uomo nella dimensione
della storia, quest’ultima tenterà di riguadagnare una dimensio-
ne vitale. I cicli realizzati per la Rai e per la francese ORTF – in
cui spiccano titoli come La presa del potere da parte di Luigi XIV
(1966), Atti degli Apostoli (1969), L’età di Cosimo de’ Medici (1972),
oltre alle biografi e di Socrate (1971), Blaise Pascal (1972), Agostino d’Ippona (1972), Cartesius (1974) – testimoniano la costante volon-
tà di cogliere e penetrare la storia nel suo divenire, limitando il va-
lore della messa in scena quale «prima organizzazione provvisoria
di un materiale astrattamente già “dato” o conosciuto» in favore
di quella rivelazione del «mistero dei gesti, dei volti, delle azioni
umane […] nella sua purezza cristallina» che solo la macchina da
presa è in grado di cogliere, a conferma che vera e sola diơ erenza,
in Rossellini, non è «quella fra storia antica e di ieri, bensì fra storia
che è realtà morta, gelida, spettrale, inorganica [e] storia come vita
e doloroso cammino degli uomini»38.
Non è soltanto Rossellini a transitare, percorrendo questo
«doloroso cammino», nei luoghi in cui la speranza nel futuro
dell’immediato dopoguerra lascia il posto ad un pessimismo
sempre più luttuoso (quello che nei suoi fi lm conduce ben due
bambini, l’Edmund di Germania anno zero e il Michel di Europa ’51, a togliersi la vita). Anche in un’altra opera chiave del neorea-
37 P. Rosen, Change Mummifi ed. Cinema, Historicity, Theory, University of
Minnesota Press, Minneapolis-London 2001, p. 34.
38 G. Fink, Essere o essere stati: il fi lm italiano, il tempo, la storia, in La storia al cinema. Ricostruzione del passato, interpretazione del presente, a cura di
G. Miro Gori, Bulzoni, Roma 1994, pp. 32-33.
180 Lessico del cinema italiano
lismo come Ladri di biciclette (1948) di Vittorio De Sica domina un palese disinganno. Quella descritta è una società violenta in cui latita ogni forma di solidarietà; un contesto in cui, a diơ eren-za di quanto accade ancora in Rossellini, nemmeno la religio-ne, persino nella forma della superstizione, riesce più a oơ rire alcun sostegno. Non è casuale, a tale proposito, che nel fi lm di De Sica la marca della bicicletta rubata sia proprio “Fides”, parola cruciale che attesta come Ladri di biciclette diventi «la storia di una “sconfi tta annunciata”, di un tentativo […] di ritrovare, in una società divenuta incomprensibile e ostile, un fi lo d’Arianna, una “fede”»39 per l’appunto.
Come dimostrano altri titoli desichiani della stagione neoreali-sta quali Sciuscià (1946) e Umberto D. (1952), si fa dunque strada nel cinema dell’epoca un atteggiamento che, culminando ideal-mente nella vera e propria “fuga dalla storia” del fi nale di Miracolo a Milano (1951), prende i lineamenti di un profondo scetticismo, cioè di uno di quei grandi sentimenti che hanno orientato «le for-me di vita (anche altamente contraddittorie) di un intero paese, della sua storia e della sua geografi a» di fronte alla fondamentale questione della “anomala modernizzazione”40. Si tratta nuova-mente della sostanziale «contraddizione aperta nel corpo vivo di una nazione tra una storicità ambita (“fare l’Italia”) e un “resto” che in questa storicità non si è mai convertito, e che di quel fare ne ha intuito e percepito il carattere “illusorio”»41.
Da questo punto di vista è interessante rilevare come Ladri di biciclette esca proprio in un anno cruciale per la storia d’Italia, quel 1948 che, dopo aver segnato l’entrata in vigore della Costituzio-ne – terreno d’elezione su cui si era rinnovata l’illusione del “fare l’Italia” – con l’avvento del quarto governo De Gasperi (31 maggio 1947 - 23 maggio 1948) decreta la fi ne dell’unità resistenziale e, non a caso, anche della fase espansiva dello stesso neorealismo.
Secondo questa prospettiva, il senso di straniamento con cui De Sica interpreta visivamente il rapporto tra Antonio, il protagonista di Ladri di biciclette, e la città che attraversa alla ricerca dell’ogget-
39 P. Cavallo, Viva l’Italia. Storia, cinema e identità nazionale (1932-1962), Li-guori, Napoli 2009, p. 219.
40 R. De Gaetano, Un sentimento scettico del mondo, in “Fata Morgana”, n. 20 (2013), p. 39.
41 Ibidem.
Storia Christian Uva 181
to perduto sembra corrispondere a quello che contrassegna all’e-poca la relazione con la realtà di tutti coloro i quali avevano ripo-sto nel mito della Resistenza le speranze di rinascita di una nuova Italia e che, alla luce degli avvenimenti storico-politici ricordati, si ritrovarono invece di fronte alla sconfi tta di un sogno o forse, leopardianamente, alla “strage” delle loro illusioni42.
Verso uno scetticismo antistorico
Il 1948 costituisce un anno particolarmente signifi cativo vi-sto che segna anche la presentazione al Festival di Venezia di La terra trema di Luchino Visconti, fi lm nato come parte di una trilogia di documentari di propaganda politica per il PCI che, proprio durante le elezioni di quell’anno, avrebbe dovuto trattare polemicamente la strage di Portella della Ginestra del 1 maggio 1947. La terra che tremava (da cui il titolo) doveva infatti essere quella calpestata dai battaglioni di contadini con le bandiere rosse e tricolori che andavano a occupare i terreni incolti dei latifondi e che invece sarebbero fi niti vittime dell’ec-cidio compiuto per mano della banda Giuliano.
L’obbligo di Visconti di limitarsi all’“episodio del mare”, chia-mando in causa Verga e i suoi Malavoglia (progetto del resto cova-to sin dal 1941), se da un lato introduce un tema gramsciano molto caro all’autore come la “questione meridionale”, dall’altro lascia fuori campo il vero fulcro politico dell’operazione fi lmica (i riferi-menti alla strage di Portella43), assumendo il sapore di un ripiega-mento su un piano sottostorico44.
Tutto ciò non fa altro che preparare il terreno alla deriva antisto-rica che troverà la sua piena espressione in Il gattopardo del 1963,
42 Cfr. G. Leopardi, Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani, a cura di A. Placanica, Marsilio, Venezia 1989, p. 44 e sgg.
43 Cfr. A.G. Mancino, Il processo della verità. Le radici del fi lm politico-indiziario italiano, Kaplan, Torino 2008, pp. 178 e sgg.
44 La sottostoria è il «sottobosco della gente qualunque» di cui parla Carlo Lizzani in un intervento al convegno di Pesaro del 1974 concepito per si-stematizzare storico-criticamente il fenomeno neorealista. C. Lizzani, Il neorealismo: quando è fi nito, quello che resta, in Il neorealismo cinemato-grafi co italiano, a cura di L. Miccichè, Marsilio, Venezia 1999, p. 100.
182 Lessico del cinema italiano
ma che viene ampiamente anticipata dalla scelta di frequentare convintamente, già negli anni precedenti, il melodramma, genere (o più correttamente macrogenere) in cui, specifi candosi di norma la vicenda di un’illusione spezzata, si aơ erma la tendenza verso uno scetticismo pervasivo e totalizzante che, «riconsegnandoci un’immagine del mondo da cui il soggetto si esilia»45, coinvolge nuovamente l’atteggiamento nei confronti della storia.
Tale propensione trova una sua prima chiara testimonianza in Senso (1954), fi lm gramsciano all’ennesima potenza sia per il suo taglio nazional-popolare sia per la prospettiva con cui viene aơ rontata la storia che fa da sfondo alla tragica vicenda senti-mentale tra la contessa Livia Serpieri e l’uƥ ciale austriaco Franz Mahler. Se da un lato infatti la scelta del melodramma ricondu-ce all’intenzione, da parte di Visconti, di radicarsi in una solida tradizione culturale italiana di stampo popolare che si intende “elevare” secondo un gusto estetizzante, dall’altro ad imporsi è il motivo, centrale nella rifl essione di Gramsci, del Risorgimento come “rivoluzione mancata”.
Il decadentismo e il proustiano sentimento nostalgico per un’e-poca e un mondo in disfacimento sembrano tuttavia avere la me-glio sull’impegno politico, rivelando l’irrisolto confl itto che tor-nerà a marcare in maniera ancora più evidente Il gattopardo. La disillusione generata dal mancato rinnovamento postrisorgimen-tale presente già nella novella di Arrigo Boito da cui Senso è tratto viene in tal modo attualizzata all’Italia degli anni cinquanta, uscita da una guerra di liberazione in cui, analogamente al Risorgimento, l’apporto popolare sembra essere stato marginalizzato a tutto van-taggio di altre forze sociali.
Opera per eccellenza improntata ai canoni del romanzo storico, qui calati nella cornice del «primo autorevole esempio di super-spettacolo d’autore»46, Senso si confi gura dunque come un fi lm-cerniera nella rappresentazione del Risorgimento, e più in gene-rale della storia italiana al cinema: d’ora in avanti infatti questo fondamentale snodo storico-politico tenderà sempre più a costi-tuire un “luogo” sul quale, dando sfogo ad un’istanza prettamente
45 R. De Gaetano, Un sentimento scettico del mondo, cit., p. 53.46 V. Spinazzola, Cinema e pubblico. Lo spettacolo fi lmico in Italia 1945-1965,
Bompiani, Milano 1974, p. 141.
Storia Christian Uva 183
antistorica, retroproiettare la delusione, la frustrazione, il disin-ganno nei confronti del presente.
L’insopprimibile tendenza a far sì che quest’ultimo non cessi mai di riconfi gurarsi nella rappresentazione del passato, unita-mente al parallelo emergere di indagini sul Risorgimento fi na-lizzate a riscontrarne la fi sionomia di fenomeno socio-politico incompiuto e problematico, determinano quindi la consapevo-lezza che il processo storico sottostante all’Unità d’Italia e la stagione che ne seguì non possano costituire il terreno imma-ginifi co in cui situare l’epos proprio di ogni “nascita di una na-zione”.
Ne sono ulteriore testimonianza negli anni cinquanta il rac-conto antieroico di una vicenda che si conclude tra i cadaveri e le macerie fumanti di una sconfi tta, come accade in La pattuglia sperduta (1954) di Piero Nelli, oppure la vera e propria denuncia dell’incapacità del Risorgimento di cambiare «la vita delle popola-zioni», riuscendo a migliorare invece solo «quella di qualche intel-lettuale e di qualche notabile»47, che trapela da Il brigante di Tacca del Lupo (1952) di Pietro Germi.
È questo il “revisionismo risorgimentale” che, facendosi strada nel cinema italiano nel corso degli anni cinquanta, trova nel decennio suc-cessivo la sua massima esplicitazione in Il gattopardo, opera con cui Vi-sconti compie la sua seconda, defi nitiva incursione in tale passato sce-gliendo di rifarsi, non a caso, a quello che Vittorio Spinazzola defi nisce, insieme a I Viceré di Federico De Roberto e a I vecchi e i giovani di Luigi Pirandello, un esempio canonico di «romanzo antistorico»48.
In verità il fi lm di Visconti nasce con un preciso intento parti-colarmente caro all’allora Partito comunista, quello di sfruttare la dimensione di saga del testo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa per confi gurare un grande racconto epico “di sinistra” capace di mutare di segno ai toni dell’opera letteraria d’origine: un romanzo storico “imperfetto” in cui la storia stessa, descritta come immobi-le e immutabile, non contempla nel proprio alveo alcuna presenza attiva delle masse.
47 E. Giacovelli, Pietro Germi, Il Castoro, Milano 1997, p. 48.48 Cfr. V. Spinazzola, Il romanzo antistorico, Editori Riuniti, Roma 1990. Per
una rifl essione sul cinema antistorico cfr. A.G. Mancino, Vecchi e giovani, Gattopardi e viceré. Il cinema antistorico italiano, in “Bianco e Nero”, n. 576-577 (2013).
184 Lessico del cinema italiano
Di fatto, dopo il lungo e travagliato percorso che conduce alla versione defi nitiva di una sceneggiatura approvata dallo stesso Palmiro Togliatti – in cui si riconosce fi nalmente il ruolo storico di quella componente popolare che «con lo Stato italiano ha sempre un conto aperto, nel 1860 come nel 1960»49 – viene partorito un fi lm dominato da un pessimismo profondo in cui la scena viene quasi completamente riguadagnata dalla corposa individualità del protagonista, il principe don Fabrizio di Salina.
È questa la fi gura attraverso la quale l’aristocratico Visconti non può esimersi dal veicolare la sua personale visione del mondo, quella di chi, come aơ erma il principe al cavaliere Chevalley sce-so in Sicilia dal Piemonte per convincere don Fabrizio ad entrare nel Senato del nuovo Regno d’Italia, si considera l’esponente di «un’infelice generazione, a cavallo fra due mondi e a disagio in tut-ti e due», e per di più «completamente senza illusioni».
In tale paradigmatico passaggio torna ad emergere prepotente-mente lo scettiscismo tipico della tradizione culturale italiana che vede in Leopardi uno tra i più lucidi sintomatologi dei costumi nazionali. La sua eơ erata lucidità nello scrutare «il corpo mostruo-so della società e della storia»50 sembra trovare un corrispettivo nell’insistente tendenza della cinepresa di Visconti a soơ ermarsi sulle crepe, sulla polvere, sui segni del disfacimento diơ uso che pervade l’opulento mondo su cui si concentra.
È in fondo la medesima vena che, in maniera maggiormente spietata e attraverso una cifra più propriamente grottesca, si può rintracciare nella coeva commedia italiana, con cui d’altra parte l’opera di Visconti non disdegna di condividere taluni toni (si veda il registro comico che connota il rapporto tra il principe di Salina e padre Pirrone oppure la resa, a tratti caricaturale, del personaggio di don Calogero Sedara) e che può farsi risalire alla presenza, tra gli sceneggiatori di Il gattopardo, di uno specialista del genere come Pasquale Festa Campanile.
Tutto ciò contribuisce a testimoniare perché, malgrado la magniloquenza della messa in scena (avvalorata dall’adozione
49 A. Anile, M.G. Giannice, Operazione Gattopardo. Come Visconti trasformò un romanzo di “destra” in un successo di “sinistra”, Le Mani, Recco 2013, p. 162.
50 M.A. Rigoni, in G. Leopardi, La strage delle illusioni. Pensieri sulla politica e sulla civiltà, a cura di M.A. Rigoni, Adelphi, Milano 1992, p. 34.
Storia Christian Uva 185
del formato panoramico del Super Technirama 70), la dimen-sione epica lasci il posto all’osservazione fi siologica di un’u-manità immersa in quella «voluttuosa immobilità» (per usare nuovamente le parole di don Fabrizio) che sembra rappresen-tare il destino fatale di qualsiasi utopia politica. In tal modo il modello manzoniano del romanzo storico viene adottato da Visconti, sulla scorta di Tomasi di Lampedusa, proprio per la sua statutaria disponibilità ad una serie di variazioni che posso-no condurre fi no al capovolgimento della sua stessa intrinseca funzionalità originaria: alla persuasione ottimistica d’un ritmo ascensionale del divenire storico subentra la messa sotto accu-sa della storia medesima, «incapace di produrre vere modifi che nel tessuto immobile dell’esistenza»51.
Accordi dissonanti
L’opera viscontiana giunge così a raơ reddare gli entusiasmi na-zionalistici che si era tentato di rinfocolare giusto un paio di anni prima in occasione del centenario dell’Unità con Viva l’Italia (1961) di Rossellini52.
Sorta di rievocazione in chiave risorgimentale di Paisà (avreb-be infatti dovuto intitolarsi proprio Paisà 1860), in sintonia con la stagione politica di cui è frutto, il fi lm di Rossellini nasce all’in-segna di un “compromesso storico-creativo” dovuto alla compre-senza di sceneggiatori per metà di area democristiano-cattolica e per metà social-comunista. Ne deriva un approccio nel contempo antiretorico e celebrativo (soprattutto nei confronti della fi gura di Garibaldi), ma soprattutto un impianto già profondamente inse-rito sul terreno di quell’impegno pedagogico che, come ricordato, nell’ultima parte della carriera rosselliniana si specifi ca in una for-ma di reazione al negativismo storico delle opere dei primi anni cinquanta e si fonda sulla strenua volontà di «vedere chiaro in sé e
51 V. Spinazzola, Il romanzo antistorico, cit., p. 8.52 Del 1961 è anche Vanina Vanini, ulteriore (sfortunato) contributo di Ros-
sellini sul Risorgimento. In questo caso l’ostracismo della critica e alcune traversie produttive determinarono addirittura la realizzazione e diơ usio-ne di una versione del fi lm non riconosciuta dall’autore.
186 Lessico del cinema italiano
per gli altri», recuperando il valore delle fonti storiche quale unica possibilità «per liberarsi dalla confusione mortale»53.
Queste parole del regista romano indicano un rinnovato “invito alla storia” che rappresenta un evidente contrappunto all’antisto-ricismo radicale incarnato dal Visconti di Il gattopardo, testimo-niando come, con l’avvento degli anni sessanta, l’atteggiamento del cinema italiano nei confronti della storia assuma una confi gu-razione ancora più composita e articolata.
In questa sorta di terreno carsico tanti sono infatti gli interstizi, i passaggi sotterranei che collegano aree su cui si posizionano fi lm eterogenei nei quali il rapporto con la storia, soprattutto quella più recente del fascismo, pur tentando la strada della pacifi cazione o riconciliazione, fi nisce immancabilmente per restare insoluto.
Il caso di Carlo Lizzani è ad esempio quello di chi, a partire dal suo esordio Achtung! Banditi! (1951), inaugura un rapporto con il passato e con la memoria che pervaderà tutta la sua fi lmografi a e che, testimoniato anche da un’intensa attività di saggista, verrà vissuto come un vero e proprio impegno storiografi co mirato ad indagare alcuni degli aspetti più controversi dell’identità italiana, a partire proprio dal dibattito fascismo-antifascismo.
Il suo debutto cinematografi co, incentrato su alcuni episodi del-la guerra partigiana a Genova e nell’Appennino ligure, è già con-traddistinto dall’urgenza di aơ rontare a caldo gli esiti di una guerra fratricida che l’Uƥ cio Centrale per la Cinematografi a di allora non esita a defi nire «dannoso […] alla formazione di una coscienza uni-taria italiana e lesivo verso l’estero del nostro prestigio di popolo civile»54. L’intento di Lizzani è d’altronde quello di confi gurare una contrapposizione ideologica da cui emerga un preciso epos: quel-lo dell’eroismo non solo dei partigiani, ma anche degli operai di una fabbrica messa a rischio dalla guerra, la cui presenza nel fi lm introduce l’ulteriore tema politico del confl itto sociale, forse non emerso a suƥ cienza nella stagione neorealista.
La seconda metà degli anni cinquanta, grazie all’aơ acciarsi delle ipotesi di un governo riformista, segnala una progressiva
53 R. Rossellini, in P. Pintus, Storia e fi lm. Trent’anni di cinema italiano (1945-1975), Bulzoni, Roma 1980, p. 33.
54 Archivio Centrale dello Stato, Ministero del Turismo e dello Spettacolo, Divisione Cinema, f. 1126, “Revisione cinematografi ca preventiva – Appun-to”, Roma 5 febbraio 1951.
Storia Christian Uva 187
ripresa di interesse nei confronti di un passato nazionale “sco-modo”, oggetto negli anni precedenti di un lavoro di rimozione favorito a livello istituzionale «da un’accurata politica di silenzio soprattutto nei mass media»55.
Paradigmatico è il Leone d’Oro attribuito dalla Mostra del Ci-nema di Venezia del 1959 ex aequo a La grande guerra di Mario Monicelli e a Il generale Della Rovere di Rossellini, fi lm che, nel farsi simbolo di una certa rinascita del cinema italiano, aơ ron-tano i due momenti più drammatici della vita italiana del primo cinquantennio del Novecento: rispettivamente il primo confl itto mondiale e il nazifascismo.
Il generale Della Rovere, segnalando il ritorno, «dopo un lun-go periodo di dissipazione», del «fi gliuol prodigo […] all’ovile»56, inaugura in eơ etti un nuovo corso che, nel susseguirsi di titoli come La lunga notte del ’43 (1960) di Florestano Vancini, Un gior-no da leoni (1961) e Le quattro giornate di Napoli (1962) di Nanni Loy, La ragazza di Bube (1964) di Luigi Comencini o Il terrorista (1963) di Gianfranco De Bosio, appare contraddistinto dalla stori-cistica (quanto politica) esigenza di porre il presente in continuità con il passato della stagione resistenziale.
Di fatto, però, il cinema sembra nuovamente mancare, dopo il caso del Risorgimento, l’obiettivo di dare vita ad una propria “gran-de narrazione” nazionale in cui la tematica antifascista metta a frutto le sue possibilità di comunicazione col pubblico.
Come dimostra già Gli sbandati (1955) di Francesco Maselli – il cui tema della Resistenza come occasione di una presa di coscien-za individuale trapassa in Il generale Della Rovere – la dimensione microstorica tende ad avere il sopravvento laddove si impone una prospettiva psicologica e morale che castra, irreggimenta, reprime l’infi ammarsi di qualsivoglia racconto dall’ampio respiro. Si spiega così «l’andamento quasi processuale di questi fi lm» in cui si sotto-pone «a inchiesta, in nome non tanto dell’antifascismo o della pa-tria o della storia quanto più semplicemente dell’umanità, il com-portamento del popolo e soprattutto della borghesia italiana»57.
55 M. Zinni, Fascisti di celluloide. La memoria del ventennio nel cinema italia-no (1945-2000), Marsilio, Venezia 2010, p. 73.
56 V. Spinazzola, Cinema e pubblico, cit. p. 228.57 Ivi, p. 231.
188 Lessico del cinema italiano
L’unica possibilità di fondare una peculiare mitologia si sposta pertanto sul topos del “bravo italiano”, vero e proprio luogo comu-ne nazionale in cui radicare un’ideale fi nzione storica. Non va di-menticato infatti che l’Italia di questi anni è un orizzonte contrad-distinto da «tutta una serie di reciproche reticenze che fanno per qualche decennio sistema», come attesta emblematicamente la famosa locuzione di Totò, una delle grandi maschere dell’italiano del dopoguerra: «A prescindere»58. Prescindere signifi ca omettere, derubricare, rimuovere e quindi creare un paradigma nazional-po-polare autoassolutorio e tranquillizzante, frutto di un dopoguerra in cui l’intera classe dirigente antifascista utilizza lo stesso
discorso sulla persecuzione antiebraica a fi ni politici, enfatizzan-do la buona condotta degli italiani rispetto alla furia eliminazionista dei tedeschi per dissociare le responsabilità dell’Italia da quelle della Germania nazista e ottenere dalle potenze vincitrici un trattamento favorevole al tavolo della pace59.
Non è un caso, a tale riguardo, che già nel cinema neorealista manchino riferimenti diretti alla Shoah e che, tranne alcune ec-cezioni60, soltanto il nuovo corso inaugurato tra la fi ne degli anni cinquanta e l’inizio dei sessanta determini la realizzazione di ope-re di un certo respiro incentrate su tale tragedia storica.
Se nel 1960 appare Kapò di Gillo Pontecorvo, l’anno dopo è la volta di L’oro di Roma di Carlo Lizzani, fi lm che si inseriscono nel-lo scenario del rapido processo di “defascistizzazione” della società messo al servizio dell’edifi cazione di una memoria collettiva auto-assolutoria e dello stesso mito degli “Italiani brava gente”.
58 M. Isnenghi, Storia d’Italia. I fatti e le percezioni dal Risorgimento alla so-cietà dello spettacolo, Laterza, Roma-Bari 2011, pp. 562-563.
59 F. Focardi, La percezione della Shoah nell’immediato dopoguerra: 1945-47, in Storia della Shoah in Italia. Vicende, memorie, rappresentazioni, a cura di M. Flores, S. Levis Sullam, M.-A. Matard Bonucci, E. Traverso, Vol. II, Utet, Torino 2010, p. 26.
60 Si vedano titoli come L’ebreo errante (1948) di Goơ redo Alessandrini, Mo-nastero di Santa Chiara (1949) di Mario Sequi, Il grido della terra (1949) di Duilio Coletti. Cfr. A. Minuz, Cinema, società italiana e percezione della Shoah nel primo dopoguerra (1945-1951). Nuove prospettive di ricerca, in “Cinema e Storia. Rivista di studi interdisciplinari”, n. 1 (2013), pp. 33-48.
Storia Christian Uva 189
Proprio questo è il titolo del noto fi lm che Giuseppe De Santis dedica nel 1964 alle vicende di un reggimento, composto da soldati provenienti da diverse regioni d’Italia, impegnato nella tragica e disastrosa “campagna di Russia” tra il 1941 e il 1943. Relegando ad un marginale ruolo di stampo farsesco l’elemento fascista (rappre-sentato dalle fi gure dei “superarditi” e dal loro comandante), l’at-tenzione si appunta sull’internazionalismo ideologico e contadino quale mito che accomuna genti di diversa provenienza ed estrazio-ne sociale, rappresentando in fondo l’ennesima illusione con cui gli italiani tentano di compensare la propria secolare «mancanza di società»61.
Italiani brava gente è un fi lm di guerra anomalo laddove, trami-te l’immissione di un personaggio comico (il soldato interpretato da Raơ aele Pisu) in un contesto totalmente tragico, esso tenta di realizzare quell’«accordo dissonante fra storia e commedia»62 di cui, per tornare al doppio Leone d’Oro del 1959, proprio La grande guerra di Monicelli è la più lucida esemplifi cazione.
Differentemente dal lavoro di De Santis, il film del regista toscano rientra di fatto nel progetto della tragicomica contro-storia nazionale che sostanzia, con gradazioni diverse, non solo altre opere monicelliane come I compagni (1963) o L’ar-mata Brancaleone (1966), ma, più in generale, buona parte della produzione popolare di questi anni. La grande guerra infatti, demitizzando la storiografia patriottica che aveva da sempre teso a celare il massacro della Prima guerra mondia-le sotto la retorica dell’audacia e del sacrificio, rappresenta la vera e propria dissacrazione di un venerato tabù nazionale (ri-presa nel 1970, con tutt’altri toni, dal Francesco Rosi di Uomi-ni contro), diventando una specie di bandiera dell’anticonfor-mismo che apre la strada alla nuova stagione cinematografica contrassegnata dal tema centrale della guerra, del fascismo e della Resistenza.
Per restare sul fronte commedico, si pensi a paradigmatici tito-li come Tutti a casa (1960) di Luigi Comencini, Una vita diƥ cile (1961) e La marcia su Roma (1962) di Dino Risi, Il federale (1961)
61 G. Leopardi, Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani, cit., p. 157.
62 M. Grande, La commedia all’italiana, cit., p. 221.
190 Lessico del cinema italiano
di Luciano Salce, Anni ruggenti (1962) di Luigi Zampa, opere che, contando su una messa in scena di grande impatto e non priva di scrupolo fi lologico, intendono fare i conti con una stagione stori-ca interpretata, più che come crociana “parentesi”63, quale vero e proprio tratto costitutivo del carattere italiano.
Un lucido orientamento all’autocoscienza nel quale si situa, come già accaduto con il neorealismo, la capacità del cinema ita-liano di comprendere i processi sociali e politici nella loro più intima essenza è rintracciabile ancor più nelle commedie incen-trate sul presente, dove la deformazione grottesca del reale si fa cifra con cui rappresentare «il naturale destino del corpo scisso e deforme della società italiana» e la sua sostanziale «estraneità al racconto (epico) della Storia»64.
Come già nel cinema dell’immediato dopoguerra, si segnala qui l’urgenza di cogliere la realtà nel suo divenire, con la fonda-mentale diơ erenza che ora il presente appare deliberatamente privo di qualsiasi spessore storico, come attesta emblematica-mente l’istantaneità del tempo consumato dal “vorace” Bruno Cortona impersonato da Vittorio Gassman in Il sorpasso (1962) di Risi.
È in tale quadro che lo scetticismo nei confronti della storia e del mondo raggiunge il suo apice dando vita ad un vero e proprio «epos capovolto»65 determinato dall’impietosa messa in scena di una cultura dell’adattamento sociale e ideologico che emerge, a maggior ragione nell’epoca di una rinnovata modernizzazione, quale ulteriore tratto distintivo dell’italianità.
Torna in gioco la contrapposizione tra «il fondale tragico del-la società civile e il proscenio comico della vita individuale»66 già delineata da La grande guerra e in fondo altrettanto centrale in un altro fi lone popolare degli anni sessanta, il western ita-liano, contemporaneo alla commedia e parimenti connotato da
63 Va ricordato che negli stessi anni viene realizzato All’armi siam fascisti! (1962), fi lm di montaggio di Lino Del Fra, Cecilia Mangini e Lino Miccichè (con commento in voice over scritto da Franco Fortini) nato proprio dall’e-sigenza di fare luce sul recente passato contrastando la tendenza all’oblio.
64 R. De Gaetano, Il corpo e la maschera. Il grottesco nel cinema italiano, Bulzoni, Roma 1999, p. 27.
65 Cfr. M. Grande, La commedia all’italiana, cit., pp. 219-231.66 Ibidem.
Storia Christian Uva 191
un’aggettivazione che, a dispetto della matrice eteroctona del genere, ne segnala la profonda aơ erenza ad alcuni tratti distin-tivi del carattere nazionale.
La declinazione italica del «cinema americano per eccellenza»67
evidenzia infatti una specifi ca attitudine ad esprimere un pro-prio punto di vista su una storia intimamente calata nell’orizzon-te culturale e identitario nazionale, rendendosi particolarmente disponibile a farsi nuovamente dispositivo anacronistico vista la sua propensione a produrre continue “intrusioni” tra epoche dif-ferenti.
Il western italiano – in particolare quello di ambientazione messicana – mette infatti in moto un peculiare procedimento di rispecchiamento defi nibile di “secondo grado”: la storia di una determinata epoca e di uno specifi co luogo geografi co (ad esem-pio il Messico della rivoluzione di Villa e Zapata) giunge ad allu-dere al presente per il tramite di un ulteriore, cruciale passaggio, quello in cui si confi gura in trasparenza la dimensione spazio-temporale dell’Italia della lotta al nazifascismo (a sua volta meta-fora, in taluni casi, del clima di violenza politica che inaugura gli “anni di piombo”).
È quanto accade in titoli come Quién sabe? (1966) di Damiano Damiani, nella trilogia di Sergio Sollima (La resa dei conti, 1966; Faccia a faccia, 1967; Corri uomo corri, 1968), in Requiescant (1967) di Carlo Lizzani, in Tepepa (1969) di Giulio Petroni o nella trilogia di Sergio Corbucci (Il mercenario, 1968; Vamos a matar compañe-ros, 1970; Che c’entriamo noi con la rivoluzione?, 1972).
Forse proprio sul terreno delineato da esempi come questi68 si può rintracciare un raro esempio di epos popolare nel cinema ita-liano se è vero che l’ambito ivi delineato risulta particolarmente disponibile a lasciar trapelare «tutto il substrato nostalgico dell’e-pica popolare di sovietica memoria, proiettata sulla latitudine del tropico» in concomitanza con una pervasiva nostalgia di quella
67 Cfr. J.-L. Rieupeyrout, Il Western, ovvero il cinema americano per eccellen-za, Cappelli, Bologna 1957 [ed. or. Le western, ou le cinéma américain par excellence, Éditions du Cerf, Paris 1953].
68 Ai quali si potrebbe aggiungere Queimada (1969) di Gillo Pontecorvo, sor-ta di western “d’autore” ambientato nelle Antille anziché in Messico (non a caso allo script partecipa Franco Solinas che fi rma anche Tepepa, Il merce-nario, Quién sabe? e La resa dei conti).
192 Lessico del cinema italiano
che forse è la «sola “rivoluzione”» conosciuta dall’Italia «nell’inte-ro Novecento, ossia la Resistenza»69.
Tale aƫ ato ideologico segnala dunque il fi ducioso sguardo ver-so un “sol dell’avvenire” tendenzialmente oscurato, invece, all’o-rizzonte dell’arido e disperato mondo descritto da Sergio Leone, permeato piuttosto da un “nichilismo epico”70 che spinge la sua macchina da presa a prediligere, soprattutto nel contesto della pri-ma trilogia (quella del “dollaro”), la microfi sionomia dell’indivi-duo anziché la dimensione corale delle grandi masse.
Ecco allora lo spazio di «evacuazione del progresso»71 in cui si ambientano Per un pugno di dollari (1964) e Per qualche dollaro in più (1965), uno scenario perfettamente congeniale al personaggio che vi agisce, “l’uomo senza nome” interpretato da Clint Eastwood. Una fi gura che, come altre protagoniste di tale fi lone, è l’emblema di una dis-identità, ovvero, nuovamente, di quella vera e propria angoscia di non essere nessuno in cui allignano, come già visto, i caratteri profondi dell’italianità72.
Su un fronte complementare la disillusione del regista si incarna nei profi li di peones come Tuco (Il buono, il brutto, il cattivo, 1966) o Juan (Giù la testa, 1971), maschere che si stagliano sullo sfondo o ai margini della “grande storia” per farsi veicolo di un sostanziale pessimismo nei confronti delle «magnifi che sorti e progressive». L’italianità del western leoniano, in sintonia con le linee portanti della contemporanea commedia, risiede d’altronde nel medesimo, bachtiniano, realismo grottesco delle maschere impiegate, con-fermando come tale dimensione risulti «l’unica forma di racconto anti-epico, comico e patetico allo stesso tempo, bozzettistico e ca-ricaturale, della vita italiana»73.
Non stupisce che tale aspetto sia già accennato nel fi lm d’esor-dio di Leone, Il colosso di Rodi (1961), peplum nel quale la stessa
69 M. Fantoni Minnella, Non riconciliati. Politica e società nel cinema italiano dal neorealismo a oggi, Utet, Torino 2004, p. 158.
70 Cfr. B. Noys, Spaghetti Communism? The Politics of the Italian Western, paper presentato al “Marxism in Culture Seminar”, Senate House, London (25 March 2011).
71 A. Fisher, Radical Frontiers in the Spaghetti Western. Politics, Violence and Popular Italian Cinema, Tauris, London 2011, p. 59.
72 Cfr. S. Stewart-Steinberg, L’eơ etto Pinocchio, cit., p. 6.73 R. De Gaetano, Il corpo e la maschera, cit., pp. 26-27.
Storia Christian Uva 193
monumentale statua posizionata all’entrata del porto della città, teatro degli eventi, sintetizza una serie di riferimenti parodici in-dirizzati ai popolareschi superuomini del fi lone storico-mitologi-co d’appartenenza (di cui il western italiano è in qualche modo la continuazione); capi indiscussi e indiscutibili che, con il loro muscoloso corpo «in Moplen»74, simboleggiano la guida infallibi-le cui aƥ dare senza remore i destini e le inquietudini dell’Italia “miracolata” dei primi anni sessanta, alludendo nel contempo al passato fascista.
Secondo questa prospettiva, il gigante dalla postura marziale che si staglia con le gambe divaricate sul mare di Rodi è nuova-mente una fi gurazione grottesca disponibile a rendersi facilmen-te emblema di quella relazione tra rappresentazione caricaturale e messa in scena tipica della visualità del regime mussoliniano, di cui sono paradigmatica testimonianza alcuni frammenti dello stesso cinema di Federico Fellini: in primis il «“Rex” di cartone, simbolo dei sogni megalomani dell’Italia fascista, o l’enorme Duce “fl oreale” che benedice il matrimonio avanguardista di Ciccio»75 in Amarcord (1973).
Prima, durante e dopo la storia
I nessi tra il cinema felliniano e la produzione di genere di questi anni sono d’altro canto evidenti laddove è proprio la cifra del grot-tesco a stabilire, pur con declinazioni diverse, le coordinate entro le quali si situa una visione del mondo per molti aspetti comune. Passato e presente vi si impastano nel contesto di una raƥ gurazio-ne carnevalesca della vita che propone l’incessante «sconsacrazio-ne e mescolanza comica dei valori e delle gerarchie costituite»76.
Nel cinema di Fellini proprio questa è la chiave di accesso ad una storia che viene scritta, cancellata e nuovamente riscritta dando
74 G. Manzoli, Da Ercole e Fantozzi. Cinema popolare e società italiana dal boom economico alla neotelevisione (1958-1976), Carocci, Roma 2013, p. 109.
75 A. Minuz, Viaggio al termine dell’Italia. Fellini politico, Rubbettino, Soveria Mannelli 2011, p. 77.
76 R. De Gaetano, Il corpo e la maschera, cit., p. 49.
194 Lessico del cinema italiano
luogo ad un palinsesto di epoche e stagioni culturali eterogenee il cui statuto appare costantemente sospeso tra fantasia e realtà.
Tale concezione trova un’ideale traduzione nella dimensione scenografi ca di Roma, per antonomasia conformazione urbana fondata sulla stratifi cazione di una serie di città che si sovrap-pongono producendo un mescolamento di modelli lontani nella storia, i quali restituiscono non soltanto una fotografi a di forme architettoniche diverse, ma soprattutto di stili di vita, stagioni cul-turali e politico-sociali, moduli dell’immaginario che hanno con-traddistinto quelle stesse epoche e che sembrano rivendicare una propria sopravvivenza nel tempo.
È così che la capitale in La dolce vita (1960) si fa teatro (quanto mai in senso letterale) di una contemporaneità in cui, nondimeno, si condensa tutto un precipitato della storia nazionale. Se infatti la “città eterna” si propone in questo fi lm come spazio simbolico dei tratti della modernità italiana e delle sue contraddizioni, allo stesso tempo essa è oggetto di una vera e propria mitologia che può essere messa in relazione con il culto della romanità costruito da Mussolini. Ecco allora l’identifi cazione speculare
che intreccia due tentativi di eternarsi nel mito di Roma, ricrean-dola nel Teatro 5 di Cinecittà in un caso, o ricostruendola in nome del nuovo impero, nell’altro. Le scenografi e felliniane e le coreografi e e l’architettura fasciste hanno in comune la trasformazione di Roma, e per estensione dell’Italia intera, in un’immensa scena teatrale77.
È qui che preferibilmente si radica la concezione felliniana della storia rispondente ad una libera visione in cui può risul-tare nuovamente feconda la pratica anacronistica, soprattutto se essa si correla ad una direttrice marcatamente metafi lmica. È quanto succede in Block-notes di un regista (1969) quando lo stesso Fellini e l’archeologo che accompagna la sua troupe nel viaggio lungo una ferrovia sotterranea osservano dal fi nestrino del treno – canonica metafora dello schermo cinematografi co – l’improvvisa quanto onirica epifania di antichi romani. Sono ulteriori fi gurazioni di quella romanità intesa come condizione culturale, prima ancora che storica (si veda anche il caso di Fel-
77 A. Minuz, Viaggio al termine dell’Italia, cit., p. 109.
Storia Christian Uva 195
lini Satyricon del 1969), in cui si identifi ca tout court una certa italianità e che costituisce nella fi lmografi a felliniana il fil rouge di una vera e propria mitobiografi a della nazione.
Quegli antichi romani sono apparizioni fugaci, simulacri di un passato che torna a farsi sfuggente, qualche anno più tardi, in Roma (1972), fi lm in cui un analogo “viaggio al centro della terra (d’Italia)” conduce nuovamente lo spettatore nelle viscere della ca-pitale. Il riferimento va alla scena degli scavi per la metropolitana interrotti a causa del ritrovamento di una domus romana le cui pitture parietali svaniscono al contatto con l’aria. Come a dire che il divario tra presente e passato è incolmabile: non appena si tenta di stabilire un rapporto con quest’ultimo, esso si dissolve, proprio come un sogno78.
Anche la storia dunque è una visione, al pari delle tante altre su cui si edifi ca il cinema felliniano. È un’apparizione, a volte un incu-bo, che tuttavia non cessa di attraversare, ora in maniera sotterra-nea ora in forma più palese, le opere del regista situando la sua fi l-mografi a in quell’orizzonte fanciullesco dell’illusione da intendersi quale terreno generativo da cui deriva non già un’evasione dalla storia, bensì un suo recupero passante per una costante quanto vitalistica reinvenzione sul piano dell’immaginario.
È il contrario di ciò che programmaticamente si prefi gge un re-gista come Michelangelo Antonioni nel cui cinema la storia diven-ta invece oggetto di una vera e propria rimozione.
Anche L’avventura, insieme a La dolce vita di Fellini e Rocco e i suoi fratelli di Visconti, è un’opera-simbolo del 1960 capace di cogliere le contraddizioni e i “buchi neri” di una modernità che tuttavia, nel caso di Antonioni, si specifi ca nell’ambito di una que-stione identitaria dall’accezione più esistenziale che socio-politi-ca, calandosi in una dimensione lunare e rarefatta – proprio come quella del paesaggio del suo fi lm – che acquista un valore allego-rico ed evocativo proprio nel momento in cui appare divelta dai cardini della storia.
Il suo cinema, pur portando sullo schermo «i rappresentanti di ceti sociali fi eri della loro assennatezza operosa, della capacità
78 Cfr. J. Paul, Rome Ruined and Fragmented: the Cinematic City in “Fellini-Satyricon” and “Roma”, in Cinematic Rome, edited by R. Wrigley, Troubador, Leicester 2008, p. 116.
196 Lessico del cinema italiano
di ripresa dimostrata dopo i disastri della guerra, della funzione centrale, o centrista, esercitata nella vita pubblica»79, non può in-somma essere ricondotto ad una semplice rifl essione sociologica sull’“alienazione” del soggetto in un moderno mondo industriale, anche se questa preoccupazione diventa centrale per l’indagine ri-volta alle modalità di percezione della realtà da parte dello stesso dispositivo cinematografi co.
Lo scacco esistenziale cui l’individuo è fatalmente destinato si traduce pertanto in un’impossibilità di essere soggetto di storia che trova nel David Locke di Professione: reporter (1975) un’ideale esemplifi cazione. Quella interpretata da Jack Nicholson è di fatto una fi gura agita dalla storia, intrappolata nelle maglie del caso o di un più oscuro destino esistenziale che rende la sua stessa “profes-sione di uomo” del tutto impossibile80.
Il cinema di Antonioni segnala in defi nitiva un posizionamento netto e risoluto fuori dalla storia attuato attraverso «la prevalenza di un formalismo come mito fi nalmente liberato, e quindi poetico».
Sono parole di una recensione di Il deserto rosso (1964) scritte da Pier Paolo Pasolini81, uno degli intellettuali che, negli stessi anni, appare tra i più coinvolti in un rapporto tormentato e confl ittuale con la storia, come attestano già alla metà degli anni cinquanta alcuni passi di Le ceneri di Gramsci:
Ma nella desolante/mia condizione di diseredato,/io possiedo: ed è il più esaltante/dei possessi borghesi, lo stato/più assoluto. Ma come io possiedo la storia,/essa mi possiede; ne sono illuminato:/ma a che serve la luce? […] Ma io, con il cuore cosciente/di chi soltanto nella storia ha vita,/potrò mai più con pura passione operare,/se so che la nostra storia è fi nita?82
Tali termini sintetizzano lucidamente l’intera parabola del futu-ro cinema pasoliniano, tutto attraversato dalla soơ erta contraddi-
79 V. Spinazzola, Cinema e pubblico, cit., p. 148.80 Cfr. P. Pintus, Storia e fi lm, cit., p. 140.81 P.P. Pasolini, Empirismo eretico, in Id., Saggi sulla letteratura e sull’ar-
te, a cura di W. Siti, S. De Laude, tomo I, Mondadori, Milano 1999, pp. 1477-1479.
82 P.P. Pasolini, Le ceneri di Gramsci, in Id., Tutte le poesie, a cura di W. Siti, tomo I, Mondadori, Milano 2003, pp. 820-821, 826.
Storia Christian Uva 197
zione tra la razionale adesione al grande circuito della storia e, allo stesso tempo, la passionale attrazione per una vita che è ai margini di essa e che solo lì può germogliare.
È nuovamente il tentativo di rintracciare e raccontare un epos quello che segna l’esperienza cinematografi ca (e, più in generale, intellettuale) di Pasolini, fondato in questo caso sulla gramsciana enfasi riservata ad un’umanità “subalterna” – sia questa rappresentata dai sottoproletari delle borgate romane o dalle popolazioni del terzo mondo – calata nella dimensione atemporale e astorica propria del mondo contadino.
Più precisamente, bisognerebbe parlare, già con riferimento al con-testo abitato dai “contadini inurbati” di Accattone (1961) e Mamma Roma (1962), di una pre-Storia dominata da una concezione pagana del tempo (il tempo “circolare” derivato dall’ancestrale ciclo delle col-ture) e quindi da un’irrazionalità vitale e salvifi ca. Ad una simile con-dizione si oppone quella che, dando avvio alla vera e propria Storia, impone il razionale e illuministico tempo lineare del progresso, che segna la fi ne di quel mondo classico, prerazionale e preindustriale.
Pre-storici non possono allora che essere tutti i personaggi del ci-nema pasoliniano che si pongano al di qua del violento sradicamen-to da ogni legame comunitario determinato dalla modernizzazione, dall’«acculturazione imposta subdolamente dalle classi dominanti» defi nita dall’autore in termini di «genocidio»83. Lo è dunque Stracci in La ricotta, episodio del collettivo Ro.Go.Pa.G. (1963); lo è Emilia in Teorema (1968); lo sono i protagonisti della “trilogia della vita” (Il De-cameron, 1971; I racconti di Canterbury, 1972; Il fi ore delle mille e una notte, 1974), e naturalmente i contadini di Porcile (1969) e dei Sopral-luoghi in Palestina per il Vangelo secondo Matteo (1963-1965), come i tanti volti delle periferie del mondo ritratti negli Appunti per un fi lm sull’India (1968) e in Appunti per un’Orestiade africana (1970)84.
Non sfuggono a tale connotazione il Cristo di Il Vangelo secondo Matteo (1964) e Totò e Ninetto di Uccellacci e uccellini (1966), i
83 P.P. Pasolini, Scritti corsari, in Id., Saggi sulla politica e sulla società, a cura di W. Siti, S. De Laude, Mondadori, Milano 1999, pp. 511-517.
84 A tale lista di personaggi si potrebbero aggiungere i protagonisti dell’opera di un altro autore come Vittorio De Seta, che negli stessi anni in Banditi a Orgosolo (1961) “canta” un mondo ugualmente primordiale, quello dei pastori sardi della Barbagia la cui «anima», come recita la voice over all’ini-zio del fi lm, è rimasta parimenti primitiva («quello che è giusto per la loro legge non lo è per quella del mondo moderno»).
198 Lessico del cinema italiano
quali peraltro evidenziano tutta la problematica quanto ambigua natura della relazione intrattenuta dal regista con la religione cri-stiana, da un lato, e con l’ideologia marxista, dall’altro.
Se è vero così, come annota lo stesso Pasolini, che proprio la “rivoluzione culturale” del cristianesimo «ha rotto la struttura cir-colare delle vecchie religioni: e ha parlato di un “fi ne”, non di un “ritorno”»85, dando appunto avvio al tempo unilineare della storia, allora la particolarità del Cristo di Il Vangelo secondo Matteo, il suo aspetto “scandaloso”, risiede proprio nell’essere stato rappresenta-to come una fi gura insieme sacra e profana, laddove la predicazio-ne dei suoi valori risulta totalmente calata in quel contesto arcaico e pre-storico, geoantropologicamente contadino (confi gurato dal paesaggio del Mezzogiorno), che, fi no all’avvento della moderniz-zazione, «ha tolto al cristianesimo il suo solo momento originale rispetto a tutte le altre religioni»86, riconducendo l’immagine stes-sa di Gesù ad una dimensione che ignorava il “tempo reale” (la storia appunto) introdotto dalla religione cristiana.
In una parola, insomma, il Cristo di Pasolini è irrazionale così come lo sono in Uccellacci e uccellini Totò e Ninetto, di fronte ai quali si posiziona insistentemente il pedante corvo marxista (de-stinato ad essere soppresso), emblema di un’ideologia vissuta dal regista in maniera controversa dato che, ancora nel ’47, Pasolini la assumeva come arma dialettica e razionalizzatrice capace proprio di «trasformare la preistoria in storia, la natura in coscienza»87.
Lo “straziato” rapporto di Pasolini con la storia è fatalmente de-stinato a sfociare in un “fi lm storico” quale Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975), trionfo di una vena ferale (contenuta nelle sadiane vicende ambientate negli ultimi mesi della Repubblica Sociale Ita-liana) che suggella l’irrimediabile fi ne del mondo mitico decantato nelle opere precedenti.
Di fatto, si tratta di un’opera quanto mai complessa e con-traddittoria. Da una parte l’elemento luttuoso segnala defi niti-vamente la fi ne della pre-Storia e l’ingresso nella Storia – come era già accaduto ad Accattone, ad Ettore (in Mamma Roma) e
85 P.P. Pasolini, Scritti corsari, in Id., Saggi sulla politica e sulla società, cit., p. 360.
86 Ibidem.87 Id., Saggi sparsi (1942-1973), in ivi, p. 44.
Storia Christian Uva 199
a Stracci, ma anche ai due burattini Jago/Totò e Otello/Ninetto
(nel cortometraggio Che cosa sono le nuvole?88) – visto che tale
transizione corrisponde fatalmente all’«attimo rapido e folgo-
rante della “morte”»89. D’altra parte la Salò storica aơ rontata da
Pasolini è quella che passa attraverso Sade, è cioè «l’essenziale
dismisura del potere nella sua purezza»90.
Il profondo, insanabile dilemma proposto da quest’opera-
testamento consiste quindi nel suo condensare il senso tragico
dell’intera produzione artistica pasoliniana attraverso l’aơ er-
mazione di un «codice binario» che è dato proprio dalla convi-
venza tra tempo della Storia e non-tempo del Potere, cioè tra la
perenne mutevolezza del tempo storico e «l’eternità del vincolo
che stringe il potere e il corpo»91.
Come si vede, dal dopoguerra in poi il cinema italiano inter-
preta e ripensa la storia sempre più come un problema nel quale
gli irrisolti nodi connaturati all’identità italiana, irrigidendosi
progressivamente, tendono a produrre visioni via via più drasti-
che, estreme, traumatiche.
La “nuova ondata” di cineasti debuttanti negli anni sessanta –
tra i quali, seppure in modo del tutto peculiare, si pone lo stesso
Pasolini – si fa del resto interprete di quella repentina infrazione
di schemi, codici, valori costituiti che, convergendo nella furia
ribelle del sessantotto, fi nisce per spazzare via anche tutta una
serie di certezze, aprendo la strada con il suo relativismo cultu-
rale alla “condizione postmoderna” teorizzata nel decennio suc-
cessivo. L’epoca d’altronde, per usare le parole di Walter Pedullà,
«è di quelle in cui si cominciano a fare delle matte risate non solo
sullo storicismo ma anche sulla storia, passione delusa di una ge-
nerazione che usava i cronometri pur di avvertire i mutamenti
“progressivi” del mondo»92.
Tutto ciò arriva a determinare, come esito estremo, un radicale
rifi uto della storia medesima fi no all’autoesilio da essa oppure, al
contrario, il tentativo di un’entusiastica quanto ideologica integra-
88 Episodio del fi lm collettivo Capriccio all’italiana (1968).
89 L. Miccichè, Pasolini nella città del cinema, Marsilio, Venezia 1999, p. 212.
90 G. Marramao, A partire da “Salò”: corpo, potere e tempo nell’opera di Paso-lini, in “aut aut”, n. 345 (2010), p. 117.
91 Ivi, p. 116.
92 W. Pedullà, La rivoluzione della letteratura, Ennesse, Roma 1970, p. 35.
200 Lessico del cinema italiano
zione nel suo corso, cui segue nondimeno l’immancabile espulsio-ne dal suo alveo e quindi la delusa estraniazione.
Nel primo caso, emblematico è l’atteggiamento di Marco Ferreri che in La grande abbuơ ata (1973) giunge a mettere in scena, facen-do ricorso ad un grottesco mortuario, una serie di individualità completamente avulse, claustrofobicamente separate dalla sto-ria. Sul secondo fronte si colloca invece Bernardo Bertolucci che, con personaggi come il Fabrizio di Prima della rivoluzione (1964) o il Giacobbe di Partner (1968), mette in scena coscienze in crisi proprio perché scisse tra la speranza del cambiamento (e quindi il sogno di essere soggetti attivi della storia) e la disillusione dell’in-tegrazione nei ranghi borghesi in cui non si può fare altro che as-sistere impotenti all’immutabilità della realtà.
Dopo ulteriori prove come Il conformista (1970) e Strategia del ragno (1970) – in cui la storia appare più che altro il tramite at-traverso il quale far passare un discorso fondamentalmente autoa-nalitico – caso particolarmente emblematico di una vera e propria monumentalizzazione del tempo è Novecento (1976), opera titanica in cui la spasmodica e annosa ricerca di una dimensione epica da parte del cinema italiano sembra fi nalmente trovare un approdo nella “cavalcata storica” proposta da Bertolucci: quella che delinea la transizione dal pasoliniano mondo contadino pre-politico/pre-storico degli inizi del secolo ad una coscienza storico-politica di più ampio respiro. In tale occasione a ricoprire un ruolo essenziale è quanto mai la tecnica fi lmica, e in particolare l’uso del carrello, che soprattutto nella prima parte del fi lm «è usato come un “agente epi-co”, al pari della musica», capace di muovere «lo spettatore dentro la forma ampia della Leggenda che ingloba la Storia»93.
Per l’ennesima volta ci si trova di fronte ad una dialettica riguar-dante la condizione di organicità o estraneità alla storia che, nello specifi co, vede da una parte i “padroni”, con il loro «tempo chiuso, storico, compiuto», e dall’altra i “paisani”, portatori di un «tempo aperto, largo, al di là della storia»94. Tra questi due estremi si posi-zionano organicamente il cinema e la sua tecnica.
93 M. Grande, L’operatore-tempo nella narrazione fi lmica, in Il cinema in profondità di campo, a cura di R. De Gaetano, Bulzoni, Roma 2003, p. 103.
94 Ibidem.
Storia Christian Uva 201
Dai fatti di storia ai fatti di memoria: il “sentimento del passato”
Anche nella produzione di Paolo e Vittorio Taviani il linguaggio e la tecnica fi lmica rappresentano, in sintonia con le marche della modernità cinematografi ca, il fi ltro primario attraverso il quale far transitare le rifl essioni su concetti chiave quali l’identità naziona-le, il regionalismo, il familismo, l’emigrazione, il classismo socia-le e la sessualità95. A tale elenco deve essere aggiunta l’ideologia, quella marxista in particolare, oggetto in un’opera come I sovver-sivi (1967) di una meditazione che culmina visivamente, come già l’anno precedente accadeva in Uccellacci e uccellini, nelle lunghe sequenze documentarie dei funerali di Togliatti, assunti quale vero e proprio spartiacque di un’epoca se è vero che proprio da una rifondazione di quella medesima ideologia la storia può ricevere nuovo impulso per rimettersi in moto.
L’“addio al padre” – da un lato padre in senso politico e natura-le, ma anche come mito e momento storico; dall’altro padre come metafora di una forma stessa di cinema da cui è giunto il momento di emanciparsi (il neorealismo) – rappresenta quindi la circostan-za dolorosa e traumatica che costringe ad abbandonare la pacifi ca-zione con se stessi per riprogettarsi, facendo leva sull’utopia della riconquista di un ruolo attivo nella storia96.
Il connubio tra contrapposizione generazionale e utopia (inte-sa in senso vitalistico, come momento creativo, “esagerato”, fi dei-stico), rispecchiato sul piano estetico nel continuo ripensamento della forma fi lmica, è pertanto il cuore di una politicità che sostan-zia una possibile alternativa al generale pessimismo nei confronti della storia medesima espresso dal cinema dell’epoca.
Ecco allora opere più canonicamente storiche, collocate già ne-gli anni settanta e ottanta, come Allonsanfàn (1974) e La notte di
95 Cfr M. Landy, Italian Film, cit., p. 165.96 È l’utopia presente, nel medesimo periodo, anche nel cinema di Pontecor-
vo, e in particolare in un’opera di un anno precedente rispetto a I sovversivi, La battaglia di Algeri (1966). Qui il racconto cronachistico delle tappe della lotta di Liberazione del popolo algerino, per il taglio rigorosamente do-cumentaristico ma contemporaneamente, a suo modo, epico, determinò signifi cativi eơ etti di coinvolgimento e partecipazione negli spettatori che allora coltivavano nuovi sogni rivoluzionari (non a caso il fi lm è diventato uno dei punti di riferimento per molti militanti delle Brigate Rosse).
202 Lessico del cinema italiano
San Lorenzo (1982), dove tornano in gioco i due cruciali momenti
del passato nazionale: il Risorgimento (quello iniziale, contestua-
lizzato nella fase della Restaurazione napoleonica) e la Resistenza.
Allonsanfàn, anche per gli accenti operistici che lo contraddi-
stinguono, riporta il pensiero al Senso viscontiano e al suo “deca-
dentismo storico”, ora incarnato nella disillusione del protagonista
(l’aristocratico Fulvio Imbriani) alla quale si contrappone tuttavia
l’utopia romantica di chi, come i suoi ex compagni rivoluzionari,
crede ancora, malgrado tutto, in un possibile rinnovamento.
La notte di San Lorenzo, rielaborazione del cortometraggio San Miniato, luglio ’44 realizzato nel 1954 con Valentino Orsini e la
consulenza di Zavattini, a dispetto della collocazione al principio
di un decennio, come gli anni ottanta, etichettato come quello del
“rifl usso” e, in ambito cinematografi co, degli «schermi opachi»97,
sembra invece confi gurarsi come l’estremo tentativo, uno degli ul-
timi, di individuare nel passato nazionale, malgrado la fragilità di
una memoria sempre più “non riconciliata”, le condizioni di un
racconto mitico. Lo strumento privilegiato cui si aƥ da tale istanza
è la stessa narrazione fi lmica intesa dichiaratamente come favola
(quella che la madre, all’inizio del fi lm, comincia a esporre al pro-
prio fi glio), quindi come racconto di una storia i cui motivi costi-
tutivi vengono attinti da un archivio memoriale.
È proprio la memoria, in eơ etti, il vero oggetto del fi lm: la me-
moria individuale e collettiva in cui si deposita e si rielabora una
serie di episodi di ferocia e crudeltà avvenuti nell’estate del ’44 in
un piccolo paesino della Toscana durante l’occupazione tedesca.
Su tale repertorio storico si esercita la trasfi gurazione favolesca che
conduce al mito (è Claude Lévi-Strauss a parlare delle favole come
«miti in miniatura»98), legittimando i registi a introdurre «Omero
nella campagna toscana»99 e, così, a portare coerentemente a com-
97 Cfr. Schermi opachi. Il cinema italiano degli anni ‘80, a cura di L. Miccichè,
Marsilio, Venezia 1998.
98 C. Lévi-Strauss, La struttura e la forma. Rifl essioni su un’opera di Vladimir Ja. Propp, in V.J. Propp, Morfologia della fi aba, Einaudi, Torino 2000, p.
183 [ed. or. La structure et la forme. Réfl exions sur un ouvrage de Vladimir Propp, in “Cahiers de l’Institut de Sciences Économiques Appliquées”, n. 9
(1960)].
99 P. Iaccio, L’utopia come momento della verità. La presenza della Storia, in Utopisti esagerati. Il cinema di Paolo e Vittorio Taviani, a cura di V. Zagar-
rio, Marsilio, Venezia 2004, p. 210.
Storia Christian Uva 203
pimento la propria missione politica mirata all’edifi cazione di un vero e proprio “epos resistenziale”.
Il fi lm dei Taviani va collocato del resto nel pieno di una stagione cinematografi ca che segnala il profi larsi di una “nuova storia” il cui oggetto privilegiato è costituito proprio dai «fatti di memoria»100. Una memoria che naturalmente
ha i suoi impedimenti che fanno capo a soơ erenze e colpevolezze passate, ha i suoi rimossi e le sue resistenze, i suoi assilli e le sue nega-zioni che la psicanalisi e la psicologia sociale descrivono sulle piccole scale individuali e che la storia delle rappresentazioni raggiunge sulle scale più grandi101.
È con gli anni settanta che il “sentimento del passato”102 tende a imporsi come inclinazione dominante nella produzione di ci-neasti di generazioni diverse, determinando un’intersezione tra memoria storica e memoria collettiva e personale che costituisce il nodo attraverso il quale, guardando al passato, si tenta di recu-perare «la chiave di interpretazione e accesso a un presente caotico e poco decifrabile»103.
La visione retrospettiva si carica così di un accento nostalgico (già d’altronde annunciata dalla “trilogia del tempo” leoniana e prossima a irrompere in tutta la sua portata con gli anni ottanta) che può nuovamente ricondurre ad un orizzonte primordiale, lon-tano e dimenticato, come il mondo contadino della bassa pianu-ra bergamasca di fi ne Ottocento di L’albero degli zoccoli (1978) di Ermanno Olmi, non semplicemente oggetto, tuttavia, di un puro vagheggiamento, quanto occasione di un preciso discorso volto ad indagare un’ambiguità di fondo: «Guardare indietro nel nostro passato signifi ca soprattutto capire se siamo andati avanti per una certa strada oppure se ci siamo fatti confondere sino al punto di
100 P. Ricoeur, La memoria dopo la storia, in http://www.fi losofi a.it/images/download/argomenti/Ricoeur_Memoria_dopo_la_storia.pdf, p. 1.
101 Ivi, p. 8.102 Cfr. P. Nora, Mémoire collective, in La nouvelle histoire, sous la direction de
J. Le Goơ , Retz, Paris 1978, p. 398.103 G.P. Brunetta, Guida alla storia del cinema italiano (1905-2003), Einaudi,
Torino 2003, p. 303.
204 Lessico del cinema italiano
perdere il senso della nostra esistenza, e perciò se la memoria è nostalgia o storia»104.
Nel contempo, la medesima vena elegiaca, nutrita consistente-mente della disillusione ideologica nei confronti del presente, può calarsi in un impianto crepuscolare che trattiene gli umori più neri della commedia italiana, come accade paradigmaticamente nel ci-nema di Ettore Scola, il cui orizzonte appare contraddistinto dalla totale “porosità” tra esterno e interno105, ovvero, ancora una volta, tra lo spazio-tempo della macrostoria e quello della microstoria.
Gli esempi di C’eravamo tanto amati (1974), Una giornata par-ticolare (1977), La terrazza (1980), La famiglia (1987), fi no a Con-correnza sleale (2001), aơ ermano, una volta di più, il disinganno nei confronti della storia, come dimostra, nel primo di questi titoli, il destino riservato allo stesso mito resistenziale “favoleg-giato” dai fratelli Taviani qualche anno più tardi: esattamente quello di un totale sgretolamento alla prova di un presente in cui l’unica dimensione epica si conferma quella vissuta in chiave tragicomica, nel minuscolo mondo dei rapporti individuali, da una serie di soggetti incompiuti abitati dal rimpianto per un’e-poca migliore106.
C’eravamo tanto amati costituisce d’altronde un caso piuttosto emblematico della trattazione del passato prossimo tipica degli anni settanta, con la sua propensione a guardare indietro in una maniera appunto nostalgica, derivata dalla sensazione che quella storia sia ormai passata e che irrimediabilmente ci si trovi fuori dal suo corso («il futuro è passato e non ce ne siamo nemmeno accor-ti» dice ad un certo punto, avvilito e disilluso, il Nicola di Stefano Satta Flores).
Tutto ciò trova un fi ltro e un corrispettivo in specifi che mar-che stilistiche. Prima di tutto nella dialettica tra bianco e nero e colore, quindi nell’uso del f lou, del fl ashback e di un preciso tema musicale funzionale a richiamare melanconicamente il passato107.
104 E. Olmi, in P. Pintus, Storia e fi lm, cit., p. 11 (corsivo mio).105 Cfr. C. Ginzburg, Il fi lo e le tracce. Vero, falso, fi nto, Feltrinelli, Milano
2006, p. 268.106 Cfr. M. Grande, La commedia all’italiana, cit., p. 238. 107 Cfr. E. Morreale, L’invenzione della nostalgia. Il vintage nel cinema italiano
e dintorni, Donzelli, Roma 2009, p. 66.
Storia Christian Uva 205
In un simile quadro il carrello, che qualche anno più tar-di percorrerà ripetitivamente – quasi fosse la pendola di un orologio della storia – il corridoio della casa borghese di La famiglia, non può che diventare l’equivalente claustrofobico e castrante dei travelling di Novecento, descritti dallo stesso Bertolucci come il corrispettivo del maestoso «incedere della Storia»108.
Il presente storico tra “epica indiziaria” e pulsione mortuaria
A questa tendenza nostalgica si contrappongono negli stessi anni le due direttrici su cui si sostanzia il cosiddetto “cinema civile”: quella espressionista di Elio Petri e quella “indiziaria” di Francesco Rosi.
Delle due, la più propensa ad eventuali incursioni nei tra-scorsi della storia nazionale appare la produzione del cineasta napoletano che, a partire da Salvatore Giuliano (1962), guarda al passato privandosi di qualsiasi sentimentalismo per approdare ad un inchiestare improntato ad un metodo rigoroso e scienti-fi co.
Si tratta, in eơ etti, di un vero e proprio “processo alla storia” condotto con totale e scrupolosa ortodossia tanto sul piano del metodo che su quello della disamina dei risultati concreti e che pone dunque il regista, proprio come il giudice, nella condi-zione «di dover procedere alla ricostruzione e all’accertamento della verità, la più ampia possibile»109.
Se in opere come Salvatore Giuliano, Il caso Mattei (1972) e Lu-cky Luciano (1973) Rosi rivolge la sua indagine alle connessioni tra i personaggi e lo scenario storico-politico in cui si inseriscono le loro azioni, successivamente si fa strada nel suo cinema una vena metaforica che culmina in un fi lm chiave come Cadaveri eccellenti (1976), nel quale la componente mortuaria, segnalata fi n dal titolo, sembra determinare un (almeno provvisorio) deragliamento del
108 B. Bertolucci, in V. Zagarrio, Bertolucci: padri-padrini e padri-padroni, in Il cinema del rifl usso. Film e cineasti italiani degli anni ‘70, a cura di L. Miccichè, Marsilio, Venezia 1997, p. 141.
109 A.G. Mancino, Il processo della verità, cit., p. 63.
206 Lessico del cinema italiano
cinema rosiano dai binari della storia, avvicinandolo per un mo-mento alla produzione parallela di Petri, in particolare al suo Todo modo, uscito nel medesimo anno.
È del resto, più a monte, la comune matrice sciasciana a mar-care l’orientamento di due opere-apologo sul tema della violenza del potere che in Rosi assume una declinazione metafi sica e in Petri grottesca. Il risultato, apparentemente paradossale, è che, pur trattandosi di fi lm profondamente radicati nel contesto110 so-cio-politico dell’Italia dell’epoca, in essi il “sentimento della sto-ria” appare totalmente annichilito dall’atmosfera cupa, funerea, claustrofobica che pervade le vicende raccontate.
Cadaveri eccellenti, veicolando lo spaesamento del presente che aƫ igge molti autori dell’epoca di fronte ai cosiddetti “anni di piombo”, sembra in particolare fare proprio quello “stile pa-ranoico” che contraddistingue molti fi lm, soprattutto di genere thriller, di tale stagione nei quali si fa ampio ricorso ad una teoria cospirativa111. Una simile visione delle cose implica una conside-razione della storia quale entità aliena o addirittura sovrumana la cui chiave interpretativa va rintracciata nel pensiero antistori-cista di un fi losofo come Karl Popper, secondo il quale la teoria sociale della cospirazione è simile a quella che si trova in Omero: tutto ciò che accade nella pianura davanti a Troia non è altro che il rifl esso delle molteplici cospirazioni tramate nell’Olimpo112, perciò qualcosa che letteralmente “passa sopra le teste” dei co-muni mortali senza poter essere aơ errato.
In Petri il disincanto e l’assenza di speranza, già presenti in Scia-scia, si fanno ancora più defi nitivi, trovando nella cifra del grotte-sco la loro espressione più risolta. Opere come il citato Todo modo o Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (1970) segna-lano un grottesco che smarrisce ogni spinta vitale, estremizzando i
110 Il contesto è proprio l’opera di Leonardo Sciascia da cui è derivato il fi lm di Rosi, mentre quello di Petri trae spunto dall’omonimo romanzo dello scrittore siciliano.
111 Cfr. A. O’Leary, Moro, Brescia, conspiracy. Lo stile paranoico nel cinema italiano, in Strane storie. Il cinema e i misteri d’Italia, a cura di C. Uva, Rubbettino, Soveria Mannelli 2011, pp. 63-78.
112 Cfr. K.R. Popper, La società aperta e i suoi nemici. Hegel e Marx falsi profeti, Armando, Roma 2003, pp. 113-121 [ed. or. The Open Society and Its Enemies. Hegel and Marx (Vol. II), Routledge, London 1945].
Storia Christian Uva 207
moduli della commedia e la sua vocazione antistorica. Per quanto riguarda in particolare Todo modo, uscito solo un anno dopo Salò o le 120 giornate di Sodoma, appare calzante l’idea anarchica di un potere che, come nel precedente pasoliniano, «non produce nes-suna vettorialità, nessuna cumulatività o “freccia” del tempo, ma solo una circolarità senza fi ne che coinvolge in un unico abbraccio vittime e carnefi ci»113.
La pulsione di morte d’altra parte rappresenta una costante del “cinema politico” degli anni settanta, che appare segnato dall’i-nesorabile approdo ad un orizzonte crepuscolare teso a confi nare fatti e personaggi in un’atmosfera sospesa, rarefatta, ora appunto grottesco-espressionista ora surreale e metafi sica.
È in fondo, per certi aspetti, la parabola descritta in tale decen-nio anche dal cinema di Monicelli – da Brancaleone alle crociate (1970) a Un borghese piccolo piccolo (1977) passando per Vogliamo i colonnelli (1973) – secondo un percorso ancora una volta contrad-distinto da una formula grottesca che, da picaresca e beơ arda, si tramuta in lugubre e funerea. Dalla caricatura dei modelli storici consacrati relativi ad un genere come quello eroico-epicizzante (Brancaleone) si passa alla vera e propria satira politica (Vogliamo i colonnelli) per approdare alla mortuaria «rappresentazione del-la “banalità del male” e, insieme, dell’insostenibile precarietà del vivere»114 (Un borghese piccolo piccolo).
Sfuggono ad una siơ atta condizione alcune forme di cinema il cui comune schiacciamento sul presente non corrisponde tuttavia ad una già postmoderna presentifi cazione del tempo avulsa dalla storia, quanto ad una fi deistica concezione del dispositivo cinema-tografi co quale strumento di intervento sulla storia, o più sempli-cemente di immersione nella realtà.
Ecco allora il “cinema militante” che, coesistendo con il “mo-vimento” (studentesco e operaio), mette in disparte il passato interessandosi al presente delle rivendicazioni dei lavoratori, delle vicissitudini dei proletari, delle lotte sindacali, come suc-
113 G. Marramao, A partire da “Salò”, cit., p. 116.114 G. Canova, Figure di un ordine cannibale, in Lo sguardo eclettico. Il cinema
di Mario Monicelli, a cura di L. De Franceschi, Marsilio, Venezia 2001, p. 185.
208 Lessico del cinema italiano
cede nel paradigmatico Apollon, una fabbrica occupata (1969) di Ugo Gregoretti.
Si tratta di opere che individuano nella demistifi cazione dei rapporti di potere la stessa politicità della macchina-cinema, il cui intervento infatti non viene mai nascosto, ma al contrario messo in evidenza e dichiarato115.
La comparsa dei nuovi strumenti elettronici di ripresa, radi-calizzando tale istanza e prefi gurando l’avvento del digitale, rap-presenta il punto di arrivo di quel processo di liberazione dello sguardo profetizzato nel 1948 da Alexandre Astruc con la sua idea di caméra-stylo116. Grazie al video si può intervenire nella storia nel suo duplice senso: cogliendo da un lato in forma inedita i temi canonicamente politici del presente, quali il potere e l’emargina-zione, per intrecciarli con quelli delle relazioni tra uomini e don-ne; sfruttando dall’altro i tempi lunghi della videoregistrazione per consentire «allo spettatore di seguire, quasi in tempo reale, il processo di lavorazione [e] l’evoluzione della “storia”»117. È ciò che accade nell’emblematico Anna (1972-1975) di Alberto Grifi e Massimo Sarchielli, pionieristica opera in elettronica che riscontra nella “bassa defi nizione” del mezzo un organico strumento attra-verso il quale stabilire un’orgogliosa diversità e nel contempo fon-dare il proprio vitale spontaneismo.
Risponde a suo modo ad una marcata istanza di militanza anche un altro fi lm uscito nei medesimi anni, apparentemente slegato da tali esperienze (anzitutto perché calato nell’orizzonte più cano-nico del fi lm storico), come Bronte: cronaca di un massacro che i libri di storia non hanno raccontato (1972) di Florestano Vancini, nel quale la dimensione della cronaca esplicitata nel titolo si tra-duce nella scelta del regista di aơ ondare la macchina da presa in un passato storico (nuovamente quello risorgimentale) che si vuole
115 Cfr. C. Uva, L’immagine politica. Forme del contropotere tra cinema, video e fotografi a nell’Italia degli anni Settanta, Mimesis, Milano 2015.
116 Cfr. A. Astruc, Nascita di una nuova avanguardia: la caméra stylo, in Leg-gere il cinema, a cura di A. Barbera, R. Turigliatto, Mondadori, Milano 1978 [ed. or. Naissance d’une nouvelle avant-garde: la caméra-stylo, in “L’Écran français”, n. 144 (1948)].
117 S. Lischi, Senza chiedere permesso: il videotape e il cinema militante, in Sto-ria del cinema italiano, vol. XIII, 1977-1985, a cura di V. Zagarrio, Marsilio-Edizioni di Bianco e Nero, Venezia-Roma 2005, p. 91.
Storia Christian Uva 209
attualizzare ricorrendo ad uno sguardo istintivo, spontaneo, im-mediato, fondato in buona parte sull’uso libero e immersivo dello zoom (secondo la lezione del Rossellini televisivo). Bronte, d’altra parte, è stato più volte considerato come un’opera totalmente fi glia del suo tempo, metafora della congiuntura socio-politica dei primi anni settanta, condensazione di rimandi tra presente e passato in cui il vissuto del ’68 si confonde continuamente con la rievocazio-ne del 1860.
Sulla sponda opposta, ma in fondo complementare, si colloca un cinema di genere ugualmente contraddistinto da un’istanza cronachistica che, calandosi in una sorta di orizzonte epico, appa-re quanto mai motivata dall’urgenza di fare i conti con il proprio tempo.
Il riferimento va al fi lone poliziesco (o, come venne all’epoca spregiativamente etichettato da certa critica, “poliziottesco”), sce-nario in cui la storia torna a compiere il suo luttuoso corso sopra le teste dei tanti “servitori dello Stato” che, come l’ispettore Rogas di Cadaveri eccellenti, fi niscono sovente per essere stritolati dagli ingranaggi del potere in cui tentano di insinuarsi.
In tale contesto la dimensione “paranoica” più sopra evocata, radicalizzata in una direttrice iperbolica, diventa pienamente fun-zionale ad un meccanismo narrativo in cui i “commissari di fer-ro” del poliziesco nostrano assurgono a moderni eroi popolari e quindi, in virtù del loro statuto di individui espulsi dalla storia (si-milmente ai protagonisti del western italiano), alla condizione di fi gure in qualche modo “epiche”.
È questa la linea che da Confessione di un commissario di poli-zia al Procuratore della Repubblica (1971) di Damiano Damiani e La polizia ringrazia (1972) di Stefano Vanzina conduce fi no a La polizia accusa: il servizio segreto uccide (1975) di Sergio Martino, riarticolandolo di volta in volta il tema già presente nel fondativo Indagine petriano: quello della «disgregazione immaginaria e re-ale dell’idea di Stato. Padre assente nel dopoguerra [trasformatosi poi] in un luogo dominato da forze oscure, che tramano contro gli stessi cittadini»118.
Questa sorta di epicizzazione del presente si nutre di un’ur-genza referenziale che sul terreno estetico si specifi ca nella vo-
118 G.P. Brunetta, Guida alla storia del cinema italiano, cit., p. 217.
210 Lessico del cinema italiano
race propensione di tale fi lone a testualizzare la realtà119 fago-citando materiali di repertorio nel tessuto audiovisivo del fi lm. Ecco allora l’abbondanza di “prelievi”, ossia di documenti del passato, tracce o residui archeologici che agganciano il testo a una situazione storica120 e che, se da un lato vengono stru-mentalizzati alle esigenze dello spettacolo di intrattenimento, dall’altro testimoniano l’irriducibile necessità di questa produ-zione di saldare il debito contratto con la realtà da cui trae ispi-razione.
Si tratta di un’ulteriore declinazione di quella pratica indizia-ria che trova ricorrente applicazione anche nella produzione di Giuseppe Ferrara, ossia in un contesto fi lmico che, ibridando le formule narrative e stilistiche del cinema militante e di impegno civile con quelle del poliziesco, ricorre all’utilizzo diơ uso di “pre-lievi” oppure di “inserti”, cioè di materiali riconducibili alla storia uƥ ciale che, a diơ erenza dei primi, sono direttamente manipo-labili dal testo fi lmico121.
La generale operazione di riscrittura cinematografica messa in atto da Ferrara coinvolge così, in un unico “mix”, documento e finzione, come accade in Il sasso in bocca del 1969 (in cui si testualizzano anche alcuni brani di Salvatore Giuliano), in Fac-cia di spia (1975) e, a seguire, in tutta la schiera di film incen-trati su una serie interminabile di “misteri italiani” dai quali emerge la quintessenza della teoria popperiana della cospira-zione, anche se in questo caso l’istanza militante del regista si traduce in una forma di vero e proprio “cinema di intervento” che, sfruttando le potenzialità manipolative del mezzo filmico, rivendica un atteggiamento orgogliosamente e ideologicamen-te controstorico.
La medesima impellenza referenziale porta ad emergere nelle trame narrative ed estetiche di molta produzione di questi anni quella componente mortuaria e luttuosa tipica, come si è già vi-
119 Il concetto è mutuato da M. Grande, La commedia all’italiana, cit., pp. 8-20.
120 Cfr. M. Dinoi, Lo sguardo e l’evento. I media, la memoria, il cinema, Le Lettere, Firenze 2008, p. 177.
121 Ad esempio una trasmissione televisiva «mostrata con le stesse modalità con cui viene prodotta dall’apparato mediatico al di qua del fi lm, ma [che] presenta al suo interno uno dei personaggi della fi nzione fi lmica», ibidem.
Storia Christian Uva 211
sto, del cinema politico e testimoniata ad esempio dalla memoria dell’eccidio di piazza Fontana – palesata in tutta la sua evidenza indessicale in La polizia ha le mani legate (1975) di Luciano Ercoli tramite l’impiego delle immagini autentiche dei funerali delle vit-time della strage alla Banca Nazionale dell’Agricoltura – oppure da quella della strage dell’Italicus, che si fa intravedere, in un breve frammento di repertorio, sotto la forma della carcassa del treno in un passaggio di Io ho paura (1977) di Damiani. Nello stesso anno un tardo poliziesco come il crepuscolare Italia: ultimo atto? di Massimo Pirri riutilizza invece le immagini degli scontri milanesi dell’aprile del 1975 tra manifestanti e forze dell’ordine culminanti con l’uccisione di Giannino Zibecchi, militante del “Coordinamen-to dei comitati antifascisti” investito da una jeep dei carabinieri.
Dopo la metà degli anni settanta si va insomma profi lando un’atmosfera da “fi ne delle grandi narrazioni” coincidente con la confi gurazione di un orizzonte sempre più chiuso nella contrap-posizione tra individuo e società e condensato in un anno chiave come il 1977, stagione particolarmente simbolica non solo per la storia repubblicana, ma anche per quella dello stesso cinema ita-liano. È infatti intorno a quest’annata che
muoiono o sono appena morti i grandi maestri che hanno reso fa-moso nel mondo il cinema italiano neorealista (Vittorio De Sica, 1974, Luchino Visconti, 1976, Roberto Rossellini, 1977), è stato ucciso Pier Paolo Pasolini […], è scomparso Pietro Germi […]. Nel maggio del 1978 [verrà] assassinato Aldo Moro […] sono tutte morti simboliche, che fanno capire improvvisamente che è fi nita una certa Italia […] e che è fi nito un certo cinema […]. Il 1977 può dunque essere un anno di svolta anche da questo punto di vista, una pietra miliare oltre la quale la storia del cinema italiano non può più essere la stessa122.
Il tema della “morte dei padri” è d’altro canto, come già eviden-ziato, un motivo nevralgico già a partire dagli anni sessanta. Pa-dri o padroni che essi siano, la loro naturale scomparsa o edipica uccisione sembra rappresentare adesso una delle conseguenze di quella “liberazione del desiderio” che va di pari passo con la men-zionata pulsione di morte, assumendo la forma di una «forza di-
122 V. Zagarrio, Dopo la morte dei padri. Dagli anni della crisi agli albori della rinascita, in Storia del cinema italiano, vol. XIII, 1977-1985, cit., p. 16.
212 Lessico del cinema italiano
struttrice [capace di] sfi gurare i legamenti sociali per colpire il po-tere politico al cuore del suo rifl esso ideologico: lo Stato-Padre»123.
Lo conferma emblematicamente un altro fi lm del 1977, In nome del Papa Re di Luigi Magni, colto all’epoca proprio quale metafora della perenne crisi dei padri alla ricerca di un’impossibile intesa con le nuove generazioni, esplicitata in un paragone ideologico ri-tenuto dalla critica particolarmente pericoloso, come attestano le seguenti parole di Giovanni Grazzini:
Dove il fi lm è più discutibile è nell’ideologia politica che lo ispira, nel ventilare un parallelo fra i sovversivi del Risorgimento e i terroristi di oggi […]. Non ci piace, insomma, che In nome del Papa Re alimenti il sospetto di aƥ ancarsi a quanti ritengono dei patrioti […] i terroristi […]. Oggi non c’è nessun presentimento d’una nuova Porta Pia, né si risponde con la pena di morte ai sanguinari: c’è soltanto, per tutti, il lugubre sbocco dell’odio seminato per anni124.
La fi ne della storia tra liquefazione e feticismo
Con la transizione agli anni ottanta è proprio la reiterata rifl es-sione sul terrorismo il contesto in cui si radica il senso di una totale perdita di punti di riferimento di fronte alla storia presente e tra-scorsa che torna a coinvolgere, in fi ligrana, la questione resisten-ziale.
Confermandosi uno dei principali fi li rossi che percorrono, a partire dal neorealismo, le articolazioni e sfumature del rapporto cinema-storia in Italia, il tema della guerra partigiana chiamato in causa dal fenomeno della lotta armata non è più, tuttavia, il luogo mitico in cui ricercare una possibile rifondazione dell’i-dentità nazionale. In diverse opere emblematiche di quest’epoca la Resistenza, piuttosto, tende ad essere associata alla vuota re-torica professata dai padri e quindi, con loro, ad essere posta sot-to processo dalle nuove generazioni, come succede in Caro papà (1979) di Dino Risi che rappresenta il confl ittuale rapporto tra un fi nanziere con trascorsi da partigiano e suo fi glio, passato alla
123 M. Grande, Eros e politica. Sul cinema di Bellocchio, Ferreri, Petri, Berto-lucci, P. e T. Taviani, Protagon, Siena 1995, p. 31.
124 G. Grazzini, In nome del Papa Re, in “Corriere della Sera”, 7 dicembre 1977.
Storia Christian Uva 213
militanza armata per tentare disperatamente di dare concretez-za all’utopia della rivoluzione “mancata e tradita” da quelli come suo padre.
Se in Maledetti vi amerò (1980) di Marco Tullio Giordana il partigiano “Saetta” è l’unico ad essere rimasto fedele ai suoi ide-ali, ciò tuttavia non è suƥ ciente a mitigare lo smarrimento del protagonista Svitol, militante di sinistra scappato in Venezuela e rientrato in Italia dopo cinque anni, di fronte ad un paesaggio di totale liquefazione125 di qualsiasi certezza ideologica e morale. Il personaggio interpretato da Flavio Bucci è infatti uno dei tanti reduci che scontano l’aver vissuto «in apnea sotto la superfi cie liquida della storia», come recita una battuta di un’opera di un anno successiva, La tragedia di un uomo ridicolo (1981) di Ber-nardo Bertolucci, la quale, insieme a Colpire al cuore (1982) di Gianni Amelio, torna ad impiegare la dinamica edipica – basata nuovamente sul confl itto generazionale e ideologico tra fi gure di ex partigiani e fi gli insoơ erenti delle loro ambiguità – come chia-ve di lettura delle origini dello stesso terrorismo.
Va rimarcato che a tale fattore si aƥ anca in questi due titoli una corposa istanza metalinguistica riguardante l’accesso pro-blematico del cinema alla storia del periodo: il binocolo con cui Primo Spaggiari in La tragedia di un uomo ridicolo crede di assi-stere al sequestro del fi glio e la macchina fotografi ca con la quale il giovane Emilio in Colpire al cuore tenta di certifi care l’ambigua relazione tra suo padre e la fi ancheggiatrice di un gruppo arma-to, da questo punto di vista, non sono altro che le metafore di un’evidente diƥ coltà di vedere e soprattutto di comprendere ciò che si vede in uno scenario di totale stallo di fronte ad una realtà indistinta e sfumata.
La mediazione tecnica (visiva o audiovisiva) è d’altronde centra-le nel rapporto che il cinema italiano degli anni ’80 instaura con la storia. Una relazione controversa poiché, in piena regola postmo-derna, condizionata, da un canto, dal senso generalizzato di “fi ne della storia” proprio di tale temperie culturale e, dall’altro, da una propensione retrospettiva di breve gittata ma di grande intensi-tà che, al di fuori della produzione fi lmica sopra evocata, torna a
125 Cfr. Z. Bauman, Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari 2003, p. VII [ed. or. Liquid Modernity, Polity Press, Cambridge 2000].
214 Lessico del cinema italiano
prediligere, anche nel cinema più popolare, la vena nostalgica e deformante di cui si è parlato in precedenza.
Ecco allora il recupero mitizzante degli anni sessanta – vagheg-giati quale vero e proprio Eden in cui qualsiasi “miracolo” era ancora possibile – che corrisponde, come testimonia emblematicamente Sapore di mare (1982) di Carlo Vanzina, ad una percezione fonda-mentalmente «fi ltrata dalle immagini cinematografi che, televisive, musicali», ossia da una «memoria di consumatori» propendente ge-neralmente verso tonalità virate sul trash e sul vintage126.
Sembra proprio questo lo «scenario rétro» defi nito da Jean Bau-drillard come la conseguenza del “feticistico” privilegio accordato all’epoca immediatamente trascorsa da cui emana per il pubblico
un profumo più vicino, più perverso, più denso, più inquietante. Ce lo possiamo spiegare ricordando […] la teoria freudiana del feticismo. Questo trauma (perdita dei referenti, ecc.) assomiglia a quella che è nel bambino la scoperta della diơ erenza dei sessi […]: la feticizzazione di un oggetto interviene per occultare questa scoperta insopportabi-le, ma, dice Freud, proprio questo oggetto qualsiasi è spesso l’ultimo oggetto intravisto prima della scoperta traumatica. Così, la storia fe-ticizzata sarà, di preferenza, quella immediatamente precedente alla nostra era “irreferenziale”127.
L’Italia che tenta di risollevarsi dalle macerie lasciate dal ter-rorismo e che si è avviata, come buona parte dei paesi del mondo occidentale, sulla strada di una nuova modernizzazione presenta del resto più di un’analogia con quella che venti anni prima si poneva sullo stesso cammino dopo essersi lasciata alle spalle i detriti della guerra.
Ora come allora tale processo viene vissuto in maniera ine-briante ma anche spiazzante. La rapacità e l’individualismo rac-contati dalla commedia italiana degli anni ‘60 tornano protago-nisti innervando i caratteri, ulteriormente degradati, di alcuni personaggi rappresentativi di un fi lone come il “cinepanettone”, inaugurato dai fratelli Vanzina con Vacanze di Natale del 1983.
126 E. Morreale, L’invenzione della nostalgia, cit., pp. 150-151.127 J. Baudrillard, La storia: uno scenario rétro, in La storia al cinema, a cura di
G. Miro Gori, cit., p. 224.
Storia Christian Uva 215
Diơ erentemente da quanto avveniva nei Sixties, l’aơ ermazione
del consumo di massa raccontato da questo tipo di cinema si in-
treccia però con l’inizio del declino della politica e delle narrazioni
ideologiche già avvertito con il tramonto degli anni settanta.
Il cinema registra questo senso di catastrofe imminente su cui,
come attestato da Prova d’orchestra (1978) di Fellini, si innesta il bi-
sogno di un decisore che non coincide con «la ricerca dell’“uomo
forte”, spauracchio agitato negli anni settanta, ma semplicemente di
qualcuno in grado di indicare una via e mostrare come percorrerla»128.
È quanto traspare, di nuovo, nella cospicua fetta di cinema po-
polare di questi anni abitata da fi gure di piccoli capi e superuomini
di periferia irriverenti e cialtroni129 cui si contrappone, in chiave
grottesco-parodica, il “decisore al contrario” incarnato da Fantozzi
nell’omonima serie di fi lm oppure – sullo sfondo del progressivo
uƥ cializzarsi della caduta delle grandi idealità collettive, politi-
che e religiose – la vera e propria fuga dal decisionismo stesso te-
matizzata in modi diversi dal cinema di Gabriele Salvatores e dai
“malincomici”130, ma soprattutto da chi, come Nanni Moretti, deli-
nea una nuova condizione di incomunicabilità e alienazione quale
metafora dello «smarrimento del presente»131.
Non è un caso che due opere simbolo di tale stagione, Palombel-la rossa (1989) e Mediterraneo (1991), si collochino proprio in coin-
cidenza di due momenti storici decisivi come il crollo del muro di
Berlino e l’alba di “tangentopoli”. Tematizzando un fondamentale
atto di diserzione riguardante la possibilità dei personaggi messi
in campo di farsi “agenti nella Storia”, tutti e due i fi lm segnalano
128 M. Gervasoni, Storia d’Italia degli anni Ottanta. Quando eravamo moderni, Marsilio, Venezia 2010, p. 40.
129 Si vedano i personaggi interpretati da Adriano Celentano in Mani di vel-luto (Castellano & Pipolo, 1979), Il bisbetico domato (Castellano & Pipolo,
1980), Asso o Innamorato pazzo (Castellano & Pipolo, 1981), ma anche
quelli incarnati da Diego Abatantuono in I fi chissimi (C. Vanzina, 1981) ed
Eccezzziunale…veramente (C. Vanzina, 1982). Cfr. ibidem.
130 È, secondo il neologismo di Stefano Reggiani, la schiera dei nuovi attori-
registi comici lanciati dalla televisione verso la fi ne degli anni settanta
(Carlo Verdone, Francesco Nuti, Massimo Troisi, Roberto Benigni). Cfr. S.
Reggiani, Dizionario del postdivismo. Centouno attori italiani del cinema e della TV, Rai-Eri, Roma 1989.
131 Cfr. R. De Gaetano, Nanni Moretti. Lo smarrimento del presente, Pellegrini,
Cosenza 2015.
216 Lessico del cinema italiano
un tempo senza spessore che in Salvatores è un passato monodi-mensionale e privo di una vera identità, mentre in Moretti è un presente in cui
non sembra esserci nessun possibile orientamento nella compren-sione del mondo e della vita [...], per cui l’individuo nella sua fragile autonomia non può far altro che difendersi (aggredendo), godere di un presente dissolto, smarrirsi (senza sicurezza di ritrovarsi)132.
Impegno postmoderno
La sua fatale condanna ad allignarsi in un simile orizzonte fa nondimeno del cinema di Moretti uno degli scenari in cui con più caparbia si manifesta la presa diretta sui fenomeni storici in atto, al punto da far apparire molte delle sue opere addirittura “profetiche” (si vedano in tal senso la fi ne del Partito comunista italiano e la “svolta della Bolognina” preannunciate dallo stes-so Palombella rossa; le vicende che avrebbero riguardato Silvio Berlusconi preconizzate nel 2006 da Il caimano, e la rinuncia al pontifi cato da parte di Benedetto XVI “vaticinata” nel 2011 da Habemus Papam).
In questo consiste l’«impegno postmoderno»133 della sua opera e di un certo tipo di cinema politico degli ultimi anni. L’impiego delle maschere, la visione onirica e surreale del mondo, un certo citazionismo, il gioco con i generi, lo stesso filtro mediatico (anzitutto quello della televisione o delle “can-zonette” pop) attraverso cui la realtà viene restituita costitui-scono nella filmografia morettiana un pastiche metanarrativo e autorif lessivo che però non conduce mai al disconoscimento della realtà medesima.
Lo stesso accade, spostando l’attenzione su un altro autore-simbolo del cinema italiano contemporaneo, se si guarda all’opera di Paolo Sorrentino, il cui discorso sul vissuto nazionale presente e passato si costruisce ricorrendo, in misura ancor maggiore, alla
132 Ivi, p. 12.133 Cfr. Postmodern Impegno. Ethics and Commitment in Contemporary Ita-
lian Culture, edited by P. Antonello, F. Mussgnug, Peter Lang, Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Wien 2009.
Storia Christian Uva 217
cifra del grottesco. È adottando tale prospettiva che il manierismo, la spettacolarizzazione, l’esibizionismo del suo fare cinema in sen-so postmoderno conducono ad uno sguardo distanziato sulla realtà che, come in Moretti, sembra costituire l’unica possibilità di raƥ gu-rare un presente impossibilitato a farsi veramente storia.
È questa la strada praticabile soprattutto quando si decide di aơ rontare – come già accade per la maschera di Berlusconi in Il caimano134 – la fi gura di un uomo politico come Giulio Andreotti, che nell’immaginario popolare ha incarnato più immediatamente l’essenza oscura dei trascorsi nazionali. Il riferimento va a Il divo (2008) in cui il linguaggio visionario adottato da Sorrentino segue tre linee direttrici che danno luogo a un potente eơ etto di surre-altà:
1) La rapida successione di eventi e personaggi che rimandano ai misteri più oscuri della storia della Prima Repubblica […]; 2) l’evoca-zione di ambienti, atmosfere e ritmi appartenenti a linguaggi cine-matografi ci diversi, che includono suggestioni di stampo felliniano, sintesi narrative da thriller mozzafi ato, tipi, riprese, luci e sonorità del cinema americano di mafi a o dello “spaghetti western”; 3) le ripetute apparizioni di Aldo Moro […] contrappunto fi sico, psicologico ed eti-co alla maschera indiơ erente di Andreotti135.
Quest’ultimo elemento consente di riannodare il fi lm di Sorren-tino ad una rifl essione in cui, più che la storia in quanto tale, è la memoria nella sua dimensione collettiva a farsi centrale tramite la fi gura di un altro uomo politico, quale Aldo Moro, che per eccel-lenza ha rappresentato l’icona sacrifi cale degli “anni di piombo”. In Il divo sono proprio le sue apparizioni fantasmatiche, mentre recita brechtianamente paradigmatiche frasi tratte dal suo diario e dalle sue lettere redatte durante la prigionia, a portare in primo piano la dimensione memoriale che ha condizionato per lungo tempo, non solo al cinema, lo sguardo sugli anni settanta. La dif-fi cile accessibilità alle fonti primarie ha infatti determinato, anche
134 Più in generale, sulla rappresentazione cinematografi ca di Berlusconi cfr. N. Marini-Maio, A Very Seductive Body Politic. Silvio Berlusconi in Cinema, Mimesis International, Milano 2015.
135 N. Marini-Maio, Non confesso, dunque sono. “Il Divo” di Paolo Sorrentino, in Strane storie, a cura di C. Uva, cit., p. 140.
218 Lessico del cinema italiano
in ambito storiografi co, un’indagine relativa a tale stagione «larga-mente condizionata dalla memoria. Dapprima, quella debordante degli ex terroristi – in larga parte appartenenti ai gruppi armati di sinistra, mentre più rare sono le memorie dei neofascisti – e solo recentemente quella delle vittime della violenza terroristica»136.
Sono esemplifi cativi in tal senso due fi lm che, tra anni novan-ta e duemila, hanno continuato a riarticolare il racconto di tale epoca: La seconda volta (1995) di Mimmo Calopresti, ispirato al libro-diario Colpo alla nuca di Sergio Lenci, vittima nel 1980 di un attentato compiuto dalla formazione armata rivoluzionaria Prima Linea, e La prima linea (2009) di Renato De Maria, tratto dal libro di memorie Miccia corta di Sergio Segio, fondatore di quel medesimo gruppo. In tutti e due i casi domina uno sguardo algido che, producendo un senso di distanziamento dalla storia di quegli anni, torna a rivolgere l’attenzione al concetto di memoria. Memoria che, soprattutto nella prospettiva del rapporto tra vitti-me e carnefi ci, appare quanto mai non riconciliabile, indice di un «passato che non passa»137 e pertanto motivo di ulteriore frattura in un’identità nazionale già congenitamente scissa e problematica.
È su questo periodo che il cinema italiano, soprattutto a parti-re dagli anni novanta, mantiene ferma l’attenzione, considerando “Piazza Fontana” e il “caso Moro” i due termini, a quo e ad quem, tra cui racchiudere la narrazione di una delle stagioni più diƥ cili della storia repubblicana. La strage del 12 dicembre 1969 e il se-questro e l’omicidio nella primavera del 1978 dell’allora presidente della Democrazia Cristiana, cui si aggiunge (almeno in un caso) l’altrettanto oscura vicenda della strage di Bologna, si confermano i tòpoi nei quali si sintetizza la complessità di tale periodo storico interpretato da tutta una linea di esempi fi lmici in termini di ro-manzo: sono ascrivibili a tale territorio, per motivi diversi, i due romanzi fi rmati da Michele Placido e da Marco Tullio Giordana (rispettivamente Romanzo criminale del 2005 e Romanzo di una
136 G. Panvini, La sfi da al labirinto. Narrazione cinematografi ca e interpreta-zione storica di fronte al «mistero» della violenza, in C. Uva, Schermi di piombo. Il terrorismo nel cinema italiano, Rubbettino, Soveria Mannelli 2007, p. 189.
137 Cfr. C. O’Rawe, «Un passato che non passa»: “La prima linea” e il ritorno agli anni Settanta, in “Bianco e Nero”, n. 1 (2012).
Storia Christian Uva 219
strage del 2012), ma anche la saga cinetelevisiva di La meglio gio-ventù (2003), diretta dallo stesso Giordana.
Aơ rontando l’epopea criminale della “peggio gioventù” della Banda
della Magliana, quello di Placido è a suo modo un romanzo di forma-
zione e di amicizia nel quale il rapporto con la storia si conferma par-
ticolarmente critico. Se da una parte essa torna infatti ad assumere,
nella sua conformazione di concatenazione incontrollabile di misteri,
l’aspetto inconoscibile e ultraterreno tipico del thriller politico italia-
no, dall’altra il regista sembra volersi fare forte della stessa tecnologia
cinematografi ca per tentare di “domare” quella materia, forzandola
in direzione di una versione dei fatti puntellata sull’impiego strumen-
tale di immagini camuơ ate digitalmente come se fossero d’archivio.
Ciò è particolarmente evidente nella scena chiave della strage alla
stazione di Bologna, occasione in cui, dopo aver ricostruito digital-
mente – con un macroscopico (voluto?) errore storico – l’esplosione
dell’ala “sbagliata” dell’edifi cio (la destra invece della sinistra), il regi-
sta mostra la fi gura del “Freddo” (ispirata al boss malavitoso Maurizio
Abatino) che vaga tra le macerie.
In questo caso il personaggio di fi nzione (nelle fattezze dell’attore
Kim Rossi Stuart) appare “intarsiato” nel fondale della Storia, rap-
presentato dal fi nto found footage dei detriti e delle vittime provo-
cati dalla defl agrazione. La natura manipolatoria di un simile proce-
dimento, evocando i precedenti di Forrest Gump (Zemeckis, 1994) e
ancora prima (in era predigitale) di Zelig (Allen, 1983), si pone così in
sintonia con una concezione del cinema quale medium di riscrittura
del passato che ora quanto mai «rifi uta la storia nel senso tradiziona-
le, legato ai concetti di origine, autenticità e documentazione»138.
Bildungsroman generazionale è anche e soprattutto La meglio gioventù di Giordana in cui la consonanza tra i moti intimi della
giovinezza e lo spirito del tempo e del Paese si incanalano nuova-
138 R. Burgoyne, Memory, History and Digital Imagery in Contemporary Film, in
Memory and Popular Film, edited by P. Grainge, Manchester University Press,
Manchester-New York 2003, p. 223. Un’analoga metodologia è stata adottata più
di recente anche da Pif (Pierfrancesco Diliberto) in La mafi a uccide solo d’estate
(2013), in cui il protagonista, proprio sul modello di Forrest Gump, viene inserito
tramite compositing digitale prima, da bambino, nelle autentiche immagini di
repertorio dei funerali del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e poi, da adulto,
in quelle delle proteste dei siciliani esclusi dalle esequie del giudice Giovanni
Falcone.
220 Lessico del cinema italiano
mente nella direttrice nostalgica, intesa proprio come “nostalgia della Storia”139, che invece è assente in Romanzo di una strage, de-dicato ai fatti del 12 dicembre ’69.
Proprio come nella raccolta di poesie di Pasolini da cui il regista prende in prestito il titolo140 della sua produzione cinetelevisiva, succede insomma che tra quest’ultima e Romanzo di una strage il lirismo ceda il passo a una prosa in cui, nelle intenzioni di Giorda-na, la storia cessa di essere l’”oggetto mancato” per acquisire i con-torni più netti di un territorio su cui esercitare il diritto di sapere.
Anche nel fi lm dedicato alla strage di Piazza Fontana è Pasolini il riferimento alto, qui però quello dell’«Io so. Ma non ho le pro-ve» del famoso articolo del 1974 su cui l’intellettuale fondava il suo «progetto di romanzo» (echeggiato da Giordana, ancora una volta, nel titolo del suo fi lm141), tornando a problematizzare, in un’ottica di impegno civile, la manzoniana questione del rapporto tra Sto-ria-Verità e Racconto-Finzione.
È proprio quell’«Io so» che Giordana intende recuperare e riat-tualizzare nel suo Romanzo di una strage, rivendicando l’esistenza di una verità («La verità esiste» è proprio la frase-slogan presente sulla locandina del fi lm) che certo cinema italiano del nuovo mil-lennio vuole programmaticamente contrapporre ad ogni forma di scetticismo. Lo dimostra, sempre nel 2012, anche Diaz di Daniele Vicari, incentrato sulla scrupolosa ricostruzione degli eventi che condussero al massacro da parte della polizia delle persone ospita-te dall’omonima scuola adibita a dormitorio, sede del media center e dell’assistenza legale nei giorni dell’anti-G8 di Genova 2001.
Nuove strategie dell’attenzione
Non è casuale che proprio da quest’anno spartiacque un cineasta come Vicari, tra i registi-simbolo del “nuovo” cinema italiano, ab-bia deciso di ripartire. I fatti di Genova del luglio 2001 anticipano infatti di neanche due mesi un altro evento cruciale, questa volta
139 Cfr. E. Morreale, L’invenzione della nostalgia, cit., p. 220.140 Cfr. P.P. Pasolini, La meglio gioventù, Sansoni, Firenze 1954.141 Il romanzo delle stragi è il titolo dell’articolo (originariamente Che cos’è
questo golpe?) pubblicato da Pasolini sul “Corriere della Sera” il 14 novem-bre 1974.
Storia Christian Uva 221
su scala planetaria, come l’attentato dell’11 settembre a New York, ovvero l’avvenimento che secondo qualcuno ha sancito «la fi ne del postmoderno»142 e dunque l’esaurimento del paradigma stesso, reso celebre da Francis Fukuyama, della «fi ne della Storia»143.
Lo conferma Giovanna Taviani, esponente della medesima ge-nerazione di Vicari aơ acciatasi alla ribalta alle soglie del nuovo millennio, quando aơ erma:
Le stragi della seconda Guerra del Golfo e delle Torri Gemelle hanno smascherato la falsa ideologia postmodernista della fi ne della storia e hanno riportato alla luce, con violenza, le contraddizioni del mondo. Credo che i registi […] quasi tutti esordienti dopo il 2001, in-tendano ripartire proprio da qui, da questo mutamento di scenario144.
Il cinema italiano contemporaneo dimostra così di dividersi, an-che in base ad una discriminante generazionale, tra il bisogno di lucidità, puntualità, nitidezza, attenzione145 con cui vuole tentare di rifondare un rapporto solido con la storia declinato soprattutto sull’attualità (istanza alla base della rinascita dello stesso “cinema del reale”), e l’irrinunciabile propensione a gettare lo sguardo più in là, verso un tempo più lontano ma pur sempre vicino che invece in-tende recuperare in una forma “umanizzata”, depurata cioè da qual-siasi esattezza o fedeltà, e quindi riconfi gurata in una dimensione fortemente soggettiva dominata dal dispiegamento dell’immagina-zione e dal libero arbitrio nei confronti della storia medesima.
Nel primo caso si potrebbe dire che la storia venga ricercata in quelle che Kracauer defi niva le «storie spontanee […presenti] nel
142 Cfr. ad es. R. Luperini, La fi ne del postmoderno, Guida, Napoli 2005.143 Cfr. F. Fukuyama, La fi ne della storia e l’ultimo uomo, BUR, Milano 1996
[ed. or. The End of History and the Last Man, Free Press, New York 1992].144 G. Taviani, La carica dei trentenni, in La meglio gioventù. Nuovo Cinema
Italiano 2000-2006, a cura di V. Zagarrio, Marsilio, Venezia 2006, p. 110.145 «Cinema dell’attenzione» è la formula con cui un’altra rappresentante
della nuova generazione di registi, Costanza Quatriglio, defi nisce una pro-duzione «capace di raccogliere le istanze di comprensione del presente, di cittadinanza, di partecipazione», C. Quatriglio, Oltre la soglia. La nuova radice del cinema italiano, in “Cinema e Storia. Rivista di studi interdisci-plinari”, n. 1 (2013), p. 209.
222 Lessico del cinema italiano
materiale oơ erto dalla realtà fi sica»146. Si tratta cioè dei fatti e degli eventi che trovano innanzitutto nel documentario, anche grazie alle potenzialità della tecnologia digitale di ripresa, la nuova occa-sione per rivolgere al mondo una «domanda di senso»147.
La generazione di cineasti cresciuta «negli anni del pensiero uni-co, dello “sciopero degli eventi” senza storia né confl itti»148 (da Fran-cesco Munzi a Vincenzo Marra, da Saverio Costanzo a Emanuele Crialese fi no a Matteo Garrone e allo stesso Vicari), a maggior ragio-ne quando si misura con la cosiddetta fi ction, sembra così rivendica-re l’urgenza di un “ritorno alla storia” che tuttavia, invece di assume-re una declinazione retrospettiva, appare improntato alla volontà di fare i conti con le contraddizioni e le criticità della propria epoca, con i “pensieri” molteplici e diversifi cati che ora la attraversano (una delle questioni nevralgiche aơ rontate dal cinema italiano contem-poraneo è quella dell’immigrazione e del rapporto con l’“altro”).
Riconducendo pertanto la storia «al livello della vita quotidiana e dando alla vita quotidiana delle prospettive storiche», tale diret-trice espressiva e politica dimostra una volta di più come, tra le pe-culiarità del cinema, vi sia quella di «unire nel modo più naturale l’evoluzione storica e i drammi individuali», confermando come la storicità non consista «obbligatoriamente nell’evocare i tempi passati, nell’esprimersi “al passato”, ma piuttosto nell’esprimere questo nuovo rapporto tra universo e individuo»149.
Per quanto riguarda invece la linea di un recupero immaginifi co della storia trascorsa, tranne rari casi150, nei medesimi anni si se-gnala perlopiù l’opera di una diversa generazione di cineasti.
146 S. Kracauer, Teoria del fi lm, Il Saggiatore, Milano 1995, p. 363 [ed. or. The-ory of Film. The Redemption of Physical Reality, Oxford University Press, New York 1960].
147 R. De Gaetano, Prefazione. L’immagine documentaria come domanda di senso, in Per un cinema del reale. Forme e pratiche del documentario italia-no contemporaneo, a cura di D. Dottorini, Forum, Udine 2013, p. 10.
148 G. Taviani, La carica dei trentenni, cit., pp. 109-110.149 Y. Biro, Il fi lm storico e i suoi aspetti moderni, in La storia al cinema. Ricostruzio-
ne del passato, interpretazione del presente, a cura di G. Miro Gori, cit., p. 22.150 Si vedano ad esempio le incursioni di stampo vintage e romanzesco negli
anni della “guerra fredda” e degli ultimi sussulti della lotta armata presen-ti, rispettivamente, in Cosmonauta (2009) e La scoperta dell’alba (2012) di Susanna Nicchiarelli.
Storia Christian Uva 223
Ne è una prova La vita è bella (1997) di Roberto Benigni, fi lm che rappresenta uno spartiacque nella rappresentazione della Shoah, di fronte alla cui indicibilità e irrappresentabilità il regista-attore sceglie la strada di un mondo che si fa favola, e di conseguenza una visione palesemente inverosimile e antistorica degli eventi.
L’esempio di Benigni, anche in ragione delle aspre divisioni susci-tate all’epoca tra detrattori e sostenitori e quindi del vivace dibattito pubblico derivato, travalica d’altronde i confi ni del cinema qualifi -candosi come oggetto culturale che partecipa in maniera decisiva alla costruzione di un immaginario storico fondato, una volta di più, sulla riattualizzazione di una memoria dominante dell’Italia repub-blicana, quella incentrata sul mito del “bravo italiano” e sulla ricon-versione di un Paese fascista in uno antifascista151.
Pur su tutt’altro piano, parimenti “sacrilego” è l’atteggiamento verso la storia assunto da Marco Bellocchio col suo Buongiorno, notte (2003), nel quale il topos dell’aơ aire Moro costituisce il principale catalizzatore di una serie di reazioni in cui l’immaginazione, facendosi intermedia-le152, attiva una rifl essione sul senso della storia che è al tempo stesso un’ennesima messa in questione del dispositivo cinematografi co.
Buongiorno, notte è fi lm memoriale all’ennesima potenza visto che, oltre a sfruttare celebri brani delle lettere di Moro, trae spunto da Il prigioniero, il libro-diario scritto dalla ex brigatista Anna Laura Braghetti con la collaborazione della giornalista Paola Tavella. Le pa-gine di quest’ultimo vengono interpretate da Bellocchio come quelle di un romanzo autobiografi co fondato su un fl usso di coscienza che mescola l’assunzione privata dei fatti con la loro risonanza pubblica.
Ne deriva un apparato fi lmico costruito sulla stratifi cazione di una serie variegata di piani dell’espressione che va dal livello pura-mente informativo a quello simbolico, determinando una sovrap-posizione di regimi della rappresentazione in cui ha buon gioco l’impiego libero di materiali di repertorio eterogenei.
Da una parte spiccano così le immagini televisive dell’epoca, come i telegiornali ma anche gli show d’intrattenimento con per-sonaggi popolari come Raơ aella Carrà o Enrico Montesano, cui si
151 Cfr. G. Lichtner, La vita è bella (ad Auschwitz): luogo della memoria e dell’amne-sia, in “Cinema e Storia. Rivista di studi interdisciplinari”, n. 1 (2013), pp. 73-74.
152 Cfr. P. Montani, L’immaginazione intermediale. Perlustrare, rifi gurare, te-stimoniare il mondo visibile, Laterza, Roma-Bari 2010.
224 Lessico del cinema italiano
contrappuntano nel fi nale del fi lm, in funzione grottesca, i primi piani degli uomini politici alla messa in suơ ragio di Moro: tutti «“lieux de mémoire” elettronici o audiovisivi»153 che confermano la scelta narrativa ed estetica, comune a molte opere sugli “anni di piombo”, di «enfatizzare la natura già mediatizzata di quegli even-ti» (come a dire che la memoria dell’accadimento è televisiva fi n dal momento stesso in cui ha luogo154).
Su un altro piano si profi lano i frammenti di opere simbolo della storia del cinema, come Tre canti su Lenin (1934) di Dziga Vertov o Paisà di Rossellini o, ancora, schegge d’archivio. Materiali che nel personale “montaggio delle attrazioni” operato da Bellocchio culminano nella sequenza dell’allucinazione mentale della prota-gonista, in cui si alternano le immagini di Moro nella “prigione del popolo” con quelle dei condannati a morte della Resistenza, men-tre la voice over di Roberto Herlitzka legge una delle lettere più commoventi indirizzate dallo statista democristiano alla moglie, lasciando poi che The Great Gig in the Sky dei Pink Floyd prenda il sopravvento.
È il cuore dell’immaginario politico quale fu fantasticato «dai militanti delle Brigate Rosse e che il fi lm presenta come un re-pertorio di immagini identitarie che li motiva, come un “sentire comune” e una memoria condivisa che li sostiene nei momenti diƥ cili»155.
Tutto ciò si condensa nella vera e propria eversione dalla storia, nuovamente di matrice onirica, rappresentata dalla scena in cui il prigioniero riconquista la libertà, riassaporando felice la lieve aria di un’alba romana. È fi nalmente il trionfo della sessantottesca im-maginazione al potere che si sostanzia in un vero e proprio rifi uto
153 R. Burgoyne, Memory, History and Digital Imagery in Contemporary Film, cit., p. 225. L’autore a sua volta riprende la nozione di lieux de mémoire elaborata da Pierre Nora in Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire, in “Representations”, n. 26 (1989).
154 C. O’Rawe, «Un passato che non passa»: “La prima linea” e il ritorno agli anni Settanta, cit., p. 100. Tale rifl essione a sua volta poggia su una conce-zione dei media audiovisivi quali strumenti cruciali nella costruzione di quella che Alison Landsberg ha defi nito una “memoria prostetica” («pro-sthetic memory»). Cfr. A. Landsberg, Prosthetic Memory. The Transfor-mation of American Remembrance in the Age of Mass Culture, Columbia University Press, New York 2004.
155 P. Montani, L’immaginazione intermediale, cit., p. 30.
Storia Christian Uva 225
del “ricatto” della storia attuato tramite una ribellione nei confron-ti della sua «fatalità religiosa»156.
Inverando l’aơ ermazione di Marc Ferro secondo cui «l’immagi-nario è storia tanto quanto la storia»157, Bellocchio insomma fa sì che il cinema e la televisione, quali elementi portanti dell’imma-ginario del Novecento, si facciano tutt’uno con la storia tout court in una progressiva (con)fusione di piani capace di attivare un pro-fi cuo dialogo tra storiografi a e narrazione.
È il medesimo principio seguito dal regista in un altro suo fi lm storico del nuovo millennio, Vincere (2009), nel quale le vicen-de riguardanti l’amore tormentato e non corrisposto di Ida Dalser verso un giovane Benito Mussolini sono nuovamente l’occasione per attivare un dispositivo intermediale in cui il ruolo del materia-le di repertorio appare ancora più decisivo visto che proprio ai mo-delli da esso veicolati si conformano i comportamenti e le passioni degli stessi personaggi storici rappresentati.
L’elemento tragicamente passionale, insieme ai rimandi all’ope-ra lirica, fanno di Vincere una sorta di aggiornamento della grande tradizione del melodramma storico, confermando il superamento, già operato in Buongiorno, notte, «di ogni utilizzo strettamente illustrativo dei materiali d’archivio […] che spinge a pensare il fi lm stesso come luogo di rimontaggio e diagnosi critica dei discorsi sociali attraverso i quali gli eventi storici sono stati costruiti e me-diaticamente condivisi all’interno di una società»158.
Tale processo ottiene una sua precisa messa in forma visiva nel peculiare impiego di elementi testuali sovrimpressi sul materia-le d’archivio. Si tratta di didascalie che, richiamando le pratiche del futurismo marinettista e del cinema sovietico d’avanguardia, si impongono grafi camente e contenutisticamente evocando nello spettatore l’epoca raccontata mediante alcune sue parole d’ordine, compiendo al tempo stesso, per via dell’uso arbitrario fattone dal
156 M. Bellocchio, in P. Mereghetti, Buongiorno, notte, in Marco Bellocchio. Il cinema e i fi lm, a cura di A. Aprà, Marsilio, Venezia 2005, p. 220.
157 M. Ferro, Cinema e storia. Linee per una ricerca, Feltrinelli, Milano 1980, p. 90 [ed. or. Cinéma et histoire. Le cinéma, agent et source de l’histoire, Denoël, Paris 1976].
158 F. Zucconi, Il fi lm, la storia e l’archivio delle immagini. Montaggio interte-stuale e semiotica della cultura, in En torno a la semiótica de la cultura, Actas del I Congreso Internacional del GESC, Fragua, Madrid 2012, p. 71.
226 Lessico del cinema italiano
regista, un atto di “violazione” nei confronti degli stessi frammenti di repertorio in cui è depositata una certa memoria nazionale.
Ancora una volta, insomma,
proprio perché risulta diƥ cile distinguere la loro dimensione stori-ca da quella astorica, prettamente estetica, la nuova vita delle imma-gini dispiega eơ etti di senso congiuntamente mostrativi e narrativi. Come se Bellocchio le “liberasse”, per impedire a chicchessia di inter-narle nel recinto di una sola Storia159.
Siamo un’altra volta di fronte all’esuberanza, alla complessità, alla sovradeterminazione160 delle immagini sulle quali, secondo Didi-Huberman, si fonda il loro connaturato anacronismo.
Siamo, cioè, nuovamente in presenza di quell’archeologica stra-tifi cazione in cui, come testimonia la paradigmatica scena di Noi credevamo citata in apertura di questo testo (ma anche tanti altri esempi fi lmici di oggi e di ieri), sembra sintetizzarsi l’antinomico statuto della stessa identità italiana. Ovvero l’aơ annoso quanto vano tentativo di recuperare una tradizione ma, nel contempo, lo specifi co proposito di aprire verso il futuro il passato nazionale, anche se questo assume le fattezze del racconto di un fallimento, come confermano le parole dello stesso Martone riguardo alla sua opera: «Il titolo ci dice che il fi lm è il racconto di una sconfi tta, e non c’è dubbio che Noi credevamo sia un fi lm tragico. Ma quan-do dico tragico, intendo anche catartico, vorrei cioè che desse una spinta all’azione. Il punto non è che tutto è fi nito, il problema è che tutto è da cominciare»161.
Filmografi a di riferimento
La presa di Roma (Alberini, 1905), Cabiria (Pastrone, 1914), Gli uomini, che mascalzoni... (Camerini, 1932), 1860 (Blasetti, 1934), Roma città aperta (Rossellini, 1945), Ladri di biciclette (De Sica,
159 M. Bertozzi, L’archivio di Bellocchio, in “Bianco e Nero”, n. 576-577 (2013), p. 152.
160 G. Didi-Huberman, Storia dell’arte e anacronismo delle immagini, cit., p. 18.
161 M. Martone, Noi credevamo, cit., p. LV.
Storia Christian Uva 227
1948), La grande guerra (Monicelli, 1959), Tutti a casa (Comenci-ni, 1960), Il sorpasso (Risi, 1962), Salvatore Giuliano (Rosi, 1962), Il gattopardo (Visconti, 1963), Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (Petri, 1970), Giù la testa (Leone, 1971), La polizia ringrazia (Vanzina, 1972), Roma (Fellini, 1972), C’eravamo tan-to amati (Scola, 1974), Salò o le 120 giornate di Sodoma (Pasoli-ni, 1975), Novecento (Bertolucci, 1976), La notte di San Lorenzo (Taviani, 1982), Colpire al cuore (Amelio, 1982), Vacanze di Nata-le (Vanzina, 1983), Palombella rossa (Moretti, 1989), Buongiorno, notte (Bellocchio, 2003), Il divo (Sorrentino, 2008), Noi credevamo (Martone, 2010).