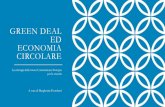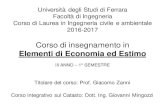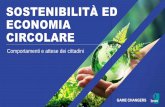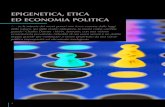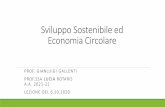cultura ed economia
Transcript of cultura ed economia

Cultura ed economia in Italia Un connubio difficile
Antonello E. Scorcu
Marzo 2012

Economia della cultura, dell’arte e della creatività
• Cultura come bene d’investimento • Cultura come bene di consumo

Cultura (arte, creatività) come bene d’investimento
• E’ tipico della tradizione anglosassone: capitale umano come fattore produttivo, non diverso dal capitale fisico: accumulazione di conoscenze volta ad accrescere la produttività individuale (e, tramite esternalità positive, la produttività di sistema). – Woessmann: il decollo economico delle aree luterane è dovuto a una
literacy rate elevata (il fedele deve poter leggere autonomamente le scritture) e non solo all’etica protestante (approccio pragmatico nell’utilizzo delle conoscenze).
– Lo stesso Grand Tour era considerato un viaggio di istruzione (con precettori, o taccuini di viaggio) piuttosto che un viaggio di piacere (e le valutazioni della Roma del ‘700° del primo ‘800 erano anche piuttosto dure, per la scarsa industriosità degli abitanti).
• L’acculturazione non è fine a se stessa ma è investimento (rinuncia al consumo) per potere consumare maggiormente in futuro.
• Rientrano in questa ottica i lavori su crescita e stock di capitale umano: – Istruzione (lettura) e crescita economica: Barro & Lee, Gaffeo & Scorcu – Stock di capitale creativo e crescita: Florida e la “classe creativa”.

Cultura (arte, creatività) come bene d’investimento
• Effetti diretti privilegiati dall’analisi iniziale sui processi di crescita
• Altrettanto importanti sembrano essere gli effetti indiretti.
• Un maggiore stock di cultura disseminato all’interno di una collettività si associa a maggior “trust”, atteggiamento cooperativo, rispetto delle leggi e delle consuetudini, capitale sociale.
• Tutti i precedenti elementi contribuiscono a rendere migliore lavita (spirituale e) materiale delle persone.

Cultura (arte, creatività) come bene di consumo
• “La cultura non si mangia” (Tremonti). Approccio fuorviante: nemmeno i programmi televisivi si mangiano (ma per questi il problema non è stato posto in questi termini
• RIflesso (involontario?) della distinzione tra otium e negotium?
• Tuttavia entrambi I beni di consumo hanno dietro settori produttivi (e possono dare da mangiare a molti).
• Perchè dovrebbe essere più accettabile un modello di sviluppo basato sul consumo (e la produzione) di beni materiali o di alcuni beni piuttosto che di altri?

Cultura (arte, creatività) come bene di consumo
• Al contrario, siamo nella “società della conoscenza” e questo significa anche che la maggior parte dei consumi (e quindi delle produzioni) riguardano i servizi. Perchè dovrebbe essere “ragionevole” il consumo di telefonia mobile o di pay per view e non la visita a un museo?
• Approccio italiano ideologizzato al sistema culturale: la cultura è altro rispetto al sistema economico. Cultura ed economia sono sfere separate. Da un punto di vista “culturale” introdurre l’economia è introdurre lo sterco del diavolo; da un punto di vista economico, la cultura è vista solo come elemento che assorbe risorse.
• Nella realtà molti paesi (p.e. la Francia) hanno fatto del consumo della cultura uno dei capisaldi del loro sviluppo economico.

Cultura (arte, creatività) come bene di consumo
• La cultura è un marchio, uno stile di vita che caratterizza una società, un luogo, una nazione.
• Nel caso dell’Italia il marchio “Cultura italiana” è fortissimo.

La cultura in Italia • In Italia la cultura è “altro” rispetto al sistema economico
per ragioni ideologiche, non perchè debba essere necessariamente così, sia per quanto riguarda la cultura come investimento, sia come consumo.
• La cultura come investimento: serve poco perchè il mix produttivo è su una conoscenza “artigianale”, che non richiede studi ma un sapere fare “con le mani” piuttosto che con la testa.
• La cultura come consumo: il peso della storia passata è (per nostra fortuna) assolutamente straodinario. Ma non riusciamo a gestire questo passato; ci si limita a (cercare di) mantenere ed a riprodurre il passato nel presente.

La cultura come investimento, in Italia. Esempi
• Qual è il valore di una laurea? In termini di incremento di salario rispetto a un non laureato, il valore di una laurea in Italia è inferiore a quello della maggiore parte dei paesi EU. Inoltre, anche una laurea in questo momento non offre particolari sicurezze rispetto alla probabilità di trovare una occupazione dati AlmaLaurea). Non deve quindi sorprendere che la quota di popolazione italiana laureata sia più bassa rispetto a quella della maggior parte dei paesi UE (e certamente più bassa rispetto a quella dei nostri competitors).
• Analoghe considerazioni porebbero essere fatte (con minore nettezza, peraltro) anche rispetto alla scuola media superiore.
• Negli USA le scuole e le università private di norma assicurano un livello di istruzione superiore a quello del sistema pubblico. In Italia (con qualche mai abbastanza frequente eccezione) il sistema di istruzione privato, al contrario è quello che assicura un “recupero anni” per studenti poco motivati. Come dire che la domanda di mercato non regolata dal settore pubblico, non è per un livello maggiore di cultura, ma piuttosto minore.

La cultura come investimento, in Italia. Esempi
• Anche a livello pubblico, il processo di accumulazione della cultura tende a un equilibrio a basso livello (bassi stipendi, bassa considerazione sociale e basso impegn per gli insegnanti, bassi stipendi offerti e basse condizioni di lavoro da parte della PA, basso impegno per gli studenti e basse richiesta da parte delle famiglie).
• In Italia abbiamo il numero maggiore di telefoni cellulari pro capite, ma si legge poco (pochi libri, pochi quotidiani). Gli stessi professionisti (medici, ingegneri, avvocati,…), che dovrebbero tenersi aggiornati costantemente, leggono per aggiornamento professionale in poco più della metà dei casi (contro circa l’80-90% di Francia e Germania).

La cultura come investimento, in Italia. Possibili spiegazioni
• Si afferma che viviamo nella società della conoscenza. In Italia si tende ad accumulare e a non utilizzare la conoscenza accumulata. Forse una delle cause dei ritardi della nazione è da ritrovarsi in questo.
• Storicamente: in Italia scarsità di materie prime, di lavoro qualificato e di capitali finanziari. Quindi ha operato con successo (fino agli anni ’80) un modello di sviluppo progressivamente basato sul “made in Italy”, produzioni di abbigliamento, calzature, meccanica leggera di precisione, autovetture di fascia bassa (Agnelli: Fiat e VW come I e D). Per la produzione del made in Italy erano richiesti limitati conoscenze tecnologiche, capitali umani e finanziari.

La cultura come investimento, in Italia. Possibili spiegazioni
• La storia dello sviluppo italiano è stata una storia di assoluto successo fino a che è stato possibile seguire traiettorie tecnologiche e organizzative già tracciate in precedenze (catching up).
• E’ mancata una propria autonoma elaborazione di un modello di sviluppo (anche in UE, ma in termini meno netti) nel momento in cui il catching up non è stato più possibile.
• In Italia si è mantenuto un modello basato sulla piccola impresa, sulle conoscenze “manuali”, sul familismo piuttosto che sul merito.
• In altri termini, in Italia, il mercato della conoscenza (cultura come investimento) è asfittico e funziona male (fuga dei cervelli, raccomandazioni,…). Siamo ancora alle corporazioni in cui un mestiere privilegiato tende a essere ereditato di generazione in generazione.

La cultura come bene di consumo, in Italia. Esempi
• Il bene culturale è valutato secondo un approccio nazionale patrimoniale (in altre nazioni l’approccio è minerario o cosmopolita). Questo approccio ha alcuni vantaggi ma anche alcuni svantaggi.
• Il “tesoro” è patrimonio della nazione e non può essere alienato o trasformato. Quindi la conservazione prevale sulla trasformazione.
• La Fenice: dov’era, com’era. Ma lo stesso vale per gli edifici. Storicizzazione “automatica”, tramite notifica, vincoli delle Soprintendenze, automatici o quasi dopo un certo numero di anni.
• Atteggiamento “punitivo” che vincola (spazio sempre minore, costi sempre maggiori – è un integrale!). La rigidità nell’approccio è il riflesso delle spoliazioni e delle distruzioni passate (dovute a scarsa consapevolezza), ma non consente mediazioni, per uno sfruttamento economico.

La cultura come bene di consumo, in Italia. Esempi
• Il bene culturale non è bene economico (per lo Stato), mentre lo è per il singolo cittadino, e questo crea un conflitto d’interessi. E’ un problema dello Stato, che non riesce a fare partecipi I cittadini dei suoi obiettivi; è un problema del cittadino, che non riesce a rapportarsi con lo Stato.
• Inoltre, dal punto di vista pubblico, non essendo considerato un bene economico, il bene culturale “costa” ma non rende. Ma in una fase di forti vincoli di spesa, non si fanno investimenti (che non frutterebbero, nell’ottica che si è adottata) e molte cose vanno in malora.
• In passato incuria per chiese di campagna (depredate, non restaurate e lasciate andare lentamente in rovina senza che nessuno se ne preoccupazze). Attualmente il processo di degrado è significativo anche per le “superstar” come Pompei e la Basilica di San Antonio a Padova.

La cultura come bene di consumo, in Italia. Possibili spiegazioni
• Spiegazioni analoghe a quelle dell’investimento in cultura.
• In Italia, la cultura non si mangia! (e siccome si conosce poco il mercato, non ci si accorge che può dare da mangiare)

• Immagine san marino patrimonio dell’umanità

La cultura come bene di consumo, in Italia. Esempi
• Musei che non hanno vere “temporanee”, a differenza di molti musei superstar di altre nazioni. Gestione rigida della collezione.
• Nel corso del tempo la storicizzazione (ma anche l’obsolescenza) sono processi che richiedono tempi sempre minori. La Storia si crea in pochi decenni: gli impressionisti erano già storicizzati in 30-40 anni; lo stesso per l’Espressionismo Astratto americano oppure per la Pop Art.
• Distinzione netta tra la sfera culturale (di pertinenza pubblica) e la gestione degli aspetti commerciali della cultura (da lasciare ai privati). Nel contempo, quando mancano i fondi, ci si rivolge al privato.

La cultura come bene di consumo, in Italia. Possibili spiegazioni
• Sgarbi: in Italia, dopo il Barocco nella pittura non è stato fatto niente di interessante.
• Ovviamente è una provocazione e come tale deve essere considerata. Tuttavia anche in questa provocazione emerge una piccola verità: il peso della storia è talmente importante che in Italia si tende a guardare all’indietro piuttosto che avanti (e forse anche perchè all’interno della nazione vi è una qualche inadeguatezza culturale).
• Incapacità ideologica di considerare la cultura come un bene economico (di consumo, ma senza che questo comporti il suo degrado) – Lo stesso atteggiamento emerge nel caso dei partiti “verdi”, in
cui si cerca di vietare tutto (anche una strada “indispensabile”).

Complementarietà tra cultura sfera culturale ed economica
• La complementarietà tra sfera culturale ed economica è possibile! • In molte nazioni questa sintesi è stata raggiunta. • La cultura non è un bene economico come gli altri; non è come un
giacimento petrolifero, da sfruttare in modo ottimale nel corso del tempo, fino all’esaurimento delle risorse.
• La cultura non è solo una testimonianza materiale del passato (“morta”) ma deve dare valori, stimoli, opportunità di miglioramento personale.
• La cultura ha quindi una dimensione economica, e deve (e ci riesce!) pagarsi, altrimenti diviene un peso morto, sia nel bilancio pubblico (governo, regioni,…) sia nella valutazione privata (che invece altrimenti la vede come elemento da sfruttare e basta)
• Un approccio non ideologico permette di valorizzare appieno la cultura (dal museo, all’istruzione)