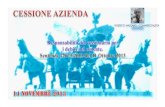Continuità aziendale e moratoria per i debiti delle piccole e medie imprese
-
Upload
giulio-tagliavini -
Category
Documents
-
view
1.351 -
download
2
description
Transcript of Continuità aziendale e moratoria per i debiti delle piccole e medie imprese

BEATRICE RONCHINI: Università di Parma, Dipartimento diEconomia. GIULIO TAGLIAVINI: Università di Parma, Dipartimento diEconomia.I due autori hanno discusso e sviluppato congiuntamenteogni contenuto. Ai fini editoriali, i paragrafi 1 e 4 sonostati redatti congiuntamente. Il paragrafo 2 è stato redattoda Beatrice Ronchini; il paragrafo 3 è stato redatto daGiulio Tagliavini.
1. PREMESSA
“ Le banche sono determinanti per rendere la crisiche stiamo affrontando più o meno duratura, più omeno profonda”1. Questa valutazione del Gover-natore Mario Draghi è saggia e si pone in opposi-zione a coloro che ritengono una politica restritti-va del credito come causa delle difficoltà delle im-prese, ma anche in opposizione a coloro che pen-sano ne sia la conseguenza.Con l’espressione “moratoria sul debito” si fausualmente riferimento all’“Avviso comune” de-finito nell’estate del corrente anno e sottoscrittodal Ministro dell’Economia e delle Finanze, dal-l’ABI e da 13 associazioni rappresentative delmondo dell’impresa industriale e commerciale2.Questo Avviso è entrato in vigore il 3 agosto. Ifirmatari dell’accordo si sono impegnati anche amonitorare l’andamento dell’iniziativa nel corsodel tempo. Essa mira a supportare le piccole emedie imprese che affrontano un contesto ma-croeconomico assai perturbato e potenzialmentein grado di mettere in dubbio la continuazionedell’attività di numerose aziende. L’obiettivoperseguito è quello di rendere la crisi meno dura-tura, meno profonda.La moratoria utilizza lo strumento operativo diprorogare i termini di rimborso di una gamma dioperazioni finanziarie molto ampia, a breve e amedio-lungo termine. Queste operazioni sonotoccate dalla proroga in modo diverso, a secon-da delle loro caratteristiche. Gli aspetti di detta-glio sono importanti e certamente definisconoun aiuto alla gestione finanziaria di imprese sa-ne, ma finanziariamente affaticate in conseguen-
S O M M A R I O
1. PREMESSA
2. IL PROVVEDIMENTO
3. IMPERATIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO ERILEVANZA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE
4. CONCLUSIONI
S A G G I 417BANCHE E BANCHIERI n. 6 2009
CONTINUITÀ AZIENDALE E MORATORIA PER I DEBITI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESEBEATRICE RONCHINI e GIULIO TAGLIAVINI
1. ABI (2009), Assemblea Ordinaria, Intervento del Go-vernatore della Banca d’Italia Mario Draghi, Roma, 8luglio.2. Il testo integrale dell’“Avviso comune per la sospen-sione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il si-stema creditizio” è reperibile sul sito web del MEF.
06_01_Saggio_Tavaglini.qxd:05_01_Saggio_Malinconico 6-01-2010 10:36 Pagina 417

za dei problemi sistemici. È opportuno com-mentare l’“Avviso comune” in modo da metterein evidenza gli aspetti più complessi che ne ca-ratterizzano l’applicazione. Un’analisi dei di-versi punti che qualificano il provvedimento indiscorso può consentire di azzardare una previ-sione circa il grado di applicazione e diffusionedelle operazioni in esso previste, quindi di prefi-gurare il suo grado di successo, nonché di indi-viduare eventuali spazi di aggiustamento o lepolitiche aziendali e bancarie da intraprendereper evitare i pericoli eventualmente presenti. Iltimore di chi scrive è che il provvedimento, percome è impostato, si rivolga e miri a sostenerele aziende che forse meno ne hanno bisogno. Leimprese che versano in uno stato di tensione fi-nanziaria, quelle cioè che potrebbero realmentetrarre una boccata d’ossigeno dalle facilitazionipreviste nell’“Avviso comune”, verosimilmentenon presentano spesso i parametri necessari peraccedervi. Il “debt rescheduling” configura, per la letteraturainternazionale, una linea di soluzione per affron-tare situazioni di difficoltà finanziaria reversibile,ma importante. L’“Avviso comune” tende invecea escludere dall’applicazione di questo debt re-scheduling i casi più nettamente configurati.L’originalità di questo provvedimento rispetto adaltre possibili misure di sostegno alle imprese su-scita l’esigenza di attente riflessioni.
2. IL PROVVEDIMENTO
L’accordo per la sospensione dei debiti delle pic-cole e medie imprese verso il sistema creditizio sisnoda e ruota attorno a dieci punti principali, ha“natura straordinaria” e durata circoscritta neltempo. Esso, come detto, è stato siglato nell’ago-sto 2009, in una fase del ciclo economico contras-segnato tra l’altro dalla contrazione del ProdottoInterno Lordo reale, da un generalizzato e pro-gressivo irrigidimento nell’erogazione dei prestitida parte delle banche e dall’allungamento deitempi di incasso dei crediti tra le imprese. In lineagenerale, negli ultimi mesi le aziende italiane sisono spesso trovate alle prese con crescenti diffi-coltà nell’accesso al credito e nel rinnovo degli af-fidamenti bancari in essere. Ciò in una fase ciclicache ha visto anche contrarsi in modo generalizza-to la loro redditività, talora a causa della forte cre-
scita degli oneri finanziari netti3, e il prefigurarsidi un fabbisogno finanziario che – nonostante ilcalo degli investimenti – si è spesso mantenutocomplessivamente elevato, verosimilmente a mo-tivo della minore capacità di autofinanziamento.Il rifinanziamento del debito è diventato un pro-blema rilevante per molte realtà aziendali, italianeed europee. Parallelamente, molte imprese nazio-nali hanno di recente lamentato una dilatazionedei tempi di istruttoria e di erogazione dei prestitisia a breve sia a medio-lungo termine; un aumen-to dei margini sui prestiti (talora in controtenden-za rispetto alle indicazioni di politica monetaria ealle condizioni del mercato interbancario) spessoassociato alla contrazione delle quantità erogatedal sistema bancario; una domanda di maggiorigaranzie da parte delle banche; richieste imprevi-ste di rientro dagli affidamenti e revoca ai primiritardi nei pagamenti4. Sebbene nell’ultimo anno la dinamica espansivadel credito alle imprese si sia ridotta in modo ge-neralizzato, tale fenomeno pare essere stato relati-vamente più intenso tra le aziende di piccola di-mensione rispetto a quelle di media e grande di-mensione, indipendentemente dal comparto di at-tività economica di appartenenza. Così, nel corsodel 2008 e del 2009, a fronte dell’aumento dell’in-debitamento e del progressivo deterioramento delquadro congiunturale, le condizioni finanziarie dimolte imprese di dimensione medio-piccola sonopeggiorate. Forse hanno concorso a determinaretale fenomeno anche la frequente assenza di un di-rettore finanziario in azienda nonché la maggiorerigidità nell’accesso ai diversi canali di finanzia-mento che connota tipicamente tali realtà impren-ditoriali. Certamente, la vulnerabilità della lorostruttura finanziaria è dipesa anche dall’elevatopeso del debito a breve termine (e del creditocommerciale in particolare) nei loro bilanci. In ef-fetti, nelle transazioni tra imprese, i notevoli e cre-scenti ritardi nell’incasso dei pagamenti dovutidai clienti (operatori della Pubblica Amministra-zione o committenti privati) hanno in diversi casiulteriormente messo a dura prova la capacità di
BANCHE E BANCHIERI n. 6 2009C O N T I N U I T À A Z I E N D A L E E M O R AT O R I A P E R I D E B I T I D E L L E P I C C O L E E M E D I E I M P R E S E418
3. Banca d’Italia (2009), Relazione Annuale sul 2008.4. Indicazioni convergenti provengono da diverse inda-gini. Si vedano, ad esempio, Banca d’Italia (2009), Bol-lettino Economico n. 57, luglio; Banca d’Italia (2009), In-dagine sul Credito Bancario; CNA (2009), Barometro su-gli effetti della crisi finanziaria, Roma, 17 marzo.
06_01_Saggio_Tavaglini.qxd:05_01_Saggio_Malinconico 6-01-2010 10:36 Pagina 418

ri dimensioni e a quelle cooperative, anche se nonrientrano nei parametri dimensionali della mora-toria sul debito.L’adesione all’“Avviso comune” da parte dellebanche è volontaria. In ogni caso, gli istituti ade-renti all’accordo devono renderlo operativo entro45 giorni dall’adesione, che va comunicata all’As-sociazione Bancaria Italiana. Secondo l’elenco ri-portato nel sito dell’ABI, ai primi di settembreavevano aderito all’iniziativa 28.000 sportelli, pa-ri all’82,5% del totale, facenti capo a circa 270banche. Le prime a partecipare all’iniziativa sonostate quelle di grandi e medie dimensioni, gli isti-tuti di minori dimensioni si sono tuttavia allineatiprogressivamente. Tanto che al 24 settembre 2009superano le 400 unità le banche e gli intermediarifinanziari aderenti all’“Avviso comune” per la so-spensione dei debiti delle piccole e medie impreseverso il sistema creditizio, per un totale di oltre31.000 sportelli del sistema bancario italiano: piùdel 90% del totale.L’adesione vincola tali operatori ad attenersi aiprincipi generali di comportamento fissati nell’a-greement stesso, sebbene nulla vieti loro di adot-tare comportamenti addirittura più favorevoli perle aziende sovvenute. In cambio, le banche chemanterranno gli impegni assunti potrebbero pote-re avere accesso ad alcune agevolazioni fiscali,che sono entrate a far parte dell’agenda politica. Le imprese potenzialmente destinatarie dell’ini-ziativa sono le piccole e medie imprese italianeresidenti in Italia, ovvero la stabile organizzazio-ne nel nostro Paese di imprese estere aventi resi-denza in Italia. Come definito dalla normativa co-munitaria, sono PMI le aziende autonome con unnumero di dipendenti inferiore a 250 e un fattura-to annuo sino a 50 milioni di euro (oppure un to-tale attivo di bilancio sino a 43 milioni di euro). Tra le aziende che rispettano tali parametri quan-titativi, sono legittimate a presentare la richiestadi applicazione dell’“Avviso comune” le sole PMI
classificate dalla banca in bonis al 30 settembre2008 e che al momento della presentazione delladomanda non abbiano posizioni in “sofferenza” o“ristrutturate” né procedure esecutive in corso.Sono al contrario escluse le aziende che:
– alla data del 30 settembre 2008 avevano espo-sizioni bancarie deteriorate (classificate cioè co-me sofferenze, partite incagliate, ristrutturate); – alla data del 30 settembre 2008 avevano ritardi
investimento e competitiva aziendale, hanno spes-so esacerbato il raggiungimento degli equilibri fi-nanziari, oltre ad avere rappresentato un rilevantecanale di propagazione della crisi stessa all’inter-no del sistema produttivo5. Per le aziende di mi-nori dimensioni, l’allungamento delle scadenze dipagamento, abbinato al tradizionale pericolo diessere razionate presso il sistema bancario, rischiadi amplificare in modo esponenziale gli effetti ne-gativi sulla liquidità aziendale. Non a caso, il peg-gioramento delle condizioni finanziarie di molteimprese si è recentemente riflesso in una crescen-te difficoltà di rimborso dei prestiti bancari e in unincremento significativo degli incagli registratidal sistema bancario tra marzo 2008 e 2009. Nonsono infatti poche le imprese che stanno da qual-che tempo sperimentando concrete difficoltà a ri-spettare i termini di rimborso convenuti sui finan-ziamenti bancari negoziati in un contesto econo-mico diverso. In un simile quadro congiunturale, la ratio del prov-vedimento di cui si discute è, dunque, ragionevol-mente, quella di cercare di fornire una “boccatad’ossigeno” al sistema produttivo italiano, suppor-tandolo in particolare nel fronteggiare le scadenzedei crediti ottenuti dal sistema bancario. Più preci-samente, l’Avviso mira a sostenere l’asse portantedel nostro apparato produttivo: le PMI. Ciò a pattoche esse siano caratterizzate da “una situazioneeconomica e finanziaria che possa provare la conti-nuità aziendale”, seppur temporaneamente indebo-lite sul piano finanziario a causa della crisi. L’accordo prevede dei meccanismi di selettività,circoscrivendo l’accesso alle agevolazioni in essopreviste alle sole imprese di piccole e medie di-mensioni che siano nel complesso sane e dotate diprospettive economiche favorevoli. Secondo sti-me di fonte ABI sarebbero comunque circa un mi-lione le aziende con le carte in regola per benefi-ciarne. Alcune banche aderenti all’agreement han-no peraltro deciso su base volontaria di estenderealcune facilitazioni anche alle imprese di maggio-
S A G G I 419BANCHE E BANCHIERI n. 6 2009
5. Da notare che in Italia appaiono decisamente superio-ri alla media europea sia l’incidenza dei debiti verso i for-nitori sul totale delle passività aziendali, sia i tempi medidi pagamento della Pubblica Amministrazione nei con-fronti delle imprese fornitrici, sia i tempi medi di dilazio-ne che ricorrono nelle transazioni tra imprese. Cfr. Bancad’Italia (2009: 184), Relazione Annuale sul 2008; UfficioStudi Confartigianato Imprese (2009), Rapporto “Dentrola crisi”, Roma, 17 marzo.
06_01_Saggio_Tavaglini.qxd:05_01_Saggio_Malinconico 6-01-2010 10:36 Pagina 419

nei pagamenti superiori a 180 giorni (past due),classificate “a incaglio” (cosiddetti “incagli og-gettivi” ex circolare n.272 del 30 luglio 2008 del-la Banca d’Italia); – alla data di presentazione della domanda pre-sentano posizioni in “sofferenza” o “ristrutturate”o con procedure esecutive (mobiliari o immobilia-ri) in corso6.
Le imprese in bonis prive di sconfini alla data dipresentazione della domanda sono ammesse inmodo pressoché automatico alla procedura, salvoesplicito e motivato rifiuto. La clientela in bonisal 30 settembre 2008 e classificata “in incaglio” almomento della domanda – cioè avente ritardi dipagamento sino a 180 giorni – non ha invece au-tomaticamente diritto alla moratoria, ma nemme-no ne risulta definitivamente esclusa. Compete al-le banche valutare caso per caso se tali aziendemeritino di accedere alle facilitazioni previste dal-l’accordo, verificando se esistono le condizioni dicontinuità aziendale. Come si spiegherà meglionel prosieguo, queste condizioni potrebbero infat-ti sussistere anche in presenza di eventuali sconfi-namenti o scaduti, soprattutto se isolati e non ri-petitivi. In sostanza, i requisiti di accesso alla moratoria ri-chiesti al momento della presentazione della ri-chiesta – non avere posizioni in “sofferenza” o“ristrutturate”, non avere rate scadute e non paga-te da più di 180 giorni, ecc. – risultano meno strin-genti di quelli necessari alla data antecedente del30 settembre 2008 – essere in bonis – ammetten-dosi che la crisi possa nel frattempo avere esacer-bato gli squilibri economico-finanziari delle im-prese pur senza metterne in discussione le pro-spettive di continuità operativa.Le aziende che rispettano i parametri quali-quan-titativi per fare richiesta di accesso alle agevola-zioni previste dall’accordo devono presentare do-manda direttamente alla propria banca entro il 30giugno 2010. La risposta deve giungere loro entro30 giorni lavorativi7.
Le agevolazioni messe in campo dall’“Avviso co-mune” consistono nelle seguenti fattispecie:
– sospensione per 12 mesi del pagamento dellaquota capitale sulle rate dei mutui, oppure dellaquota capitale implicita nei canoni di leasing im-mobiliare o mobiliare (in questo caso la moratoriapuò durare anche solo sei mesi);– allungamento a 270 giorni delle scadenze deicrediti commerciali a breve termine riferito alleanticipazioni sui crediti certi ed esigibili;– misure per favorire la ricapitalizzazione diaziende sane che versano in transitoria fase di dif-ficoltà. Esse si sostanziano in “appositi finanzia-menti” bancari “pari a un multiplo dell’aumentodi capitale effettivamente versato dai soci dell’im-presa”.
I requisiti per beneficiare della fattispecie dell’al-lungamento della scadenza dei prestiti a breve so-no gli stessi richiesti per ottenere la sospensionedel debito a medio-lungo termine e sono quelli giàpassati in rassegna. Da notare che sia la sospen-sione che l’allungamento del termine della sca-denza dei crediti sono neutrali e ininfluenti sulgiudizio che le banche elaborano circa la qualitàcreditizia del beneficiario di tali operazioni e sullesue posizioni debitorie. In linea generale,l’accesso a tali facilitazioni da parte di un’impresanon influisce sulla classificazione delle relativeesposizioni da parte del sistema bancario. Dettoancora diversamente, la fruizione dei beneficidell’“Avviso comune” non può costituire un vali-do “motivo per classificare l’operazione stessa oaltre della medesima impresa tra quelle incagliate,in sofferenza o ristrutturate”, anche se evidente-mente l’imprenditore sarà convinto o temerà ilcontrario.Con riferimento al profilo della sospensione, lefattispecie contrattuali atte a beneficiarne sono leoperazioni di leasing finanziario e i mutui (ipote-cari e non ipotecari) di durata superiore ai 18 mesie già in essere al 3 agosto 2009, data della firmadell’“Avviso comune”. Con riferimento ai mutui,“le rate devono essere in scadenza o già scadute(non pagate o pagate solo parzialmente) da nonpiù di 180 giorni alla data di presentazione delladomanda”; la sospensione della quota capitale
BANCHE E BANCHIERI n. 6 2009C O N T I N U I T À A Z I E N D A L E E M O R AT O R I A P E R I D E B I T I D E L L E P I C C O L E E M E D I E I M P R E S E420
6. Mentre per le posizioni classificate “in bonis” rilevala classificazione della banca, il presupposto dell’assenzadi “procedure esecutive in corso” include invece qualsia-si procedura esecutiva in corso a carico dell’impresa. Cfr.ABI (2009), Avviso Comune, Domande Ricorrenti.7. Come chiarito nella lettera circolare dell’ABI del 6agosto 2009, prot. DG 002836, le imprese possono presen-tare richiesta non appena la banca abbia aderito all’Accor-
do, anche se questo non è ancora operativo. In questo ca-so, però, i 30 giorni per la risposta decorreranno dal mo-mento in cui l’adesione è concretamente operativa.
06_01_Saggio_Tavaglini.qxd:05_01_Saggio_Malinconico 6-01-2010 10:36 Pagina 420

termine, non sono compresi invece nella casisti-ca dell’“Avviso comune” i finanziamenti banca-ri all’importazione, le operazioni di finanzia-mento su anticipazioni su contratti o le opera-zioni a revoca. Da notare, inoltre, che la dilazio-ne massima di 270 giorni può essere concessadalle banche in un’unica soluzione ma anche apiù riprese9. Nulla vieta, peraltro, che esse fissi-no un termine di scadenza del rimborso del cre-dito anche superiore a 270 giorni, trattandosi diuna ipotesi migliorativa senz’altro ammessa dal-l’agreement.In conclusione, come chiarisce il punto 5 dell’“Av-viso comune”, sia le operazioni di sospensione siaquelle per il sostegno delle esigenze di cassa delleimprese vanno eseguite sostanzialmente a titologratuito da parte del sistema bancario. Ai clientibeneficiari di tali facilitazioni non possono infattiessere praticati aumenti di tasso rispetto a quantoconvenuto nel contratto originario10, né possonoessere richieste garanzie aggiuntive o essere ap-plicate commissioni, spese di istruttoria o interes-si di mora per il periodo di sospensione come con-seguenza dell’ammissione alle suddette agevola-zioni. Il parametro di costo dell’operazione po-stergata nei termini di rimborso rimane quindi im-mutato. Le banche possono ciò nondimeno richie-dere il rimborso delle spese vive – debitamentedocumentate – sostenute nei confronti di terzi econnesse con l’operazione, così come possonofarsi rilasciare nuove garanzie a fronte di opera-zioni volte a sostenere i processi di ricapitalizza-zione aziendali. Esse possono infine legittima-mente riscuotere tutte le voci di spesa convenutecon la clientela prima della richiesta da parte diquesta di beneficiare delle facilitazioni previstedall’“Av-viso comune” e dunque negoziate a pre-scindere da queste.
comporta la traslazione del piano di ammortamen-to per il medesimo arco di tempo mentre gli inte-ressi sul capitale sospeso sono da corrisponderenei termini originari.In linea di principio, possono essere ammessi albeneficio sospensivo anche i crediti cartolarizzati:in tal caso, compete alla banca “valutare caso percaso ed eventualmente attivarsi nei modi più op-portuni per poter dare esito positivo alla richiestadell’impresa”8. In questa ipotesi, il rischio in capoalla banca mutuante si modifica effettivamente, ela sua gestione di liquidità ne risente, a differenzadel caso generale. Queste sono le ragioni per cui ilbanchiere ritiene in linea di massima più proble-matica la postergazione dei termini di rimborso dicrediti cartolarizzati.Sono invece espressamente esclusi dall’ambitoapplicativo dell’“Avviso comune” i contratti amedio-lungo termine stipulati successivamenteall’entrata in vigore dell’accordo, i contratti dileasing operativo, le operazioni a medio-lungotermine che prevedono una agevolazione pubbli-ca intesa come contributo in conto interessi e/ocapitale, nonché i mutui richiesti per finalità nonaziendali (stipulati cioè non nell’esercizio dell’at-tività d’impresa né per la gestione aziendale).Per quanto concerne le operazioni a breve termi-ne, l’obiettivo perseguito dai firmatari dell’“Av-viso comune” tramite la fattispecie dell’allunga-mento della scadenza è quello di evitare che “sipossa scatenare un effetto domino tra PMI”, valea dire una situazione tale per cui un’azienda pos-sa cadere in crisi di liquidità a causa del mancatorispetto dei propri impegni contrattuali da partedei suoi debitori. In tale ottica, le operazioni ban-carie a breve termine suscettibili di allungamen-to della scadenza sono le linee di credito a sca-denza fissa nelle “forme tecniche per anticipa-zione di crediti, nello specifico, ad esempio, an-ticipi SBF su effetti o ricevute, anticipi su fattureItalia ed estero”. Sono ammessi al beneficio del-l’allungamento sia i contratti conclusi prima del3 agosto 2009, sia quelli stipulati successiva-mente al varo dell’agreement ed entro il 30 giu-gno 2010, data ultima per richiederne l’applica-zione. Nonostante siano tipicamente a breve
S A G G I 421BANCHE E BANCHIERI n. 6 2009
8. “La banca cedente potrà farsi carico della sospensionefacendo sì che la società veicolo riceva l’intero importodella rata dovuta”. Cfr. ABI (2009), Avviso Comune, Do-mande Ricorrenti.
9. L’allungamento a 270 giorni va inteso come dilazionemassima in funzione della durata originaria dell’anticipo.Così, ad esempio, se la scadenza originaria del prestitoera 30 giorni, l’allungamento massimo possibile risulta di240 giorni. Cfr. ABI (2009:16), Avviso Comune, Doman-de Ricorrenti.10. Posto che la sospensione riguarda soltanto la quota ca-pitale, per il computo della quota interessi resta invecevalido quanto contrattualmente concordato alla stipuladel contratto. Al riguardo, risulta perfettamente legittimoche nell’ambito dei mutui a tasso indicizzato la quota in-teressi possa variare al mutare del parametro di riferimen-to convenuto.
06_01_Saggio_Tavaglini.qxd:05_01_Saggio_Malinconico 6-01-2010 10:36 Pagina 421

3. IMPERATIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO ERILEVANZA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE
L’“Avviso comune” non configura alcun vincolocontrattuale a favore del soggetto che ha preceden-temente ottenuto un finanziamento e che adessoaspira a ottenere una sospensione dei termini dirimborso. Questo lo si evince dal punto 6, terzo ca-poverso del documento. Anche l’impresa che hatutte le caratteristiche favorevoli può non essereammessa, sia pure con motivazione esplicita.D’altra parte, le singole banche non hanno alcunobbligo ad aderire al previsto schema generale eper aderire lo devono fare in forma esplicita. Que-sto lo si evince dal punto 2, terzo paragrafodell’“Avviso comune”. Una volta che una singolabanca abbia aderito, non ha poi alcun obbligo arealizzare le operazioni in esso contemplate. Ilpunto appena citato conferma che “non sono pre-visti automatismi”. Nel complesso, di conseguen-za, si evince che l’“Avviso comune” non è certoun contratto, o una promessa unilaterale, e nonconfigura obblighi per una parte o diritti per l’altra.L’“Avviso comune” ha un rilievo giuridico limita-to, o forse proprio non ha alcun rilievo contrattua-le. È piuttosto un atto politico che registra la con-vergenza dei soggetti che lo hanno firmato versoalcune valutazioni e verso alcune strumentazioniper affrontare le difficoltà sistemiche che si pre-sentano. La cronaca fornisce già la sensazione chela clientela non percepisca appieno questo caratte-re ibrido dell’“Avviso comune”. In capo al clientefinanziato, che usualmente non segue con suffi-ciente attenzione la discussione politica e istitu-zionale, sorge facilmente il convincimento (erra-to) che tale automatismo esista e quindi si scatenauna forte insoddisfazione nel caso in cui le aspet-tative siano disattese. D’altra parte, un provvedi-mento che comportasse un obbligo contrattuale aconcedere una proroga ai termini di rimborso è as-solutamente inimmaginabile, tanto sarebbero in-congrue le conseguenze. Nel mondo delle impre-se si sono diffusi i seguenti convincimenti:
a. presentare una richiesta di moratoria dei termi-ni di rimborso è equivalente a una dichiarazionedi consapevolezza di qualche difficoltà finanzia-ria (visto che un’impresa senza problemi di rota-zione dei debiti finanziari non ha alcun vantaggioe quindi non propone la richiesta di moratoria); b. la richiesta di applicazione di moratoria dei ter-
mini di rimborso verrà in seguito valutata dallabanca in modo del tutto discrezionale. Questi due convincimenti non corrispondono inpieno al dettato dell’“Avviso comune”, ma hannoun loro rilievo.Il provvedimento, al punto 3, precisa che la so-spensione dei termini di rimborso è destinata a es-sere applicata a “imprese con una situazione eco-nomica e finanziaria che possano provare la conti-nuità aziendale ma che a causa della crisi presen-tino difficoltà finanziarie temporanee”. Questopunto è di cruciale importanza. Da un lato, la so-spensione dei termini di rimborso non può essereapplicata a imprese che hanno già manifestatochiari segnali di difficoltà finanziaria, in ragionedella condivisa considerazione che, in tal caso,ogni sospensione tende ad aggravare le successivepossibilità di recupero coattivo del credito el’aggravamento progressivo delle condizioni fi-nanziarie nel periodo precedente alla futura insol-venza. L’“Avviso comune” non deve dunque com-portare una controproducente moratoria nelle di-chiarazioni di insolvenza.Il secondo capoverso del punto 3 precisa, almenocome primo riferimento, il modo in cui la conti-nuità aziendale deve essere individuata: si richiededi essere in bonis al 30 settembre 2008; di non ave-re procedure esecutive in corso né posizioni in“sofferenza” o “ristrutturate” al momento della pre-sentazione della domanda. Non si può escludereche le imprese che versano in uno stato di difficoltàfinanziaria temporanea, conseguente alla crisi ma-crofinanziaria, siano già oltre tali limiti. È evidenteche su questo punto non si può identificare un cri-terio perfetto, ma solo di larga approssimazione.L’effetto della crisi sistemica sui conti dell’impresasi traduce in diversi casi in una caduta del fatturato,anche molto evidente, e in un innalzamento del li-vello del capitale circolante. Questi fenomeni, inseconda battuta, amplificano il complessivo fabbi-sogno finanziario aziendale. In questa situazione, ilfare ricorso al criterio della continuità aziendale èmolto ambiguo. Con un peggioramento netto dellasituazione finanziaria, discriminare tra ciò che ètemporaneamente legato alla congiuntura econo-mica e ciò che è invece strutturale diviene compitopraticamente impossibile. Lo sconquasso macroe-conomico sta cambiando le dinamiche concorren-ziali di molti settori; non è possibile immaginareuna situazione di forte difficoltà a cui seguirà il ri-
BANCHE E BANCHIERI n. 6 2009C O N T I N U I T À A Z I E N D A L E E M O R AT O R I A P E R I D E B I T I D E L L E P I C C O L E E M E D I E I M P R E S E422
06_01_Saggio_Tavaglini.qxd:05_01_Saggio_Malinconico 6-01-2010 10:36 Pagina 422

In primo luogo, in tali documenti il concetto dicontinuità aziendale (going concern) risulta defi-nito avendo come riferimento una situazione ma-croeconomica ordinata e con la volontà di indivi-duare imprese che, in tale contesto, stiano mani-festando segnali di importante difficoltà. Si trattadi una procedura volta a individuare casi critici,nettamente caratterizzati da segnali negativi. Ilconcetto di continuità aziendale che rende con-creto l’“Avviso comune” ha invece l’obiettivo diindividuare, in un contesto ambientale fortemen-te perturbato, le imprese migliori, quelle che so-no poi destinatarie potenziali delle facilitazioniprefigurate dall’accordo stesso. Non si tratta quidi accertare le situazioni aziendali squilibrate inuno scenario generale complessivamente ordina-to, ma di certificare piuttosto la forza finanziariadelle imprese che si muovono in un quadro eco-nomico generale assai disordinato. Questa diffe-renza di fondo definisce un ambito di ragiona-mento, e di conseguenza indicatori di riferimen-to, assai diversi.In secondo luogo, e conseguentemente, nell’ambi-to del citato principio di revisione il set di parame-tri utili a monitorare la continuità aziendale si rife-risce a tre aree di osservazione: il profilo finanzia-rio, il profilo della gestione, il profilo generale deisegnali pregiudizievoli di vario tipo. Ogni gravesegnale negativo, di vario genere, viene interpreta-to come traccia di un pericolo per la continuitàaziendale. Ai fini dell’applicazione dell’“Avvisocomune” occorre invece distinguere in modo piùraffinato. Che a livello aziendale esista una com-promissione della capacità di rimborso è fuori didiscussione, altrimenti non ci sarebbe neppurel’esigenza della moratoria. Che ci possa essere unacaduta del fatturato, e della marginalità, o un appe-santimento del circolante, è normale. Il set degliindicatori pensati dal principio di revisione n. 570sono fuori linea dal punto di vista operativo neces-sario in questo caso.In realtà, per dare sostanza al concetto di “conti-nuità aziendale” secondo l’“Avviso comune” oc-corre individuare uno schema di valutazione e dianalisi diverso. Al riguardo, è di rilievo un set piùlimitato di fenomeni e, quindi, di indicatori:
– le variabili relative alla gestione caratteristica,e in particolare le caratteristiche del prodotto (in-novazione e tecnologia) e del posizionamento dimercato;
pristino delle condizioni competitive pre-crisi; oc-corre invece immaginare una situazione di diffi-coltà che creerà nuove occasioni per alcuni e intro-durrà ostacoli nuovi e insormontabili per altri. Ivantaggi competitivi di diversi sistemi economicisi stanno rafforzando, quelli di altri indebolendo. Inquesto quadro è particolarmente difficile distingue-re, come l’“Avviso comune” vorrebbe, tra impresecon difficoltà completamente assorbibili e destina-te a continuare l’attività e imprese con un livello didifficoltà tale da precluderne la vita futura. In prati-ca, si tratterà di distinguere in modo molto empiri-co tra situazioni di difficoltà che sembrano moltogravi (prescindendo dalla reversibilità) e situazionimodestamente peggiorate nei parametri finanziari,magari però in via stabile.È utile ricordare che una precedente politica finan-ziaria aziendale aggressiva, basata sul debito e/osu una strategia acquisitiva, può benissimo rappre-sentare essa stessa un oggettivo e insormontabileostacolo alla continuità aziendale. La continuitàaziendale può quindi mancare anche in presenza diuna gestione caratteristica soddisfacente, se la ge-stione finanziaria appare disfunzionale rispetto al-le condizioni di quadro. Anche questo elemento la-scia poi nel concreto indefinito il principio dellacontinuità aziendale, come è ovvio che sia, anchese, a una prima lettura, tale principio appare chia-ro, convincente, immediatamente operativo.Il riferimento al concetto di “continuità aziendale”evoca il corrispondente concetto precisato nelloStandard contabile Ias 1 e nel Principio di revisio-ne n. 570. Tale linea di analisi del problema è stataridefinita e posta all’attenzione della comunità fi-nanziaria dal recente Documento Banca d’Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009 (Tavolo dicoordinamento fra Banca d’Italia, Consob e Isvapin materia di applicazione degli IAS/IFRS – Infor-mazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sullacontinuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle ve-rifiche per riduzione di valore delle attività e sulleincertezze nell’utilizzo di stime). La banca non ècerto tenuta ad applicare questi documenti per da-re contenuto operativo al dettato dell’“Avviso co-mune”. È tuttavia utile esaminare questi documen-ti per verificare se la linea di ragionamento giàtracciata con riferimento a essi sia utile anche inquesta occasione. La risposta è negativa. Gli stan-dard sopra citati si prefiggono scopi diversi e sonopoco coerenti con lo schema logico dell’“Avvisocomune”. Principalmente per due ragioni.
S A G G I 423BANCHE E BANCHIERI n. 6 2009
06_01_Saggio_Tavaglini.qxd:05_01_Saggio_Malinconico 6-01-2010 10:36 Pagina 423

– i parametri di flessibilità della produzione e, inparticolare, il mix tra costi fissi e costi variabili ela capacità di controllo del capitale circolante;– la capacità di non generare fabbisogno finan-ziario in modo esagerato rispetto alla fase di ral-lentamento dell’attività;– il non dover sostenere le conseguenze di prece-denti strategie finanziarie incongrue;– le caratteristiche di integrità dell’imprenditoree del management.
La tradizionalissima regola di valutazione del cre-dito si basa sulle cosidette “5 C”, ossia character,capacity, capital, collateral e condition. In condi-zioni particolarmente dure, la caratteristica ben piùimportante è “character”. Parafrasando il rockeritaliano più conosciuto, “l’imprenditore conta”.Per le imprese in una buona situazione finanziariaè del tutto ovvio immaginare una difficoltà tempo-ranea a produrre flussi di cassa idonei ad alimenta-re il rimborso del debito finanziario. È difficile, macerto non impossibile, che in un momento così dif-ficile risultino prodotti flussi di autofinanziamentosufficientemente coerenti con le quote in conto ca-pitale in scadenza. La conseguenza logica è la po-sticipazione delle quote in conto capitale. La pro-duzione dei fondi necessari per il rimborso del de-bito finanziario avviene o con autofinanziamento,o con smobilizzo dell’attivo, o con ristrutturazione(proroga) del debito esistente, o con l’incrementodei capitali apportati dai soci. In questa fase è deltutto ovvio che le varie strade siano difficilmentepercorribili, senza alcuna eccezione tra le quattropossibilità. È evidente che per le imprese di suc-cesso, ma in temporaneo rallentamento, la gestio-ne finanziaria del corrente anno e probabilmentedel prossimo si basino sul rifinanziamento del de-bito precedentemente acceso, a prescinderedall’“Avviso comune”. È quindi evidente che lamaggior quota delle singole operazioni di postici-po delle rate avviene e sarebbe avvenuta comun-que, essendo precluse le alternative ed essendo dipiena convenienza per la banca non alimentare percause finanziarie il deterioramento del valore delportafoglio prestiti. Dal punto di vista logico appa-re evidente che una parte rilevante, o molto rile-vante, del fenomeno moratoria sarebbe stata rea-lizzata anche a prescindere dall’“Avviso comune”.I finanziamenti riferiti al capitale circolante, e par-ticolarmente gli anticipi dei crediti commercialinelle varie forme tecniche esistenti, meritano un
commento specifico. La moratoria sui rimborsi ditali finanziamenti, sia pure opportuna sotto un pun-to di vista generale, è incongrua rispetto alla logicadi fondo della tecnica finanziaria. Come magistral-mente descritto da Tancredi Bianchi in I fidi ban-cari (1977)11, la continua verifica della rotazionedel capitale circolante dell’impresa è un connotatotipico della banca commerciale. La migliore verifi-ca di una attuale capacità di credito sta nel testarein continuazione l’effettiva rotazione del capitaleinvestito nel circolante. È evidente che ciò è logi-camente incompatibile con ogni disegno di mora-toria. La necessità di una moratoria sul rimborsodelle operazioni finanziarie a sostegno del circo-lante è la prova esplicita di una difficoltà importan-te. L’aver esteso la moratoria a tali forme tecnichedesensibilizza notevolmente la banca nei riguardidell’evoluzione nel breve termine della forza fi-nanziaria di una impresa. La criticità della situa-zione macrofinanziaria ha posto in essere un forteirrigidimento del credito commerciale, il cui mer-cato, per il principio dei “vasi comunicanti”, è inconnessione diretta con il mercato del credito ban-cario al circolante. Ogni difficoltà del primo pro-duce inevitabilmente eguali difficoltà sul secondo.
4. CONCLUSIONI
Il provvedimento, come abbiamo visto non pro-priamente cogente per alcun operatore, è opportu-no sotto diversi profili. Per un verso è la chiaraesplicitazione di un comportamento che sarebbestato comunque ineluttabile. Per altri versi è unadichiarazione di intenti tanto opportuna quanto dif-ficile da precisare nel suo contenuto tecnico più ri-levante, che è il principio della continuità azienda-le. Infine, tale provvedimento risulta assai oppor-tuno per le imprese, sia sotto il profilo materialeche sotto il profilo delle aspettative, così come ri-sulta nel complesso propizio per le banche, in ra-gione del fatto che la misurazione della qualità delcredito è assai difficile in questa fase ed è dunqueutile, in diversi casi, posticipare di qualche tempoil riscontro più preciso in questa direzione. In con-dizioni ambientali critiche, la valutazione del me-rito di credito probabilmente si focalizza sul profi-lo dell’integrità personale dell’imprenditore.
BANCHE E BANCHIERI n. 6 2009C O N T I N U I T À A Z I E N D A L E E M O R AT O R I A P E R I D E B I T I D E L L E P I C C O L E E M E D I E I M P R E S E424
11. Bianchi T. (1977), I fidi bancari, Utet, Torino.
06_01_Saggio_Tavaglini.qxd:05_01_Saggio_Malinconico 6-01-2010 10:36 Pagina 424