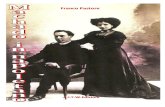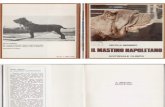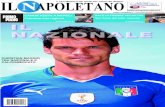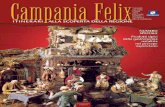Content-La Canapicoltura Nel Napoletano
-
Upload
elisabetta-coppola -
Category
Documents
-
view
11 -
download
4
description
Transcript of Content-La Canapicoltura Nel Napoletano
-
lavoro14
sosio Capasso nel suo libroCanapicoltura e sviluppo neicomuni atellani (istituto distudi atellani, 1994) riferiscedella dicolt di individuarel'origine della coltivazione dellacanapa.
Poich il processo di lavora-zione della canapa legato al-l'acqua, sicuramente la suaorigine va ricercata l dove ceraun fiume o a un lago.
erodoto ci narra che nella lon-tana terra degli sciti oltre il marnero si trovava la canapa, un ma-teriale molto simile al lino che itraci coltivavano per realizzarevestiti. in Cina era conosciuta nel500 a.C., ed citata nello shu-King , un classico della storiogra-fia cinese. Gli sciti la portarono ineuropa intorno al 1500 a.C., spin-gendosi verso la foce del Danu-bio. in seguito si diuse tragermani, i greci e i romani che laportarono in Gallia.
ai tempi dei romani impor-tanti lavoratori di canapa erano imiseni. allora la canapa fu utiliz-zata soprattutto come cordi-gliera per la flotta imperiale.
Dopo la distruzione di misenoda parte dei saraceni i cittadinidel luogo si rifugiarono nell'en-troterra e fondarono fratta,lodierna frattamaggiore.
La citt stata il cuore dellaproduzione e della trasforma-zione della canapa. Con questomateriale si produssero corde etessuti fino alla fine degli anni 50del 900. fu allora, ben primadella crisi, che in questi comunisi svilupp unintensa attivit le-gata alla canapa: talmente dif-fusa era la lavorazione dellacanapa che garage, villette e
ogni tipo di edificio disponibilefu trasformato in un laboratorio.
La citt unita a frattaminore,Grumo nevano, arzano, Casan-drino Cardito, Caivano e Cri-spano da unidentit storica cherisale molto indietro nel tempo:tutti questi comuni furono lociromani e poi casali medioevali,che sorsero sui resti dellanticacitt osca di atella, distrutta nelVii secolo. Leconomia della ca-napa stimol a tal punto gli abi-tati di allora che questi centri siconfigurano oggi come una-unica realt urbana di circa280.000 abitanti, su una superfi-cie di 52,3 kmq, e con una den-sit media 3.977 ab/kmq. inquest area ,d u n q u e ,l e c o n o m i adella canapa unattivitm i l l e n a r i ache statacapace di ca-ratterizzare etrasformare ilpaesaggio.
Qui, lele-mento natu-rale diriferimento lantico fiumeClanio. un fiume che aveva unacaratteristica particolare: la por-tata decresceva durante lin-verno e aumentava alla fonte neimesi estivi provocando nel mesedi agosto delle piene che avveni-vano proprio nel periodo dellamacerazione. non solo, quindi,lorganizzazione della lavora-zione della canapa lungo il fiumedisponeva delle risorse necessa-rie a fini produttivi, ma era anche
adatta alla bonifica del territorio.infatti, il corso del fiume era co-stituito da margini irregolari conmeandri e fiumiciattoli che sim-paludavano rendendo lam-biente malsano e dicile agliinsediamenti umani sin dallanti-chit. Le erbacce che crescevanosul fondo e il crollo dei marginicreava acquitrini malsani e infettiche obbligavano a una manu-tenzione continua. nel 1312 uneditto di roberto dangi ordi-nava alle popolazioni residenti inloco di eseguire a proprie spese inecessari lavori di sistemazione edi pulizia.
i vicer spagnoli adarono iprimi lavori di bonifica all'archi-tetto Giulio Cesare fontana cherealizz un nuovo alveo e retti-fic le sponde con laggiunta dipiccoli corsi detti lagnuoli cre-ando cos un sistema di canaliche da quel momento fu deno-minato regi Lagni.
allinizio dellottocento furonoeettuate nuove opere di boni-fica con murat, e in seguito, nel1838, dopo particolari studi cheriguardavano tutti i terreni mal-sani di terra di Lavoro, furonoeseguiti lavori di canalizzazionetra i regi Lagni e il Lago di Patriasotto la direzione delling. Vin-cenzo antonio rossi.
ai tempi dei borboni il fiumeera limpido e pescoso e una suadeviazione verso nord in dire-zione della reggia di Caserta erautilizzata per la navigazione. inseguito la deviazione che por-tava alla reggia di Caserta fu in-terrata e divenne lattuale vialeCarlo iii. Ci che rimane dellan-tico fiume Clanio oggi scorre sot-terraneo e confluisce ancora nel
Lago di Patria. un tempo, in questo territorio
e nelle sue immediate vicinanzele acque del fiume venivano uti-lizzate per la macerazione di unaltro prodotto tessile, il lino, cheera coltivato anche nelle aree pe-demontane della Collina dei Ca-maldoli.
oggi i regi Lagni sono statilargamente cementificati. i canalidi cemento sono finalizzati allaraccolta delle acque piovane perlirrigazione dei campi, ma rac-colgono anche gli scarichi diacque reflue e di peggiore fat-tura e le convogliano a maresenza depurazione.
L' a t t i v i t della coltiva-zione e lavo-razione dellacanapa si svi-lupp inmodo parti-colare a par-t i r ed a l l o t t o -c e n t o ,quando fu-rono realiz-zati maceri divarie gran-dezze, anchea notevole distanza dal Lagno,che erano connessi ad esso conapposite canalizzazioni.
i maceri pi piccoli sono collo-cati vicino alle case rurali. Qui, neicicli di riposo dalla coltivazionedi canapa, erano puliti e veni-vano utilizzati per lallevamentodi oche e anatre, oltre ad essereadibiti a peschiere dove si alleva-vano pesci tra quali tinche ecarpe, che garantivano la pu-rezza delle acque liberandoledagli insetti, in particolare dalle
zanzare. fu quello un periodo di tra-
sformazione delle case rurali invere e proprie aziende agricole:la loro estensione crebbe per ac-cogliere gli operai e si realizza-rono depositi per piante raccoltee lavorate. Lattivit febbrile sa-rebbe proseguita per buonaparte del 900 fino allinizio deglianni 50 quando nei comuni atel-lani garage, villette e abitazionidi varie tipologie si andavanotrasformando in laboratori senzanessun controllo urbanistico.
nel recente passato l'italia stata la seconda nazione almondo, dopo la russia, per laproduzione della canapa. nelprimo decennio del novecento siproducevano 795.000 quintaliannui su una superficie investitapari a 79.477 ettari contro i3.440.570 quintali su 686.197 et-tari della russia.
alla produzione italiana con-tribuiva il napoletano con 89.000quintali e la provincia di Casertacon 157.000 quintale; il resto eraprodotto tra le provincie di fer-rara e di bologna.
Poi questindustria fiorente co-minci a declinare. negli annisettanta la produzione fu di soli10.080 quintali su una superficieinvestita di 899 ettari. il declinocontinu inesorabile. La crisicomport una forte disoccupa-zione, nel solo casertano vi fu-rono coinvolti ben 40 comuni e,in particolare, nel napoletano,frattamaggiore che era stata sto-ricamente il cuore della produ-zione della canapa. alloriginedel declino ci furono cause sicu-ramente legate all'introduzionesul mercato di fibre sintetiche ela rinuncia degli imprenditori di
la canapicoltura nelnapoletano
un ritorno alle origini in chiave (quasi) futuristica
Speranza e opportunit, tra terreni avvelenati e criSi occupazionaledi antonio guarino
Una carta del XVIII secolo indicante i paesi della zona atellana (diocesi di Aversa) e lintero percorso del Clanio (Lagni)
oggi, in terradi lavoro lacoltivazionedella canapa Strategicaperchpermette didepurare aBaSSo coSto iterreni daimetalli peSantiche lhannoavvelenata
[
l'italia Statala Secondanazione almondo per laproduzionedella canapa(750.000 q.annui) di cuimolti Siproducevano anelle provinciedi napoli e dicaSerta
[
febbraio 2013
politicadomani
Vasche per la macerazione della canapa
-
lavoro 15
investire in nuove tecnologie; mauna parte della responsabilit vaattribuita allendemica disatten-zione e miopia dei programmi disviluppo del governo centrale elocale. a questa va aggiunta lin-capacit (o opportunit?) di di-stinguere nella lavorazione della
canapa la so-stanza che sicoltiva a finidi produ-zione tessile eindustriale daquella che sicoltiva comesostanza stu-pefacente, dicui si ritro-vano testi-m o n i a n z edelluso inquesta formafin dai tempi
pi remoti. infatti, nel 1961 il go-verno italiano sottoscrisse la con-venzione internazionale dettaConvenzione unica sulle sostanzestupefacenti, a cui seguironoquelle del 1971 e del 1988, conlobiettivo di far scomparire la ca-napa dal mondo (entro 25 annidallentrata in vigore delle con-venzioni).
in realt si cre allora una to-tale confusione tra Cannabis sa-tiva da cui si ricavano le fibre e laCannabis indica dalla quale siottengono marijuana, hashish ealtre droghe. La confusione credanni enormi alla produzionedella cannabis sativa e allecono-mia ad essa legata. infatti in que-gli anni, era il 1966, la societinglese techical association ofthe Pulp and Paper industry rac-comandava la coltivazione dellacanapa per la fabbricazione della
carta. Le cartiere italiane avreb-bero potuto assorbire 500.000quintali di produzione su una su-perficie pari a 22.000 ettari: unosviluppo economico importante(soprattutto per le province dinapoli e Caserta), se si considerache oggi l'italia spende intorno ai2.000 milioni di euro annui perimportare pasta di legno per fab-bricare carta.
Contemporaneamente, neglianni delle convenzioni che si an-davano a sottoscrivere, in italia sifecero ricerche per ricavare lacarta dalla canapa. ricerche chenel 1977 ottennero a tal fine un
Canapadescrizione di una pianta
Una carta del XVIII secolo indicante i paesi della zona atellana (diocesi di Aversa) e lintero percorso del Clanio (Lagni)
La canapa una pianta erbacea,appartenente alla famiglia dellecannabacee (della quale fa parteanche il luppolo) e all'ordine delleurticales, a ciclo annuale la cui al-tezza varia tra 1,5 e 2 metri, e in al-cune sottospecie pu arrivare fino a5 m. Presenta una lunga radice a fit-tone (radice con radica principalepi sviluppata delle secondarie) e unfusto, eretto o ramificato, con escre-scenze resinose, angolate, a voltecave, specialmente al di sopra delprimo paio di foglie.
Le foglie sono picciolate e prov-viste di stipole (appendici simili afoglie che si differenziano alla basedel picciolo); ciascuna di esse pal-mata setta (foglie sullo stesso pianoe sullo stesso picciuolo, con solchiche raggiungono la base della ner-vatura), composta da 5 a 13 foglio-line lanceolate, a marginedentato-seghettato, con punte acu-minate fino a 10 cm di lunghezza ed1,5 cm di larghezza; nella partebassa del fusto le foglie si presen-
contributo dalla Comunit euro-pea. stato infatti dimostratocome dalla canapa si ottiene unacarta migliore perch i tratta-menti chimici necessari sonomeno aggressivi. inoltre, rispettoalla produzione ottenuta con glialberi, la canapa contiene un 33per cento in pi di cellulosa deglialberi e impiega 120 giorni a ri-crescere rispetto ai 50 anni deglialberi.
un ritorno alla produzione dicanapa presenta altri aspetti po-sitivi. oggi la coltivazione dellacanapa strategica per il nostroterritorio, la storica terra di La-voro. essa permette di depu-rare a basso costo i terreni daimetalli pesanti che costituisconoi principali elementi che hannoavvelenato questa terra tra il ca-sertano e il napoletano e in par-ticolar modo lungo quella fasciache corre lungo i regi Lagni. Lericerche sulle propriet della ca-napa hanno dimostrato, peresempio, che radici, fusto e fogliesucchiano anche lo zinco rila-sciato nellambiente dalla pre-senza di concerie e acciaierie.
Dalla raccolta si possono otte-nere prodotti dindirizzo energe-tico come, per esempio, laproduzione di etanolo. inoltre,attraverso il nuovissimo pro-cesso pro.e.satm. - una tecnolo-gia il cui primo prototipo statorealizzato in Piemonte dallamossi & Ghisolfi, multinazionaledella chimica tutta italiana chenegli ultimi anni ha deciso di in-vestire in ricerca - possibile pro-durre carburante verde di nuovagenerazione in alternativa allebiomasse alimentari come zuc-chero di canna o mais, evitandocos il loro aumento di prezzo sulmercato.
La fibra anche utilizzabile inedilizia nella realizzazione di pa-nelli per lisolamento energeticoe di pannelli fonoassorbenti.
e qui siamo entrati in un altrotema importante qual quellodel risparmio energetico. Per ora,data lattuale scarsit di fibra dicanapa, essa mescolata conaltre fibre naturali di importa-zione che provengono dai paesiin via di sviluppo, come il kenaf e
tano opposte, nella parte alta invecetendono a crescere alternate, soprat-tutto dopo il nono/decimo nododella pianta, ovvero a maturazionesessuale avvenuta (dopo la fase ve-getativa iniziale, nota popolarmentecome "levata").
Salvo rari casi di ermafroditismo,le piante di canapa sono dioiche e ifiori unisessuali crescono su indivi-dui di sesso diverso. I fiori maschili(staminiferi) sono riuniti in pannoc-chie terminali, presentante ciascuno5 tepali (petali e sepali in un unicoorgano) fusi alla base e 5 stami.
I fiori femminili (pistilliferi) sonoriuniti in gruppi di 2-6 alle ascelle dibrattee formanti spighe corte;ognuno mostra un calice membra-naceo che avvolge strettamente unovario supero (ovario posizionatosopra il punto di inserzione dellealtre parti fiorali), sormontato dadue stili (prolungamenti dell'ovario)e due stimmi (recettori di polline).
La pianta germina in primavera efiorisce in estate inoltrata. L' impol-linazione anemofila (trasporto tra-mite il vento). In autunnocompaiono i frutti, degli acheni durie globosi, ciascuno trattenente unseme con un endosperma carnosoed embrione curvo.
Il contenuto di metaboliti secon-dari vincola la tassonomia in duesottogruppi o chemiotipi a secondadell'enzima preposto nella biosintesidei cannabinoidi. Si distingue il che-miotipo CBD, caratterizzato dall'en-zima CBDA-sintetasi checontraddistingue la canapa destinataad usi agroindustriali e terapeutici eil chemiotipo THC caratterizzatodall'enzima THCA-sintetasi pre-sente nelle variet di cannabis desti-nate a produrre droga emedicamenti. L'ibrido f1 manifestala contemporanea presenza di en-trambi i maggiori cannabinoidiCBD e THC confermando l'aspettopolitipico della cannabis.
I preparati psicoattivi come l'ha-shish e la marijuana sono costituitidalla resina e dalle infiorescenzefemminili ottenuti appunto dal ge-notipo THCA-sintetasi.
la iuta.La coltivazione della canapa
ha una filiera lunga. oltre alla carta, alluso nei pro-
cessi di decontaminazione del-lambiente, al carburante verde,alle applicazioni in edilizia, la ca-napa si trasforma in fibre percorde, tessuti, legno e geotessilia uso forestale per le applicazionidingegneria naturalistica e la
produzione di bioplastiche rici-clabili in sostituzione dei derivatidel petrolio.
intanto le ricerche vannoavanti e la diusione della pro-duzione di canapa, oltre che avantaggi economici in termini diuso industriale, commercializza-zione e creazione di lavoro por-ter certamente a nuoveapplicazioni e nuove prospettive.
Si creata inpaSSato unatotaleconfuSionetra cannaBiSSativa da cuiSi ricavano lefiBre e lacannaBiSindica da cui,invece, Siottengonodroghe
[
febbraio 2013
politicadomani
fibre di canapa per isolanti acustici
a cura di Marco Battiato
raccolta della canapa nel bolognese
![ISPANISMI NEL DIALETTO NAPOLETANO - ilc.it Riccio - Ispanismi nel napoletano.pdf · direttamente assunti dal napoletano. S.v. per es.: abboscà[re] ... La DEFINIZIONE di norma ripresa](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5c6c31a209d3f2a1458c5458/ispanismi-nel-dialetto-napoletano-ilcit-riccio-ispanismi-nel-direttamente.jpg)