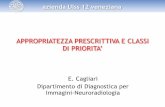Condizioni di sostenibilità sociale della sostenibilità prescrittiva
-
Upload
giacomo-gubert -
Category
Documents
-
view
7 -
download
0
description
Transcript of Condizioni di sostenibilità sociale della sostenibilità prescrittiva
-
CONDIZIONI DI SOSTENIBILIT SOCIALE
DELLA SOSTENIBILIT PRESCRITTIVA.
Alcune osservazioni sui rifiuti solidi urbani e sulla transizione demografica.
Abstract: il discorso sociale sulla sostenibilit deve sottostare a due condizioni di sostenibilit sociale:
la prima attribuibile a Niklas Luhmann, concernente il divieto di dedifferenziazione; la seconda,
sovraordinata, presentata da Robert Spaemann, riguarda la questione dei fini e la riconquista dell'umano.
Alla luce di queste considerazioni si possono interpretare alcuni risultati di un'indagine microsociologica
sull'azione di separazione dei rifiuti domestici, condotta dall'autore, e gli effetti perversi delle politiche
demografiche internazionali.
Giacomo Gubert, dottorando in sociologia dei fenomeni internazionali, del territorio e del
servizio sociale presso l'Universit degli studi di Trieste.
I
La presa di coscienza dei limiti intrinseci al progetto moderno ha dato l'occasione per i
pi vari e stravaganti ripensamenti: ad ogni possibile interpretazione della crisi
corrisponde un'attribuzione di responsabilit conseguente ed una proposta di soluzione
che, eliminando il male, renda possibile la salvezza dell'uomo e della societ. Emiliano
Bazzanella, sulle orme dell'irrazionalismo contemporaneo, in ci tra i pi radicali e
curiosi: l'essere stesso, a cominciare dalle categorie di Aristotele, ad essersi dimostrato
strumento di quella soggezione, esclusione e disuguaglianza1 che non solo hanno
caratterizzato il pensiero occidentale, ma hanno creato le condizioni per cui l'ecologia
stessa, cos come viene espressa attualmente, rischia di degenerare nel proprio contrario.
Non poteva egli formulare unipotesi meno falsificabile di questa, visto che nulla si dice n
nulla viene dal non essere. Tuttavia il modo migliore per mascherare queste attribuzioni
causali che, in quanto unilaterali, sono facilmente confutabili, quello di inserirle in uno
schema oppositivo temporale (in passato medioevo-modernit, ora modernit-
postmodernit): dopo l'epoca moderna, che ha compromesso la sopravvivenza stessa
dell'uomo e del pianeta, ecco quella postmoderna che, in quanto tale, dovr essere una
risposta ai pesanti problemi ereditati dal passato. Che cosa si intenda poi con questi
termini difficile dirlo: possiamo solo essere certi che non vi sia in essi nulla di certo. In
un contesto tanto fantastico, l'invenzione del concetto regolativo di sostenibilit o di
sviluppo sostenibile pu certamente lasciare delusi: non significa altro che volgere in
positivo il problema stesso che tutte queste riflessioni ha originato. La modernit fallita
perch era insostenibile, ci che seguir dovr quindi poter essere sostenuto. Toccher poi
1 Cfr. Bazzanella, 2002. 1
CONDIZIONI DI SOSTENIBILIT SOCIALE
DELLA SOSTENIBILIT PRESCRITTIVA.
Alcune osservazioni sui rifiuti solidi urbani e sulla transizione demografica.
Abstract: il discorso sociale sulla sostenibilit deve sottostare a due condizioni di sostenibilit sociale: la prima attribuibile a Niklas Luhmann, concernente il divieto di dedifferenziazione; la seconda, sovraordinata, presentata da Robert Spaemann, riguarda la questione dei fini e la riconquista dell'umano. Alla luce di queste considerazioni si possono interpretare alcuni risultati di un'indagine microsociologica sull'azione di separazione dei rifiuti domestici, condotta dall'autore, e gli effetti perversi delle politiche demografiche internazionali.
Giacomo Gubert, dottorando in sociologia dei fenomeni internazionali, del territorio e del servizio sociale presso l'Universit degli studi di Trieste.
I
La presa di coscienza dei limiti intrinseci al progetto moderno ha dato l'occasione per i pi vari e stravaganti ripensamenti: ad ogni possibile interpretazione della crisi corrisponde un'attribuzione di responsabilit conseguente ed una proposta di soluzione che, eliminando il male, renda possibile la salvezza dell'uomo e della societ. Emiliano Bazzanella, sulle orme dell'irrazionalismo contemporaneo, in ci tra i pi radicali e curiosi: l'essere stesso, a cominciare dalle categorie di Aristotele, ad essersi dimostrato strumento di quella soggezione, esclusione e disuguaglianza che non solo hanno caratterizzato il pensiero occidentale, ma hanno creato le condizioni per cui l'ecologia stessa, cos come viene espressa attualmente, rischia di degenerare nel proprio contrario. Non poteva egli formulare unipotesi meno falsificabile di questa, visto che nulla si dice n nulla viene dal non essere. Tuttavia il modo migliore per mascherare queste attribuzioni causali che, in quanto unilaterali, sono facilmente confutabili, quello di inserirle in uno schema oppositivo temporale (in passato medioevo-modernit, ora modernit-postmodernit): dopo l'epoca moderna, che ha compromesso la sopravvivenza stessa dell'uomo e del pianeta, ecco quella postmoderna che, in quanto tale, dovr essere una risposta ai pesanti problemi ereditati dal passato. Che cosa si intenda poi con questi termini difficile dirlo: possiamo solo essere certi che non vi sia in essi nulla di certo. In un contesto tanto fantastico, l'invenzione del concetto regolativo di sostenibilit o di sviluppo sostenibile pu certamente lasciare delusi: non significa altro che volgere in positivo il problema stesso che tutte queste riflessioni ha originato. La modernit fallita perch era insostenibile, ci che seguir dovr quindi poter essere sostenuto. Toccher poi al politico e allo studioso di turno riempire questo buzzword largely devoid of content dei significati pi acconci: normalmente, data l'origine del lemma, essi avranno una intonazione istituzionale riformista tecnocratica, senza tuttavia poter escludere elementi di stampo pi utopico, mistico o romantico, ivi rifugiatisi. Certamente, "nel suo significato concreto, lo sviluppo sostenibile implica che le esigenze di tutela dell'ambiente non possano impedire l'esercizio del diritto delle persone e dei popoli allo sviluppo e che, d'altra parte, in nome dello sviluppo non si possono continuare attivit devastanti per l'ecosistema"; ci non toglie il duplice fatto che, in primo luogo, spesso questo significato concreto non si ponga, lasciando spazio al puro arbitrio, e al contempo giustificandolo, e secondariamente, che esso sia in se stesso largamente indeterminabile e in quanto tale, facilmente preda di tali abusi. Ma l'aspetto dell'ideale regolativo di sostenibilit sul quale vogliamo concentrare la nostra attenzione, e per il quale esso rimane ancora all'interno del progetto moderno, la sua concezione puramente strumentale della natura. certo, "l'empiet dell'ottimismo utopico" stata abbandonata, non si crede pi che "gli alberi cresceranno sino a raggiungere il cielo", aumentata la coscienza di un limite; nondimeno il progetto di fondo permane quello cartesiano di gestione funzionale del mondo, semmai intensificato proprio in ragione della minaccia del venire meno della possibilit di vita sulla terra per noi o per le prossime generazioni. permane nell'idea di sostenibilit una dimensione utopica, ben evidenziata da Robert Spaemann: "la ricchezza del mondo il capitale che noi abbiamo da amministrare con fedelt. Ci consentito vivere degli interessi che esso produce, ma non di distruggerlo nella sua sostanza. tipica della hybris utopica anche l'idea che esistano pianificazioni globali che pensano anche ogni effetto collaterale di azioni immense. Ma quanto pi grande la pianificazione, tanto pi enormi sono gli effetti collaterali imprevedibili. Small non solo beautiful, ma sempre pi l'unica cosa responsabile, sotto il profilo della controllabilit e della correggibilit delle conseguenze." quest'ultima affermazione trova conferma negli innumerevoli casi, gi attuati e possibili, di gestione ecoefficiente di sistemi limitati, quali ad esempio le imprese.
Constatare il permanere di questa volont di dominio sulla natura non significa rifugiarsi in una contro utopia estatica, opponendo, per esprimersi in termini antropologici, un male inteso homo sapiens all'homo faber. Significa invece rendere evidente, ponendo in questo modo le basi per una difesa da essa, una corrente riduzione della realt, un'astrazione, certo necessaria alla scienza ma ultimamente dannosa all'uomo e al suo bene vivere associato; in breve: socialmente insostenibile. Scrive Spaemann: "una civilt, nella quale una tale scienza rappresenta l'accesso decisivo alla realt, una civilt a crescente contingenza, una civilt ipotetica" e oltre: "se il senso dei mezzi costituito soltanto dai fini, i quali a loro volta sono di nuovo mezzi per il conseguimento di fini ulteriori, allora il senso pu venire fondamentalmente dal futuro, e l'utopia diventa la forma del senso dominante dell'epoca". mascheramento scientifico di questa utopia la sociologia positivista che, assumendo pienamente questa riduzione della realt, "scienza che ha la sua verit nella capacit di pre-vedere. Il futuro, nella sua radicale e costitutiva insicurezza, viene reso disponibile ad un presente che pu essere operativo su di esso". il pensatore che ha concepito con grande coerenza e lucidit la societ in questi termini, Niklas Luhmann; in questo senso egli il vero erede del fondatore della sociologia, il Vicomte de Bonald. afferma Spaemann: "oggigiorno la teoria dei sistemi e la teoria evoluzionistica hanno completato il monismo moderno traendone l'ultima conseguenza. La teoria dei sistemi intende tutte le prestazioni del sistema come funzioni dell'autoaffermazione in un ambiente dal quale il sistema stesso si trova separato. Anche la differenziazione interna tra le funzioni del sistema una prestazione d'adattamento al servizio della conservazione del sistema. Gli organismi sono sistemi di questo tipo, ma anche le strutture psichiche o le formazioni sociali possono essere interpretate sistematicamente. Tuttavia interpretazione sistemica sinonimo di interpretazione funzionale alla conservazione." confrontarsi con il particolare esito dello scontro della teoria luhmanniana con la questione ecologica significa affrontare, nelle sue conseguenze ultime e insuperabili, quell'elemento di continuit tra progetto moderno e idea di sostenibilit, alla ricerca delle sue condizioni di possibilit sociale.
Il sociologo di Bielefeld, attraverso la critica svolta in comunicazione ecologica, individua una prima fondamentale condizione di sostenibilit, che si riduce, con espressione sintetica, al divieto di dedifferenziazione funzionale sia nei sottosistemi che nel sistema sociale stesso. Riassume Spaemann: "acuta e disincantata fu perci, alcuni anni fa, la sua critica al movimento ecologista, nella misura che esso cerca di pensare societ e natura come un ecosistema unitario. In un tale sistema di complessit illimitata i problemi non riuscirebbero nemmeno a trovare formulazione. Non avrebbe alcun compito, il suo sviluppo sarebbe esclusivamente naturale, uno varrebbe l'altro. Con altre parole: il discorso sul "sistema" sarebbe diventato cosi generico, da diventare vuoto. Alla luce dell'alto grado di differenziazione i problemi ecologici, come ha mostrato Luhmann, potrebbero essere solo portati pi vicini alla loro soluzione, se tradotti rispettivamente nella logica interna dei sottosistemi sociali: della politica, del diritto, dell'economia, della scienza. In ci non si deve sottacere la funzione della retorica morale. Ma essa non corrisponde alla funzione che i retorici si autoattribuiscono volentieri." questa condizione di sostenibilit, per il suo carattere essenzialmente formale, pi liberale di quanto possa sembrare: probabile che apra un campo di possibilit di adattamento della societ alla minaccia ecologica pi vasto di quello implicato dalla retorica dello sviluppo sostenibile. Essendo posta in essere tuttavia da quello che Hans Jonas ha denominato "il concetto pi vuoto di societ che sia mai stato proposto", questa condizione rischia di rimanere indeterminata se non assume come "fine e criterio l'uomo in quanto uomo, quale per natura". E questa pertanto la condizione fondamentale perch la condizione luhmanniana abbia senso. E simmetricamente perch l'idea di sostenibilit non rimanga vuota. di fatto il sociologo di Bielefeld rigetta espressamente questa possibilit assumendo egli una radicale inconoscibilit della realt, ed in particolare di quella umana. rebus sic stantibus, reinserire, anche solo come criterio ultimo, una presunta natura umana, farebbe esplodere il sistema a causa di complessit non riducibili. Si imbatte in un problema da lui stesso generato e in lui irrisolvibile. In ci l'approccio funzionale alla realt messo con le spalle al muro e costretto ad una difesa celata quanto maldestra. Luhmann esclude la possibilit di reintrodurre nel discorso sociale la riflessione sulla natura dell'uomo in quanto uomo e la questione connessa dei fini attraverso una temporalizzazione. Il sociologo di Bielefeld, dimostrando di condividere il solito pregiudizio modernista, afferma infatti che questa preoccupazione per l'uomo e per l'etica apparterebbe al pensiero della vecchia Europa e quindi ad una societ non ancora differenziata funzionalmente, ossia una societ in cui lilluminazione delle funzioni latenti non ancora compiuta e in cui pertanto la latenza ha ancora una funzione. ma proprio l'incapacit, tutta interna al suo approccio, di considerare questa dimensione dell'esistenza, che anche empiricamente non si lascia ridurre ad altro, per quanto la societ disponga di mezzi pi sofisticati per il controllo dei sistemi psichici, mostra il carattere immunitario di questo pregiudizio modernista. Una teoria basata sul cos ma anche altrimenti, una sociologia senza qualit, costretta ad affermazioni quasi deterministe sul rapporto tra semantica e forma di differenziazione sociale. ritorna lo oggi non pi possibile, fondamento della modernit assiologica, di delnociana memoria. Questa incapacit si mostra proprio a proposito della retorica morale nella comunicazione ecologica: Luhmann vede in essa la forma pi comune di dedifferenziazione, che si ripresenta, come nota ironicamente, negli anni '80 di ogni secolo, e che noi in contesto altrettanto polemico, abbiamo denominato sostenibilit prescrittiva e ideologia dell'ambientalmente corretto ci che la sostiene. Si tratta certamente di un fenomeno reale, come abbiamo avuto modo di constatare nella nostra ricerca sulla separazione dei rifiuti, di cui riferiremo sotto, tipico di alcuni attori sociali, anche istituzionali. Tuttavia non si pu non notare che esso sia in un certo modo necessitato dal suo diretto antagonista: l'unico modo infatti in cui la teoria di Luhmann, bench contenga in modo irriflesso "elementi irrinunciabili di un agire moralmente buono", pu vedere la dimensione morale della societ, proprio quello dedifferenziante, per lui massimamente inaccoglibile; a meno che non si accetti la riduzione della morale a pura comunicazione di stima o disistima. Ma proprio questa astrazione mostra che il funzionalismo sistemico "non in grado di interpretare adeguatamente il pensiero di una vita felice che orienta l'azione." se questo pensiero necessario al bene vivere associato (svolge la funzione di ci che non ha funzione) si deve superare Luhmann, e superarlo nella direzione della riscoperta di ci che il sociologo di Bielefeld a causa dei suoi presupposti non solo non pu vedere ma non pu nemmeno vedere di non vedere.
Stabilite queste due condizioni di sostenibilit, ci resta da considerare un ultima questione. Nella riflessione sino ad ora condotta, per nulla originale, ci siamo appoggiati al filosofo tedesco Robert Spaemann, che in pi occasioni, in risposta alla crisi, in particolare ecologica, del progetto moderno, "ha tentato la via di una riabilitazione del diritto naturale nella sua concezione classica e di una riproposizione di un etica eudaimonistica." ecco un suo pensiero conclusivo e riassuntivo di quanto abbiamo sino a qui esposto: "l'espansione della civilt tecnologica ancora guidata dall'utopia che vuole che tutti i danni ecologici, provocati dai suoi interventi sulla natura, possano essere risanati da ulteriori interventi, trasformando cos il rapporto di reciproca simbiosi, espresso nella parola cultura, in un rapporto di totale fattibilit. Ci sono buoni motivi per ritenere che in questo modo la specie umana si affatichi troppo e vada incontro alla fine; in ogni caso la discussione in proposito ancora aperta. E considerato che c', e che d'altra parte oggi, per la prima volta, l'ambiente umano, nel suo insieme, diventato una variabile dipendente su scala planetaria, il diritto naturale pu significare forse l'unica richiesta rivoluzionaria ancora possibile, la richiesta cio che in questa polemica l'onere della prova spetti ai fautori di ulteriori interventi espansionistici sulla natura. Probabilmente ci sarebbe inconciliabile con i rapporti di produzione capitalistici, sarebbe un argomento contro questi rapporti, ma lo sarebbe in un senso esattamente opposto a quello marxiano, che pone come criterio della sua critica proprio la progressiva espansione tecnologica. Questo vale in modo particolare per gli interventi sulla natura umana, ovvero per la manipolazione genetica. Nell'impeto del dominio progressivo della natura, l'uomo stesso, quale essere naturale, diventa infatti una variabile dipendente di questo processo, che a sua volta diventa qualcosa di radicalmente spontaneo. In questo caso il diritto naturale avrebbe la chiara funzione di contrastare la tendenza verso tale caduta, proprio rispettando la fondamentale spontaneit naturale dell'uomo stesso. La costituzione biologica dell'uomo non pu essere oggetto del nostro volere e del nostro fare, perch non disponiamo in proposito di alcun criterio."
Pur cercando la stessa risposta nei medesimi termini, Jonas assume verso di essa una posizione, non disperata, ma certamente agnostica: "nel momento in cui un tale sapere [] sull'essenza dell'uomo e tramite ci forse addirittura qualcosa dell'essenza dell'essere [] sar di nuovo parte di noi - attualmente impossibile dire quando e se lo sar -, esso potr fornire una base per il sapere altamente utile e molto necessario intorno ai fini. Fino ad allora dobbiamo vivere con la nostra povert e possiamo forse consolarci con il ricordo che gi una volta il 'so di non sapere' si rivelato come un inizio della filosofia". In un altro linguaggio ritroviamo, come presupposto implicito di questa posizione di Jonas, proprio quel pregiudizio modernista (il non essere pi possibile) che svuota di senso la teoria sistemica luhmanniana. Esso frutto di un'istanza pi esistenziale che teorica, come emerge con maggiore chiarezza nella riflessione jonasiana sull'uomo nella civilt tecnologica. l'esito ne un'analoga "non risposta" che, a vari livelli, scientifico (l'idea di sostenibilit), sociosistemico (Luhmann) e filosofico (Jonas), si ripresenta riguardo alla questione ecologica.
II
Nella prima sezione di questo intervento abbiamo indicato due condizioni di sostenibilit della sostenibilit, lasciando in ombra le specificazioni "sociale" e "prescrittiva" indicate nel titolo e assumendo uno stile assertorio piuttosto che argomentativo. Tutto ci accaduto per ragioni di brevit e per nostra incompetenza. Ora vogliamo tentare, alla luce di alcune osservazioni a carattere empirico, di dare una certa consistenza sociale e sociologica ai ragionamenti svolti. Il meno che si potr dire che esse, rispetto agli asserti generali della prima sezione, risulteranno sbiadite e ampiamente ambigue. Se in parte ci determinato dalla natura di ci di cui trattiamo (libere azioni umane, principalmente), in parte indica per un bisogno di ripensamento della scienza sociale, sia a livello teorico che metodologico, che solo agli inizi. Ho in mente, per citarne solo due, il tentativo di Emmanuele Morandi di formulare una "sociologia metafisica", che rigetti la pesante eredit positivistica e quello di Andrea M. Maccarini di rintracciare nel concreto mutamento dell'associazionismo ambientalista i segni di una nuova sociabilit e quindi dell'uscita da quellindividualismo moderno, che noi abbiamo incluso nella nostra seconda condizione di sostenibilit. I due casi a cui ci riferiremo, sono peraltro molto eterogenei: nel primo si tratta di una delle pi semplici azioni proambientali, la separazione dei rifiuti domestici; nel secondo di un evento fondamentale nella vita delle persone, azione per la quale non vi possono essere motivi sufficienti, che la procreazione. Diversa anche la visuale di osservazione: nel primo caso abbiamo cercato di spiegare l'azione in oggetto, nel secondo di valutare la sostenibilit delle politiche pubbliche globali volte a favorire o costringere determinate scelte riproduttive. Verso la prima azione vi una tendenza di pubblicizzazione, evidente anche normativamente, verso la seconda di separazione tra un ambito assolutamente privato, la sessualit, ed uno tendenzialmente pubblico, soprattutto l dove la forte crescita o decremento demografico hanno sottratto le nascita, collettivamente considerate, all'ambito della normalit inserendolo in quello dell'emergenza. Lilluminazione di una funzione latente ha reso problematico il suo espletamento. I due casi sono accomunati dall'essere entrambi componenti, pi o meno importanti, di quei fattori globali che formano il calcolo di sostenibilit: in ragione di ci essi sono oggetto delle sue preoccupazioni prescrittive. In particolare l'azione di separazione dei rifiuti un esempio del porsi della sostenibilit come criterio di unit dell'agire mentre nel caso demografico come ideale politico.
Il primo caso preso in esame un'azione proambientale, quella di separazione dei rifiuti domestici. Nel nostro lavoro di tesi di laurea ci siamo proposti di cercarne le ragioni. Avevamo gi partecipato ad un progetto di ricerca del genere a Lipsia; lo replicammo, apportando alcuni miglioramenti in base al pre-test tedesco, nella nostra citt natale, Trento. i risultati ottenuti, che in questa sede non ci interessano in quanto tali, furono confortanti pur essendo la ricerca piuttosto artigianale. Analizzando la comunicazione sociale (e istituzionale) concernente questa e altre azioni simili, avevamo notato la presenza di una forte componente morale, nella forma di appello ai valori, a doveri, coscienza ambientale, disposizioni, stili di vita, sensibilit, ecc. Ritenemmo ci una lesione della condizione luhmanniana di sostenibilit. Lo schema di verifica fu il seguente: se tutti questi elementi moraleggianti spiegano meno l'azione, secondo i correnti indici statistici, del calcolo delle utilit, dell'habitus, delle condizioni esterne, allora abbiamo un debole indizio della loro insostenibilit. Questa ipotesi venne sostanzialmente confermata; ma l'apporto pi significativo alla spiegazione dell'azione dovette essere attribuito alla specificazione di explicans e explicandum, oltre che alla variabile latente habitus. Alcune osservazioni a questo proposito.
1) non destano meraviglia i risultati ottenuti attraverso la specificazione. Se dal punto di vista pratico questa via non stata percorsa del tutto indarno, spingendo ad esempio l'azienda municipalizzata a rimuovere alcuni ostacoli specifici all'azione di separazione dei rifiuti organici, piuttosto che insistere con azioni di moralizzazione e informazione di natura ideologica al fine di convincere i cittadini a produrre in casa il compost; dal punto di vista sociologico si tratta di un vicolo cieco. Spiegare fatti molto particolari con caratteristiche altrettanto specifiche, non molto attraente. La specificazione il tentativo di salvare la relazione pseudocausale "disposizioni generiche motivano n comportamenti specifici" dal suo fallimento. infatti comunemente e da tempo noto che vi uno scarso legame tra disposizioni e comportamento come in generale con altre ipotetiche determinanti delle azioni ambientali. Le meta analisi di de Haan e Kuckartz per l'area tedesca, quelle di Hines, Hungerford, Tomera oltre a Six e Eckes per gli studi in lingua inglese, confermano questo fallimento: sembra che nulla dipenda da nulla o, se si desiderosi di costruire modelli di equazioni strutturali a 51 variabili manifeste e 17 latenti, che tutto dipenda da tutto. Tale dato, a cui la sociologia mi sembra del tutto assuefatta, soprattutto indicativo dei limiti metodologici della sociologia di matrice positivista. essa partecipe della lesione della seconda condizione di sostenibilit in quanto sostituisce il riferimento ad una antropologia con un modellino di azione del tutto oggettivante l'uomo. in questo modo perpetua, a livello riflesso, l'esclusione della questione dei fini dalla costruzione del sociale.
2) pur non essendoci allora del tutto chiari questi limiti della conoscenza sociologica di matrice positivista, sulla base di considerazioni logiche proponemmo una reinterpretazione del modellino antropologico, quello della teoria della scelta razionale, il cui esito ci sembra istruttivo. I teorici di questo approccio sottolineano ripetutamente che solo in questo modo possibile spiegare causalmente l'azione. Una comprensione causale dell'azione tuttavia incompatibile con il presupposto della libert dell'attore, di cui, almeno dialetticamente, i teorici della scelta razionale si fanno forti contro i sistemici. In senso proprio la spiegazione razionale dell'azione invece una comprensione per motivi ed quindi possibile solo ex post. In questo senso si oppone a quella "semantizzazione della scienza come previsione" centrale nella scienza positivista. Conoscere i motivi razionali di un'azione potr certo essere d'aiuto nel prevedere gli esiti di azioni future ma solo presupponendo quella natura umana che invece si esclude, con gli esiti oggettivanti gi tratteggiati. In questo contesto si devono inoltre ridiscutere i fondamenti della inferenza statistica nelle scienze sociali.
3) nemmeno il valore esplicativo del costrutto habitus sorprende: la separazione dei rifiuti domestici , o pu essere predisposta in modo da diventarlo, un'azione ripetitiva facilmente soggetta a routinizzazione. La presenza di habiti sospende sia il presunto calcolo delle utilit sia l'esplicito riferimento ai valori: rappresenta una sgravio dell'atto di decisione analogabile a quello dell'agire istituzionale. un indizio a favore della proficuit di una certa stabilizzazione delle pratiche socialmente definite come sostenibili (quali e quanti tipi di rifiuti separare, secondo quali modalit) e pertanto contro la diffusione di un senso di allarme sociale, confidando nella euristica della paura. Esso un elemento di quella precondizione necessaria alla vita sensata che la normalit.
Introduciamo ora il riferimento alle politiche demografiche mondiali allo scopo di mostrare l'importanza che la seconda condizione (la questione dei fini) riveste per l'idea di sostenibilit, proprio l dove si dispone di mezzi potenti per tradurla in azione. Non si tratta di fantasmi, evocati da capziose analisi di principio, n di quisquilie, ma delle concrete possibilit di vita di milioni di persone. Pochi altri fenomeni globali, come i tentativi di imporre una sostenibilit demografica, hanno causato un pari numero di lesioni dei diritti fondamentali, in primo luogo della vita, nel sostanziale assenso delle societ sviluppate, preoccupate di veder compromesso dalla crescita della popolazione il proprio livello di vita. In questa sede non ci interessa dare notizia di tali crimini ma comprendere la loro relazione con l'idea regolativa di sostenibilit. Il fatto pi interessante proprio questo assenso, rivelativo di quelle contraddizioni che noi abbiamo chiamato insostenibili.
1) per quanto riguarda i decisori collettivi di queste politiche (alcuni governi nazionali, in massima parte di tipo autoritario, alcune agenzie ONU e le ONG ad esse collegate, finanziate da stati democratici) si pu supporre una compresenza di reale preoccupazione per la sostenibilit dello sviluppo, che in un contesto di societ ipotetica, dove tutto disponibile all'uso e in assenza di una chiara nozione dell'uomo, degenera nella sua sottomissione alle esigenze di autoconservazione del sistema e di un'utilizzazione ideologica del concetto di sostenibilit, che nei paesi finanziatori pu garantire un certo consenso, al servizio di scopi del tutto differenti dalla preoccupazione ecologica. la fantasia del terrore, della paura e del potere non trova limiti se non quello di perpetuare le condizioni della sua esistenza. Per esemplificazioni rimandiamo all'opera di Barry Commoner, che su questo punto molto esplicito nella sua denuncia. disponiamo inoltre di un bellissimo studio dell'antropologa femminista Gail Kligman sulla politica demografica violentemente pronatalista di Ceauescu il cui duplice scopo fu quello s di aumentare la popolazione rumena ma soprattutto di ridefinire la distinzione pubblico/privato per ottenere il pi ampio assoggettamento possibile del cittadino allo stato. Lo stesso si pu dire, almeno nelle intenzioni, delle politiche antinataliste correnti. L'intenzione comune quella di ricondurre politicamente tutto al binomio tecnica-individuo. l'esito , in entrambi i casi, disumanizzante.
2) per quello che concerne gli effetti di queste politiche di sostenibilit disumane essi sono realmente insostenibili, perversi, fallimentari: gli interventi del premio nobel Amartya Kumar Sen lo dimostrano in modo molto convincente. che alcune agenzie ONU, ci non ostante, direttamente o indirettamente insistano su politiche coercitive, lascia pensare che i fini perseguiti non siano proprio quelli pubblicamente confessati, per i quali raccolgono finanziamenti. Nel mare di pure intenzioni che le conferenze internazionali sull'ambiente hanno prodotto, sembra che le uniche che abbiano trovato una seppur parziale applicazione siano proprio quelle maggiormente antiumane. Il moralismo ambientale su scala planetaria si accompagna al massimo di immoralit, in quanto cerca di alterare lesperienza-fondamento della cura paterna/materna, sulla quale lo stesso Jonas ha insistito nel suo tentativo di costruire unetica della responsabilit.
Concludiamo questo nostro modesto tentativo con una riflessione di Erich Voegelin: "al fine, non di rendere possibile l'impresa ma di farla apparire possibile, ogni intellettuale gnostico che elabora un programma di trasformazione del mondo deve prima di tutto costruire un quadro del mondo dal quale siano stati eliminati quei caratteri essenziali della costruzione dell'essere che farebbero apparire disperato e insensato il programma stesso." ripercorrere all'indietro, recuperando quei caratteri nella formulazione di una nuova scienza sociale, il maggior compito che il dibattito sulle condizioni della sostenibilit ci lascia in eredit.
BIBLIOGRAFIA
Allodi, Leonardo, 2002: "Postfazione. Robert Spaemann e la critica della ragione funzionalista", in R. Spaemann, 2002: 207-236.
Autiero, Antonio, 1995: "Esiste un'etica ambientale?". in V. Domenichelli, N. Olivetti Rason, C. Poli (a cura di): Diritto pubblico dell'ambiente, Cedam, Padova, pp. 7-27.
Bazzanella, Emiliano, 2002: Echologia. Introduzone a una fenomenologia della propriet e alla critica del pensiero ontologica, Asterios Editore, Trieste.
Belardinelli, Sergio, 1993: Una sociologia senza qualit. Saggi su Luhmann, FrancoAngeli, Milano.
Bondolfi, Alberto: 1998: "L'uomo di fronte alla natura e al suo sviluppo sostenibile. Alcune linee di fondo della riflessione etico-ecologica in Europa", in "Studia Patavina" 45 (1998) 1:21-37.
Cascioli, Riccardo, 1997: Il complotto demografico, Casale Monferrato, Piemme.
Commoner, Barry, 1990: Fare pace con il pianeta, Milano, Garzanti Editore.
Di Cristofaro Emilio e Paolo Trucco (a cura di), 2002: Eco-efficienza. Metodologie, strumenti, casi di successo, Guerini e Associati, Milano.
Eckes, Thomas e Six Bernd, 1994: Fakten und Fiktionen in der Eintellung-Verhaltens-Forschung: eine Meta Analyse, in Zeitschrift fr Sozialpsychologie, pp. 253-271, Bern, Hans Huber Verlag.
1996: Meta Analysen in der Einstellungs-Verhaltens-Forschung, in Zeitschrift fr Sozialpsychologie, pp. 7-17, Bern, Hans Huber Verlag.
Esty, Daniel C., 2001: "A term's Limits. (palnning of sustainable development)", in "Foreign Policy", Sept, 2001.
Golser, Karl e Heeger, Robert (a cura di), 1996: "Moralerziehung im neuen Europa", Verlag A. Weger, Brixen.
Gubert, Daniele, 1997: "Ecologia S.Profonda?", http:\\www.belder.com\dantheman\studies\ ecosprofonda.html
Gubert, Giacomo, 1999: L'azione sociale ambientalmente corretta: il caso della separazione dei rifiuti a Lipsia e Trento. Tesi di Laurea, Universit degli studi di Trento.
Haan, Gerhard de e Kuckartz, Udo, 1996: Umweltbewusstsein, Opladen, Westdeutscher Verlag.
Hines, J. M. H. R. Hungerford, A. N. Tomera, 1987: An Analysis and Synthesis of Research on Responsible Environmental Behavior: A Meta-Analysis, in The Journal of Environmental Education, pp. 1-8.
Jonas, Hans, 1999: Organismo e libert, Einaudi, Torino.
Kligman, Gail, 1998: The Politics of Duplicity, University of California Press, Berkeley.
Lindenberg, Siegwart, 1985: An Assessment of the New Political Economy: Its Potential for the Social Sciences and for Sociology in Particular, in Sociological Theory, pp. 99-114.
Madotto, Rita, 1993: Ecocapitalismo, Datanews, Roma.
Marchetti, Laura (a cura di), 2000: "Sette tesi per cambiare i Verdi (e la vita)", in "Diorama letterario", 2000 (232): 25-32.
Mckenzie-Mohr, Doug, 2000: "Promoting Sustainable Behavior: An Introduction to Community-based Social Marketing", in "Journal of Social Issues", Fall, 2000.
Morandi, Emmanuele, 2000: La societ accaduta. Tracce di una 'nuova' scienza sociale in Erich Voegelin, FrancoAngeli, Milano.
2002: L'attuarsi della societ :saggi teorici sull'azione sociale e il realismo sociologico, FrancoAngeli Milano.
Lanza, Alessandro, 1999: Lo sviluppo sostenibile, il Mulino, Bologna.
Luhmann, Niklas, 1990: Paradigm lost: ber die ethische Reflexion der Moral, Suhrkamp, Frankfurt a. M..
1992: Comunicazione ecologica. Pu la societ moderna adattarsi alle minacce ecologiche?, FrancoAngeli, Milano.
1993: Soziologische Aufklrung V Konstruktivistische Perspektiven, Westdeutscher Verlag, Opladen.
Paiva Duarte, Fernanda de, 2001: "'Save the Earth' or 'Manage the Earth'? The Politics of Environment Globality in High Modernity", in "Current Sociology", January 2001, Vol. 49(1): 91-111.
Pardi, Francesco, 1996: L'indifferenza dell'Etica, FrancoAngeli, Milano.
Poli, Corrado, 1995: "Etica ambientale: teoria, politica, pratica", in V. Domenichelli, N. Olivetti Rason, C. Poli (a cura di): Diritto pubblico dell'ambiente, Cedam, Padova, pp. 29-42.
Schooyans, Michel, 2000: Nuovo disordine mondiale, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo.
Sen, Amartya Kumar, 1995: Limbroglio demografico, in La rivista dei libri, pp. I-VIII
1997: "Azione e benessere: l'agenda dello sviluppo", in "Dimensioni dello sviluppo", XII (1), 1997: 9-24.
Sitari, Rosario, 2002: "Lo sviluppo sostenibile e le biotecnologie", in "Studium", 2002, 98 (6): 821-832.
Six, Bernd, 1992: Neuere Entwicklungen und Trends in der Einstellung-Verhaltens-Forschung, in E. H. Witte (a cura di): Einstellung und Verhalten, Braunschweig.
Spaemann, Robert, 1988; "L'empiet dell'utopismo utopico. Laudatio di Hans Jonas", in "Rivista di teologia morale", 1988, 122 (1): 15-24.
1990: Niklas Luhmanns Herausforderung der Philosophie, in N. Luhmann, 1990.
1994: Per la critica dellutopia politica, Milano, FrancoAngeli.
1998: Felicit e Benevolenza, Vita e Pensiero, Milano.
2002: L'origine della sociologia dallo spirito della Restaurazione, Laterza, Bari.
Spaemann, Robert und Reinhard Lw, 1991: "Die Frage Wozu?", Piper, Mnchen.
Veneziani, Marcello, 1990: Processo all'Occidente, SugarCo Edizioni, Milano.
Voegelin, Eric, 1968: La nuova scienza politica, Torino, Borla Editore.
1970: "Il mito del mondo nuovo", Rusconi, Milano.
Cfr. Bazzanella, 2002.
La societ non tollera vuoti. Scrive Daniel Esty: "Yet, for all its laudable goals and initial fanfare, sutainable development has become a buzzword largely devoid of content. A recent Internet search generated 570,000 hits on a term for wich there is non agreed definition. Focus groups and surveys show that the public has no idea what it means. " in Esty, 2001.
Cfr. de Paiva Duarte, 2001.
Per una panoramica divulgativa, sintetica e critica, prevalentemente italiana, delle colorazioni del pensiero ecologista cfr. M. Veneziani, 1990: 104-122. Una curiosa descrizione della galassia ideologica (deep) ecologista cfr. D. Gubert, 1997.
Sitari, 2002: 821.
Forse l'elemento capace di far uscire da questo quadro il concetto di irreversibilit, nella sua interpretazione non puramente utilitarista.
Cfr. Spaemann, 1988. La fine dell'utopia della crescita esponenziale illimitata, che significa la separazione del progetto emancipatorio moderno, contro il quale Spaemann si a pi riprese battuto, da quello tecnocratico, non per questo senza significato; sembra tuttavia che proprio il concetto-ombrello di sviluppo sostenibile riesca ad occultare il fallimento di questo ideale modernista
Si tratta di una espressione idiomatica tedesca, usata da Spaemann e tradotta tale e quale da Autiero.
Dello stesso avviso sono gli estensori delle "Sette tesi per cambiare i Verdi (e la vita)", secondo le quali l'espressione "sviluppo sostenibile" un ossimoro. Scrivono infatti: "Tale categoria si fonda sulla analisi economica classica del rapporto costi/benefici e sull'idea che l'espansione e l'accelerazione economica debba svolgersi a beneficio della generazione presente senza per compromettere la possibilit delle generazioni future di attingere a questo deposito strumentale che la natura, risorsa, non pi inesauribile ma limitata, per la soddisfazione dei bisogni umani. Una idea apparentemente nobile che nasconde, lo sostiene Wolfgang Sachs, la preoccupazione non tanto per la durata della Natura, ma per la durata della produzione, perch tramite la tutela della risorsa, venga data garanzia anche alle generazioni future di continuare a perseguire, nonostante i rischi di scarsit, questo attuale modello di crescita e di sviluppo -di malsviluppo;" in Laura Marchetti (a cura di), 2000: 25-32. Essi tuttavia credono di trovare risposta rifugiandosi nell'utopia.
Spaemann, 1988: 20. Essere responsabili di tutto si inverte in una totale irresponsabilit. Cfr. Spaemann, 1994.
Cfr. Di Cristofaro e Trucco (a cura di), 2002.
Un'analisi piuttosto critica delle prospettive di questo ecocapitalismo in Madotto, 1993.
Spaemann, 1994: 43.
Ibid.: 44.
Morandi, 2002: 243.
Cfr. Spaemann, 2002.
Con "monismo moderno" Spaemann si riferisce al livellamento della distinzione tra vita e vita buona, da lui descritta come una inversione della teleologia. Cfr. Spaemann e Lw, 1991.
Spaemann, 1998: 64-65.
Spaemann, 1990: 70-71. Traduzione nostra. Il testo della Laudatio stato tradotto passim in Spaemann 2002 da Allodi. Una sua traduzione integrale di prossima pubblicazione.
In una risposta a Belardinelli, Luhmann chiarisce in poche battute il suo concetto non quantitativo di dedifferenziazione. Cfr. Belardinelli, 1993.
Jonas, 1999: 169.
Cfr. Spaemann, 1994: 184.
Di fatto vi gi un'attenzione crescente allo sviluppo umano che si propone di orientare il discorso sulla sostenibilit. Mi sembra tuttavia che essa si arresti ad un livello o retorico o ancorato alla pura soddisfazione dei bisogni primari; incontra cio la difficolt di non conoscere ci che cerca di promuovere. Sintomo di ci l'affidarsi ad obiettivi utopici come quello della progressiva ed illimitata emancipazione, secondo il modello della societ opulenta occidentale.
Cfr. Luhmann, 1993. Ci sarebbe da domandarsi quanto i presupposti costruttivisti di Luhmann possano essere separati dalla teoria dei sistemi, costituendone l'aspetto pi irragionevole. La distinzione realista voegeliniana tra conoscenza prenoetica, costitutiva, e noetica della societ mi sembra andare in questa direzione; cfr. Morandi, 2000 e 2002.
Cfr. Spaemann, 1985: 10.
Non che Luhmann condivida un tale determinismo comtiano, tuttavia questo assunto talmente fondamentale nel suo sistema che non pu essere difeso che con una tale immunizzazione, persino contraddittoria con tutto il suo stile di pensiero. Del resto tutto ci non che individuare un possibile punto di emersione di quel necessario momento di incondizionatezza, senza il quale il sistema funzionale annullerebbe lo stesso pensiero del sistema funzionale. Cfr. R. Spaemann, 1998: 195.
Cfr. G. Gubert, 1999.
Golser, 1996: 169. Traduzione nostra.
Spaemann, 1998: 65.
Il superamento riguarda pi i presupposti che la teoria stessa, non illudendosi che una tale confutazione di principio possa mettere in crisi in impianto tanto imponente. Esso invece in grado di mostrare l'esistenza di uno spazio per iniziare una sociologia reincludendo proprio quei presupposti che sono stati superati.
Allodi, 2002: 236.
Spaemann, 1994: 188. La riscoperta della natura umana non ha solo valore negativo di limite ma anche positivo di prima risorsa dello sviluppo. A livello macro ci si mostra nella relazione positiva tra densit di popolazione e sviluppo.
Jonas, 1999: 262.
Tuttavia ci che Jonas interpreta come una impossibilit, Spaemann riconosce come un guasto nella autocomprensione dell'agire, a cui proprio il recupero di ci che la crisi attuale mostra essere solo pregiudizialmente "modernamente impossibile" pu porre rimedio. Cfr. Spaemann, 1998: 185-201
In tutt'altro contesto, Coleman sembra avvalorare la nostra seconda condizione di sostenibilit, quando riflette sugli effetti della nuova struttura sociale, in cui dominano gli attori corporati "funzionalmente differenziati", che sembrano incapaci di rendersi responsabili della globalit della persona, sulle nuove generazioni e, nelle terminologia propria di questo Autore, sulla formazione del capitale sociale. Cfr. Coleman, 1995 (II): 358-363.
Morandi, 2000 e 2002.
Cfr. Maccarini, 1997.
Cfr. per l'equazione base di sostenibilit Commoner, 1990: 187.
Per l'illustrazione di particolari e risultati delle due indagini postali, cfr. G. Gubert, 1999.
Accompagnata da un sentimento personale di irritazione; esso aveva due ragioni. 1) Una valutazione comparativa: tutta questa retorica in campo ambientale contrasta fortemente con la modalizzazione di ampi ambiti della vita sociale e personale, con una societ che si dice caratterizzata dalla fine dell'idea stessa di dovere o un mondo moderno in cui la Morale ha cessato di essere il fondamento della prescrizione obbligante e dell'integrazione sociale, come scrive Pardi, 1996. 2) Una convinzione: una tale moralizzazione non solo ingiusta ma persino controproducente. Se il risultato che si vuole ottenere una maggiore frequenza di azioni proambientali, l'appello ai valori, alle norme, alla coscienza, alla sensibilit sembra essere una confessione di impotenza pi che un contributo al suo raggiungimento.
Per l'analisi di un caso analogo cfr. Mckenzie-Mohr, 2000
Cfr. Gubert e Struffi, 1986.
de Haan e Kuckartz, 1997
Hines et al., 1987.
Six, 1992 e Eckes, 1994.
Si continuano a pubblicare spiegazioni causali che spiegano percentuali ridicole di varianza.
Cfr. Voegelin, 1968.
Cfr. Lindenberg. 1985 per la tripartizione RREEMM, SRSM e OSAM dei modellini antropologici pi comuni della ricerca sociologica. Certamente il modello della scelta razionale, soprattutto se non interpretato causalmente, presenta il vantaggio di essere pi rispettoso della libert e dignit dell'agente, guadagnando con ci anche in esplicativit, limitatamente ad azioni e sistemi di azione relativamente semplici.
Per questa argomentazione mi sono riferito alle opere di von Kutschera, 1981, 1991, 1993. Simile ma meno radicale, ci sembra la posizione assunta da Boudon, 1985 e 1995.
Morandi, 2002: 246.
Rimandiamo alle opere di denuncia sociale di Cascioli, 1997 e Schooyans, 2000.
In buona parte si tratta di decisori sottratti al voto democratico di coloro che dovrebbero rappresentare.
L'esito della totale emancipazione dell'uomo dalla natura la ricaduta nello stato di natura, nel puro dominio dell'uomo sull'uomo.
Commoner, 1990: 179-206.
Cfr. Kligman, 1998.
Cfr. Maccarini, 1997: 153-182.
Cfr. Sen, 1995 e 1997. Mi sembra tuttavia che nelle strategie di empowerment permanga una componente utopica emancipatoria prettamente moderna.
Cfr. Voegelin, 1990: 25.
PAGE
1
PP. CARMELITANISostenibilit dellla sostenibilit.doc
-
al politico e allo studioso di turno riempire questo buzzword largely devoid of content2 dei
significati pi acconci: normalmente, data l'origine del lemma, essi avranno una
intonazione istituzionale riformista tecnocratica3, senza tuttavia poter escludere elementi
di stampo pi utopico, mistico o romantico, ivi rifugiatisi4. Certamente, "nel suo significato
concreto, lo sviluppo sostenibile implica che le esigenze di tutela dell'ambiente non
possano impedire l'esercizio del diritto delle persone e dei popoli allo sviluppo e che,
d'altra parte, in nome dello sviluppo non si possono continuare attivit devastanti per
l'ecosistema"5; ci non toglie il duplice fatto che, in primo luogo, spesso questo significato
concreto non si ponga, lasciando spazio al puro arbitrio, e al contempo giustificandolo, e
secondariamente, che esso sia in se stesso largamente indeterminabile e in quanto tale,
facilmente preda di tali abusi. Ma l'aspetto dell'ideale regolativo di sostenibilit sul quale
vogliamo concentrare la nostra attenzione, e per il quale esso rimane ancora all'interno del
progetto moderno, la sua concezione puramente strumentale della natura.6 certo,
"l'empiet dell'ottimismo utopico"7 stata abbandonata, non si crede pi che "gli alberi
cresceranno sino a raggiungere il cielo"8, aumentata la coscienza di un limite;
nondimeno il progetto di fondo permane quello cartesiano di gestione funzionale del
mondo, semmai intensificato proprio in ragione della minaccia del venire meno della
possibilit di vita sulla terra per noi o per le prossime generazioni.9 permane nell'idea di
sostenibilit una dimensione utopica, ben evidenziata da Robert Spaemann: "la ricchezza
del mondo il capitale che noi abbiamo da amministrare con fedelt. Ci consentito
vivere degli interessi che esso produce, ma non di distruggerlo nella sua sostanza. tipica
2 La societ non tollera vuoti. Scrive Daniel Esty: "Yet, for all its laudable goals and initial fanfare, sutainable development has become a buzzword largely devoid of content. A recent Internet search generated 570,000 hits on a term for wich there is non agreed definition. Focus groups and surveys show that the public has no idea what it means. " in Esty, 2001. 3Cfr. de Paiva Duarte, 2001. 4 Per una panoramica divulgativa, sintetica e critica, prevalentemente italiana, delle colorazioni del pensiero ecologista cfr. M. Veneziani, 1990: 104-122. Una curiosa descrizione della galassia ideologica (deep) ecologista cfr. D. Gubert, 1997. 5 Sitari, 2002: 821. 6 Forse l'elemento capace di far uscire da questo quadro il concetto di irreversibilit, nella sua interpretazione non puramente utilitarista. 7 Cfr. Spaemann, 1988. La fine dell'utopia della crescita esponenziale illimitata, che significa la separazione del progetto emancipatorio moderno, contro il quale Spaemann si a pi riprese battuto, da quello tecnocratico, non per questo senza significato; sembra tuttavia che proprio il concetto-ombrello di sviluppo sostenibile riesca ad occultare il fallimento di questo ideale modernista 8 Si tratta di una espressione idiomatica tedesca, usata da Spaemann e tradotta tale e quale da Autiero. 9 Dello stesso avviso sono gli estensori delle "Sette tesi per cambiare i Verdi (e la vita)", secondo le quali l'espressione "sviluppo sostenibile" un ossimoro. Scrivono infatti: "Tale categoria si fonda sulla analisi economica classica del rapporto costi/benefici e sull'idea che l'espansione e l'accelerazione economica debba svolgersi a beneficio della generazione presente senza per compromettere la possibilit delle generazioni future di attingere a questo deposito strumentale che la natura, risorsa, non pi inesauribile ma limitata, per la soddisfazione dei bisogni umani. Una idea apparentemente nobile che nasconde, lo sostiene Wolfgang Sachs, la preoccupazione non tanto per la durata della Natura, ma per la durata della produzione, perch tramite la tutela della risorsa, venga data garanzia anche alle generazioni future di continuare a perseguire, nonostante i rischi di scarsit, questo attuale modello di crescita e di sviluppo -di malsviluppo;" in Laura Marchetti (a cura di), 2000: 25-32. Essi tuttavia credono di trovare risposta rifugiandosi nell'utopia. 2
-
della hybris utopica anche l'idea che esistano pianificazioni globali che pensano anche ogni
effetto collaterale di azioni immense. Ma quanto pi grande la pianificazione, tanto pi
enormi sono gli effetti collaterali imprevedibili. Small non solo beautiful, ma sempre
pi l'unica cosa responsabile, sotto il profilo della controllabilit e della correggibilit delle
conseguenze."10 quest'ultima affermazione trova conferma negli innumerevoli casi, gi
attuati e possibili, di gestione ecoefficiente11 di sistemi limitati, quali ad esempio le
imprese.12
Constatare il permanere di questa volont di dominio sulla natura non significa
rifugiarsi in una contro utopia estatica, opponendo, per esprimersi in termini antropologici,
un male inteso homo sapiens all'homo faber. Significa invece rendere evidente, ponendo
in questo modo le basi per una difesa da essa, una corrente riduzione della realt,
un'astrazione, certo necessaria alla scienza ma ultimamente dannosa all'uomo e al suo
bene vivere associato; in breve: socialmente insostenibile. Scrive Spaemann: "una civilt,
nella quale una tale scienza rappresenta l'accesso decisivo alla realt, una civilt a
crescente contingenza, una civilt ipotetica"13 e oltre: "se il senso dei mezzi costituito
soltanto dai fini, i quali a loro volta sono di nuovo mezzi per il conseguimento di fini
ulteriori, allora il senso pu venire fondamentalmente dal futuro, e l'utopia diventa la
forma del senso dominante dell'epoca".14 mascheramento scientifico di questa utopia la
sociologia positivista che, assumendo pienamente questa riduzione della realt, "scienza
che ha la sua verit nella capacit di pre-vedere. Il futuro, nella sua radicale e costitutiva
insicurezza, viene reso disponibile ad un presente che pu essere operativo su di esso".15
il pensatore che ha concepito con grande coerenza e lucidit la societ in questi termini,
Niklas Luhmann; in questo senso egli il vero erede del fondatore della sociologia, il
Vicomte de Bonald.16 afferma Spaemann: "oggigiorno la teoria dei sistemi e la teoria
evoluzionistica hanno completato il monismo moderno17 traendone l'ultima conseguenza.
La teoria dei sistemi intende tutte le prestazioni del sistema come funzioni
dell'autoaffermazione in un ambiente dal quale il sistema stesso si trova separato. Anche
la differenziazione interna tra le funzioni del sistema una prestazione d'adattamento al
servizio della conservazione del sistema. Gli organismi sono sistemi di questo tipo, ma
anche le strutture psichiche o le formazioni sociali possono essere interpretate
sistematicamente. Tuttavia interpretazione sistemica sinonimo di interpretazione
10 Spaemann, 1988: 20. Essere responsabili di tutto si inverte in una totale irresponsabilit. Cfr. Spaemann, 1994. 11 Cfr. Di Cristofaro e Trucco (a cura di), 2002. 12 Un'analisi piuttosto critica delle prospettive di questo ecocapitalismo in Madotto, 1993. 13 Spaemann, 1994: 43. 14 Ibid.: 44. 15 Morandi, 2002: 243. 16 Cfr. Spaemann, 2002. 17Con "monismo moderno" Spaemann si riferisce al livellamento della distinzione tra vita e vita buona, da lui descritta come una inversione della teleologia. Cfr. Spaemann e Lw, 1991. 3
-
funzionale alla conservazione."18 confrontarsi con il particolare esito dello scontro della
teoria luhmanniana con la questione ecologica significa affrontare, nelle sue conseguenze
ultime e insuperabili, quell'elemento di continuit tra progetto moderno e idea di
sostenibilit, alla ricerca delle sue condizioni di possibilit sociale.
Il sociologo di Bielefeld, attraverso la critica svolta in comunicazione ecologica,
individua una prima fondamentale condizione di sostenibilit, che si riduce, con
espressione sintetica, al divieto di dedifferenziazione funzionale sia nei sottosistemi che
nel sistema sociale stesso. Riassume Spaemann: "acuta e disincantata fu perci, alcuni
anni fa, la sua critica al movimento ecologista, nella misura che esso cerca di pensare
societ e natura come un ecosistema unitario. In un tale sistema di complessit illimitata i
problemi non riuscirebbero nemmeno a trovare formulazione. Non avrebbe alcun compito,
il suo sviluppo sarebbe esclusivamente naturale, uno varrebbe l'altro. Con altre parole: il
discorso sul "sistema" sarebbe diventato cosi generico, da diventare vuoto. Alla luce
dell'alto grado di differenziazione i problemi ecologici, come ha mostrato Luhmann,
potrebbero essere solo portati pi vicini alla loro soluzione, se tradotti rispettivamente
nella logica interna dei sottosistemi sociali: della politica, del diritto, dell'economia, della
scienza. In ci non si deve sottacere la funzione della retorica morale. Ma essa non
corrisponde alla funzione che i retorici si autoattribuiscono volentieri."19 questa condizione
di sostenibilit, per il suo carattere essenzialmente formale20, pi liberale di quanto
possa sembrare: probabile che apra un campo di possibilit di adattamento della societ
alla minaccia ecologica pi vasto di quello implicato dalla retorica dello sviluppo
sostenibile. Essendo posta in essere tuttavia da quello che Hans Jonas ha denominato "il
concetto pi vuoto di societ che sia mai stato proposto",21 questa condizione rischia di
rimanere indeterminata se non assume come "fine e criterio l'uomo in quanto uomo, quale
per natura"22. E questa pertanto la condizione fondamentale perch la condizione
luhmanniana abbia senso. E simmetricamente perch l'idea di sostenibilit non rimanga
vuota.23 di fatto il sociologo di Bielefeld rigetta espressamente questa possibilit
assumendo egli una radicale inconoscibilit della realt, ed in particolare di quella
18 Spaemann, 1998: 64-65. 19 Spaemann, 1990: 70-71. Traduzione nostra. Il testo della Laudatio stato tradotto passim in Spaemann 2002 da Allodi. Una sua traduzione integrale di prossima pubblicazione. 20 In una risposta a Belardinelli, Luhmann chiarisce in poche battute il suo concetto non quantitativo di dedifferenziazione. Cfr. Belardinelli, 1993. 21 Jonas, 1999: 169. 22 Cfr. Spaemann, 1994: 184. 23 Di fatto vi gi un'attenzione crescente allo sviluppo umano che si propone di orientare il discorso sulla sostenibilit. Mi sembra tuttavia che essa si arresti ad un livello o retorico o ancorato alla pura soddisfazione dei bisogni primari; incontra cio la difficolt di non conoscere ci che cerca di promuovere. Sintomo di ci l'affidarsi ad obiettivi utopici come quello della progressiva ed illimitata emancipazione, secondo il modello della societ opulenta occidentale. 4
-
umana.24 rebus sic stantibus, reinserire, anche solo come criterio ultimo, una presunta
natura umana, farebbe esplodere il sistema a causa di complessit non riducibili. Si
imbatte in un problema da lui stesso generato e in lui irrisolvibile. In ci l'approccio
funzionale alla realt messo con le spalle al muro e costretto ad una difesa celata quanto
maldestra. Luhmann esclude la possibilit di reintrodurre nel discorso sociale la riflessione
sulla natura dell'uomo in quanto uomo e la questione connessa dei fini attraverso una
temporalizzazione. Il sociologo di Bielefeld, dimostrando di condividere il solito pregiudizio
modernista, afferma infatti che questa preoccupazione per l'uomo e per l'etica
apparterebbe al pensiero della vecchia Europa e quindi ad una societ non ancora
differenziata funzionalmente, ossia una societ in cui lilluminazione delle funzioni latenti
non ancora compiuta e in cui pertanto la latenza ha ancora una funzione.25 ma proprio
l'incapacit, tutta interna al suo approccio, di considerare questa dimensione
dell'esistenza, che anche empiricamente non si lascia ridurre ad altro, per quanto la
societ disponga di mezzi pi sofisticati per il controllo dei sistemi psichici, mostra il
carattere immunitario di questo pregiudizio modernista. Una teoria basata sul cos ma
anche altrimenti, una sociologia senza qualit, costretta ad affermazioni quasi
deterministe sul rapporto tra semantica e forma di differenziazione sociale.26 ritorna lo
oggi non pi possibile, fondamento della modernit assiologica, di delnociana
memoria. Questa incapacit si mostra proprio a proposito della retorica morale nella
comunicazione ecologica: Luhmann vede in essa la forma pi comune di
dedifferenziazione, che si ripresenta, come nota ironicamente, negli anni '80 di ogni
secolo, e che noi in contesto altrettanto polemico, abbiamo denominato sostenibilit
prescrittiva e ideologia dell'ambientalmente corretto ci che la sostiene27. Si tratta
certamente di un fenomeno reale, come abbiamo avuto modo di constatare nella nostra
ricerca sulla separazione dei rifiuti, di cui riferiremo sotto, tipico di alcuni attori sociali,
anche istituzionali. Tuttavia non si pu non notare che esso sia in un certo modo
necessitato dal suo diretto antagonista: l'unico modo infatti in cui la teoria di Luhmann,
bench contenga in modo irriflesso "elementi irrinunciabili di un agire moralmente
buono"28, pu vedere la dimensione morale della societ, proprio quello
dedifferenziante, per lui massimamente inaccoglibile; a meno che non si accetti la
24 Cfr. Luhmann, 1993. Ci sarebbe da domandarsi quanto i presupposti costruttivisti di Luhmann possano essere separati dalla teoria dei sistemi, costituendone l'aspetto pi irragionevole. La distinzione realista voegeliniana tra conoscenza prenoetica, costitutiva, e noetica della societ mi sembra andare in questa direzione; cfr. Morandi, 2000 e 2002. 25 Cfr. Spaemann, 1985: 10. 26 Non che Luhmann condivida un tale determinismo comtiano, tuttavia questo assunto talmente fondamentale nel suo sistema che non pu essere difeso che con una tale immunizzazione, persino contraddittoria con tutto il suo stile di pensiero. Del resto tutto ci non che individuare un possibile punto di emersione di quel necessario momento di incondizionatezza, senza il quale il sistema funzionale annullerebbe lo stesso pensiero del sistema funzionale. Cfr. R. Spaemann, 1998: 195. 27 Cfr. G. Gubert, 1999. 28 Golser, 1996: 169. Traduzione nostra. 5
-
riduzione della morale a pura comunicazione di stima o disistima. Ma proprio questa
astrazione mostra che il funzionalismo sistemico "non in grado di interpretare
adeguatamente il pensiero di una vita felice che orienta l'azione."29 se questo pensiero
necessario al bene vivere associato (svolge la funzione di ci che non ha funzione) si deve
superare Luhmann, e superarlo nella direzione della riscoperta di ci che il sociologo di
Bielefeld a causa dei suoi presupposti non solo non pu vedere ma non pu nemmeno
vedere di non vedere.30
Stabilite queste due condizioni di sostenibilit, ci resta da considerare un ultima
questione. Nella riflessione sino ad ora condotta, per nulla originale, ci siamo appoggiati al
filosofo tedesco Robert Spaemann, che in pi occasioni, in risposta alla crisi, in particolare
ecologica, del progetto moderno, "ha tentato la via di una riabilitazione del diritto naturale
nella sua concezione classica e di una riproposizione di un etica eudaimonistica."31 ecco un
suo pensiero conclusivo e riassuntivo di quanto abbiamo sino a qui esposto: "l'espansione
della civilt tecnologica ancora guidata dall'utopia che vuole che tutti i danni ecologici,
provocati dai suoi interventi sulla natura, possano essere risanati da ulteriori interventi,
trasformando cos il rapporto di reciproca simbiosi, espresso nella parola cultura, in un
rapporto di totale fattibilit. Ci sono buoni motivi per ritenere che in questo modo la specie
umana si affatichi troppo e vada incontro alla fine; in ogni caso la discussione in proposito
ancora aperta. E considerato che c', e che d'altra parte oggi, per la prima volta,
l'ambiente umano, nel suo insieme, diventato una variabile dipendente su scala
planetaria, il diritto naturale pu significare forse l'unica richiesta rivoluzionaria ancora
possibile, la richiesta cio che in questa polemica l'onere della prova spetti ai fautori di
ulteriori interventi espansionistici sulla natura. Probabilmente ci sarebbe inconciliabile con
i rapporti di produzione capitalistici, sarebbe un argomento contro questi rapporti, ma lo
sarebbe in un senso esattamente opposto a quello marxiano, che pone come criterio della
sua critica proprio la progressiva espansione tecnologica. Questo vale in modo particolare
per gli interventi sulla natura umana, ovvero per la manipolazione genetica. Nell'impeto
del dominio progressivo della natura, l'uomo stesso, quale essere naturale, diventa infatti
una variabile dipendente di questo processo, che a sua volta diventa qualcosa di
radicalmente spontaneo. In questo caso il diritto naturale avrebbe la chiara funzione di
contrastare la tendenza verso tale caduta, proprio rispettando la fondamentale
spontaneit naturale dell'uomo stesso. La costituzione biologica dell'uomo non pu essere
29 Spaemann, 1998: 65. 30 Il superamento riguarda pi i presupposti che la teoria stessa, non illudendosi che una tale confutazione di principio possa mettere in crisi in impianto tanto imponente. Esso invece in grado di mostrare l'esistenza di uno spazio per iniziare una sociologia reincludendo proprio quei presupposti che sono stati superati. 31 Allodi, 2002: 236. 6
-
oggetto del nostro volere e del nostro fare, perch non disponiamo in proposito di alcun
criterio."32
Pur cercando la stessa risposta nei medesimi termini, Jonas assume verso di essa una
posizione, non disperata, ma certamente agnostica: "nel momento in cui un tale sapere
[] sull'essenza dell'uomo e tramite ci forse addirittura qualcosa dell'essenza dell'essere
[] sar di nuovo parte di noi - attualmente impossibile dire quando e se lo sar -, esso
potr fornire una base per il sapere altamente utile e molto necessario intorno ai fini. Fino
ad allora dobbiamo vivere con la nostra povert e possiamo forse consolarci con il ricordo
che gi una volta il 'so di non sapere' si rivelato come un inizio della filosofia"33. In un
altro linguaggio ritroviamo, come presupposto implicito di questa posizione di Jonas,
proprio quel pregiudizio modernista (il non essere pi possibile) che svuota di senso la
teoria sistemica luhmanniana. Esso frutto di un'istanza pi esistenziale che teorica, come
emerge con maggiore chiarezza nella riflessione jonasiana sull'uomo nella civilt
tecnologica.34 l'esito ne un'analoga "non risposta" che, a vari livelli, scientifico (l'idea di
sostenibilit), sociosistemico (Luhmann) e filosofico (Jonas), si ripresenta riguardo alla
questione ecologica.
II
Nella prima sezione di questo intervento abbiamo indicato due condizioni di
sostenibilit della sostenibilit, lasciando in ombra le specificazioni "sociale"35 e
"prescrittiva" indicate nel titolo e assumendo uno stile assertorio piuttosto che
argomentativo. Tutto ci accaduto per ragioni di brevit e per nostra incompetenza. Ora
vogliamo tentare, alla luce di alcune osservazioni a carattere empirico, di dare una certa
consistenza sociale e sociologica ai ragionamenti svolti. Il meno che si potr dire che
esse, rispetto agli asserti generali della prima sezione, risulteranno sbiadite e ampiamente
ambigue. Se in parte ci determinato dalla natura di ci di cui trattiamo (libere azioni
umane, principalmente), in parte indica per un bisogno di ripensamento della scienza
sociale, sia a livello teorico che metodologico, che solo agli inizi. Ho in mente, per
citarne solo due, il tentativo di Emmanuele Morandi36 di formulare una "sociologia
32 Spaemann, 1994: 188. La riscoperta della natura umana non ha solo valore negativo di limite ma anche positivo di prima risorsa dello sviluppo. A livello macro ci si mostra nella relazione positiva tra densit di popolazione e sviluppo. 33 Jonas, 1999: 262. 34 Tuttavia ci che Jonas interpreta come una impossibilit, Spaemann riconosce come un guasto nella autocomprensione dell'agire, a cui proprio il recupero di ci che la crisi attuale mostra essere solo pregiudizialmente "modernamente impossibile" pu porre rimedio. Cfr. Spaemann, 1998: 185-201 35 In tutt'altro contesto, Coleman sembra avvalorare la nostra seconda condizione di sostenibilit, quando riflette sugli effetti della nuova struttura sociale, in cui dominano gli attori corporati "funzionalmente differenziati", che sembrano incapaci di rendersi responsabili della globalit della persona, sulle nuove generazioni e, nelle terminologia propria di questo Autore, sulla formazione del capitale sociale. Cfr. Coleman, 1995 (II): 358-363. 36 Morandi, 2000 e 2002. 7
-
metafisica", che rigetti la pesante eredit positivistica e quello di Andrea M. Maccarini37 di
rintracciare nel concreto mutamento dell'associazionismo ambientalista i segni di una
nuova sociabilit e quindi dell'uscita da quellindividualismo moderno, che noi abbiamo
incluso nella nostra seconda condizione di sostenibilit. I due casi a cui ci riferiremo, sono
peraltro molto eterogenei: nel primo si tratta di una delle pi semplici azioni
proambientali, la separazione dei rifiuti domestici; nel secondo di un evento fondamentale
nella vita delle persone, azione per la quale non vi possono essere motivi sufficienti, che
la procreazione. Diversa anche la visuale di osservazione: nel primo caso abbiamo
cercato di spiegare l'azione in oggetto, nel secondo di valutare la sostenibilit delle
politiche pubbliche globali volte a favorire o costringere determinate scelte riproduttive.
Verso la prima azione vi una tendenza di pubblicizzazione, evidente anche
normativamente, verso la seconda di separazione tra un ambito assolutamente privato, la
sessualit, ed uno tendenzialmente pubblico, soprattutto l dove la forte crescita o
decremento demografico hanno sottratto le nascita, collettivamente considerate,
all'ambito della normalit inserendolo in quello dell'emergenza. Lilluminazione di una
funzione latente ha reso problematico il suo espletamento. I due casi sono accomunati
dall'essere entrambi componenti, pi o meno importanti, di quei fattori globali che
formano il calcolo di sostenibilit:38 in ragione di ci essi sono oggetto delle sue
preoccupazioni prescrittive. In particolare l'azione di separazione dei rifiuti un esempio
del porsi della sostenibilit come criterio di unit dell'agire mentre nel caso demografico
come ideale politico.
Il primo caso preso in esame un'azione proambientale, quella di separazione dei
rifiuti domestici. Nel nostro lavoro di tesi di laurea ci siamo proposti di cercarne le ragioni.
Avevamo gi partecipato ad un progetto di ricerca del genere a Lipsia; lo replicammo,
apportando alcuni miglioramenti in base al pre-test tedesco, nella nostra citt natale,
Trento.39 i risultati ottenuti, che in questa sede non ci interessano in quanto tali, furono
confortanti pur essendo la ricerca piuttosto artigianale. Analizzando la comunicazione
sociale (e istituzionale) concernente questa e altre azioni simili, avevamo notato la
presenza di una forte componente morale, nella forma di appello ai valori, a doveri,
coscienza ambientale, disposizioni, stili di vita, sensibilit, ecc. Ritenemmo ci una lesione
della condizione luhmanniana di sostenibilit40. Lo schema di verifica fu il seguente: se
37 Cfr. Maccarini, 1997. 38 Cfr. per l'equazione base di sostenibilit Commoner, 1990: 187. 39 Per l'illustrazione di particolari e risultati delle due indagini postali, cfr. G. Gubert, 1999. 40 Accompagnata da un sentimento personale di irritazione; esso aveva due ragioni. 1) Una valutazione comparativa: tutta questa retorica in campo ambientale contrasta fortemente con la modalizzazione di ampi ambiti della vita sociale e personale, con una societ che si dice caratterizzata dalla fine dell'idea stessa di dovere o un mondo moderno in cui la Morale ha cessato di essere il fondamento della prescrizione obbligante e dell'integrazione sociale, come scrive Pardi, 1996. 2) Una convinzione: una tale moralizzazione non solo ingiusta ma persino controproducente. Se il risultato che 8
-
tutti questi elementi moraleggianti spiegano meno l'azione, secondo i correnti indici
statistici, del calcolo delle utilit, dell'habitus, delle condizioni esterne, allora abbiamo un
debole indizio della loro insostenibilit. Questa ipotesi venne sostanzialmente confermata;
ma l'apporto pi significativo alla spiegazione dell'azione dovette essere attribuito alla
specificazione di explicans e explicandum, oltre che alla variabile latente habitus. Alcune
osservazioni a questo proposito.
1) non destano meraviglia i risultati ottenuti attraverso la specificazione. Se dal punto
di vista pratico questa via non stata percorsa del tutto indarno, spingendo ad esempio
l'azienda municipalizzata a rimuovere alcuni ostacoli specifici41 all'azione di separazione
dei rifiuti organici, piuttosto che insistere con azioni di moralizzazione e informazione di
natura ideologica al fine di convincere i cittadini a produrre in casa il compost; dal punto di
vista sociologico si tratta di un vicolo cieco. Spiegare fatti molto particolari con
caratteristiche altrettanto specifiche, non molto attraente. La specificazione il tentativo
di salvare la relazione pseudocausale "disposizioni generiche motivano n comportamenti
specifici" dal suo fallimento. infatti comunemente e da tempo noto42 che vi uno scarso
legame tra disposizioni e comportamento come in generale con altre ipotetiche
determinanti delle azioni ambientali. Le meta analisi di de Haan e Kuckartz43 per l'area
tedesca, quelle di Hines, Hungerford, Tomera44 oltre a Six e Eckes45 per gli studi in lingua
inglese, confermano questo fallimento: sembra che nulla dipenda da nulla o, se si
desiderosi di costruire modelli di equazioni strutturali a 51 variabili manifeste e 17 latenti,
che tutto dipenda da tutto. Tale dato, a cui la sociologia mi sembra del tutto
assuefatta46, soprattutto indicativo dei limiti metodologici della sociologia di matrice
positivista.47 essa partecipe della lesione della seconda condizione di sostenibilit in
quanto sostituisce il riferimento ad una antropologia con un modellino di azione del tutto
oggettivante l'uomo.48 in questo modo perpetua, a livello riflesso, l'esclusione della
questione dei fini dalla costruzione del sociale.
2) pur non essendoci allora del tutto chiari questi limiti della conoscenza sociologica di
matrice positivista, sulla base di considerazioni logiche proponemmo una reinterpretazione
del modellino antropologico, quello della teoria della scelta razionale, il cui esito ci sembra
si vuole ottenere una maggiore frequenza di azioni proambientali, l'appello ai valori, alle norme, alla coscienza, alla sensibilit sembra essere una confessione di impotenza pi che un contributo al suo raggiungimento. 41 Per l'analisi di un caso analogo cfr. Mckenzie-Mohr, 2000 42 Cfr. Gubert e Struffi, 1986. 43 de Haan e Kuckartz, 1997 44 Hines et al., 1987. 45 Six, 1992 e Eckes, 1994. 46 Si continuano a pubblicare spiegazioni causali che spiegano percentuali ridicole di varianza. 47 Cfr. Voegelin, 1968. 48 Cfr. Lindenberg. 1985 per la tripartizione RREEMM, SRSM e OSAM dei modellini antropologici pi comuni della ricerca sociologica. Certamente il modello della scelta razionale, soprattutto se non interpretato causalmente, presenta il vantaggio di essere pi rispettoso della libert e dignit dell'agente, guadagnando con ci anche in esplicativit, limitatamente ad azioni e sistemi di azione relativamente semplici. 9
-
istruttivo. I teorici di questo approccio sottolineano ripetutamente che solo in questo modo
possibile spiegare causalmente l'azione. Una comprensione causale dell'azione tuttavia
incompatibile con il presupposto della libert dell'attore,49 di cui, almeno dialetticamente, i
teorici della scelta razionale si fanno forti contro i sistemici. In senso proprio la
spiegazione razionale dell'azione invece una comprensione per motivi ed quindi
possibile solo ex post. In questo senso si oppone a quella "semantizzazione della scienza
come previsione"50 centrale nella scienza positivista. Conoscere i motivi razionali di
un'azione potr certo essere d'aiuto nel prevedere gli esiti di azioni future ma solo
presupponendo quella natura umana che invece si esclude, con gli esiti oggettivanti gi
tratteggiati. In questo contesto si devono inoltre ridiscutere i fondamenti della inferenza
statistica nelle scienze sociali.
3) nemmeno il valore esplicativo del costrutto habitus sorprende: la separazione dei
rifiuti domestici , o pu essere predisposta in modo da diventarlo, un'azione ripetitiva
facilmente soggetta a routinizzazione. La presenza di habiti sospende sia il presunto
calcolo delle utilit sia l'esplicito riferimento ai valori: rappresenta una sgravio dell'atto di
decisione analogabile a quello dell'agire istituzionale. un indizio a favore della proficuit
di una certa stabilizzazione delle pratiche socialmente definite come sostenibili (quali e
quanti tipi di rifiuti separare, secondo quali modalit) e pertanto contro la diffusione di un
senso di allarme sociale, confidando nella euristica della paura. Esso un elemento di
quella precondizione necessaria alla vita sensata che la normalit.
Introduciamo ora il riferimento alle politiche demografiche mondiali allo scopo di
mostrare l'importanza che la seconda condizione (la questione dei fini) riveste per l'idea di
sostenibilit, proprio l dove si dispone di mezzi potenti per tradurla in azione. Non si
tratta di fantasmi, evocati da capziose analisi di principio, n di quisquilie, ma delle
concrete possibilit di vita di milioni di persone. Pochi altri fenomeni globali, come i
tentativi di imporre una sostenibilit demografica, hanno causato un pari numero di lesioni
dei diritti fondamentali, in primo luogo della vita, nel sostanziale assenso delle societ
sviluppate, preoccupate di veder compromesso dalla crescita della popolazione il proprio
livello di vita. In questa sede non ci interessa dare notizia di tali crimini51 ma comprendere
la loro relazione con l'idea regolativa di sostenibilit. Il fatto pi interessante proprio
questo assenso, rivelativo di quelle contraddizioni che noi abbiamo chiamato insostenibili.
1) per quanto riguarda i decisori collettivi52 di queste politiche (alcuni governi
nazionali, in massima parte di tipo autoritario, alcune agenzie ONU e le ONG ad esse
49 Per questa argomentazione mi sono riferito alle opere di von Kutschera, 1981, 1991, 1993. Simile ma meno radicale, ci sembra la posizione assunta da Boudon, 1985 e 1995. 50 Morandi, 2002: 246. 51 Rimandiamo alle opere di denuncia sociale di Cascioli, 1997 e Schooyans, 2000. 52 In buona parte si tratta di decisori sottratti al voto democratico di coloro che dovrebbero rappresentare. 10
-
collegate, finanziate da stati democratici) si pu supporre una compresenza di reale
preoccupazione per la sostenibilit dello sviluppo, che in un contesto di societ ipotetica,
dove tutto disponibile all'uso e in assenza di una chiara nozione dell'uomo, degenera
nella sua sottomissione alle esigenze di autoconservazione del sistema e di un'utilizzazione
ideologica del concetto di sostenibilit, che nei paesi finanziatori pu garantire un certo
consenso, al servizio di scopi del tutto differenti dalla preoccupazione ecologica.53 la
fantasia del terrore, della paura e del potere non trova limiti se non quello di perpetuare le
condizioni della sua esistenza. Per esemplificazioni rimandiamo all'opera di Barry
Commoner, che su questo punto molto esplicito nella sua denuncia.54 disponiamo inoltre
di un bellissimo studio dell'antropologa femminista Gail Kligman sulla politica demografica
violentemente pronatalista di Ceauescu 55 il cui duplice scopo fu quello s di aumentare la
popolazione rumena ma soprattutto di ridefinire la distinzione pubblico/privato per
ottenere il pi ampio assoggettamento possibile del cittadino allo stato. Lo stesso si pu
dire, almeno nelle intenzioni, delle politiche antinataliste correnti. L'intenzione comune
quella di ricondurre politicamente tutto al binomio tecnica-individuo.56 l'esito , in
entrambi i casi, disumanizzante.
2) per quello che concerne gli effetti di queste politiche di sostenibilit disumane essi
sono realmente insostenibili, perversi, fallimentari: gli interventi del premio nobel Amartya
Kumar Sen lo dimostrano in modo molto convincente.57 che alcune agenzie ONU, ci non
ostante, direttamente o indirettamente insistano su politiche coercitive, lascia pensare che
i fini perseguiti non siano proprio quelli pubblicamente confessati, per i quali raccolgono
finanziamenti. Nel mare di pure intenzioni che le conferenze internazionali sull'ambiente
hanno prodotto, sembra che le uniche che abbiano trovato una seppur parziale
applicazione siano proprio quelle maggiormente antiumane. Il moralismo ambientale su
scala planetaria si accompagna al massimo di immoralit, in quanto cerca di alterare
lesperienza-fondamento della cura paterna/materna, sulla quale lo stesso Jonas ha
insistito nel suo tentativo di costruire unetica della responsabilit.
Concludiamo questo nostro modesto tentativo con una riflessione di Erich Voegelin: "al
fine, non di rendere possibile l'impresa ma di farla apparire possibile, ogni intellettuale
gnostico che elabora un programma di trasformazione del mondo deve prima di tutto
costruire un quadro del mondo dal quale siano stati eliminati quei caratteri essenziali della
costruzione dell'essere che farebbero apparire disperato e insensato il programma
53 L'esito della totale emancipazione dell'uomo dalla natura la ricaduta nello stato di natura, nel puro dominio dell'uomo sull'uomo. 54 Commoner, 1990: 179-206. 55 Cfr. Kligman, 1998. 56 Cfr. Maccarini, 1997: 153-182. 57 Cfr. Sen, 1995 e 1997. Mi sembra tuttavia che nelle strategie di empowerment permanga una componente utopica emancipatoria prettamente moderna. 11
-
stesso."58 ripercorrere all'indietro, recuperando quei caratteri nella formulazione di una
nuova scienza sociale, il maggior compito che il dibattito sulle condizioni della
sostenibilit ci lascia in eredit.
BIBLIOGRAFIA
Allodi, Leonardo, 2002: "Postfazione. Robert Spaemann e la critica della ragione funzionalista", in R.
Spaemann, 2002: 207-236.
Autiero, Antonio, 1995: "Esiste un'etica ambientale?". in V. Domenichelli, N. Olivetti Rason, C. Poli (a
cura di): Diritto pubblico dell'ambiente, Cedam, Padova, pp. 7-27.
Bazzanella, Emiliano, 2002: Echologia. Introduzone a una fenomenologia della propriet e alla critica del
pensiero ontologica, Asterios Editore, Trieste.
Belardinelli, Sergio, 1993: Una sociologia senza qualit. Saggi su Luhmann, FrancoAngeli, Milano.
Bondolfi, Alberto: 1998: "L'uomo di fronte alla natura e al suo sviluppo sostenibile. Alcune linee di fondo
della riflessione etico-ecologica in Europa", in "Studia Patavina" 45 (1998) 1:21-37.
Cascioli, Riccardo, 1997: Il complotto demografico, Casale Monferrato, Piemme.
Commoner, Barry, 1990: Fare pace con il pianeta, Milano, Garzanti Editore.
Di Cristofaro Emilio e Paolo Trucco (a cura di), 2002: Eco-efficienza. Metodologie, strumenti, casi di
successo, Guerini e Associati, Milano.
Eckes, Thomas e Six Bernd, 1994: Fakten und Fiktionen in der Eintellung-Verhaltens-Forschung: eine
Meta Analyse, in Zeitschrift fr Sozialpsychologie, pp. 253-271, Bern, Hans Huber Verlag.
1996: Meta Analysen in der Einstellungs-Verhaltens-Forschung, in Zeitschrift fr
Sozialpsychologie, pp. 7-17, Bern, Hans Huber Verlag.
Esty, Daniel C., 2001: "A term's Limits. (palnning of sustainable development)", in "Foreign Policy", Sept,
2001.
Golser, Karl e Heeger, Robert (a cura di), 1996: "Moralerziehung im neuen Europa", Verlag A. Weger,
Brixen.
Gubert, Daniele, 1997: "Ecologia S.Profonda?", http:\\www.belder.com\dantheman\studies\
ecosprofonda.html
Gubert, Giacomo, 1999: L'azione sociale ambientalmente corretta: il caso della separazione dei rifiuti a
Lipsia e Trento. Tesi di Laurea, Universit degli studi di Trento.
Haan, Gerhard de e Kuckartz, Udo, 1996: Umweltbewusstsein, Opladen, Westdeutscher
Verlag.
Hines, J. M. H. R. Hungerford, A. N. Tomera, 1987: An Analysis and Synthesis of Research on
Responsible Environmental Behavior: A Meta-Analysis, in The Journal of
Environmental Education, pp. 1-8.
Jonas, Hans, 1999: Organismo e libert, Einaudi, Torino.
58 Cfr. Voegelin, 1990: 25. 12
-
Kligman, Gail, 1998: The Politics of Duplicity, University of California Press, Berkeley.
Lindenberg, Siegwart, 1985: An Assessment of the New Political Economy: Its Potential for the Social
Sciences and for Sociology in Particular, in Sociological Theory, pp. 99-114.
Madotto, Rita, 1993: Ecocapitalismo, Datanews, Roma.
Marchetti, Laura (a cura di), 2000: "Sette tesi per cambiare i Verdi (e la vita)", in "Diorama letterario",
2000 (232): 25-32.
Mckenzie-Mohr, Doug, 2000: "Promoting Sustainable Behavior: An Introduction to Community-based
Social Marketing", in "Journal of Social Issues", Fall, 2000.
Morandi, Emmanuele, 2000: La societ accaduta. Tracce di una 'nuova' scienza sociale in Erich Voegelin,
FrancoAngeli, Milano.
2002: L'attuarsi della societ :saggi teorici sull'azione sociale e il realismo sociologico,
FrancoAngeli Milano.
Lanza, Alessandro, 1999: Lo sviluppo sostenibile, il Mulino, Bologna.
Luhmann, Niklas, 1990: Paradigm lost: ber die ethische Reflexion der Moral, Suhrkamp, Frankfurt a. M..
1992: Comunicazione ecologica. Pu la societ moderna adattarsi alle minacce ecologiche?,
FrancoAngeli, Milano.
1993: Soziologische Aufklrung V Konstruktivistische Perspektiven, Westdeutscher Verlag,
Opladen.
Paiva Duarte, Fernanda de, 2001: "'Save the Earth' or 'Manage the Earth'? The Politics of Environment
Globality in High Modernity", in "Current Sociology", January 2001, Vol. 49(1): 91-111.
Pardi, Francesco, 1996: L'indifferenza dell'Etica, FrancoAngeli, Milano.
Poli, Corrado, 1995: "Etica ambientale: teoria, politica, pratica", in V. Domenichelli, N. Olivetti Rason, C.
Poli (a cura di): Diritto pubblico dell'ambiente, Cedam, Padova, pp. 29-42.
Schooyans, Michel, 2000: Nuovo disordine mondiale, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo.
Sen, Amartya Kumar, 1995: Limbroglio demografico, in La rivista dei libri, pp. I-VIII
1997: "Azione e benessere: l'agenda dello sviluppo", in "Dimensioni dello sviluppo", XII (1), 1997:
9-24.
Sitari, Rosario, 2002: "Lo sviluppo sostenibile e le biotecnologie", in "Studium", 2002, 98 (6): 821-832.
Six, Bernd, 1992: Neuere Entwicklungen und Trends in der Einstellung-Verhaltens-
Forschung, in E. H. Witte (a cura di): Einstellung und Verhalten, Braunschweig.
Spaemann, Robert, 1988; "L'empiet dell'utopismo utopico. Laudatio di Hans Jonas", in "Rivista di
teologia morale", 1988, 122 (1): 15-24.
1990: Niklas Luhmanns Herausforderung der Philosophie, in N. Luhmann, 1990.
1994: Per la critica dellutopia politica, Milano, FrancoAngeli.
1998: Felicit e Benevolenza, Vita e Pensiero, Milano.
2002: L'origine della sociologia dallo spirito della Restaurazione, Laterza, Bari.
Spaemann, Robert und Reinhard Lw, 1991: "Die Frage Wozu?", Piper, Mnchen.
Veneziani, Marcello, 1990: Processo all'Occidente, SugarCo Edizioni, Milano.
Voegelin, Eric, 1968: La nuova scienza politica, Torino, Borla Editore.
1970: "Il mito del mondo nuovo", Rusconi, Milano.
13