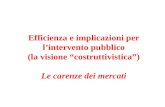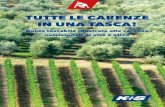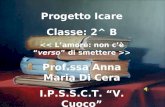Classe V B Liceo delle scienze Umane Opzione economico … DI CLASSE... · 4ASE 21 18 2 2 1 2 16 19...
Transcript of Classe V B Liceo delle scienze Umane Opzione economico … DI CLASSE... · 4ASE 21 18 2 2 1 2 16 19...
1
Repubblica Italiana Provincia Autonoma di Trento
Istituto di Istruzione “Marie Curie”
Pergine Valsugana TNTTD00401C
Anno Scolastico 2014/15
Documento finale del Consiglio di Classe per l'Esame di Stato art. 15 D.P.R. 323 d.d.23.07.1998
Classe V B Liceo delle scienze Umane Opzione economico sociale
Materia Docente Firma I.R.C. Rossin Elena
Lingua e letteratura italiana Antonazzo Simona
Lingua e cultura straniera inglese Martin Katherine Anne
Lingua e cultura straniera spagnolo Garcia Daniel
Matematica Carlin Barbara
Scienze Umane Fontana Benedetta (sost. Franzoi Nadia)
Storia Denicolai Stefania
Filosofia Denicolai Stefania
Diritto ed economia Moreschini Ezia
Fisica Brezzi Giovanni
Storia dell’arte Mattocci Rita
Scienze motorie e sportive Moroni Antonio
Rappresentanti degli studenti Gramola Anna
Piazza Benedetto
2
Indice Presentazione dell’Istituto
Finalità dell’Istituto
Caratteri specifici dell’indirizzo e profilo professionale in uscita
Presentazione e storia della classe Prospetto di evoluzione della classe nel triennio Quadro orario settimanale della classe quinta Continuità didattica nel triennio
Percorso formativo realizzato sulla base della programmazione collegiale Profilo di indirizzo Profilo della classe e obiettivi educativi e formativi raggiunti Metodologie d’insegnamento condivise Attività di recupero e potenziamento svolte nella classe quinta Strumenti di verifica e criteri di valutazione Criteri collegiali di valutazione assunti dal Consiglio di Classe Attività didattiche e formative svolte nel triennio approvate dal Consiglio di Classe Stage formativi curricolari (se previsti) Simulazioni delle prove d’esame Griglie usate per la correzione delle simulazioni Percorsi didattici Insegnamento della religione cattolica(IRC) Lingua e letteratura italiana Lingua Inglese Lingua spagnola Ed. fisica Diritto ed Economia Fisica Matematica Filosofia Storia Storia dell’arte Scienze umane
Testi delle simulazioni delle prove d’esame
4
Caratteri specifici dell’indirizzo e profilo professionale in uscita Introduzione La Riforma dei Licei del 2010 ha introdotto all’interno del Liceo delle Scienze Umane l’opzione economico sociale, un indirizzo liceale centrato sulle discipline giuridiche, economiche e sociali, già presente nei sistemi scolastici europei e capace di rispondere all’interesse per il mondo di oggi, per la comprensione dei complessi fenomeni economici, sociali e culturali che lo caratterizzano e che propone un nuovo piano di studi che porta il mondo nelle aule di scuola e offre ai propri allievi la possibilità di conoscere i linguaggi necessari per cominciare a “leggerlo” diventando cittadini consapevoli e protagonisti attivi nel loro tempo. La partecipazione democratica nelle società globalizzate, dove le trasformazioni sono incessanti e avvengono a velocità accelerata, richiede nuovi strumenti culturali nelle persone, conoscenza e padronanza di dinamiche complesse, difficili da comprendere anche per gli osservatori più esperti. Il liceo economico-sociale, nato dalla precedente esperienza del Liceo delle Scienze Umane, ma rispetto al quale presenta un potenziamento dell’area scientifica con l’introduzione dello studio della Fisica al triennio, il consolidamento di una materia caratterizzante come Diritto ed Economia, la valorizzazione della Storia dell’Arte, cerca di rispondere a questa sfida. LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE (NUOVO ORDINAMENTO) Il liceo economico-sociale, “liceo della contemporaneità”, rappresenta una nuova possibilità per l’orientamento degli studenti all’uscita dalla secondaria di primo grado. L’opzione economico-sociale consente di acquisire strumenti culturali per affrontare in profondità questioni attuali - dalle risorse disponibili alle regole giuridiche della convivenza sociale, dal benessere individuale e collettivo alla responsabilità delle scelte da compiere - attraverso il concorso di più materie di studio, tutte interessanti per uno studente di oggi, ma tanto più significative perché chiamate a collaborare tra loro. Per capire la complessità del presente, a partire da un’approfondita conoscenza delle radici storiche dei fenomeni e per proiettarsi con altrettanto interesse e consapevolezza verso il futuro, servono infatti i contenuti, gli strumenti e i metodi di discipline diverse: nel caso del liceo economico-sociale, sono le discipline economiche e giuridiche, linguistiche e sociali, scientifiche ed umanistiche, tutte ugualmente importanti per fornire una preparazione liceale aggiornata e spendibile in più direzioni. Il LES è l’unico liceo non linguistico dove si studia accanto alla prima lingua straniera, l’Inglese (che dovrà essere conosciuto ad un livello di competenza comunicativa corrispondente almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) una seconda lingua straniera, in sostituzione del Latino. All’ultimo anno, si introduce l’insegnamento in una lingua straniera di una materia non linguistica (CLIL). Gli aspetti che distinguono l’identità del liceo economico-sociale da quella degli altri licei, ma anche dall’istruzione tecnica economica, sono molti: l’integrazione di discipline complementari, le scienze economiche e sociologiche si avvalgono infatti delle scienze matematiche, statistiche e umane (psicologia, sociologia, antropologia, metodologia della ricerca) per l’analisi e l’interpretazione dei fenomeni economici e sociali; lo sguardo rivolto alla contemporaneità, insieme all’interesse per la ricerca; l’approccio umanistico che mette la persona al centro dell’economia, lo studio delle interdipendenze e dei legami tra la dimensione internazionale, nazionale, locale ed europea, tra istituzioni politiche,
5
economia, cultura e società. Il corso di studi prevede 27 ore settimanali nel primo biennio che aumentano a 30 ore settimanali negli anni successivi, è suddiviso in due bienni e in un quinto anno. Al termine del quinquennio gli studenti sostengono l’esame di Stato e conseguono il diploma di Istruzione Liceale che consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie. La varietà delle discipline studiate consente di proseguire gli studi in ambiti molto diversi anche se privilegiate sono le facoltà legate alle scienze sociali come scienze politiche, sociologia, psicologia, giurisprudenza, economia, statistica, lauree brevi inerenti i servizi sociali, oltre a quelle linguistiche, ma anche l’inserimento nel mercato del lavoro offrendo una solida preparazione, aperta verso più fronti e sostenuta da competenze multiple, tutte spendibili in numerose situazioni professionali.
6
Presentazione e storia della classe La classe è composta da 18 studenti, di cui 12 femmine e 6 maschi, di cui si fornisce l’elenco:
Ambrosi Federica
Brusamolin Noemi
Casagranda Valentina
Cucino Silvia
Dalledonne Mirta
Egenter Filippo
Gramola Anna
Lazzeri Michele
Martinelli Cinzia
Oss Emer Margherita
Oss Emer Mattia
Perez Taborda Maria Josè
Piazza Benedetto
Puliafico Chiara
Purin Angela
Ricchi Sara
Sottopietra Gloria
Suchevan Vasyl
Prospetto di evoluzione della classe nel triennio
Classe Iscritti Promossi Di cui
promossi con carenze
Respinti Ritirati Anno estero
3ASE 21 21 6 / / /
4ASE 21 18 2 2 1 2
16 19 1
7
Il numero complessivo di carenze nel triennio: 8 Quadro orario settimanale della classe quinta
Materia Ore settimanali I.R.C. 1 Lingua e letteratura italiana 4 Lingua e cultura straniera inglese 3 Lingua e cultura straniera Op.Tedesco/spagnolo 3
Matematica 3 (1) Scienze Umane 4 Storia 2 Filosofia 3 Diritto ed economia 3 Fisica 2 Storia dell’arte 2 Scienze motorie e sportive 2
Continuità didattica nel triennio Dalla classe terza si è mantenuta la continuità in IRC, Italiano, Fisica, Spagnolo, Storia dell’arte ed Educazione fisica, mentre si sono verificati cambiamenti in Diritto ed Economia, Scienze Umane, Storia e Filosofia, Inglese e Matematica. La tabella seguente riporta la composizione dei Consigli di Classe nell’arco del triennio.
Materia
d’insegnamento Terza Quarta Quinta
Diritto ed economia Bampi Moreschini Moreschini
Scienze umane Dallafior Dallafior Fontana (in sost. di Franzoi)
Storia e filosofia Denicolai - Lionetti Denicolai Denicolai
Inglese Moser Franceschi Martin
Matematica Pedrotti Carlin Carlin
IRC Rossin Rossin Rossin
Italiano Antonazzo Antonazzo Antonazzo
8
Ed. fisica Moroni Moroni Moroni
Spagnolo Garcia Garcia Garcia
Storia dell’arte Mattocci Mattocci Mattocci
Fisica Brezzi Brezzi Brezzi
Percorso formativo realizzato sulla base della programmazione collegiale Profilo di indirizzo Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: Conoscenze
conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche; comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; Possiede una cultura scientifica e umanistica di base; Conosce i testi del patrimonio letterario italiano, che sa collocare in quadri di riferimento di divenire storico, di specificità linguistica e di contenuto; Conosce ed utilizza il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica, che sa analizzare ed interpretare; Sa spiegare le principali tematiche filosofiche; Conosce le strutture sintattiche, morfologiche e lessicali della lingua spagnola e inglese; Possiede conoscenza dei caratteri salienti della storia della letteratura spagnola e inglese; Conosce le principali espressioni artistiche di diverse civiltà e aree culturali; Conosce le nozioni e il significato dei procedimenti algebrici e analitici e possiede la capacità di coglierne i mutui collegamenti, le analogie strutturali e l’organizzazione complessiva; Conosce gli argomenti di base e i metodi della fisica classica; Competenze
individua le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei fenomeni culturali; utilizza le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; ha acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. sa identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale; Capacità
9
Possiede capacità linguistico- espressive; Possiede capacità logico-interpretative; Possiede capacità di astrazione e rielaborazione; Possiede capacità di argomentazione; Possiede capacità di operare con la lingua straniera; Possiede capacità di lavorare in gruppo; Possiede capacità di organizzare il proprio lavoro con consapevolezza ed autonomia, sapendosi orientare dinanzi a nuovi problemi; Possiede capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli adeguati alle diverse situazioni proposte; Possiede capacità di reperire strumenti adatti all’aggiornamento delle proprie conoscenze; sviluppa la capacita di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici.
10
Profilo della classe e obiettivi educativi e formativi raggiunti Nel corso del Triennio la classe ha risposto alle sollecitazioni didattico-educative dei docenti in modo discontinuo e eterogeneo. Non tutto il gruppo classe è riuscito a sviluppare competenze di analisi e capacità operative sufficienti. L’interesse per le diverse discipline e il livello di conoscenza degli argomenti raggiunto nella maggior parte di esse sono stati nel complesso adeguati. Non sono sempre seguiti, per una parte della classe almeno, l’impegno e la costanza necessari per il raggiungimento di una preparazione solida e approfondita e per lo sviluppo di un metodo di lavoro efficace e autonomo. La situazione relativa all’impegno, alle competenze e conoscenze acquisite e al profitto è quindi differenziata. Una parte della classe ha dimostrato senso di responsabilità, puntualità nel lavoro domestico, autonomia discreta nello studio e impegno costante, raggiungendo dei livelli più che buoni in una o più materie. Un’altra parte, pur impegnandosi nelle attività didattiche con una certa serietà, è riuscita a conseguire risultati nell’insieme abbastanza sufficienti, con il permanere comunque di qualche difficoltà in alcune discipline. Una terza parte della classe, infine, è stata discontinua nell’attenzione durante le lezioni e nell’impegno domestico, o selettiva rispetto alle materie studiate, raggiungendo livelli di competenze e conoscenze differenti, in alcuni casi non sufficienti. Questo quadro disomogeneo non ha permesso, spesso, di avanzare celermente nello svolgimento dei programmi. Sotto l’aspetto relazionale, durante il triennio sono emerse alcune personalità leader che, in alcuni casi, si sono distinte per il comportamento corretto e per senso di responsabilità, in altri, al contrario, hanno dimostrato superficialità e alimentato demotivazione scolastica in studenti caratterialmente influenzabili. Il clima in classe è stato, per lo più, sereno e collaborativo. Isolati momenti di tensione non hanno, tuttavia, ostacolato lo svolgimento delle attività scolastiche. Durante il quinto anno la classe si è mostrata meno passiva alle sollecitazioni degli insegnanti, un po’ più puntuale e regolare nello svolgimento del lavoro assegnato. Tale atteggiamento ha influito positivamente sul profitto di alcuni studenti.
Metodologie d’insegnamento condivise A seconda delle caratteristiche delle varie discipline, i singoli docenti hanno adottato metodi di lavoro il più possibile diversificati: la lezione frontale con partecipazione attiva della classe; la lezione aperta nelle sue varie tipologie (dibattito, presentazioni, lavori di gruppo, ecc.) per sollecitare continuamente l’attenzione e l’interesse e coinvolgere direttamente gli studenti nel processo di apprendimento; l’attività con l’uso di laboratori. Oltre ai libri di testo e al materiale in fotocopia, si è fatto ricorso anche ai mezzi audiovisivi e multimediali, all’informazione (giornali, internet, ecc), alle risorse della nostra biblioteca, alle offerte culturali del territorio, all’incontro con esperti. Le metodologie didattiche comuni sono state:
lezione frontale
lezione partecipata
lavoro cooperativo di gruppo
attività laboratoriale
11
uso di strumenti multimediali (audiovisivi, Internet…)
lavoro sul testo: riconoscimento delle parole – chiave, individuazione dei concetti fondamentali- schematizzazione
seminari con esperti.
Attività di recupero e potenziamento svolte nella classe quinta Riscontrate nel corso dell’anno carenze e lacune diffuse, il Consiglio di Classe ha stabilito di attivare i seguenti interventi di recupero/potenziamento: Storia e filosofia: corso di recupero di 6 ore ad inizio d’anno scolastico; Inglese: sportello nel trimestre; Matematica: 7 h di corso di recupero ad inizio d’anno; Fisica: corso di recupero ad inizio d’anno scolastico; Italiano: potenziamento di 8 ore a maggio;
Strumenti di verifica e criteri di valutazione I criteri e le modalità delle verifiche e delle valutazioni sono quelli stabiliti nella programmazione del Consiglio di Classe: almeno 2 verifiche nel primo periodo per tutte le materie; almeno 3 verifiche nel secondo periodo; valutazione in itinere attraverso la discussione guidata e la correzione del lavoro domestico. I parametri del voto numerico sono tratti dalla griglia proposta dalla Commissione Progetto d’Istituto; la valutazione quadrimestrale tiene conto degli esiti delle verifiche formative, dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione, in termini di rispetto del contratto formativo e dei progressi rispetto al livello di partenza.
12
Criteri collegiali di valutazione assunti dal Consiglio di Classe Facendo riferimento alla programmazione delle attività educative e didattiche del Consiglio di Classe, si evidenzia la tabella di corrispondenza.
Voto numerico Descrizione
3 Insufficienze gravissima o prova non svolta 4 Gravi lacune 5 Conoscenze lacunose 6 Sufficienti conoscenze di base 7 Discrete conoscenze di base e qualche capacità critica 8 Conoscenze complete e consapevoli 9 Ottime conoscenze e buone capacità critiche
10 Eccellenti conoscenze e capacità di stabilire criticamente approfonditi collegamenti interdisciplinari, spiccato senso critico
Attività didattiche e formative svolte nel triennio approvate dal Consiglio di Classe
Classe terza
a.s. 2012/13
VISITE GUIDATE - INCONTRO ESPERTI – SEMINARI &Co
Beach volley – torneo a Bibione (fine aprile-inizio maggio)
Pet Therapy con la prof.ssa Mattocci durante le lezioni di storia dell'arte.
Uscita sul territorio in giornata presso l'Abbazia di Novacella-Bressanone (solo gli studenti che frequentano l'IRC).
20/11 Spettacolo teatrale in lingua al Teatro S. Chiara di Trento
STAGE: Stage aziendale di 4 settimane prima delle vacanze di Pasqua VEDI TABELLA SEGUENTE
13
Classe quarta
a.s. 2013/14
VISITE GUIDATE - INCONTRO ESPERTI – SEMINARI &Co
6 dicembre 2013 Riva del Garda – Festival della Famiglia;
Visione dello spettacolo in lingua inglese presso il Teatro di Pergine: "Macbeth";
Partecipazione ai campionati studenteschi;
Viaggio di istruzione sportivo "Beach volley" [3 studenti meritevoli anche in ambito scolastico];
Progetto incontro con l'antropologa Martinello Lorena (durata di quattro ore durante le lezioni di Scienze umane);
A tu per tu con la ricerca - presso il Muse di Trento;
Visione dello spettacolo "La vita di Galileo" con la 4^ALS - giovedì 13 febbraio 2014 ore 20:45.
Partecipazione alle Olimpiadi della matematica (gruppo ristretto e volontario);
Teatro di Pergine: Spettacoli "Coppia aperta, quasi spalancata" il 27 marzo 2014 e "La divina Odissea degli sposi" il 22 novembre 2013 ad ore 10:30.
VIAGGI D’ISTRUZIONE 7 – 11 aprile 2014 Siviglia
Classe quinta
a.s. 2014/15
VISITE GUIDATE - INCONTRO ESPERTI – SEMINARI &Co
Concorso "Giovani e Lavoro" - prof.ssa Moreschini;
13 ottobre 2014 Trento – Filmestival Religion Today: visione del film Don Giuseppe Diana. Dialogo sulla camorra al Teatro S. Marco di Trento. Ore 10:00 con prof.ssa Rossin
"Porte aperte" all'Università di Trento: 13/02/2015 e 20/03/2015
20 novembre 2014 Verona – “Job Orienta”
4 febbraio 2015 Trento Consiglio Provinciale
14 aprile 2015 Visita al Vittoriale degli Italiani – Gardone Riviera
8 maggio 2015 incontro con Aido-Avis all’interno di Progetto Salute
15 maggio 2015 Partecipazione alla premiazione del Concorso Giovani e Lavoro presso il Consiglio Provinciale;
Teatro in lingua al Teatro di Pergine - visione di Frankenstein del 10/12/2014 dalle 10:45 in poi.
Visione al Teatro di Pergine: Il giovane favoloso il 16/12/2015 e
14
Ritorneranno i prati il 29/04/2015;
Progetto disagio psicologico con uscita sul territorio il giorno 16/10/2014 presso il foyer del teatro di Pergine (4-5 ora di lezione) - prof.ssa Mattocci;
Progetto "La prima Guerra mondiale in Trentino" incontri con gli esperti. Adone Bettega, esperto di storia locale: 11/03/’15 e 09/04/’15 durante le ore di Storia;
Luigi Ranzato, psicologo per i Popoli: 31/03/’15 durante le ore di italiano.
Due incontri con l’antropologa Lorena Martinello (due incontri da due ore);
VIAGGI D’ISTRUZIONE
25 – 28 marzo 2015 Praga
Anno scolastico 2013/14 - Stage AMBROSI FEDERICA PERGINE VALS. SOS Villaggio del fanciullo 25 febbraio - 23
marzo BRUSAMOLIN NOEMI CASTELNUOVO Comuntà di valle C3 25 febbraio - 23
marzo CASAGRANDA VALENTINA
LON - LASES APT TRENTO 25 febbraio - 23 marzo
CUCINO SILVIA PERGINE VALS. ASIF Chimelli 25 febbraio - 23 marzo
DALLEDONNE MIRTA RONCEGNO Silvelox 25 febbraio - 23 marzo
EGENTER FILIPPO TENNA APSP S.Spirito Pergine 25 febbraio - 23 marzo
FERRAI LORENA BORGO VALS. APSP S.Spirito Pergine 25 febbraio - 23 marzo
GRAMOLA ANAN PERGINE VALS. DEDA GROUP 25 febbraio - 23 marzo
GUIDI EDERA TELVE APSP S.Spirito Pergine 25 febbraio - 23 marzo
LAZZERI MCIHELE PERGINE VALS. COMUNE di PERGINE - BIBLIOTECA 25 febbraio - 23 marzo
MARTINELLI CINZIA CALCERANICA COMUNE di TRENTO - BIBLIOTECA 25 febbraio - 23 marzo
OSS EMER MARGHERITA PERGINE VALS. DEDA GROUP 25 febbraio - 23 marzo
OSS EMER MATTIA PERGINE VALS. Cooperativa sociale Handicrea 25 febbraio - 23 marzo
15
PEREZ TABORDA M.JOSE'
PERGINE VALS. Traduzione STR 25 febbraio - 23 marzo
PULIAFICO CHIARA PERGINE VALS. CS4 Coop. Sociale 25 febbraio - 23 marzo
PURIN ANGELA SPERA APSP S.Lorenzo e S.Maria della Mis. 25 febbraio - 23 marzo
RICCHI SARA CALCERANICA CASSA RURALE di PERGINE 25 febbraio - 23 marzo
SOTTOPIETRA GLORIA LON - LASES CASTELLO del BUONCONSIGLIO Trento 25 febbraio - 23 marzo
SUCHEVAN VASYL PERGINE VALS. Informatica Trentina 25 febbraio - 23 marzo
SULEJMANI VILDANE PERGINE VALS. Pluris Consulting 25 febbraio - 23 marzo
WILLIYAM EL BAHSSA SAAD
PERGINE VALS. APT Valsugana 25 febbraio - 23 marzo
Simulazioni delle prove d’esame Accanto alle tradizionali prove scritte e orali, nella seconda parte dell’anno sono state proposte simulazioni delle prove scritte e orali previste dal nuovo regolamento per l’Esame di Stato. Simulazione della I prova scritta: Italiano lunedì 27 aprile 2015 – 6 ore da 60’ Simulazione della II prova scritta: Diritto ed Economia martedì 28 aprile 2015 –6 ore da 60’ Simulazione della III prova: (4 materie con 2 discipline da 2 quesiti e con 2 discipline con 3 quesiti):
Tipologia Data e durata Discipline interessate
B
giovedì 30 aprile
2015 – 3 ore da 60’
Scienze umane (3 quesiti) Inglese (3 quesiti) Storia (2 quesiti)
Matematica (2 quesiti)
La votazione in quindicesimi e i criteri di valutazione sono stati esplicitati agli studenti.
I criteri di valutazione sono stati concordati in sede di Consiglio di Classe. I testi delle prove assegnate e le griglie di correzione sono parte integrante del presente documento.
Per la prova di italiano si è consentito l’uso del vocabolario della lingua italiana, per le lingue straniere del dizionario bilingue, per Diritto ed Economia si è consentito l’uso del Codice Civile e della testo della Costituzione italiana non commentati e del Dizionario di italiano.
17
Griglia di valutazione della prima prova
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M.CURIE” – PERGINE VALSUGANA TRENTO
Griglia di valutazione della I prova scritta: ITALIANO Candidato TIPOLOGIA A ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO max. punteggio
riportato indicatori comprensione complessiva del testo ……………………….……………….. 3 rigore nell’analisi testuale ……………………………………………………… 4 rielaborazione personale ………………………………………….……………. 4 correttezza e proprietà di linguaggio ………………………………………. 4
punteggio totale TIPOLOGIA B SAGGIO BREVE
Indicatori individuazione del focus e titolazione ……………………………………….. 2 correttezza nell’interpretazione dei documenti e completezza nella citazione delle fonti ………………………………………………………….……
5
coerenza logica e rigorosa argomentazione delle tesi ………………... 4 registro linguistico adeguato al destinatario, proprietà e rispetto degli spazi assegnati…………….………………………………………………….
4
punteggio totale ARTICOLO DI GIORNALE indicatori individuazione del focus, efficacia dell’attacco e titolazione ……….. 3 correttezza nell’interpretazione dei documenti e completezza nella citazione delle fonti ……………………………………………………………
4
coerenza logica e chiara distinzione fra informazioni e opinioni….. 4 corretto uso di un linguaggio giornalistico (chiarezza, concisione, precisione, densità informativa) …………………………………………….
4
punteggio totale TIPOLOGIA C SVILUPPO DI UN ARGOMENTO DI CARATTERE STORICO
indicatori pertinenza e conoscenza dei contenuti ………..…………………………. 5 coerenza logica e capacità argomentativa …….……………………...… 4 correttezza e proprietà di linguaggio ………………………………………. 4 rielaborazione personale ……………………………………………………. 2
punteggio totale TIPOLOGIA D TRATTAZIONE DI UN TEMA DI ORDINE GENERALE
indicatori pertinenza e conoscenza dei contenuti ………………………..………….. 4 coerenza logica e capacità argomentativa ………………………………… 4 correttezza e proprietà di linguaggio ……………………………………….. 4 rielaborazione personale ………………………………………….…………….. 3
punteggio totale Valutazione complessiva ………/15
Griglia di valutazione della seconda prova
19
Griglia di valutazione della Terza Prova
Indicatori Descrittori Livelli di prestazione Punteggio Punteggio conseguito
Contenuto nullo o privo di informazioni significative
1
Contenuto parziale e frammentario
2
Contenuto essenziale, ma corretto
3 Conoscenze Completezza del
contenuto
Contenuto esauriente 4
Scarsa conoscenza del linguaggio specifico
1
Parziale padronanza del linguaggio specifico
2 Correttezza espressiva e specificità del linguaggio Completa padronanza del
linguaggio specifico 3
Scarse e lacunose 1 Complessivamente adeguate 2
Competenze sul piano dell'analisi e della sintesi Puntuali e complete 3
Scarsa 1
Adeguata 2
Competenze
Pertinenza della risposta e coerenza logica e argomentativa Organica e articolata 3
Scarsa e/o inappropriata 1 Capacità
Rielaborazione critica e personale Puntuale 2
Punteggio totale
21
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC)
Docente Elena Rossin
Testi adottati Nessun testo utilizzato
Altri materiali Fotocopie di approfondimento e materiale audiovisivo.
PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO 2015
ARGOMENTI
ore
Secolarizzazione e pluralismo religioso. Indagine sulle tendenze e gli atteggiamenti religiosi, e non, della società contemporanea.
“God in back”. Vito Mancuso parla del ritorno del religioso e della religiosità nel post-moderno.
America religiosa ed Europa secolarizzata: come la sociologia della religione tenta di spiegare questo fenomeno.
Le nuove forma di religiosità: tentativi di classificazione.
“New Age”: origini, caratteristiche e contenuti di questa nuova forma di religiosità. La posizione della Chiesa Cattolica nei confronti del fenomeno New Age.
Esoterismo e “ricerca deviata del sacro” (satanismo). L’ammonimento di alcuni documenti del Magistero Ecclesiale. Riflessioni da parte di pensatori laici.
La ricerca del “sacro” in alcuni cantautori italiani: F. Battiato, R. Zero.
15
Rapporto tra ragione e fede. “Credere” non significa “rinunciare a pensare”. Le “ragioni del cuore” di Blaise Pascal (lettura e commento di alcuni Pensieri).
Il dialogo tra Norberto Bobbio e il Cardinal Maria Martini sulla necessità di essere “credenti pensanti”.
6
La figura di Don Giuseppe Diana. Percorso in preparazione alla partecipazione del “Religion Today filmfestival”
1
22
“La medicina nell’era della tecnica”: lettura e commento di un testo di U. Galimberti
Bioetica. Alcune notizie storiche ed informazioni metodologiche. Confronto tra etica cristiana ed etica laica sulle principali questioni di bioetica. Aspetti medico-scientifici, etici e giuridici.
Questioni affrontate:
Interruzione volontaria di gravidanza
Fecondazione assistita
Clonazione e ricerca eugenetica
8
PROGRAMMA DA SVOLGERE DAL16/05/2015 ALL’ 9/06/2015
Trapianto d’organi
Eutanasia e terapia del dolore
5
N° debiti in ingresso 0
Attività di recupero //
N° alunni N° totale ore
11 19
Metodologia Strumenti di verifica Supporti didattici
Lezione frontale 20%
Elaborati risultanti dai lavori di gruppo
Audiovisivi
Lettura documenti 20% Lavori individuali Schede
23
Discussione in classe 40% Verifiche orali e interventi spontanei
Lavori di gruppo 20%
Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità specifiche
Attraverso l’itinerario didattico dell’Insegnamento della Religione Cattolica gli alunni hanno potuto acquisire una conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del Cattolicesimo, nel quadro più ampio delle grandi Religioni e delle maggiori tradizioni culturali, tenendo aperto sempre il confronto con il mondo laico.
Finalità dell’I.R.C. è quella di contribuire, assieme alle altre discipline, al pieno sviluppo della personalità dello studente, attraverso il raggiungimento di capacità critiche e di confronto, oltreché attraverso l’acquisizione di conoscenze.
In particolare si è cercato di sollecitare negli studenti l’acquisizione delle seguenti competenze:
Comprendere e riconoscere il ruolo e l’importanza culturale e storica della Religione Cristiana, ai fini di una più corretta e completa comprensione della Cultura e della Società contemporanea;
Sapersi confrontare con il pensiero ateo e con le istanze laiche della società moderna e contemporanea al fine di affinare le personali capacità critiche di lettura della storia del pensiero della società occidentale;
Conoscere i nuovi traguardi della scienza medica e delle moderne tecnologie al fine di valutarne le conseguenze etiche per gli individui e l’intera società.
L’elemento qualificante del percorso scolastico è stato quello di definire una propria personale cultura biblico-religiosa, alla luce delle proposte e anche delle contraddizioni del mondo contemporaneo. Il motivo conduttore è stato il ruolo della Cultura religiosa in un contesto globale di Secolarizzazione.
Sul piano degli Obiettivi formativi si è cercato di promuovere una partecipazione al dialogo educativo, di incentivare la collaborazione e l’intervento costruttivo con i compagni e con gli insegnanti. Si è puntato molto sull’attività in classe nel segno della correttezza intesa come puntualità nella presenza, continuità, rispetto degli impegni presi. Per quanto riguarda il metodo di lavoro, ci si è indirizzati verso l’acquisizione di autonome capacità conoscitive e critiche.
Al termine del percorso didattico, si può dire che gli studenti sono sufficientemente capaci di confronto fra il Cattolicesimo ed i vari sistemi di significato della società laica e sono in grado di comprendere e rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia etica e religiosa.
24
Rapporto con la classe
Gli alunni avvalentesi dell’I.R.C. sono stati 11 su un totale di 19.
Gli studenti della classe hanno dimostrato livelli di partecipazione e di interesse diversi, soprattutto nel primo periodo, quando un gruppo tendeva a rimanere più passivo. Nel secondo periodo, invece, la classe è parsa più coesa e la partecipazione alle tematiche affrontate si è fatta più vivace e costruttiva. I livelli raggiunti sono quindi, nel complesso, buoni. Le lezioni si sono svolte in un clima sereno, rispettoso delle diverse opinioni e aperto al confronto.
25
Letteratura italiana Docente Prof.ssa Simona Antonazzo
Testi adottati G. Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria, L’attualità della letteratura, Paravia Editore, voll. 2, 3.1,3.2, Milano - 2012. D. Alighieri, Divina Commedia, Paradiso (edizione a scelta).
Altri materiali Fotocopie,appunti delle lezioni,materiale multimediale e video.
Argomenti di letteratura italiana N. ore
1. L’ETÀ DEL ROMANTICISMO + Esercitazioni sul saggio breve.
41
2. L’ETÀ POSTUNITARIA
10
3. LA CRISI DELLA RAGIONE 40
4. EUGENIO MONTALE 3
5. GIUSEPPE UNGARETTI 3
6. DANTE ALIGHIERI, DIVINA COMMEDIA - PARADISO (dal 27/09 fino al 21/02)
9
N° debiti in ingresso 0 Attività di potenziamento dal 14/05 al 18/05 - 2015
N° alunni N° totale ore Tutta la classe 8
Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità specifiche
Metodologia Strumenti di verifica Supporti didattici Lezione frontale; Lezione interattiva; Lezione ascoltata;
Verifiche orali lunghe; Verifiche orali brevi; Prove scritte: Elaborati secondo le tipologie previste dall'esame di Stato; Verifiche sintetiche valide per l'orale -Test a crocette;
Libro di testo; Letture integrative (saggi, romanzi); Dispense; Audiovisivi;
26
L'insegnamento delle materie letterarie deve essenzialmente contribuire al pieno sviluppo della personalità degli studenti, insegnare a comunicare e quindi a rapportarsi correttamente con gli altri sul piano della comprensione reciproca e della collaborazione sociale, incrementare le conoscenze culturali di base e sviluppare l'interesse per le opere letterarie. Tutto ciò deve promuovere negli studenti la formazione di una autonoma capacità di interpretazione e una fondata sensibilità estetica; Gli studenti, in linea di massima: Sanno decodificare, capire e interpretare i testi letterari nelle varie epoche; Sanno cogliere le caratteristiche peculiari della lingua nei diversi generi letterari sotto l’ aspetto lessicale, retorico e stilistico; Sanno individuare gli influssi e i condizionamenti che la situazione storica, nelle sue implicazioni sociali, politiche, economiche e soprattutto culturali, esercita su un autore; Sanno individuare la poetica di un autore attraverso la lettura dei testi. Rapporto con la classe Costante, in generale, è stata la partecipazione al dialogo educativo e abbastanza costante l’impegno profuso. Tuttavia questo non è stato garanzia per tutti gli studenti di dell’acquisizione di un metodo di studio abbastanza efficace, solo in alcuni casi si è accertata una certa competenza espositiva, argomentativa e rielaborativa. L’interesse per la discipline può considerarsi complessivamente discreto come anche il livello di conoscenza degli argomenti proposti. Non manca all’interno del gruppo qualche individualità che nel corso dell’anno, per una particolare attitudine alle discipline umanistiche, ha manifestato una crescita notevole, non solo sul piano delle conoscenze e delle competenze, ma anche su quello della maturazione personale. La classe ha necessitato spesse volte di stimoli e motivazioni allo studio che è potuto risultare, quindi, un po’ superficiale o insufficiente. L’affiatamento, in fine, tra i vari membri della classe e tra gli stessi e l’insegnante è risultato sufficientemente accettabile. Osservazioni del docente Il programma di italiano ha subito dei tagli notevoli per ragioni legate soprattutto alle difficoltà, spesso riscontrate in aula, di mantenere l’interesse, l’attenzione e atteggiamenti volti all'apprendimento e al rispetto del lavoro del docente e di un gruppo di studenti che ha dimostrato costante impegno nei confronti del proprio percorso formativo. Contenuti 1. L'ETÀ DEL ROMANTICISMO Il neoclassicismo e pre-romanticismo: aspetti generali (Winckelmann e la letteratura gotica: poesia cimiteriale, ossianismo, wertherismo - Rousseau e lo Sturm und Drang ) [vol. 2 – da p.559 + Appunti] L'età del Romanticismo: Aspetti generali del Romanticismo europeo - Le ideologie - Le istituzioni culturali - Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale - Il pubblico - Lingua letteraria e lingua dell'uso comune, La concezione dell'arte e della letteratura nel Romanticismo europeo: la poetica classicista e la poetica romantica - [vol. 2 - da p. 684 + appunti] Il movimento romantico in Italia [vol. 2 - da p. 727 + appunti ] La poesia nell’età romantica [vol. 2 – da p. 741] La poesia in Italia [vol. 2 – da p. 752] Il romanzo in Europa [vol. 2 – da p. 765] Il romanzo in Italia [vol. 2 – da p. 790] Il lato oscuro della realtà: il riemergere dell’irrazionale nel mondo e nell’uomo [vol. 2- da p. 798] Alessandro Manzoni, poetica: la concezione della storia e della letteratura [vol. 2 – da p. 828] Testi antologici – volume 2: Microsaggio – Il romanzo epistolare, p. 575; Microsaggio – Origine del termine “Romanticismo”, p. 684;
27
A. W. Schlegel, La «melancolia» romantica e l'ansia d'assoluto, p. 717 (lettura consigliata); W. Wordsworth, La poesia, gli umili, il quotidiano, p. 720 (lettura consigliata); Victor Hugo, Il «grottesco» come tratto distintivo dell'arte moderna, p. 723; Madame de Staël, Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni , p. 728; Giovanni Berchet, La poesia popolare in Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo, p. 731; Pietro Giordani, "Un italiano" risponde al discorso della De Staël, in fotocopia; Pietro Borsieri, La letteratura, l'«arte di moltiplicare le ricchezze» e «la reale natura delle cose» in Il programma del Conciliatore , p. 735; Microsaggio – Il romanzo di formazione, p. 788; Microsaggio – L’eroe romantico, p. 810 (lettura consigliata); ALESSANDRO MANZONI Manzoni, Storia e invenzione poetica in Lettera a M. Chauvet sull'unità di tempo e di luogo nella tragedia, p. 833; Manzoni, L’utile, il vero e l’interessante in La lettera a Cesare d’Azeglio “Sul romanticismo”, p. 834; Manzoni, La funzione della letteratura: render le cose «un po' più come dovrebbono essere», in Lettera a Claude Fauriel del 9 febbraio 1806 , in fotocopia; Manzoni, Il romanzesco e il reale in Lettera a M. Chauvet , in fotocopia. GIACOMO LEOPARDI (libro di testo + fotocopie + appunti) Visione del film: Il giovane favoloso, regia di Mario Martone; La vita e il pensiero, vol. 3.1 – da p. 6 a p.11; La poetica del “vago e indefinito”, vol. 3.1 – da p. 13; La teoria del piacere e i concetti di “noia”, “morte”, “illusione” (appunti) Uomo e natura: pessimismo storico, pessimismo cosmico, pessimismo eroico (appunti); I Canti, vol. 3.1 - p. 32; Le operette morali e l’«arido vero», vol. 3.1 - p. 98; Testi antologici – volume 3.1 GIACOMO LEOPARDI Dallo Zibaldone: La teoria del piacere, Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza, Indefinito e infinito, Il vero è brutto, Teoria della visione, Ricordanza e poesia, Indefinito e poesia, La doppia visione, La rimembranza , da p. 16; Dallo Zibaldone: Il giardino della sofferenza (in fotocopia); Da Pensieri: La noia è in qualche modo il più sublime dei sentimenti umani (in fotocopia); Da I Canti: L’infinito; La sera del dì di festa; Ultimo canto di Saffo (II e III strofa); La quiete dopo la tempesta; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La ginestra o il fiore del deserto, da p. 32; Da Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese e Dialogo di Plotino e Porfirio, da p. 99; S. Timpanaro, Pessimismo e progressismo nel pensiero leopardiano, p. 95 (lettura consigliata). 2. L'ETÀ POSTUNITARIA Il Positivismo (libro di testo + appunti), da p. 143; Il Naturalismo francese e il realismo (accenni al romanzo realista francese), da p. 185 + appunti; Il Verismo italiano: poetica e contenuti, da p. 208 + appunti; GIOVANNI VERGA Vita, poetica e tecnica narrativa, da p. 288 + appunti; L’ideologia verghiana ("l'ideale dell'ostrica", la “religione della famiglia”, l’impossibilità di mutar stato, il motivo dell’esclusione), appunti; Vita dei campi, da p. 301; Il ciclo dei Vinti - I Malavoglia, da p. 321; Testi antologici – vol. 3.1 Flaubert, I sogni romantici di Emma (lettura consigliata, pag. 193); E. e J. de Goucourt: Un Manifesto del Naturalismo da Prefazione a Germinie Lacerteux , p. 196; Microsaggio - Il discorso indiretto libero, p. 192; GIOVANNI VERGA Impersonalità e "regressione" da Prefazione all' Amante di Gramigna in Vita dei campi ,p. 294; Fantasticheria, Rosso Malpelo, La Lupa in Vita dei Campi , da p. 302 + p. 390;
28
I "vinti" e la "fiumana del progresso" in Prefazione a I Malavoglia, p. 321; La roba in Novelle rusticane , p. 347; I Malavoglia (lettura integrale consigliata): Da I Malavoglia: Il mondo arcaico e l'irruzione della storia (cap. I), La conclusione del romanzo: L'addio al mondo pre-moderno (cap. 15), da p. 331; Microsaggio - Lo straniamento, p. 318; R. Luperini, Verga e il lavoro: intenti edificanti e critica dell’alienazione, p. 319; La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati, da p. 163; Il caso BAUDELAIRE, vita e poetica (appunti + riferimento al testo p. 417); Simbolismo (accenni ai poet maudit: Verlaine e Rimbaud), appunti + riferimento al testo p. 431; Testi antologici – vol. 3.1 SCAPIGLIATURA Arrigo Boito, Dualismo, p. 173; Arrigo Boito, Lezione di anatomia, da Libro dei versi (in fotocopia); Emilio Praga, Preludio da Penombre (in fotocopia); Igino U. Tarchetti, Memento da Disjecta (lettura in aula); Microsaggio - La boheme parigina, p. 163 – lettura consigliata; Cletto Arrighi, La Scapigliatura da La Scapigliatura e il 6 febbraio (in fotocopia); C. BAUDELAIRE Corrispondenze in Spleen e Ideale IV- Fiori del male, p. 422; L’albatro da I fiori del Male, p. 424; Spleen in Spleen e Ideale IV- Fiori del male, p. 428; Il cigno in Quadri parigini, LXXXIX (in fotocopia); Perdita d’aureola in Lo Spleen di Parigi, p. 407; SIMBOLISMO P. Verlaine , Arte poetica in Allora e ora, p.434; A. Rimbaud, Vocali in Opere , p. 444; 3. LA CRISI DELLA RAGIONE Il Decadentismo: panorama letterario, appunti + riferimento al testo da p. 396; GIOVANNI PASCOLI La vita e il percorso letterario; La poetica del fanciullino, La poesia come memoria: strumento per recuperare il passato e “regredire” La poesia dell'inquietudine: gli aspetti dell’adultità che turbano l’ingenuità del fanciullo; La natura inquietante; Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia-nido. GABRIELE D’ANNUNZIO La vita e il percorso letterario, appunti + riferimento al testo da p. 478; L’ideologia e la poetica, schemi riassuntivi; Il panismo estetizzante del superuomo. L'incontro con Nietzsche. L'estetismo nell'arte e nella vita; L'esteta edonista: Il Piacere; L'esteta superuomo, Le vergini delle rocce; La raccolta di poesie: Alcyone da Le laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi; Visita al Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera; I MOVIMENTI D'AVANGUARDIA: Il Futurismo - Il Crepuscolarismo - in appunti e schemi sintetici; Il romanzo moderno psicoanalitico (in fotocopia); ITALO SVEVO La vita e il percorso letterario: appunti; La coscienza della crisi e l'inettitudine umana: l'incontro con Schopenhauer, Freud, Darwin, Joyce, Swift e Sterne. L'ironia. Caratteri dei romanzi sveviani; vicenda e tematiche. Una vita: l’inettitudine schopenhaueriana; Senilità: l’inettitudine intellettuale;
29
La coscienza di Zeno, un grande romanzo d’avanguardia. L'inettitudine salutare. LUIGI PIRANDELLO La vita e il percorso letterario, appunti; La coscienza della crisi dell'Io e la relatività dei punti di vista; L'arte come rappresentazione della crisi: l'umorismo. Le forme della convivenza con la crisi: La narrazione dell'incomprensibilità della vita: Il fu Mattia Pascal; L'abbandonarsi al flusso vitale: Uno, nessuno, centomila; Le novelle per un anno: dall’umorismo al Surrealismo. Il concedersi attimi di quotidiana follia: La carriola; e) Il teatro umoristico e il teatro nel teatro: L'incomunicabilità; Il conflitto forma-vita Testi antologici – vol 3.2 - GIOVANNI PASCOLI Una poetica decadente in Il fanciullino (p. 554); Microsaggio 11: Il "fanciullino" e il superuomo: due miti complementari (p. 559); X Agosto e L'assiuolo in Myricae (pp. 576+581); Il gelsomino notturno e La mia sera in Canti di Castelvecchio (p. 608 + fotocopia); Digitale purpurea in Poemetti (p. 594); Temporale, Il lampo e Il tuono (pp.584+ 589 + fotocopia); Lavandare e Italy (pp. 574 + 600) - GABRIELE D’ANNUNZIO Il Piacere: lettura integrale consigliata; Il verso è tutto in Il Piacere – appunti; La sera fiesolana, Le stirpi canore , La pioggia nel pineto e Meriggio in Alcyone (da p. 513 a 525); Il programma politico del superuomo in Le vergini delle rocce, libro I (p. 501); - MOVIMENTI DI AVANGUARDIA FUTURISMO: Microsaggio 1: Il mito della macchina (p. 652) lettura consigliata; F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo e Manifesto tecnico della letteratura futurista - (pp. 655+658); A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire in L'incendiario (p. 667) CREPUSCOLARISMO: S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale (p. 700); G. Gozzano, Totò Merumeni in Colloqui (p. 720); - ITALO SVEVO La coscienza di Zeno, lettura integrale; Le ali del gabbiano in Una vita, cap. 8 (p. 759); Il ritratto dell'inetto in Senilità, cap. 12 (p. 768); "Il fumo” cap. III - La vita non è né brutta né bella, ma è originale !" cap. VII - Psico-analisi, cap. VIII - La profezia di un'apocalisse cosmica in La coscienza di Zeno (da p. 789 e sg. + fotocopia); Lettura critica: Svevo e la psicoanalisi (p. 822) + L’inetto come “abbozzo” dell’uomo futuro da L’uomo e la teoria darwiniana (in fotocopia); Programma svolto dopo il 15 maggio 2015 - LUIGI PIRANDELLO La psicologia di Binet: “Ciascuno di noi è uno, ma contiene numerose persone” (in fotocopia); La vita come "enorme pupazzata":lettera alla sorella Lina, del 31 ottobre 1886 (in fotocopia); Un'arte che scompone il reale in L'umorismo (p. 847); Il treno ha fischiato e La carriuola in Novelle per un anno (p. 868 + fotocopia); Storia di parole: Maschera (p.284); Uno, nessuno e centomila - lettura integrale; La costruzione della nuova identità e la sua crisi in Il Fu Mattia Pascal (p. 884); Mia moglie e il mio naso (in fotocopia); Nessun nome in Uno, nessuno e centomila (p. 907) ;
30
Eventuale visione in aula dello spettacolo teatrale “Così è (se vi pare)”; 4. EUGENIO MONTALE Vita e percorso letterario, appunti. La coerenza dell'essenzialità; La poesia del "varco"; Il male di vivere; Il tempo e la memoria; Le raccolte poetiche più rappresentative: Ossi di seppia-Le occasioni-La bufera e altro- Satura; 5. GIUSEPPE UNGARETTI Vita e percorso letterario, appunti; L’essenzialità e il dolore; Il dolore della guerra; Le raccolte poetiche più rappresentative: L’allegria e Sentimento del tempo; Testi antologici – vol 3.2 - EUGENIO MONTALE Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, I limoni, Cigola la carrucola del pozzo in Ossi di seppia (pp. 236 e sg.) Non recidere forbice quel volto; La casa dei doganieri in Le Occasioni (p. 266 + 268); Piccolo testamento in La Bufera e altro; Ho sceso dandoti il braccio in Satura (p.288); Letture critiche consigliate: Le tematiche degli Ossi di seppia di P.V. Mengaldo (p.257). - GIUSEPPE UNGARETTI Il porto sepolto – Veglia – Sono una creatura – I fiumi – San Martino del Carso– Mattina - Soldati – Fratelli in L’allegria (da p. 171 + fotocopia); 5. DANTE ALIGHIERI, DIVINA COMMEDIA Paradiso: struttura della cantica; Primo canto: analisi (protasi e invocazione, ascesa al cielo, primo dubbio di Dante, secondo dubbio di Dante, "transumanar": riflessione linguistica); Terzo canto: analisi (le anime del Cielo della Luna e la chiarificazione su quanto la loro volontà sia pienamente conforme al “Sommo Bene”).
31
INGLESE Docente Katherine Anne Martin
Testi adottati Ballabio, Brunetti, Lynch Roots- Culture, literature, society, ed. Europass
Altri materiali Fotocopie, DVD, video online
Argomenti N. ore
Entry test and initial evaluation of the class 3
Crime 10
Frankenstein 10
Animal Farm 8
Democracy 9
The Internet 7
The Family 8
The US economy and the UK general election 5
Reading and Writing skills 8
Speaking skills and pronunciation practice 5
Grammar revision 4
(in allegato le indicazioni dei contenuti) N° debiti in ingresso 0 Attività di recupero sportello
N° alunni N° totale ore 10 10
Metodologia Strumenti di verifica Supporti didattici
32
Lezioni interrativi Verifiche scritte libro di testo
Lezioni frontali verifiche orali Audiovisivi
Lavori di gruppo e in coppia relazioni Teatro
Lavoro individuale simulazioni prova d’esame Esercizi d’ascolto
Discussioni in classe Dizionari monolingue e bilingue
Attività di auto verifica Fotocopie
Lezioni con mind maps LIM Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità specifiche comprendere il contenuto di testi di varia tipologia quali articoli e testi letterari di diverso genere (anche con l'ausilio del dizionario bilingue), comprendere discorsi estesi e argomentazioni complesse su temi nuovi e familiari; comprendere film in lingua standard con sottotitoli; partecipare ad una discussione su argomenti familiari e su temi del proprio ambito disciplinare, argomentando il proprio punto di vista; relazionare brevemente su argomenti letterari studiati precedentemente; illustrare argomenti noti in modo chiaro e semplice; scrivere un saggio breve sostenendo con argomenti efficaci il proprio punto di vista; Rapporto con la classe Il gruppo classe si è subito dimostrato collaborativo ed interessato agli argomenti proposti e molto volenteroso a migliorare il proprio livello d’inglese. Nonostante l’ampia diversità di livello linguistico all’interno della classe, gli studenti collaborano tra di loro in modo molto proficuo, traendo benefici dai pregi di ognuno. Inoltre abbiamo stabilito di utilizzare esclusivamente la lingua inglese in classe, regola che si è rivelata una grande sfida per gli studenti. Tuttavia hanno anche manifestato sin dall’inizio un forte bisogno di sostegno, supporto morale ed incoraggiamento, credendosi spesso inadeguati e lamentandosi della loro situazione visto che purtroppo la classe ha cambiato insegnante d’inglese ogni anno. Si sono dimostrati quasi sempre pronti con le consegne ed il materiale, mentre lo studio si è limitato ad essere spesso mnemonico o superficiale senza dimostrare grande capacità di interpretazione o collegamento. Osservazioni del docente La classe si presenta con un livello molto eterogeneo. 2 studenti hanno trascorso l’anno all’estero negli stati uniti e gli stessi hanno seguito l’esame FCE con successo. Altri due studenti si presentano al livello B2, la parte rimanente della classe oscilla tra un basso livello B1 e un livello quasi B2. Nel trimestre abbiamo lavorato lentamente, alzando gradualmente le aspettative. Verso la fine del trimestre alcune lezioni specifiche sono state dedicate a come pianificare e svolgere un breve saggio, a produrre testi coerenti e coesi, a dare al proprio saggio un'introduzione, un corpo centrale e una conclusione. All’inizio del pentamestre, invece, la classe ha acquisito competenze nell’analisi dei testi, cercando dei collegamenti tra questi ed i contesti sociali e storici, ed in particolar modo con quanto studiato durante le ore di CLIL e le ore d’inglese. Nell’ultimo periodo hanno studiato due argomenti d’attualità e questo ha dato loro l’opportunità d’esprimere le proprie opinioni.
33
Contenuti Attività di lettura ed ascolto e produzione orale e scritta svolte dal libro di testo: Ballabio, Brunetti, Lynch Roots- Culture, literature, society Europass An overview of the US economy (p182-183, p187) A changing family – family types, the family in songs (p300-301, p308-309) The web – Communication and privacy (p320-321) What is Democracy? – The documents, Democracy and the distribution of wealth, Rosa Parks, Nelson Mandela, Animal Farm, The Grapes of Wrath (p 90-93 p96-105) The Crown, Parliament and Government, Political Parties (p194-195) Letture e temi per discussione Crime – How knife culture is making our streets dangerous places, Should spitting out gum be banned?, True Crime Stories. (Trattati dal libro For Real Intermediate, Hobbs & Keddle, Cambridge) Frankenstein - Romantic Rebel – P.B.Shelley (For Real Intermediate, Hobbs & Keddle, Cambridge), The gothic novel and a brief biography of Mary Shelley (notes from the internet), The Monster comes to Life (A Mirror of the Times Mingazzini & Salmoiraghi, Morano Editore), Mary Shelley’s Frankenstein (Only Connect…Volume 2, Spiazzi &Tavella, Zanichelli) Animal Farm – Animal Farm – abridged story, (http://cbhs.portlandschools.org/UserFiles/Servers/Server_1098483/File/Migration/Animal-Farm-Abridged.pdf), The Russian Revolution (English in Mind Cambridge) Internet – The tyranny of technology (abridged from New English File Advanced, Oxenden & Latham-Koenig, Oxford), Music and the Internet Revolution (FCE Buster, Clyde, Dodgson, Harwood, ELI) Family – Goya’s Family Portrait – listening activity and vocabulary building (New English File Advanced, Oxenden & Latham-Koenig, Oxford), Gender gaps on the brain (Cutting Edge Upper Intermediate, Cunningham & Moor, Longman) Other - Land of the Innuit (Get on Track to FCE, Copage, Luque-Mortimer, Stephens, Pearson-Longman) Across Antartica, Robotics, The Picture of Dorian Gray (Gateway Destination B2, Spencer, Macmillan) Approfondimento linguistico Modali di consiglio ed obbligo (Get Inside Language, Vince, Macmillan) How to write a review (FCE Buster, Clyde, Dodgson, Harwood, ELI) Film, video clip e uscite didattiche Frankenstein (1994) directed by Kenneth Brannagh Stage adaptation of Frankenstein at Teatro di Pergine My Family Portrait Pink
34
LINGUA SPAGNOLA Docente Daniel Garcia
Testi adottati Libri “Uso de la gramatica. Nivel intermedio”, “Así somos”
Altri materiali Fotocopie, powerpoint, internet
Argomenti N. ore
Grammatica 32
Cultura e civiltà 20
Conversazione, attività pratica 25
Prove 10
(in allegato le indicazioni dei contenuti) N° carenze in ingresso Nessuna carenza in ingresso Attività di recupero Nessuna
N° alunni N° totale ore 18 87
Metodologia Strumenti di verifica Supporti didattici
Lezione frontale e interattive, lezione interattiva, esercitazioni guidate, lavori di gruppo, lavori di ricerca
Verifiche scritte ed orali, relazioni, lavori di ricerca, dialoghi e prove di traduzione simultanea
Libri di testi, fotocopie, internet, powerpoint, canzoni
35
Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità specifiche In relazione alla programmazione curricolare si ritiene siano conseguiti, a diversi livelli e con un risultato nella maggioranza dei casi appena sufficiente, i seguenti obiettivi in termini di: Competenze Potenziare la competenza linguistica che consente agli alunni una discreta interazione in contesti diversificati Sostenere una conversazione funzionale al contesto Comprendere una varietà di messaggi orali in contesti diversificati Utilizzare le nuove tecnologie per lo studio della lingua e per l’approfondimento culturale Comprendere e riassumere testi Produrre testi orali e scritti di tipo descrittivo e/o espositivo Educare al cambiamento e allo sviluppo di un’educazione interculturale che porti al studenti ad un atteggiamento positivo ed aperto nei confronti del diverso da sé mediante il contatto con le altre realtà Conoscenze Vocabolario vario Funzioni comunicative Strutture sintattiche fondamentali Capacità specifiche Linguistico-espressive Logico analitiche Interpretative Interagire correttamente e con atteggiamento collaborativi Confrontarsi con una cultura diversa ed apprezzarla nella sua peculiarità Rapporto con la classe La classe 5 BSE presenta due gruppi chiaramente differenziati per quanto riguarda la relazioni con il docente: un primo gruppo relativamente comunicativo e con una discreta capacità di socializzare, e un altro gruppo per il quale la comunicazione è quasi nulla e inefficace. Di solito l’insegnante deve ricorrere a una severità e autorità impropria di una classe 5, con studenti maggiorenni. Non è un gruppo insolente neanche difficile da gestire a un livello accademico, ma impossibile da coinvolgere e interagire nel piano personale e sociale. Osservazioni del docente La classe 5 BSE è caratterizzata da un notevole senso di unità e un clima positivo tra gli studenti che, però, non si riflette nell’andamento accademico, avendo un’enorme disparità di livelli, abilità, impegno e attitudine nei confronti del docente. Ci sono elementi –scarsi- che dimostrano una maturità e responsabilità ottima, insieme a una preoccupante mediocrità e incapacità d’apprendimento. Eccetto un piccolo numero di allievi più volenterosi che abili, la maggior parte della classe presenta delle gravissime carenze formative e personali per affrontare un percorso linguistico di grado superiore. Dopo cinque anni di studio di lingua spagnola, quasi nessuno è in grado de farsi capire in questa lingua e continuano a fare gli stessi sbagli che farebbero gli alunni della scuola elementare. In definitiva, la classe non ha raggiunto il livello linguistico previsto per la fine di un quinquennio (B2 secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento). Contenuti
36
Grammatica (libro Uso de la gramática. Nivel intermedio) Unidad 1. Pasado simple. Unidad 2. Imperfecto. Unidad 3. Pluscuamperfecto, “por”, “para”. Unidad 4. Diferencias “saber”, “conocer”, “poder”. Unidad 5. Perífrasis “estar + gerundio”. Unidad 6. Imperativo. Unidad 7. Preposiciones. Unidad 8. Futuro simple y compuesto. Unidad 9. Condicional. Unidad 10. Subjuntivo. “Quizás”, “ojalá”. Unidad 11. Género de los sustantivos. Unidad 14. Ausencia o presencia de artículos. Unidad 15. Comparativos y superlativos. Unidad 16. Contraste entre “ser” y “estar”. Cultura e civiltà (libro Así somos, fotocopie e internet) El idioma español en el mundo. España. Geografía y división territorial. Etimología nombre España. Idiomas oficiales en España. Las fiestas en España. La música española. El Español de Latinomérica. El Camino de Santiago. El desastre del Prestige. El terrorismo en España. El 11-M. El machismo en el lenguaje. Programma svolto fino al 15 maggio. Dal 16 maggio al termine delle lezione si prevedono 10 ore di ripasso, conversazione e prove scritte ed orali.
37
EDUCAZIONE FISICA Docente ANTONIO MORONI
Testi adottati
Altri materiali Palestra: piccoli e grandi attrezzi
Argomenti N. ore
Potenziamento fisiologico (primo periodo): resistenza generale, velocità, allungamento. 12
Rielaborazione degli schemi motori (primo periodo) 12
Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico (primo e secondo periodo)
30
Conoscenze e pratica delle attività sportive (primo e secondo periodo) 30
Metodologia Strumenti di verifica Supporti didattici
Lezione frontale
Lavoro di gruppo
Processi individualizzati Esercitazioni guidate
verifica delle capacità condizionali e coordinative attraverso l’esecuzione di particolari esercizi e relativo miglioramento verifiche dirette a valutare il grado di appropriazione di un linguaggio tecnico verifiche che valutino la capacità di gestire autonomamente un lavoro ed organizzarlo all’interno del gruppo
Piccoli e grandi attrezzi
38
Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità specifiche Consapevolezza che il movimento è esigenza di vita Consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti motori Discrete capacità coordinative e condizionali Discrete abilità motorie e specifiche, concernenti le attività sportive praticate: pallavolo, pallacanestro, pallamano, unihockey, calcio a 5. Rapporto con la classe
Ho cercato di inculcare l’amore per l’attività motoria, per lo sport, soprattutto come mezzo per conoscere e stare meglio
con il proprio corpo. Sono riuscito ad instaurare, grazie alla maturità dei ragazzi, un rapporto di amicizia, di rispetto, di
fiducia reciproca ed un dialogo, questi elementi hanno influito positivamente sulla partecipazione all’attività per la quale i
ragazzi hanno sempre dimostrato grande impegno ed interesse.
Osservazioni del docente Ho svolto il programma in maniera completa, sviluppando i vari punti della programmazione.
Ho sempre cercato nel mio lavoro di avere sempre presenti quelle che sono le finalità dell’Educazione Fisica, cioè tendere
al coinvolgimento degli alunni, indirizzati all’organizzazione del patrimonio motorio delle varie discipline sportive e delle
attività espressive; tutto questo facendo ricorso ad un metodo individualizzato, ad una continua valutazione dello sviluppo,
tenendo conto delle tendenze e degli interessi personali.
Contenuti
1) Potenziamento fisiologico attraverso:
- miglioramento delle funzioni cardio-respiratorie;
- aumento della forza muscolare;
- sviluppo della velocità di movimento e di reazione;
- aumento della mobilità articolare ed allungamento muscolare.
2) Rielaborazione degli schemi motori attraverso: proposte didattiche varie e molteplici tali da proporre situazioni sempre nuove e diverse;
rapporti non abituali con la spazio e con il tempo con l’uso di piccoli e grandi attrezzi.
39
3) Consolidamento del carattere e del senso civico attraverso: giochi di squadra che implicano il rispetto delle regole, l’assunzione di ruoli, spirito di collaborazione, affidamento di compiti di giuria, arbitraggio e di organizzazione. 4) Conoscenza e pratica delle attività sportive attraverso: fondamentali individuali e di squadra della pallavolo, conoscenza dei ruoli e delle regole principali; fondamentali individuali e di squadra della pallacanestro, conoscenza dei ruoli e delle regole principali fondamentali individuali e di squadra del calcio a 5, conoscenza dei ruoli e delle regole principali fondamentali individuali e di squadra della pallamano, conoscenza dei ruoli e delle regole principali fondamentali individuali e di squadra dell’unihockey, conoscenza dei ruoli e delle regole principali
PROGRAMMA TEORICO regolamento, fondamentali individuali e di squadra della pallavolo regolamento, fondamentali individuali e di squadra della pallacanestro regolamento, fondamentali individuali e di squadra del calcio a 5 regolamento, fondamentali individuali e di squadra della pallamano regolamento, fondamentali individuali e di squadra dell’unihockey ATTIVITA’ SPORTIVE EXTRACURRICOLARI SVOLTE partecipazione ai campionati studenteschi: sci, snowboard, calcio a cinque, pallavolo, nuoto, atletica, orienteering partecipazione al Beach&Volley School 2014, torneo nazionale di beach volley ( hanno partecipato quattro alunne)
40
DIRITTO ED ECONOMIA
Docente Ezia Moreschini
Testi adottati A SCUOLA DI DIRITTO E DI ECONOMIA
Gustavo Zagrebelsky, Cristina Trucco, Giuseppe Bacceli
Argomenti N. ore
Principi fondamentali della Costituzione e i diritti e i doveri dei cittadini 16
L’organizzazione costituzionale 20
L’amministrazione dello Stato 6
Stato autonomistico, Europa e organismi internazionali, Prov. Aut. Trento 20
Il diritto globale e la globalizzazione 10
Stato e mercato e il terzo settore 8
Spesa pubblica e sistema tributario 6
Politiche di stabilizzazione nell’area euro 4
(in allegato le indicazioni dei contenuti) N° debiti in ingresso 0
N° alunni N° totale ore 19 90
Metodologia Strumenti di verifica Supporti didattici
Lezione frontale Verifiche scritte Libro di testo
Lezione interattiva Verifiche orali Laboratorio
Lettura di quotidiani Prove strutturate Quotidiani
41
Uscite didattiche Simulazioni d’esame Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità specifiche Premesso che i livelli di interesse, impegno e partecipazione della classe sono risultati diversificati, alcuni studenti hanno conseguito un discreto livello di conoscenze e competenze, grazie ad un lavoro costante e responsabile e ad una capacità di accostarsi alla materia come esperienza formativa della propria personalità, ma anche come occasione di conoscenza della realtà e chiave di interpretazione della società. Altri, meno coinvolti, hanno dimostrato qualche difficoltà di concentrazione e discontinuità nell’impegno, per cui il livello della preparazione è risultato più superficiale, in qualche caso non omogeneo. Gli obiettivi didattici e cognitivi proposti per l’anno in corso sono stati sostanzialmente raggiunti. Complessivamente gli studenti hanno acquisito i nuclei fondamentali della disciplina, ottenendo risultati mediamente soddisfacenti.
• Comprendere il concetto di Stato e gli elementi che lo costituiscono
• Conoscere la composizione, l’organizzazione e la funzione degli organi costituzionali
• Identificare nel testo costituzionale la struttura e i principi fondamentali che lo caratterizzano
• Conoscere e comprendere gli elementi essenziali della vita democratica e delle libertà dei cittadini
• Comprendere i principi costituzionali che regolano la Pubblica amministrazione
• Conoscere, interpretare e sistematizzare le principali norme che regolano l’attività dello stato, le autonomie locali e in particolare le ragioni dell’autonomia della Regine a statuto speciale Alto Adige Sudtirol.
• Conoscere le differenze tra settore pubblico e settore privato
• Comprendere le ragioni giuridiche ed economiche del terzo settore
• Conoscere le tappe fondamentali dell’unificazione europea dal 1957 ad oggi , gli organi UE e le loro funzioni. Illustrare il concetto di cittadinanza europea ed individuare le finalità dell’ONU.
42
• Individuare i nuclei portanti della cultura economica (impresa, mercato, finanza pubblica, debito pubblico, spesa sociale, stabilità della moneta ed equità nel rapporto fra i Paesi e le generazioni)
• Comprendere cause ed effetti del processo di globalizzazione in atto
• Comprendere gli effetti della politica economica sui sistemi economici
Rapporto con la classe
Il rapporto con la classe è stato corretto e costruttivo, alcuni studenti hanno raggiunto un discreto livello di consapevolezza e responsabilità rispetto al lavoro e al dialogo educativo, altri, più riservati e forse meno coinvolti, si sono limitati ad un ascolto meno attivo. Nel complesso la classe,che io conosco da due anni, in questo ultimo anno scolastico, è maturata e ha compreso il significato di lavoro e di responsabilità. La frequenza alle lezioni, è stata abbastanza regolare per la maggior parte degli studenti. Osservazioni del docente …………………………….. Contenuti
• Lo Stato e gli elementi costitutivi
• Origine, struttura e principi della Costituzione
• I diritti di libertà
• I diritti socio-economici e i doveri
• La forma di governo e i sistemi elettorali
• Il Parlamento e il governo
• Presidente della Repubblica, Magistratura, Corte Costituzionale
• L’amministrazione dello Stato e i principi costituzionali della Pubblica Amministrazione
• Lo Stato autonomistico: le regioni e gli enti locali (P.A.T.)
• L’Unione Europea e gli altri organismi internazionali
43
• Il diritto nell’età, della globalizzazione
• Lo sviluppo sostenibile e il patto intergenerazionale
• L’economia pubblica
• Le ragioni giuridiche e le ragioni economiche del terzo settore
• La distribuzione del reddito e la spesa pubblica
• Bilancia dei pagamenti, sistemi di cambio e teorie del commercio internazionale
• Un mondo senza confini: la globalizzazione
Parte che si prevede di svolgere dal 16 maggio 2015 al termine delle lezioni.
• Le politiche di stabilizzazione nell’area euro
• Il sistema tributario
45
Fisica Docente Giovanni Brezzi
Testi adottati Caforio-Ferilli: Fisica! (ed. verde)
Altri materiali Lavagna luminosa, applets.
Argomenti N. ore
Fenomeni termici Modello microscopico di gas, liquido e solido. Modello atomo (planetario). Temperatura (concetto microscopico, associata alle vibrazioni atomiche) e scale termometriche. Dilatazione termica. Calore (trasferimento di energia). Equilibrio termico. Calore specifico. Cambiamenti di stato e cenni al calore latente.
20
Onde Proprietà delle onde, sovrapposizione, trasferimento di energia ma non di materia, longitudinali e trasversali, periodo, frequenza, velocità. Raggi e fronti d’onda. Onde meccaniche ed elettromagnetiche Riflessione di una onda trasversale su vincolo fisso o libero. Onde sonore: concetto di suono, classificazione, intensità, velocità (aria o altri materiali. Onde elettromagnetiche: non meccanica, propagazione nel vuoto, classificazione in frequenza e lunghezza d’onda, velocità.
18
Elettrologia Isolanti e conduttori (e modello microscopico). Metodi di elettrizzazione. Concetto di circuito aperto e chiuso. Cenni su lla tensione. Corrente elettrica. Legge di Ohm V=Ri, resistenza. Effetto Joule. Intensità luminosa di lampadine in serie e in parallelo. Da fare dopo il 15 maggio: cenni sul magnetismo e sull’effetto magnetico delle correnti.
7
(al 15/5)
N° carenze in ingresso / Attività di recupero Corso di recupero 3 ore, recupero in itinere.
Metodologia Strumenti di verifica Supporti didattici
Lezione frontale e dialogata, uso di applets. Verifiche scritte, verifiche orali. Libro di testo,
laboratorio.
46
Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità specifiche Conoscenza (mediamente) degli argomenti trattati. Gli studenti sono in grado di risolvere semplici esercizi numerici. Rara la capacità di gestire in autonomia un argomento assegnato o un argomento trattato non di recente. Rapporto con la classe Buono, dal punto di vista personale, il rapporto con la classe, che ho dalla terza. La classe si è dimostrata di buon livello, buona la partecipazione, corretto il comportamento. La classe a volte si dimostra dispersiva e richiede la totale circoscrizione degli argomenti trattati, evidenziando buona attitudine al lavoro ma scarsissima autonomia.
47
MATEMATICA Docente Barbara Carlin
Testi adottati Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica.azzurro, Zanichelli, vol. 5
Altri materiali Esercizi tratti da altri testi
Argomenti N. ore
Ripasso equazioni e disequazioni di primo e secondo grado, razionali intere e fratte
4
Funzioni razionali intere e fratte: definizione, dominio, codominio, simmetria pari e dispari
11
Intersezione con gli assi e studio del segno di una funzione razionale intera o fratta
5
Ripasso funzione esponenziale e logaritmica: dominio, intersezioni con gli assi e studio del segno
8
Limiti di funzioni razionali fratte: definizioni, calcolo e loro interpretazione geometrica
15
Studio degli asintoti di una funzione razionale fratta: asintoti verticali, orizzontali e obliqui
14
Derivata prima di una funzione: rapporto incrementale, definizione, interpretazione geometrica, formule di derivazione
14
Massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale di una funzione: studio del segno della derivata prima e andamento della funzione
12
Ripasso e studio completo di funzioni razionali intere e fratte 15
(in allegato le indicazioni dei contenuti) N° debiti in ingresso 1 (colmata nella prima parte dell’anno scolastico) Attività di recupero Corso di recupero in orario extrascolastico nel periodo settembre/ottobre e recupero in itinere
N° alunni N° totale ore 18 98
Metodologia Strumenti di verifica Supporti didattici
Lezione frontale: 40% Lezione interattiva, partecipata, lavori di gruppo: 15% Esercitazioni guidate: 45%
Verifiche scritte di varia tipologia: 60% Verifiche orali: 30% Simulazioni terza prova d’esame: 10%
Libro di testo Esercizi vari tratti da altri testi
48
Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità specifiche In generale, la classe: Si è approcciata alla disciplina sforzandosi di adottare la terminologia specifica, non ancora padroneggiandola, ma si esprime con un linguaggio corretto e più tecnico rispetto a quello di inizio anno; Ha recuperato e ha acquisito maggior padronanza e consapevolezza nel calcolo numerico e algebrico; Conosce il concetto di funzione ed è in grado di valutarne il dominio, il codominio, le intersezioni con gli assi cartesiani e lo studio del segno; È in grado di calcolare i limiti di una funzione razionale sia intera che fratta, anche in casi di indeterminazione; Sa ricavare l’equazione degli asintoti di una funzione razionale intera e fratta (orizzontale, verticale e obliquo); Sa calcolare la derivata di una funzione razionale intera o fratta e ne conosce sia la definizione che il significato geometrico; Sa utilizzare lo studio della derivata di una funzione razionale intera e fratta per determinarne i punti stazionari (massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale); Sa rappresentare nel piano cartesiano l’andamento di una funzione razionale intera e fratta. Rapporto con la classe Il rapporto con la classe, seguita fin dallo scorso anno scolastico, è sempre stato corretto e improntato al rispetto. Nel corso delle lezioni l’atteggiamento è stato quasi sempre collaborativo ed interessato, nonostante qualche studente presentasse alcune difficoltà, anche pregresse, nello studio della matematica, che ne hanno limitato la partecipazione attiva. La regolare frequenza e l’impegno quasi sempre costante, hanno permesso alla maggior parte del gruppo classe di interiorizzare gli argomenti trattati anche se qualcuno tende ancora a preferire uno studio prevalentemente mnemonico anziché ragionato. Osservazioni del docente Tranne un paio di studenti che dimostra ancora difficoltà di logica e calcolo che compromettono il raggiungimento di una preparazione adeguata, la classe si può dividere in due gruppi: uno ha conseguito risultati pienamente sufficienti, nonostante l’impegno non sempre costante; un altro si è distinto per maggior interesse e partecipazione ed ha raggiunto una preparazione più che buona. Contenuti Ripasso: equazioni di I grado, discriminante e numero di soluzioni di un’eq. di II grado, parabola e significato geometrico di un’eq. di II grado, disequazioni di I e II grado, intere e fratte, risoluzione delle disequazioni come studio del segno di rette e parabole. Le funzioni definizione, variabili dipendenti e indipendenti, dominio e codominio di funzioni razionali intere e fratte, simmetria delle funzioni: parità e disparità, intersezione di una funzione con gli assi cartesiani, studio del segno di una funzione, rappresentazione cartesiana dei sopracitati elementi caratteristici di una funzione. Limiti di funzioni e asintoti
49
concetto intuitivo di limite dato dall’osservazione e dall’esame del grafico approssimativo della funzione, calcolo dei limiti per sostituzione,
forme indeterminate del tipo 00
e ∞∞
,
asintoti orizzontali, verticali e obliqui derivanti dallo studio dei limiti di funzioni razionali intere e fratte e loro rappresentazione sul piano cartesiano, grafico probabile di funzione. Derivata di una funzione rapporto incrementale e suo significato geometrico, interpretazione geometrica: derivata in un punto come coefficiente angolare della retta tangente al grafico della funzione in quel punto, definizione di derivata mediante il limite del rapporto incrementale, calcolo per casi semplici (funz. polinomiali di primo, secondo grado), formule per il calcolo di alcune derivate (pensando allo studio di sole funzioni razionali fratte): derivata delle funzioni polinomiali, formula del quoziente di funzioni polinomiali. Studio della derivata prima punti stazionari, studio degli intervalli di crescenza e decrescenza mediante il segno della derivata prima, massimi e minimi, relativi e assoluti, flessi a tangente orizzontale. Grafico delle funzioni razionali intere e razionali fratte
50
Filosofia
Docente Stefania Denicolai
Testi adottati Nuovo protagonist i e test i della f i losofia, Abbagnano Fornero, vol.3A+3B, ed. Paravia
Argomenti N. ore
L’IDEALISMO TEDESCO: HEGEL
16
LA CONTESTAZIONE DELL'HEGELISMO
11
LA SINISTRA HEGELIANA E IL MARXISMO
21
NIETZSCHE
10
N° carenze in ingresso due Attività di recupero corso di recupero, recupero in itinere
N° alunni N° totale ore 18 58
Metodologia Strumenti di verifica Supporti didattici Lezione frontale Verifiche orali Libro testo
Lezione interattiva Verifiche scritte Testi filosofi Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità specifiche Capacità: • Selezione delle informazioni
• Potenziamento delle abilità argomentative Competenze: • Contestualizzazione dei concetti
• Comparazione tra autori e piattaforme tematiche differenti
Rapporto con la classe
51
La classe ha dimostrato, nel corso del triennio, una non sempre costante partecipazione al dialogo educativo ed un discontinuo impegno nello studio. Ciò non ha permesso a tutti gli studenti l’acquisizione di un metodo di studio adeguato. Dal punto di vista del profitto emergono delle differenze fra i singoli studenti, in particolare si evidenzia accanto a diverse fragilità, un piccolo gruppo che ha ottenuto risultati più che discreti. Osservazioni del docente Per quanto riguarda lo svolgimento del programma si è voluto proporre il contenuto della materia in modo da stimolare gli studenti ad intervenire riflettendo criticamente, proponendo quesiti. Laddove è stato possibile, si è cercato di integrare alcune delle problematiche storiche con quelle filosofiche (ad esempio le teorie marxiste con il reale divenire storico di queste). I criteri di valutazione hanno evidenziato la richiesta, da parte dell'insegnante, dell'acquisizione della capacità di rielaborare criticamente i diversi contenuti. Tale obiettivo è stato raggiunto inizialmente attraverso un lavoro guidato mirato, però, al raggiungimento successivo di abilità individuali. Durante la verifica orale, sempre relativa ad una vasta parte di programma in modo da rendere possibili collegamenti e confronti, si è richiesto lo sforzo di riflettere in modo critico attribuendo maggiore importanza alle riflessioni filosofiche più significative. La trattazione delle teorie filosofiche ha sempre seguito l’indirizzo della contestualizzazione storica e della problematizzazione delle diverse tematiche incontrate con l’intento di far comprendere il legame esistente tra la domanda filosofica e la concreta esperienza esistenziale umana. Infine, si evidenziano i seguenti criteri di verifica e valutazione: • Capacità di esporre in modo logico e organico
• Capacità di individuare ed illustrare sinteticamente le tesi principali di un autore
• Capacità di problematizzazione a partire da un argomento proposto
• Capacità di confrontare e contestualizzare risposte differenti inerenti un medesimo problema
• Capacità di conferire una struttura logico-argomentativa ai problemi presi in esame
• Capacità di riconoscere termini e concetti filosofici
Contenuti HEGEL • I capisaldi del sistema • Idea, Natura, Spirito. Le ripartizioni della filosofia • La Dialettica • La fenomenologia dello spirito (in sintesi) • La logica (unicamente nella sua struttura fondamentale) • La filosofia dello Spirito • Lo spirito oggettivo: Diritto astratto -Moralità- Eticità • La filosofia della storia • Lo spirito assoluto: Arte-Religione (in sintesi)-Filosofia LA CONTESTAZIONE DELL'HEGELISMO SCHOPENHAUER • Il mondo della rappresentazione come "velo di Maya" • La scoperta della via d'accesso alla cosa in sé • Caratteri e manifestazioni della "volontà di vivere" • Il pessimismo
52
• Le vie di liberazione dal dolore: arte, etica della pietà, ascesi. LA SINISTRA HEGELIANA E IL MARXISMO La sinistra hegeliana è stata trattata come corrente, senza soffermarsi sugli autori minori. FEUERBACH • La critica alla religione • Umanismo naturalistico MARX • Caratteristiche del marxismo • La critica al "misticismo logico"di Hegel • La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione • "politica" e "umana" • La critica dell'economia borghese e la problematica dell'alienazione • Il distacco da Feuerbach e l'interpretazione della religione in chiave "sociale" • La concezione materialistica della storia • Dall'ideologia alla scienza • Struttura e sovrastruttura • La legge della storia e le grandi formazioni economico- sociali • La critica agli ideologi della sinistra hegeliana • Il "Manifesto" • Borghesia, proletariato e lotta di classe • Il Capitale • Merce, lavoro e plusvalore • La rivoluzione e la dittatura del proletariato • Le fasi della futura società comunista NIETZSCHE • La denuncia delle "menzogne millenarie" dell'umanità e l'ideale di un "oltre-uomo" • Nietzsche e Schopenhauer • Il "dionisiaco" e l' "apollineo" come categorie interpretative del mondo greco • L'accettazione totale della vita
53
Storia
Docente Stefania Denicolai
Testi adottati Tempi Moderni, Maifreda, vol.3, ed. Mondadori
Altri materiali • Analisi delle leggi razziali i ta l iane del 1938 • Analisi del Manifesto degli scienziat i i ta l iani razzist i del 1938 • Analisi del Manifesto degli scienziat i i ta l iani ant irazzist i, luglio 2008
Argomenti N. ore
L’EUROPA AVVIATA VERSO LA PRIMA GUERRA MONDIALE 7
L'ETA' GIOLITTIANA
5
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
12
LA CRISI DELLO STATO LIBERALE E L'AVVENTO DEL FASCISMO IN ITALIA
10
LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR ALLA COSTITUZIONE DEL TERZO REICH
14
MODALITA’ CLIL IL MONDO TRA LE DUE GUERRE. LA "GRANDE CRISI" E I PRIMI ANNI TRENTA
20
L'EUROPA VERSO LA SECONDA GUERRA MONDIALE
10
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
8
L'ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
5
N° carenze in ingresso tre Attività di recupero corso recupero, recupero in itinere
N° alunni N° totale ore 18 91
Metodologia Strumenti di verifica Supporti didattici Lezione frontale Verifiche orali Libro testo
54
Lezione interattiva Verifiche scritte audiovisivi
slide Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità specifiche Capacità • miglioramento abilità espressive e argomentative Competenze
• ricostruzione di un contesto spazio-temporale
• gerarchizzazione dei fattori storici Rapporto con la classe La classe ha dimostrato, nel corso del triennio, una non sempre costante partecipazione al dialogo educativo ed un discontinuo impegno nello studio. Ciò non ha permesso a tutti gli studenti l’acquisizione di un metodo di studio adeguato. Dal punto di vista del profitto emergono delle differenze fra i singoli studenti, in particolare si evidenzia accanto a diverse fragilità, un piccolo gruppo che ha ottenuto risultati più che discreti. Osservazioni del docente Per quanto riguarda lo svolgimento del programma si è voluto proporre il contenuto della materia in modo da stimolare gli studenti ad intervenire riflettendo criticamente, proponendo quesiti. Laddove è stato possibile, si è cercato di integrare alcune delle problematiche storiche con quelle filosofiche (ad esempio le teorie marxiste con il reale divenire storico di queste). I criteri di valutazione hanno evidenziato la richiesta, da parte dell'insegnante, dell'acquisizione della capacità di rielaborare criticamente i diversi contenuti. Tale obiettivo è stato raggiunto inizialmente attraverso un lavoro guidato mirato, però, al raggiungimento successivo di abilità individuali. La parte storica è stata integrata con quella storiografica con l’intento di motivare gli avvenimenti offrendone,così, un' interpretazione non esclusivamente nozionistica. Durante la verifica orale, sempre relativa ad una vasta parte di programma in modo da rendere possibili collegamenti e confronti, si è richiesto lo sforzo di riflettere in modo critico attribuendo maggiore importanza ai fatti più rilevanti. Comune a tutto lo svolgimento del programma è stato un criterio di presentazione degli eventi mirato dapprima a un inquadramento delle strutture di lunga durata (economia e società) e poi a un’analisi cronologicamente ordinata degli eventi procedendo, per così dire, secondo cerchi concentrici: Mondo-Europa–Italia. Durante le verifiche, è stato richiesto agli studenti la memorizzazione soltanto delle date più importanti non esigendo in modo fiscale il ricordo delle altre senza rinunciare, però, ad una buona contestualizzazione periodica degli avvenimenti. In fine si evidenziano i seguenti criteri di verifica e valutazione: • Conoscenza degli eventi e capacità di collocarli nel tempo e nello spazio
• Capacità di stabilire e spiegare le relazioni tra i fatti storici
• Comprensione e utilizzo di concetti e termini storici anche in rapporto a specifici contesti storico-culturali e/o economico-sociali
• Capacità di conferire una struttura logico-argomentativa ai problemi presi in esame
55
Contenuti L'EUROPA AVVIATA VERSO LA PRIMA GUERRA MONDIALE
• Le lotte per la conquista del monopolio sui mercati • Trust e cartelli • L’inizio dell’imperialismo • La diplomazia di Bismarck • Il sistema bismarckiano delle alleanze • La politica interna della Germania bismarckiana • Dopo Bismarck: il nuovo corso tedesco L'ETA' GIOLITTIANA • Il decollo industriale • I nuovi compiti dello Stato liberale • Legislazione sociale, opere pubbliche, riforme • Le difficoltà della politica riformatrice • La guerra di Libia • Il nazionalismo italiano si organizza in movimento politico • I problemi del Mezzogiorno nell'età giolittiana • Le elezioni generali dell'ottobre 1913; la "settimana rossa";la fine dell'età giolittiana LA PRIMA GUERRA MONDIALE • L'Europa verso la guerra: guerre balcaniche e crisi marocchine • Lo scoppio del conflitto • Gli schieramenti a favore della guerra. • La neutralità italiana. Il paese diviso • Le operazioni di guerra nel 1914-'15 • Il problema dei paesi neutrali. L'intervento italiano a fianco dell'Intesa • Il fronte militare italiano nel primo anno di guerra • Le grandi offensive tedesche ed austriache del 1916 • La propaganda pacifista dei socialisti, di Wilson, del papa. Le ripercussioni della guerra sulla società civile • La rivoluzione del febbraio del 1917. La Russia stipula una pace separata • Gli Stati Uniti si schierano a fianco dell'Intesa • Le operazioni di guerra del 1917 • Le offensive tedesche della primavera del 1918 e le controffensive alleate • I Trattati di pace • La Società delle Nazioni LA CRISI DELLO STATO LIBERALE E L'AVVENTO DEL FASCISMO IN ITALIA • Il dopoguerra in Europa: il "biennio rosso" • L'Italia nel 1919 • Nascono i "Fasci di combattimento" • L'ultimo ministero Giolitti: l'occupazione delle fabbriche; il Trattato di Rapallo, il blocco nazionale con i fascisti • Lo squadrismo fascista • La Marcia su Roma • Il primo governo Mussolini • Le elezioni del '24. Il delitto Matteotti • Il discorso del 3 gennaio 1925. L'organizzazione dello Stato fascista • La politica economica e sociale del fascismo. La "Carta del lavoro" e il sistema corporativo
56
• I Patti Lateranensi • L'opposizione degli antifascisti LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR ALLA COSTITUZIONE DEL TERZO REICH • Le difficoltà delle democrazie occidentali fra dopoguerra e "grande crisi" (linee generali) • La Costituzione della Repubblica di Weimar • Gli anni terribili:1922-'23 • Gli accordi di Locarno • La "grande crisi" del 1929 apre la strada al nazismo • L'eliminazione delle opposizioni e la conquista del potere • La costruzione dello Stato totalitario IL MONDO TRA LE DUE GUERRE. LA "GRANDE CRISI" E I PRIMI ANNI TRENTA
MODALITA’ CLIL
• The Roaring Twenties – Powerpoint presentations (teacher’s own), quiz adapted from http://www.bbc.co.uk/bitesize/quiz/q94296394 • The Wall Street Crash – What is Wall Street? www.youtube.com/watch?v=29LjGFD3DEk and What was the Wall Street Crash? www.youtube.com/watch?v=D_-PTnMQ_x0 , reading comprehension (teacher’s own) • The Great Depression – Photographs of Americans during the Great Depression (Google images), What contributed to the boom and bust in America? http://downloads.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/wjec/history/pdf/boomandbust.pdf • The Dust Bowl - http://www.history.com/topics/dust-bowl, reading comprehension and word search activity http://easyscienceforkids.com/all-about-dust-bowl/ • The New Deal and FDR - reading comprehension http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/history/mwh/usa/newdealrev1.shtml • Presentations on famous figures during the 1920s and 1930s • Students own material on Amelia Earhart, Al Capone, J. Edgar Hoover, Eleanor Roosevelt, Jesse Owens, Charlie Chaplin, Mahatma Gandhi, Henry Ford and Bonnie and Clyde L'EUROPA VERSO LA SECONDA GUERRA MONDIALE • L'Italia fascista negli anni Trenta • L'Italia antifascista • La Germania di Hitler prepara la guerra • L'aggressione fascista all'Etiopia • L'Asse Roma-Berlino • L'aggressione nazista all'Austria, alla Cecoslovacchia, alla Polonia. Francia e Inghilterra scendono in campo LA SECONDA GUERRA MONDIALE • I caratteri della guerra • L'invasione della Polonia • La guerra a occidente: il crollo della Francia • L'intervento italiano sul fronte alpino • La "battaglia d’Inghilterra" e la guerra sui mari • La " guerra parallela" dell'Italia fascista • La guerra italo-greca e l'invasione tedesca dei Balcani
57
• L'attacco tedesco all'URSS • Il "nuovo ordine" nei paesi occupati • La Carta atlantica • L'attacco giapponese alla base americana di Pearl Harbur. Il conflitto diventa mondiale • Riprende l'offensiva tedesca in Russia. La battaglia di Stalingrado • La controffensiva anglo-americana nel Mediterraneo: lo sbarco in Sicilia • La liberazione della Francia • La Germania invasa da est e da ovest. L'insurrezione partigiana in Italia. • L'esplosione della bomba atomica. La resa del Giappone • Le conferenze di Teheran, Jalta, Postdam. La divisione del mondo secondo "sfere di influenza" L'ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE • L'Italia dalla " non belligeranza" all'entrata in guerra a fianco della Germania • L'incrinatura del "consenso": i primi cedimenti del "fronte interno" • Dal malcontento all'opposizione. Gli scioperi del marzo 1943 • Lo sbarco alleato in Sicilia; la crisi del regime fascista • Il governo Badoglio annuncia l'armistizio. La fuga del re a Brindisi • La Resistenza e i Comitati di Liberazione • La svolta di Salerno; la liberazione di Roma; l'insurrezione del Nord
58
Storia dell’arte Docente Rita Mattocci
Testi adottati Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Zanichelli, vol:3 ( versione verde multimediale)
Altri materiali PPT, Video, Film, Monografie
Argomenti N. ore
Tutto il programma 57
N° carenze in ingresso nessuna Attività di recupero nessuna
N° alunni N° totale ore / /
Metodologia Strumenti di verifica Supporti didattici
Per es. Lezione frontale, lezione interattiva, esercitazioni guidate, lavori di gruppo, visite guidate, …
Per es. Verifiche scritte, verifiche orali, relazioni, prove strutturate, simulazioni prova d’esame, ….
Per es. libro di testo, audiovisivi, teatro, biblioteca, laboratorio, giornali, …
Lezione frontale Prove scritte Libro di testo
Prove orali video
PPT
film
59
Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità specifiche La comprensione dei principi che regolano i differenti e complementari processi della percezione e della comunicazione artistica. Consolidamento del linguaggio specifico della materia. L’acquisizione di un metodo di lettura dell’opera d’arte, sia sotto il profilo tecnico, sia nel contesto comunicativo culturale di appartenenza. Conoscenza dei molteplici contesti storici, artistici e culturali che hanno differenziato l’arte dalle origini ai nostri giorni. Rapporto con la classe Il gruppo classe è composto di diciotto alunni. Il lavoro didattico è stato svolto come previsto dal programma d’inizio anno scolastico, con una rilevante partecipazione e costante impegno. Gli alunni hanno dimostrato di aver raggiunto buona maturità e responsabilità, lo studio è stato costante e propositivo, ottime le discrete espositive e la rielaborazione critica degli argomenti svolti. Va inoltre ricordato la regolare presenza durante i giorni di lezione che ha senz’altro contribuito a facilitare e seguire costantemente il percorso didattico. Osservazioni del docente Approfondimenti: “ Il disagio nell’arte: il corpo ridisegnato”, progetto culturale-artistico sul disagio comportamentale. Contenuti Neoclassicismo: A. Canova e le teorie del Winckelmann Opere: Paolina Bonaparte come Venere vincitrice; Amore e psiche. J.L.David. Opere: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat. Il Romanticismo. Opere: La Zattera della Medusa e La libertà guida il popolo. I Macchiaioli. Giovanni Fattori. Opere: Soldati del ’59, La rotonda Palmieri, In vedetta. Quadro storico dell’Italia nel periodo dei Macchiaioli e confronti con la Francia Repubblicana. Storia e innovazioni: l’architettura del ferro. (cenni) L’Impressionismo: tecnica e stile. C.Monet. Opere: Le Ninfee; La cattedrale di Roan; Impressione, sole nascente; E.Degas. Opere: Lezione di danza; l’Assenzio. Post-impressionismo. P.Çèzanne. Opere: I giocatori di carte, la montagna Saint Victoire. V.Van Gogh. Opere: Mangiatori di patate; Campo di grano con volo di corvi. P. Gaugin. Opere: il Cristo giallo, Che fai! Sei gelosa?
60
Verso il crollo degli imperi centrali: la Secessione Viennese. Art Nouveau e G.Klimt. Opere: Giuditta1, Danae. I Fauves: tecnica e stile. Matisse. Opere: Donna con il cappello, Nudo rosa, La stanza rossa. L’Espressionismo. Il gruppo Die Brucke. Munch. Opere: L’urlo, Passeggiata lungo il Corso Carl Johann, Pubertà, la fanciulla malata. Kirchner. Opere: Cinque donne per la strada. Il Cubismo. Picasso. Periodi artistici e tecniche artistiche. Opere: Les Demoiselles D’Avignon, Guernica. Il Futurismo: F.T. Marinetti e il manifesto futurista. Teorie e pensiero futurista. Boccioni. Opere: Forme uniche nella continuità dello spazio. Balla. Opere: Dinamismo di un cane a guinzaglio. Russolo: gli intonarumori. Il Dada: Storia e stile. M. Ducamp. Opere: Orinatoio, L.H.O.O.Q. M. Ray. Opere: Cadeau. Arp. Opere: Ritratto a Tristan Tzara. Surrealismo e S. Freud. Tecniche e pensiero surrealista attraverso le opere di J. Mirò, Magritte e Dalì. Metodo paranoico- critico di Dalì. Opere: La scala dell’evasione, Il carnevale di Arlecchino, Ceci n’est pas une pipe, La bella prigioniera, La passeggiata di Euclide. Il Razionalismo architettonico: l’esperienza del Bauhaus, architettura fascista, architettura organica. Firenze: stazione di S. Maria Novella e Michelucci; Como, Casa Del Fascio di Terragni; Milano: Palazzo di Giustizia di Piacentini. La bonifica della pianura pontina, la nascita di nuove città. Roma Mussoliniana: quartiere EUR, via della Conciliazione (approfondimento video storico Istituto luce). Metafisica. Carrà e De Chirico. Informale (cenni) J. Pollock (film)
61
SCIENZE UMANE Docente BENEDETTA FONTANA
Testi adottati - A. Bianchi, P. Di Giovanni, Metodologia oggi, Paravia, 2011 - A. Bianchi, P. Di Giovanni, La dimensione sociologica, Paravia, 2012
Altri materiali - Presentazioni informatiche multimediali - Filmati - Appunti
Argomenti N. ore
L’avventura dello Stato moderno: dallo Stato liberale al Welfare State 24
Il lavoro 24
I media 16
Dove va la famiglia? 4
La globalizzazione 14 (previste)
Come si progetta una ricerca 14
La scienza: scienza e senso comune 6
La ricerca interdisciplinare 6
(in allegato le indicazioni dei contenuti) N° carenze in ingresso 0 Attività di recupero Nessuna
Metodologia Strumenti di verifica Supporti didattici
Lezione interattiva Verifiche scritte Libri di testo
Lezione frontale Verifiche orali Presentazioni informatiche
Lavori di gruppo Simulazioni prova d'esame Laboratorio
62
Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità specifiche Saper ricostruire a grandi linee il cammino dello Stato moderno, dallo Stato liberale al Welfare State ed inquadrare i problemi che le diverse forme statali hanno incontrato o incontrano Saper illustrare i problemi legati alla moderna divisione del lavoro e ricostruire la loro evoluzione fino ai giorni nostri Cogliere la complessità dei problemi legati al mercato del lavoro e al fenomeno della disoccupazione, avendo nozione delle politiche sociali a riguardo Saper ricostruire lo sviluppo dei media e illustrare criticamente le concezioni maturate a proposito Rendersi conto della complessità del processo di cambiamento in atto e dei vantaggi di analisi attente ai molti fattori in gioco. Comprendere in linea di massima le grandi trasformazioni della globalizzazione attraverso le sue caratteristiche principali, la sua storia e i dibattiti che l’accompagnano Comprendere la complessità degli elementi e dei passaggi che compongono una ricerca Saper distinguere tra scienza e senso comune e in particolare saper evidenziare le differenze nel modo di pensare e rapportarsi alla realtà d’origine di errori di comprensione e fraintendimenti delle acquisizioni scientifiche. Saper cooperare con esperti di altre discipline allo svolgimento di attività di ricerca multidisciplinare in area socio-economica. Rapporto con la classe Gli studenti hanno tenuto quasi sempre un comportamento corretto e responsabile nei rapporti interpersonali, sia tra di loro, sia con l'insegnante. Durante le lezioni, una parte della classe ha manifestato una buona partecipazione alle attività scolastiche, intervenendo in maniera pertinente e ordinata; un'altra parte ha assistito alle lezioni più passivamente. Nel complesso le indicazioni metodologiche fornite dall'insegnante sono state rispettate. Non tutti gli studenti hanno frequentato in maniera assidua. Osservazioni del docente Nessuna Contenuti Problemi e scenari del mondo di oggi. L’avventura dello Stato moderno: dallo Stato liberale al Welfare State. Stato provvidenza o sistema economico – politico? L’espansione dello Stato e la contrazione dei servizi statali. Il lavoro. La moderna divisione del lavoro. Conseguenze della moderna divisione del lavoro. I sistemi a basso margine di autonomia del XX secolo. L’evoluzione dei sistemi a basso margine di autonomia. Il problema della divisione del lavoro oggi. Il mercato del lavoro. Il fenomeno moderno della disoccupazione. L’aumento attuale della disoccupazione. Significato dell’economia sommersa. I media. L’esplosione tecnologica. Media benefici o malefici? Dove va la famiglia? Il matrimonio romantico, il declino della famiglia coniugale, il calo di nuzialità; le unioni di fatto. Testi: “Il potere è necessario e naturale” di A. Comte; “I bisogni individuali dal punto di vista del sistema sociale” di T. Parsons; “La cacciata dei contadini dalla terra” di K. Marx; “La tradizione del mondo che cambia” di A. Giddens; “Il potere degli attori non statali” di S. Cassese.
63
Fare ricerca: come si progetta una ricerca. Come nasce una ricerca. Definire l’oggetto di studio. Elaborare un progetto di ricerca. Fare ricerca: Scelte e problemi della ricerca. Ricerca quantitativa o qualitativa Testo: “Teoria del sovraccarico urbano di Milgram” di K.R. Scherer, R. P. Abels e C.S. Fischer La consapevolezza scientifica. La scienza: scienza e senso comune. Perché è importante capire la scienza. Alcune caratteristiche della scienza. Il buon ricercatore. La ricerca interdisciplinare: che cos’è l’interdisciplinarietà. Come si fa ricerca interdisciplinare. Testi: “Due modi di immaginare il ruolo del metodo e del ricercatore” brani tratti da Bacone, Popper e Carnap;”Interdisciplinarietà, multidisciplinarità e false interdisciplinarità”. Progamma svolto fino al 10 maggio Programma da svolgere tra l'11 maggio e la fine della scuola: La globalizzazione. Che cos’è la globalizzazione. Verso una società mondiale. Globalismo e antiglobalismo. Complessità della globalizzazione. Dimensioni della globalizzazione.
65
Testi delle simulazioni delle prove d’esame
Istituto di istruzione superiore “M. Curie” – Pergine Valsugana A.S. 2014/2015
2^ SIMULAZIONE DELLA 1^ PROVA DELL’ESAME DI STATO 27 aprile 2015
Classi: 5^ AFM – CAT - ALS – ASA – ASU –ASE - BSE Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. TIPOLOGIA A – Analisi e commento di un testo Claudio Magris, dalla Prefazione di L’infinito viaggiare, Mondadori, Milano 2005. Claudio Magris è nato a Trieste nel 1939. Saggista, studioso della cultura mitteleuropea e della letteratura del“mito asburgico”, è anche autore di testi narrativi e teatrali. Non c’è viaggio senza che si attraversino frontiere – politiche, linguistiche, sociali, culturali, psicologiche, anche quelle invisibili che separano un quartiere da un altro nella stessa città, quelle tra le persone, quelle tortuose che nei nostri inferi sbarrano la strada a noi stessi. Oltrepassare frontiere; anche amarle – in quanto definiscono una realtà, un’individualità, le danno forma, salvandola così dall’indistinto – ma senza idolatrarle, senza farne idoli che esigono sacrifici di sangue. Saperle flessibili, provvisorie e periture, come un corpo umano, e perciò degne di essere amate; mortali, nel senso di soggette alla morte, come i viaggiatori, non occasione e causa di morte, come lo sono state e lo sono tante volte. Viaggiare non vuol dire soltanto andare dall’altra parte della frontiera, ma anche scoprire di essere sempre pure dall’altra parte. In Verde acqua Marisa Madieri, ripercorrendo la storia dell’esodo degli italiani da Fiume dopo la Seconda guerra mondiale, nel momento della riscossa slava che li costringe ad andarsene, scopre le origini in parte anche slave della sua famiglia in quel momento vessata dagli slavi in quanto italiana, scopre cioè di appartenere anche a quel mondo da cui si sentiva minacciata, che è, almeno parzialmente, pure il suo. Quando ero un bambino e andavo a passeggiare sul Carso, a Trieste, la frontiera che vedevo, vicinissima, era invalicabile, – almeno sino alla rottura fra Tito e Stalin e alla normalizzazione dei rapporti fra Italia e Jugoslavia – perché era la Cortina di Ferro, che divideva il mondo in due. Dietro quella frontiera c’erano insieme l’ignoto e il noto. L’ignoto, perché là cominciava l’inaccessibile, sconosciuto, minaccioso impero di Stalin, il mondo dell’Est, così spesso ignorato, temuto e disprezzato. Il noto, perché quelle terre, annesse dalla Jugoslavia alla fine della guerra, avevano fatto parte dell’Italia; ci ero stato più volte, erano un elemento della mia esistenza. Una stessa realtà era insieme misteriosa e familiare; quando ci sono tornato per la prima volta, è stato contemporaneamente un viaggio nel noto e nell’ignoto. Ogni viaggio implica, più o meno, una consimile esperienza: qualcuno o qualcosa che sembrava vicino e ben conosciuto si rivela straniero e indecifrabile, oppure un individuo, un paesaggio, una cultura che ritenevamo diversi e alieni si mostrano affini e parenti. Alle genti di una riva quelle della riva opposta sembrano spesso barbare, pericolose e piene di pregiudizi nei confronti di chi vive sull’altra sponda. Ma se ci si mette a girare su e giù per un ponte, mescolandosi alle persone che vi transitano e andando da una riva all’altra fino a non sapere più bene da quale parte o in quale paese si sia, si ritrova la benevolenza per se stessi e il piacere del mondo. 1. Comprensione del testo Dopo un’attenta lettura, riassumi il contenuto del testo. 2. Analisi del testo 2.1. Soffermati sugli aspetti formali (lingua, lessico, ecc.) del testo. 2.2. Soffermati sull’idea di frontiera espressa nel testo. 2.3. Soffermati sull’idea di viaggio espressa nel testo. 2.4. Spiega l’espressione “si ritrova la benevolenza per se stessi e il piacere del mondo”. 2.5. Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 3. Interpretazione complessiva e approfondimenti Proponi una interpretazione complessiva del testo proposto, facendo riferimento ad altri testi di Magris e/o di altri autori del Novecento. Puoi fare riferimento anche a tue esperienze personali. TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” (puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) CONSEGNE
66
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato. Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. AMBITO ARTISTICO – LETTERARIO ARGOMENTO: Il dono. DOCUMENTI
ORATORIO DI SAN SILVESTRO - Roma Donazione di Costantino, 1248
Jacques-Louis DAVID Antioco e Stratonice, 1774
PARMIGIANINO Adorazione dei Magi, 1529 circa
«La madre aveva steso una tovaglia di lino, per terra, su una stuoia di giunco, e altre stuoie attorno. E, secondo l‟uso antico, aveva messo fuori, sotto la tettoia del cortile, un piatto di carne e un vaso di vino cotto dove galleggiavano fette di buccia d‟arancio, perché l‟anima del marito, se mai tornava in questo mondo, avesse da sfamarsi. Felle andò a vedere: collocò il piatto ed il vaso più in alto, sopra un‟asse della tettoia, perché i cani randagi non li toccassero; poi guardò ancora verso la casa dei vicini. Si vedeva sempre luce alla finestra, ma tutto era silenzio; il padre non doveva essere ancora tornato col suo regalo misterioso. Felle rientrò in casa, e prese parte attiva alla cena. In mezzo alla mensa sorgeva una piccola torre di focacce tonde e lucide che parevano d‟avorio: ciascuno dei commensali ogni tanto si sporgeva in avanti e ne tirava una a sé: anche l‟arrosto, tagliato a grosse fette, stava in certi larghi vassoi di legno e di creta: e ognuno si serviva da sé, a sua volontà. […] Ma quando fu sazio e sentì bisogno di muoversi, ripensò ai suoi vicini di casa: che mai accadeva da loro? E il padre era tornato col dono? Una curiosità invincibile lo spinse ad uscire ancora nel cortile, ad avvicinarsi e spiare. Del resto la porticina era socchiusa: dentro la cucina le bambine stavano ancora intorno al focolare ed il padre, arrivato tardi ma sempre in tempo, arrostiva allo spiedo la coscia del porchetto donato dai vicini di casa. Ma il regalo comprato da lui, dal padre, dov‟era? – Vieni avanti, e va su a vedere – gli disse l‟uomo, indovinando il pensiero di lui. Felle entrò, salì la scaletta di legno, e nella cameretta su, vide la madre di Lia assopita nel letto di legno, e Lia inginocchiata davanti ad un canestro. E dentro il canestro, fra pannolini caldi, stava un bambino appena nato, un bel bambino rosso, con due riccioli sulle tempie e gli occhi già aperti. – È il nostro primo fratellino – mormorò Lia. – Mio padre l‟ha comprato a mezzanotte precisa, mentre le campane suonavano il “Gloria”. Le sue ossa, quindi, non si disgiungeranno mai, ed egli le ritroverà intatte, il giorno del Giudizio Universale. Ecco il dono che Gesù ci ha fatto questa notte.» [Grazia DELEDDA, Il dono di Natale, 1930, in G. D., Le novelle, 4, La Biblioteca dell‟identità de L‟Unione Sarda, Cagliari 2012] «Gli uomini disapprendono l‟arte del dono. C‟è qualcosa di assurdo e di incredibile nella violazione del principio di scambio; spesso anche i bambini squadrano diffidenti il donatore, come se il regalo non fosse che un trucco per vendere loro spazzole o sapone. In compenso si esercita la charity, la beneficenza amministrata, che tampona programmaticamente le ferite visibili della società. Nel suo esercizio organizzato l‟impulso umano non ha più il minimo posto: anzi la donazione è necessariamente congiunta all‟umiliazione, attraverso la
67
distribuzione, il calcolo esatto dei bisogni, in cui il beneficato viene trattato come un oggetto. Anche il dono privato è sceso al livello di una funzione sociale, a cui si destina una certa somma del proprio bilancio, e che si adempie di mala voglia, con una scettica valutazione dell‟altro e con la minor fatica possibile. La vera felicità del dono è tutta nell‟immaginazione della felicità del destinatario: e ciò significa scegliere, impiegare tempo, uscire dai propri binari, pensare l‟altro come un soggetto: il contrario della smemoratezza. Di tutto ciò quasi nessuno è più capace. Nel migliore dei casi uno regala ciò che desidererebbe per sé, ma di qualità leggermente inferiore. La decadenza del dono si esprime nella penosa invenzione degli articoli da regalo, che presuppongono già che non si sappia che cosa regalare, perché, in realtà, non si ha nessuna voglia di farlo. Queste merci sono irrelate come i loro acquirenti: fondi di magazzino fin dal primo giorno.» [Theodor W. ADORNO, Minima moralia. Meditazioni della vita offesa, trad. it., Einaudi, Torino 1994 (ed. originale 1951)] «La Rete di certo promuove la diffusione di una nuova cultura del dono, dello scambio reciproco (o quasi). Possiamo percorrere strade aperte, sconfinate, che offrono nuove possibilità di stabilire contatti e anche di dare vita a forme di aggregazione fondate sostanzialmente sul dono, ma che rimangono racchiuse in piccole nicchie, microcosmi con cui giocare o dove si può apprendere, nei quali ci si mostra, si costruiscono e si modificano identità, si condividono interessi, si elaborano linguaggi. Un dono costretto quindi dentro piccole mura fatte di specchi, trasparenti, che riflettono e amplificano la luce e i legami, ma che non sempre riescono a sopravvivere alle intemperie, agli improvvisi venti del mondo contemporaneo. E quando si spezzano, non si può fare altro che costruire qualcosa di simile, un po‟ più in là. Una delle caratteristiche della Rete è quella di dare vita a comunità immaginate, che non sempre necessitano di relazioni tra gli individui.» [Marco AIME e Anna COSSETTA, Il dono al tempo di Internet, Einaudi, Torino 2010] «Difficilmente si diventa una persona generosa da soli: la generosità è una cosa che si impara. […] Quando un dono s‟inserisce in una catena di reciprocità generalizzata, si lascia meno facilmente interpretare come un fenomeno puramente individualistico e interessato. Nel caso di una reciprocità diretta, invece, la tentazione è forte di assimilare lo scambio di doni a una variante dello scambio mercantile. […] È così che, in un mercoledì del mese di luglio 2007, Barbara Bunnell diventa la prima paziente nella storia a ricevere un rene all‟interno di una catena di reciprocità generalizzata. Dopo che il primo donatore regala il suo rene a Barb, Ron Bunnell, il marito di Barb, darà un suo rene ad Angela Heckman; poi la madre di Angela darà un suo rene a qualcun altro ancora, e così via, in una catena continua che aiuterà altre sette persone. All‟inizio di questa catena c‟è un giovane uomo, Matt Jones, che accetta di donare un rene “senza perché”; cioè non per salvare dalla dialisi una persona cara, ma solo per la gioia di aiutare sconosciuti.» [Mark ANSPACH, Cosa significa ricambiare? Dono e reciprocità, in AA.VV., Cosa significa donare?, Guida, Napoli 2011] «Da una lettura sommaria e superficiale si può concludere che oggi non c‟è più posto per il dono ma solo per il mercato, lo scambio utilitaristico, addirittura possiamo dire che il dono è solo un modo per simulare gratuità e disinteresse là dove regna invece la legge del tornaconto. In un‟epoca di abbondanza e di opulenza si può addirittura praticare l‟atto del dono per comprare l‟altro, per neutralizzarlo e togliergli la sua piena libertà. Si può perfino usare il dono - pensate agli «aiuti umanitari» - per nascondere il male operante in una realtà che è la guerra. […] Ma c‟è pure una forte banalizzazione del dono che viene depotenziato e stravolto anche se lo si chiama «carità»: oggi si «dona» con un sms una briciola a quelli che i mass media ci indicano come soggetti - lontani! - per i quali vale la pena provare emozioni... Dei rischi e delle possibili perversioni del dono noi siamo avvertiti: il dono può essere rifiutato con atteggiamenti di violenza o nell‟indifferenza distratta; il dono può essere ricevuto senza destare gratitudine; il dono può essere sperperato: donare, infatti, è azione che richiede di assumere un rischio. Ma il dono può anche essere pervertito, può diventare uno strumento di pressione che incide sul destinatario, può trasformarsi in strumento di controllo, può incatenare la libertà dell‟altro invece di suscitarla. I cristiani sanno come nella storia perfino il dono di Dio, la grazia, abbia potuto e possa essere presentato come una cattura dell‟uomo, un‟azione di un Dio perverso, crudele, che incute paura e infonde sensi di colpa. Situazione dunque disperata, la nostra oggi? No! Donare è un‟arte che è sempre stata difficile: l‟essere umano ne è capace perché è capace di rapporto con l‟altro, ma resta vero che questo «donare se stessi» - perché di questo si tratta, non solo di dare ciò che si ha, ciò che si possiede, ma di dare ciò che si è - richiede una convinzione profonda nei confronti dell‟altro. Donare significa per definizione consegnare un bene nelle mani di un altro senza ricevere in cambio alcunché. Bastano queste poche parole per distinguere il «donare» dal «dare», perché nel dare c‟è la vendita, lo scambio, il prestito. Nel donare c‟è un soggetto, il donatore, che nella libertà, non costretto, e per generosità, per amore, fa un dono all‟altro, indipendentemente dalla risposta di questo. Potrà darsi che il destinatario risponda al donatore e si inneschi un rapporto reciproco, ma può anche
68
darsi che il dono non sia accolto o non susciti alcuna reazione di gratitudine. Donare appare dunque un movimento asimmetrico che nasce da spontaneità e libertà.» [Enzo BIANCHI, Dono. Senza reciprocità – Festival filosofia – Carpi, 16/09/2012 – http://www.vita.it/non-profit/volontariato] 2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO ARGOMENTO: Siamo quel che mangiamo? DOCUMENTI «“Le evidenze scientifiche pubblicate nell’ultimo anno non lasciano dubbi - dice Massimo Volpe, presidente della Siprec (Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare) - la vita sedentaria è un rischio per il cuore. Se a questo si aggiunge che spesso si mangia male, il quadro generale peggiora. Commettiamo troppi peccati di gola, trascuriamo la dieta mediterranea e gli alimenti cardine di una sana alimentazione. Pochissimi sanno davvero giudicare la salubrità di un alimento, molti si nutrono in modo disorganizzato”. Il 95 per cento, continua l’esperto, dichiara che il pranzo è il pasto più importante, ma poi l’80 per cento sceglie una pasta molto condita accompagnata dal pane. Un italiano su due mangia carne magra, ma c’è un buon 20 per cento che sceglie carni grasse più volte alla settimana; il 45 per cento consuma formaggi come minimo tre volte alla settimana. Uno su tre, poi, mangia pesce appena una volta alla settimana, mentre andrebbe consumato almeno due, tre volte. “Dobbiamo modificare le nostre abitudini - dice il cardiologo - e renderci conto che la salute del cuore si costruisce mattone dopo mattone, proprio come una casa. Sia il medico che il paziente possono imparare a fare prevenzione”.» Adele SARNO, Otto ore seduti? Il cuore rischia doppio. Arriva l’auto-test per la prevenzione, “la Repubblica” – 1 aprile 2011 «Mercoledì 17 novembre 2010. La quinta sessione del Comitato Intergovernativo dell’UNESCO [...] ha iscritto la Dieta Mediterranea nella prestigiosa lista (sc. del patrimonio culturale immateriale dell’umanità). [...] La Dieta Mediterranea rappresenta un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni che vanno dal paesaggio alla tavola, includendo le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo. La Dieta Mediterranea è caratterizzata da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, costituito principalmente da olio di oliva, cereali, frutta fresca o secca, e verdure, una moderata quantità di pesce, latticini e carne, e molti condimenti e spezie, il tutto accompagnato da vino o infusi, sempre in rispetto delle tradizioni di ogni comunità. Tuttavia, la Dieta Mediterranea (dal greco diaita, o stile di vita) è molto più che un semplice alimento. Essa promuove l’interazione sociale, poiché il pasto in comune è alla base dei costumi sociali e delle festività condivise da una data comunità, e ha dato luogo a un notevole corpus di conoscenze, canzoni, massime, racconti e leggende. La Dieta si fonda nel rispetto per il territorio e la biodiversità, e garantisce la conservazione e lo sviluppo delle attività tradizionali e dei mestieri collegati alla pesca e all’agricoltura nelle comunità del Mediterraneo.» CNI-UNESCO, La Dieta Mediterranea è patrimonio immateriale dell’Umanità, www.unesco.it «La politica alimentare [...] si deve basare sul concetto che l’energia primaria della vita è il cibo. Se il cibo è energia allora dobbiamo prendere atto che l’attuale sistema di produzione alimentare è fallimentare. […] Il vero problema è che da un lato c’è una visione centralizzata dell’agricoltura, fatta di monoculture e allevamenti intensivi altamente insostenibili, e dall’altro è stata completamente rifiutata la logica olistica, che dovrebbe essere innata in agricoltura, per sposare logiche meccaniciste e riduzioniste. Una visione meccanicista finisce con il ridurre il valore del cibo a una mera commodity, una semplice merce. È per questo che per quanto riguarda il cibo abbiamo ormai perso la percezione della differenza tra valore e prezzo: facciamo tutti molta attenzione a quanto costa, ma non più al suo profondo significato. […] Scambiare il prezzo del cibo con il suo valore ci ha distrutto l’anima. Se il cibo è una merce non importa se lo sprechiamo. In una società consumistica tutto si butta e tutto si può sostituire, anzi, si deve sostituire. Ma il cibo non funziona così.» Carlo PETRINI in Petrini-Rifkin. Il nuovo patto per la natura, “la Repubblica” - 9 giugno 2010 «Mangiare mentre si legge la posta, si gioca o si lavora al pc può avere serie conseguenze sulla nostra forma fisica. [...] Secondo quanto riportato dalla rivista American Journal of Clinical Nutrition, chi mangia svolgendo altre attività, sia questa navigare in internet o sui profili degli amici su Facebook, è più propenso ad esagerare con le quantità in quanto non ha il senso delle calorie che sta realmente introducendo e inoltre ha più voglia di dolci. [...] Quindi nonostante sia costume sempre più diffuso quello di mangiare rimanendo “connessi” col mondo intorno a noi, per chi ci tiene a non mettere su chili di troppo, meglio evitare le distrazioni durante i pasti e focalizzare l’attenzione su quello che si sta consumando.» Silvia MAGLIONI, Mangiare davanti al computer fa male alla linea,www.leonardo.it 3. AMBITO STORICO-POLITICO ARGOMENTO: Ottobre 1917: colpo di stato o rivoluzione sociale? DOCUMENTI Tra la metà di aprile e l’inizio di luglio scesero in sciopero oltre un milione e mezzo di lavoratori. E lo spettro delle categorie era più ampio di quanto mai si fosse visto in agitazione. Artigiani, lavandaie, tintori, barbieri,
69
sguatteri, camerieri, facchini, autisti, domestici, non soltanto nelle due capitali ma in tutte le città dell’impero si affiancarono ai veterani degli scioperi come metallurgici e tessili. Scesero in sciopero persino le prostitute. Quasi tutte le rivendicazioni erano di carattere economico. Volevano retribuzioni più elevate per tenere il passo dell’inflazione e il miglioramento della situazione alimentare. In particolare aveva assunto carattere quasi sacramentale la giornata lavorativa di otto ore. I lavoratori si vedevano il simbolo di tutti i loro diritti e della loro vittoria nell’ambito della rivoluzione […]. C’era inoltre negli operai un rinnovato senso della propria dignità. Essi erano ormai consapevoli di se stessi in quanto «cittadini» e di «aver fatto la rivoluzione» (o almeno di avervi svolto un ruolo guida) e non erano più disposti a farsi trattare senza rispetto da dirigenti e capi intermedi. Per molti scioperanti la rivendicazione era di essere trattati con maggior rispetto […]. Orlando FIGES, La tragedia di un popolo, 2000 I due mesi che separavano l’insuccesso del colpo di stato di Kornilov dalla presa del potere da parte dei bolscevichi, videro accelerarsi, in un contesto di acuta crisi economica, la disgregazione della società e dello stato. Nell’esercito, il colpo di stato annullò il residuo di fiducia che i soldati potevano ancora avere nei loro ufficiali; esso aveva rivelato fino a che punto ordini operativi potevano nascondere manovre controrivoluzionarie. Si imponeva più che mai la vigilanza: da allora non vi fu un ordine del Comando che non venisse analizzato, discusso, rimesso in causa. In queste condizioni, l’esercito scomparve quale forza combattente e quale strumento di repressione al servizio dello stato. Le diserzioni assunsero un’ampiezza ineguagliata. Disertori e soldati in permesso diedero un nuovo slancio al movimento contadino. Nelle campagne, le «azioni illegali» si erano moltiplicate dal mese di luglio […]. Il mondo operaio non era da meno. La circolare del ministro del Lavoro Skobelev (28 agosto), che dichiarava illegali le riunioni nelle aziende durante l’orario lavorativo, fu sentita come una vera dichiarazione di guerra del governo alla classe operaia. I bolscevichi denunciarono subito la collusione tra «Skobelev e C.» e la classe imprenditoriale. Questa classe colse l’occasione della circolare per riprendere i propri «diritti» nell’impresa limitando le competenze dei comitati d’impresa e licenziando i «sobillatori». In settembre-ottobre centinaia di imprese cessarono la loro produzione. Migliaia di operai si trovarono sul lastrico. In questa situazione gli scioperi furono meno numerosi che in maggio, ma più violenti (il numero di sequestri di datori di lavoro aumentò considerevolmente), più radicali, più politicizzati: gli scioperanti esigevano spesso il controllo operaio sulla produzione e, sempre più, le dimissioni del governo e il passaggio di potere ai soviet. Nicolas WERTH, Storia dell’Unione Sovietica, 1990 Gli storici hanno più volte attribuito la nascita del regime monopolistico al caso, vale a dire al fatto che molti menscevichi e socialisti-rivoluzionari abbandonarono il Congresso dei soviet in segno di protesta contro l’usurpazione del potere da parte dei bolscevichi. Tale opinione è priva di fondamento. Lenin e i suoi seguaci sapevano bene che in Russia non c’era un solo partito, socialista o meno, pronto a condividere le basi del programma bolscevico. I bolscevichi non potevano dividere il potere con i menscevichi semplicemente perché questi ultimi negavano la possibilità di realizzare il socialismo in una Russia arretrata. I bolscevichi non potevano giungere a compromessi neanche con i socialisti rivoluzionari, perché questi ultimi si consideravano rappresentanti dei contadini russi e negavano il ruolo guida del proletariato nello sviluppo storico […]. La presa di potere da parte dei bolscevichi creò una situazione assolutamente nuova, che alcuni storici russi hanno definito con precisione “utopia al potere”: le trasformazioni sociali sembravano di natura soggettiva, autoimposti, dovuti alla fede ideologica e alle convinzioni. I bolscevichi si distinguevano da tutti gli altri partiti perché proponevano un programma di ricostruzione radicale della società che si differenziava dai progetti di tutti gli altri partiti, socialisti e non socialisti, tanto che, anche se lo avessero voluto, non avrebbero potuto trovare dei partner per una coalizione. Ma essi credevano fanaticamente nell’ineluttabilità e nell’attualità delle trasformazioni sociali che propugnavano. Victor ZASLAVSKY, Storia del sistema sovietico, 1995 AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO ARGOMENTO: Tecnologia pervasiva DOCUMENTI Anche la Silicon Valley ha la sua religione. E potrebbe presto diventare il paradigma dominante tra i vertici e gli addetti ai lavori della culla dell’innovazione contemporanea. È il «transumanismo» e si può definire, scrive il saggista Roberto Manzocco in “Esseri Umani 2.0” (Springer, pp. 354), come «un sistema coerente di fantasie razionali para-scientifiche», su cui la scienza cioè non può ancora pronunciarsi, «che fungono da risposta laica alle aspirazioni escatologiche delle religioni tradizionali». Per convincersene basta scorrerne i capisaldi: il potenziamento delle nostre capacità fisiche e psichiche; l’eliminazione di ogni forma di sofferenza; la sconfitta dell’invecchiamento e della morte. Ciò che piace ai geek della Valley è che questi grandiosi progetti di
70
superamento dell’umano nel “post-umano” si devono, e possono, realizzare tramite la tecnologia. E tecniche, la cui fattibilità è ancora tutta da scoprire, come il “mind uploading”, ossia il trasferimento della coscienza su supporti non biologici, e le “nanomacchine”, robot grandi come virus in grado di riparare le cellule cancerose o i danni da malattia degenerativa direttamente a livello molecolare. Fabio CHIUSI, TRANS UMANO la trionferà, l’Espresso - 6 febbraio 2014 Lord Martin Rees, docente di Astrofisica all’Università di Cambridge e astronomo della Regina, la vede un po’ diversamente: i robot sono utili per lavorare in ambienti proibitivi per l’uomo — piattaforme petrolifere in fiamme, miniere semidistrutte da un crollo, centrali in avaria che perdono sostanze radioattive — oltre che per svolgere mestieri ripetitivi. Ma devono restare al livello di «utili idioti: la loro intelligenza artificiale va limitata, non devono poter svolgere mestieri intellettuali complessi. L’astronomo della Corte d’Inghilterra, occhi rivolti più alle glorie del passato che alle speranze e alle incognite di un futuro comunque problematico, propone una ricetta che sa di luddismo. Una ricetta anacronistica ed estrema che si spiega con l’angoscia che prende molti di noi davanti alla rapidità con la quale la civiltà dei robot — della quale abbiamo favoleggiato per decenni e che sembrava destinata a restare nei libri di fantascienza — sta entrando nelle nostre vite. Che i robot stiano uscendo dalle fabbriche lo sappiamo da tempo: il bancomat è un bancario trasformato in macchina, in servizio notte e giorno. In molti supermercati il cassiere non c’è più, sostituito da sensori, lettori di codici a barre, sistemi di pagamento automatizzati. In Giappone e Francia si moltiplicano treni e metropolitane guidati da un computer (è così la nuova Linea 5 della metropolitana di Milano), così come tutti i convogli che si muovono all’interno dei grandi aeroporti del mondo sono, ormai, senza conducente. Massimo GAGGI, E il robot prepara cocktail e fa la guerra, “Corriere Della Sera. La Lettura” - 26 gennaio 2014 Per molto tempo al centro dell'attenzione sono state le tecnologie e gli interrogativi che si portano dietro: «Meglio i tablet o i netbook?», «Android, iOs o Windows?», seguiti da domande sempre più dettagliate «Quanto costano, come si usano, quali app...». Intanto i docenti hanno visto le classi invase da Lim, proiettori interattivi, pc, registri elettronici o tablet, senza riuscire a comprendere quale ruolo avrebbero dovuto assumere, soprattutto di fronte a ragazzi tecnologicamente avanzati che li guardavano con grandi speranze e aspettative. Per gli studenti si apre una grande opportunità: finalmente nessuno proibisce più di andare in internet, di comunicare tramite chat, di prendere appunti in quaderni digitali o leggere libri elettronici. Dianora BARDI, La tecnologia da sola non fa scuola, “Il Sole 24 Ore” - 12 gennaio 2014 Passando dal tempo che ritorna al tempo che invecchia, dal tempo ciclico della natura regolato dal sigillo della necessità al tempo progettuale della tecnica percorso dal desiderio e dall’intenzione dell’uomo, la storia subisce un sussulto. Non più decadenza da una mitica età dell’oro, ma progresso verso un avvenire senza meta. La progettualità tecnica, infatti, dice avanzamento, ma non senso della storia. La contrazione tra “recente passato” e “immediato futuro”, in cui si raccoglie il suo operatore, non concede di scorgere fini ultimi, ma solo progressi nell’ordine del proprio potenziamento. Null’altro, infatti, vuole la tecnica se non la propria crescita, un semplice sì a se stessa. L’orizzonte si spoglia dei suoi confini. Inizio e fine non si congiungono più come nel ciclo del tempo, e neppure si dilatano come nel senso del tempo. Le mitologie perdono la loro forza persuasiva. Tecnica vuol dire, da subito, cingendo degli dèi. Umberto GALIMBERTI, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica - Feltrinelli, Milano 2002 TIPOLOGIA C – TEMA DI ARGOMENTO STORICO L’assassinio dell’Arciduca ereditario austriaco Francesco Ferdinando, avvenuto il 28 giugno 1914 ad opera di un nazionalista serbo, fu il motivo occasionale dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Quali erano in realtà i motivi profondi e perduranti che preludevano al primo conflitto globale della storia? TIPOLOGIA D – TEMA DI ORDINE GENERALE "Ogni individuo porta con sé, dalla nascita, un diritto uguale ed intangibile a vivere indipendentemente dai suoi simili in tutto ciò che lo riguarda personalmente ed a regolare da sé il proprio destino"(A. de Tocqueville). Questo principio è accolto dallo statuto delle Nazioni Unite e dalla nostra Costituzione, che pone a fondamento della convivenza civile il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà. Tali valori però risultano oggi drammaticamente violati, basti pensare ai recenti e continui tragici sbarchi clandestini sulle coste siciliane. Rifletta il candidato su questi odierni e gravi fenomeni di violazione dei diritti umani.
71
_______________________ Durata massima della prova: 6 ore. È consentito soltanto l’uso del dizionario italiano. È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.
72
ESAME DI STATO 2014/2015
SIMULAZIONE SECONDA PROVA D’ESAME DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA
RETELESNORD EST/RETE NAZIONALE LES
Parte prima: trattazione di argomento La società in cui viviamo ha attraversato e continua ad attraversare trasformazioni epocali di natura culturale, economica, sociale e giuridica che, spesso, stanno portando ad un inasprimento delle diseguaglianze di classe. La ricchezza tende sempre più a concentrarsi nelle mani di pochi e non è in grado di produrre maggiore sviluppo per tutti. Le questioni economiche e sociali e le contraddizioni che ne derivano rischiano di minare le basi della stessa democrazia: i cittadini percepiscono il rischio di non contare in maniera egualitaria e vedono nelle diseguaglianze un tradimento della promessa democratica. Lo Stato contemporaneo deve assumersi il ruolo di garante dell’uguaglianza e delle pari opportunità, e adottare tutte le misure giuridiche, economiche e sociali utili al superamento delle disparità per assicurare una vera democrazia partecipativa. Partendo dai documenti allegati il/la candidato, approfondisca il significato di Democrazia che emerge dal dettato costituzionale, rifletta sulle relazioni esistenti tra democrazia, diseguaglianza e sviluppo economico, infine indichi quali strumenti (politiche pubbliche), la nostra Costituzione prevede per il superamento delle diseguaglianze che impediscono l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Parte seconda: quesiti di approfondimento
1) Il candidato individui e spieghi quali sono le fonti di finanziamento del Welfare State. 2) Il candidato, partendo dal dettato costituzionale, descriva il principio di progressività delle
imposte. 3) Il candidato spieghi quali sono gli strumenti della politica di bilancio espansiva.
Durata della prova: 6 ore -E’ consentito l’uso del dizionario della lingua italiana e della Costituzione e/o Codice Civile non commentati
73
ALLEGTI DOCUMENTO 1 DISCORSO SULLA COSTITUZIONE DI PIERO CALAMANDREI (26 gennaio 1955) L‟art.34 dice:” I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”. Eh! E se non hanno i mezzi? Allora nella nostra costituzione c‟è un articolo che è il più importante di tutta la costituzione, il più impegnativo per noi che siamo al declinare, ma soprattutto per voi giovani che avete l‟avvenire davanti a voi. Dice così: ”E‟ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l‟effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all‟organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. E‟ compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana: quindi dare lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti, dare una scuola a tutti, dare a tutti gli uomini dignità di uomo. Soltanto quando questo sarà raggiunto, si potrà veramente dire che la formula contenuta nell‟art. primo- “L‟Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro “- corrisponderà alla realtà. Perché fino a che non c‟è questa possibilità per ogni uomo di lavorare e di studiare e di trarre con sicurezza dal proprio lavoro i mezzi per vivere da uomo, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro, ma non si potrà chiamare neanche democratica perché una democrazia in cui non ci sia questa uguaglianza di fatto, in cui ci sia soltanto una uguaglianza di diritto, è una democrazia puramente formale, non è una democrazia in cui tutti i cittadini veramente siano messi in grado di concorrere alla vita della società, di portare il loro miglior contributo, in cui tutte le forze spirituali di tutti i cittadini siano messe a contribuire a questo cammino, a questo progresso continuo di tutta la società. E allora voi capite da questo che la nostra costituzione è in parte una realtà, ma soltanto in parte è una realtà. In parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno di lavoro da compiere.[…[ Però, vedete, la costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La costituzione è un pezzo di carta: la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l‟impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità.[…] Per questo una delle offese che si fanno alla costituzione è l‟indifferenza alla politica, l‟indifferentismo politico […] DOCUMENTO 2 POVERTÀ, ALLARME DELL'OCSE: COSÌ LE DISUGUAGLIANZE FRENANO LA CRESCITA Secondo lo studio “Focus inequality and growth” (dicembre 2014) all’aumentare delle disparità economiche corrisponde una frenata della crescita dei paesi. L’Italia, dal 1985 al 2010, ha perso per questo il 6,6 per cento di Pil. “Servono politiche ridistributive”
74
Estimated consequences of changes in inequality (1985 – 2005) on subsequent cumulative growth (1990-2010)
Growth rates, in percentages
75
Note: The chart reports the estimated consequences of changes in inequality on the growth rate of GDP per capita (relative to the population aged 25-64) over the period 1990-2010. “Actual” is the actual growth rate of GDP per capita; “Impact of inequality” is obtained based on the observed changes in inequality across OECD countries (in 1985-2005) and the impact of inequality on growth estimated in the analysis; “Without impact of inequality” is the difference “Actual - Im- pact of inequality”. It should be interpreted as the growth rate that would have been observed had inequality not changed. Actual growth in Germany is computed starting in 1991; the changes in inequality are limited to the period 1985-2000 in the case of Austria, Belgium, Spain and Ireland. ROMA - La crescita nelle differenze di reddito fra i più ricchi e i più poveri ci fa perdere miliardi e miliardi di euro e di conseguenza molti punti percentuali di Pil, e non bastano misure politiche ed economiche per affrontare la povertà assoluta, ma bisogna concentrarsi sulla ridistribuzione non solo nei confronti del dieci per cento delle persone che stanno peggio ma anche con provvedimenti orientati a quel 40 per cento che rappresenta le classi sociali medio-basse. Questi i risultati, per certi versi sconvolgenti, dell’ultima relazione Ocse “Focus inequality and growth” che ha analizzato la correlazione fra aumento nelle disuguaglianze sociali e frenata della crescita economica in 21 paesi, fra cui l’Italia. Nello studio si mostra come le differenze di reddito siano ai massimi storici degli ultimi trent’anni: oggi, nell’area Ocse, il 10 per cento più ricco della popolazione guadagna 9,5 volte di più del 10 per cento più povero, mentre negli anni ’80 il rapporto era di 7. Anche l’indice di Gini, che misura le disuguaglianze sociali, è aumentato in media di tre punti percentuali, passando da 0,29 a0,32 in una scala in cui 0 è nessuna disuguaglianza sociale e 1 è tutto il reddito concentrato nelle mani di una sola persona. Fra l’altro l’Italia ha registrato proprio lo stesso aumento di indice Gini della media Ocse, passando da 0,291 a 0,321. Ma tutto questo è abbastanza noto. Quello che invece fino a oggi risultava meno dimostrabile era il legame fra disparità di reddito e crescita economica: il rapporto ha rilevato come, all’aumentare delle disparità economiche corrisponda una frenata della crescita del paese. Con un aumento del coefficiente di Gini in media di tre punti, come detto sopra, l’Ocse ha stimato che nei ventuno paesi esaminati ci sia stata, nei 25 anni, fra il 1985 e il 2010, una perdita di ben l’8.5 per cento del Pil (0,35 per cento all’anno). L’Italia, per esempio, ha perso il 6,6 per cento di Pil a causa della disuguaglianza, registrando una crescita dal 1985 al 2010 leggermente superiore all’8 per cento, mentre sarebbe potuta essere del 14,7 per cento. Come dire, il nostro prodotto interno lordo sarebbe potuto crescere di quasi il doppio rispetto a quanto è cresciuto se la nostra società avesse diminuito drasticamente le disuguaglianze. Più o meno la stessa riduzione di punti percentuali di Pil a causa delle disparità di reddito (fra il 6 e il 7 per cento) è stata registrata negli Stati Uniti e in Svezia. Più del 10 per cento di Pil sarebbero andati in fumo in Messico (-11,3 per cento) e Nuova Zelanda (-15,5 per cento), e quasi il 9 per cento nel Regno Unito, in Finlandia e in Norvegia. Dall’altro lato dello spettro, una diminuzione delle differenze nella distribuzione del reddito ha aiutato il Pil pro capite a crescere in Spagna, Francia e Irlanda. E gli effetti negativi di queste differenze nel reddito, secondo l’OCSE, non si fanno sentire solo nel 10 per cento più povero della popolazione, ma anche nei quattro ultimi decili, in pratica in quasi metà degli abitanti che fanno parte dei ceti meno abbienti. Da qui la raccomandazione del rapporto di attuare politiche ridistributive mirate attraverso sussidi alle famiglie con bambini, per esempio, per favorirne l’educazione e la scalata sociale, ma anche attraverso tasse e sussidi mai però dati a caso. Infatti, si rileva nello studio, la ridistribuzione frena la crescita solo quando è fatta male, a pioggia e crea quindi spreco di risorse non essendo focalizzata ad obiettivi e categorie di persone ben precisi. Ma perché la disuguaglianza frena la crescita? Dalla relazione OCSE emerge una teoria ben precisa che ha a che fare, come accennato, con l’istruzione: le differenze di reddito, prevenendo l’accumulazione di capitale umano, creano meno opportunità educative per le categorie di cittadini più svantaggiati, anche quando vengono da famiglie con un livello di istruzione medio-alto. Queste
76
mancate opportunità si rilevano sia nei meno anni di scuola che nella scarsa qualità del processo di apprendimento di certe capacità, ad esempio le abilità matematiche. In conclusione, il rapporto sfata il mito secondo cui i politici devono sempre trovare un difficile compromesso fra il favorire la crescita economica e il combattere le disuguaglianze sociali. In pratica, dice l’Ocse, se si attuano misure per ridurre le disparità di reddito, anche l’economia in generale ne gioverà parecchio. (Maurizio Molinari in http://www.network.redattoresociale.it/ 8 dicembre 2014) ü OCSE: Conseguenze stimate dei cambiamenti nell'ineguaglianza (1985-2005) sul successivo sviluppo cumulativo (1990-2010) ü OCSE: Dati relativi ad alcuni dei Paesi presi in esame nel grafico Tasso di crescita reale
1990- 2010 Impatto della disuguaglianza
Tasso di crescita senza l’impatto della disuguaglianza
Ireland 64,6 4,4 60,2 United Kingdom 40,9 -8,6 49,6 Sweden 35,5 -7,2 42,7 Finland 34,4 -8,6 43,1 Norway 34,0 -8,5 42,6 New Zealand 28,4 -15,5 43,9 United States 28,3 -6,0 34,3 Germany 25,7 -5,7 31,3 France 18,5 3,6 14,9 Spain 17,3 6,4 10,9 Italy 8,0 -6,6 14,7 Mexico 0,5 -11,3 11,8
DOCUMENTI n. 3 La disuguaglianza uccide la crescita: ecco la dimostrazione di Stiglitz Con il teorema di Stiglitz viene inferto un altro duro colpo all'ortodossia liberista dominante ai tempi della grande crisi: se l' indice di Gini (ovvero l'indicatore che misura la diseguaglianza) au- menta il «moltiplicatore» degli investimenti diminuisce e dunque il Pil frena. Ecco perché. di Roberto Petrini, da Repubblica, 31 maggio 2013 È la diseguaglianza il vero killer del Pil. Nei paesi dove i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri il Prodotto interno lordo segna il passo e, a volte precipita. Nelle nazioni dove si estende una grande middle class si affaccia invece la prosperità. Il premio Nobel Joseph Stiglitz rompe gli indugi e formalizza in un vero e proprio teorema, come egli stesso lo definisce, la sintesi degli studi che conduce da anni.
77
Il teorema di Stiglitz dal fronte keynesiano getta una bomba oltre le trincee liberiste. Si fonda sul meccanismo di quella che gli economisti chiamano «propensione al consumo»: i ricchi ce l'hanno più bassa del ceto medio, dunque se la distribuzione del reddito li favorisce lo shopping, contraria- mente a quanto si potrebbe pensare intuitivamente, si deprime. E' invece il ceto medio a consumare quasi tutto quello che ha in tasca e a spingere Pil ed economia, quando la distribuzione del reddito lo favorisce. La prova? Il grafico di Stiglitz è inattaccabile: quando i ricchi (ovvero l' 1 per cento più ricco della popolazione) si è appropriano del 25 per cento del reddito scoppia la «bomba atomica economica». E' successo con la Grande Crisi degli Anni Trenta e con la Grande Recessione di que- sto secolo. Altro che teorie liberiste che hanno segnato gli ultimi trent' anni: «Gli apologeti della di- seguaglianza sostengono che dare più soldi ai più ricchi - scrive Stiglitz nella sua relazione - sarà un vantaggio per tutti, perché porterebbe ad una maggiore crescita. Si tratta di una idea chiamata "tric- kle-down economics" (economia dell' effetto a cascata). Essa ha un lungo pedigree e da tempo è stata screditata». L' occasione per presentare gli straordinari risultati delle ricerche di Stiglitz in una sorta di antepri- ma mondiale, è il convegno organizzato a Roma dalla Sieds (la Società italiana di economia, demo- grafia e statistica), cominciato ieri, dove il premio Nobel invierà le considerazioni conclusive, scrit- te a quattro mani, con il suo più stretto collaboratore italiano dell' Università Politecnica delle Mar- che, Mauro Gallegati. Così il mainstream va nell' angolo. Il teorema è chiaro e lucido come una formula chimica o una re- lazione fisica: se l' indice di Gini (ovvero l' indicatore di diseguaglianza inventato da un economista italiano, appunto Corrado Gini) aumenta, dunque aumenta la diseguaglianza, il «moltiplicatore» de- gli investimenti diminuisce e dunque il Pil frena. L'equazione di Stiglitz rischia di essere il terzo colpo agli assunti della teoria economica dominante ormai vacillanti. Il primo è stato nei mesi scorsi quello che ha messo in crisi il «dogma» dell' auste- rità: l' Fmi ha infatti calcolato che il taglio del deficit di 1 può ridurre il Pil di 2 e non solo – come si credeva fino ad oggi – di mezzo punto. L' altro colpo mancino è stato quello che ha smontato, sma- scherando un errore «Excel», la teoria del debito di Rogoff e Reinhard secondo la quale oltre il 90 per cento nel rapporto con il Pil porta inevitabilmente alla recessione. Ma il nuovo assalto di Stiglitz rischia di essere ancora più pericoloso rispetto alle tesi dello status quo economico. La diseguaglianza infatti per il premio Nobel, fiacca fino ad uccidere il Pil, non so- lo per via della caduta dei consumi ma anche perché il sistema è «inefficiente» se prevalgono rendi- te e monopoli. «Spesso la caccia alla rendita – concludono Stiglitz e Gallegati – comporta un vero spreco di risorse che riduce la produttività e il benessere del paese». (31 maggio 2013)
78
DOCUMENTO 4 Democrazie e democratizzazioni di Pietro Grilli di Cortona Democrazie e democratizzazioni
Da Atlante Geopolitico 2012
Con la fine del Novecento crolla definitivamente l‟idea che la democrazia sia un tipo di regime politico possibile e praticabile solo nell‟area degli stati occidentali, ossia Europa, Americhe e mondo anglosassone. In un certo senso, quella grande rivoluzione democratica preconizzata da Alexis de Tocqueville, un po‟ meno di due secoli fa, sembrerebbe oggi aver trovato una sua quasi compiuta realizzazione con l‟affermarsi di principi, istituzioni e procedure democratiche in paesi del mondo culturalmente lontani e geograficamente eccentrici rispetto al mondo occidentale. Gli interrogativi non riguardano solo l‟effettivo successo di questo processo di espansione della democrazia, che implica evidentemente una valutazione sia della quantità dei paesi coinvolti, sia della qualità e del modello di democrazia che poi si afferma nei vari scenari nazionali, ma anche gli effetti che un simile fenomeno potrà avere sull‟intera politica internazionale.[…] l‟espansione della democrazia nel mondo non ha prodotto ovunque un modello uniforme di democrazia, ma ha avuto come risultato – lo vedremo più avanti – anche la formazione di molte pseudo-democrazie o regimi ibridi che, se in larga parte costituiscono un‟evoluzione e un progresso rispetto ai regimi autoritari o totalitari precedenti, dall‟altra non rappresentano ancora democrazie liberali compiute.[…] Seymour M. Lipset ha poi sostenuto l‟esistenza di una forte correlazione della democrazia con lo sviluppo economico: più una nazione è benestante, industrializzata, istruita e urbanizzata, tanto più è facile che il regime sia democratico. Un paese povero aumenta le probabilità del nepotismo e del clientelismo; un paese ricco favorisce la crescita dei ceti medi e delle organizzazioni indipendenti, vede sdrammatizzare la questione della redistribuzione del reddito e aumentare l‟efficienza del sistema. Non è la ricchezza in quanto tale ad aiutare la democratizzazione, ma i fattori correlati ad essa e allo sviluppo socio-economico, come il più alto livello di istruzione e una più equa distribuzione del reddito. La correlazione tra sviluppo socio- economico e democrazia ha certo una sua rilevanza, ma non può essere considerata una „legge‟ sociale. È infatti evidente come la democrazia si stia sempre più diffondendo anche in paesi privi dei requisiti socio-economici di sviluppo. Si pensi a casi come Benin, Botswana, India, Mongolia, Namibia, Sudafrica, ma anche al caso contrario della Cina, dove a forti indici di sviluppo socio- economico non corrisponde alcuna apertura democratica. DOCUMENTO 5 Il Papa avverte: "Con disuguaglianze e povertà democrazia a rischio"
Adnkronos
"La crescita delle diseguaglianze e della povertà mette a rischio la democrazia". E' l'allarme che Papa Francesco lancia, nel discorso rivolto ai partecipanti all'assemblea plenaria del Pontificio Consiglio 'Giustizia e Pace', guidati dal cardinale Peter Turkson e ricevuti nella sala Clementina del Palazzo Apostolico in Vaticano. "La democrazia, inclusiva e partecipativa - ricorda il Papa - presuppone sempre un'economia e un mercato che non escludono e che siano equi: si tratta allora di vincere le cause strutturali delle diseguaglianze e della povertà". Il fenomeno della globalizzazione, osserva Francesco esaminandone "benefici e pericoli", se da un lato "ha accresciuto notevolmente la ricchezza aggregata dell'insieme e di parecchi singoli Stati", dall'altro "ha anche inasprito i divari tra i vari gruppi sociali, creando diseguaglianze e nuove povertà negli stessi Paesi considerati più ricchi". Lavoro - Bergoglio sottolinea poi che "il diritto fondamentale al lavoro non può essere considerato una variabile dipendente dai mercati finanziari e monetari". "Il lavoro - ricorda il Papa - è un bene fondamentale rispetto alla dignità, alla formazione di una famiglia, alla realizzazione del bene comune e della pace". Francesco spiega che "uno degli aspetti dell'odierno sistema economico è lo sfruttamento dello squilibrio internazionale nei costi del lavoro, che fa leva su miliardi di
79
persone che vivono con meno di due dollari al giorno. Un tale squilibrio - lamenta - non solo non rispetta la dignità di coloro che alimentano la manodopera a basso prezzo, ma distrugge fonti di lavoro in quelle regioni in cui esso è maggiormente tutelato". Dunque, "si pone qui il problema di creare meccanismi di tutela dei diritti del lavoro nonché dell'ambiente, in presenza - osserva il Papa - di una crescente ideologia consumistica, che non mostra responsabilità nei confronti delle città e del Creato". Francesco condanna anche "i perduranti squilibri tra settori economici, tra remunerazioni, tra banche commerciali e banche di speculazione, tra istituzioni e problemi globali: è necessario tenere viva la preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale". Stato sociale - Bergoglio avverte: "Lo stato di diritto sociale non va smantellato, in particolare il diritto fondamentale al lavoro". E cita "tre strumenti fondamentali per l'inclusione sociale dei più bisognosi: l'istruzione, l'accesso all'assistenza sanitaria e il lavoro per tutti". In particolare, Francesco sottolinea che "l'istruzione, il lavoro e l'accesso al welfare per tutti sono elementi chiave sia per lo sviluppo e la giusta distribuzione dei beni, sia per il raggiungimento della giustizia sociale, sia per appartenere alla società e partecipare liberamente e responsabilmente alla vita politica, intesa come gestione della 'res publica'. Visioni che pretendono di aumentare la redditività, a costo della restrizione del mercato del lavoro che crea nuovi esclusi - è il monito del Pontefice - non sono conformi a un'economia a servizio dell'uomo e del bene comune, a una democrazia inclusiva e partecipativa". Una autentica giustizia sociale, rimarca ancora il Papa, "esige, da una parte, profonde riforme che prevedano la ridistribuzione della ricchezza prodotta e l'universalizzazione di mercati liberi a servizio della famiglie; e dall'altra, la ridistribuzione della sovranità, sia sul piano nazionale sia sul piano sovranazionale". (…)
80
Tracce della simulazione di terza prova
INTERNET ADDICTION
Are we hooked on addiction?
Dr Mark Collins is the head of the addictions unit at the Priory, an expensive clinic in Roehampton. “Over the last 18 months we have noticed a big rise in the number of behavioural addictions, so-called to distinguish them from substance dependencies,” he says. “People are looking down on smokers, alcoholics and cocaine addicts, but then go and spend five hours in an Internet chat room.” Says Collins. Behavioural addictions include compulsive attachments to plastic surgery, the Internet, mobile phones and even sun beds.
It seems that in our fast-paced modern life, we are increasingly turning to comfort behaviour, activities which temporarily make us feel happier, less stressed and lonely. Experts warn that these are the very things that can lead us into dependency no matter how harmless they may seem at first. While behavioural addictions may sound less serious than being hooked on drink or drugs, according to experts, their potential for ruining lives may actually be quite similar. They can lead to obsession, debt and the breakdown of relationships.
Internet addiction
Caroline Harrison, 37, a full time mother of three, admits to compulsively using the Internet. “I was surfing to discover something about my youngest child’s skin problem when I found this amazing parenting website with lively message boards,” she says. “Soon I found I couldn’t go a day without logging on. I started spending all evening “chatting” to my new online friens instead of spending time with my husband. It never crossed my mind that it could be addictive. But now I feel tense if I can’t get access to my computer. The people there seem more real and supportive than my own family and friends. I often feel depressed and lonely in real life because my husband works long hours, so being on the site makes me feel good. Well, temporarily good.”
READ THE TEXT AND ANSWER THE QUESTIONS.
81
1.According to the text, why has there been a rise in behavioural addictions and what can be the consequences of these behavioural addictions?
2. In your opinion, what impact can technology have on family life?
3.Apart from internet addiction, what are other dangers of using the Internet?
82
Quesiti di storia 1. Dopo averla definita, spiega da chi, come e quando fu risolta la questione
fiumana (Max 10 righe) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. 28 ottobre 1922 e 3 gennaio 1925: due date che hanno segnato profondamente e drammaticamente la storia italiana. Dopo aver individuato con precisione gli avvenimenti che si riferiscono alle suddette date, mettili in relazione fra loro. (Max 10 righe)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
83
Quesiti di Scienze Umane 1) Una ricerca è costituita da una sequenza di passaggi concatenati tra loro. Una di queste tappe è “l’elaborazione del disegno di ricerca”. Di che cosa si tratta? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2) In che modo l’organizzazione scientifica del lavoro (taylorismo) ha modificato le condizioni lavorative negli Stati Uniti e in Europa a partire dal Novecento? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3) Quali sono i principali motivi della diffusione nel mondo del modello occidentale di matrimonio romantico? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________