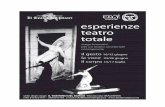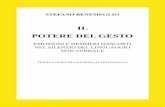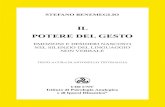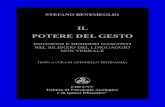Cita7 gesto
-
Upload
sergio-cueto -
Category
Documents
-
view
217 -
download
2
description
Transcript of Cita7 gesto
-
Leitmotiv 2/2002http://www.ledonline.it/leitmotiv/
71
7.
Micla Petrelli
Il gesto della citazione
Ancora un passo e sarebbe apparso lidiota.Colui ch rimasto senza quasi parola, in apparenza
Mara Zambrano
Pensare alla citazione, a quel luogo del testo solitamente ben disegnato, dalprofilo concluso, allacciato forte, con la forza del senso, a ci che gli gravitaintorno, ma nello stesso tempo abbastanza separato da respirare in autono-mia, entro i limiti del muro di cinta dello spazio tipografico. Pensare alla cita-zione pu voler dire osservarla cos, come un effetto di scrittura, una esigenzainterna al discorso, che del discorso sa articolare le direzioni, gli svolgimenti,anche gli inabissamenti.
Comunque sia, la pagina che ospita una citazione ha laria di un prodottofinito, sebbene di alto artigianato. Ci che rischia di sfuggire nel descriverlaretoricamente, semioticamente, stilisticamente, il fatto che essa definisce ilproprio orizzonte di esistenza, semplicemente sta nel testo, con tutta levi-denza del gesto, del movimento di pensiero, di lettura e scrittura che lha gene-rata e in quel testo instaurata. E si fa distante, rendendosi quasi inavvicinabile,scostante, cos ben incastonata come appare, quando la si vuol apprendereprescindendo dallinterrogarsi sul procedimento, il gesto appunto, del citare.
Innanzi tutto citare come convocare, chiamare a s, avocare parole cheportano nel loro etimo il tratto, la traccia di un moto espressivo della voce (unin-citamento, appunto). una richiesta daiuto a voce alta che interrompe la so-litudine silenziosa di chi scrive. E in questo caso, chi scrive, nellallestire lascena della citazione, in realt pu essere mosso da due differenti scopi, avolte non del tutto estranei, anzi ambiguamente implicati: in primo luogo
-
Micla Petrelli
Leitmotiv 2/2002http://www.ledonline.it/leitmotiv/
72
chiamare laltro a testimoniare lautenticit, la veridicit del proprio dire, citan-dolo in giudizio perch la propria parola risulti credibile e il lettore pienamentepersuaso di ci 1; oppure, sottolineare lintenzione di voler prendere su di s,assumersi, ogni responsabilit, in quanto soggetto propositivo e attivo dello-perazione di embrayage: apparire senza ombra di dubbio lAutore di quel te-sto. Perch citare pu voler rimarcare: io cito. Dunque, una dialettica dellin-decisione tra insufficienza ed eccedenza della parola propria, un indizio di in-stabilit dellidentit autoriale.
Prodigiosamente la citazione si insedia tra apparizioni e sparizioni, prota-gonista di un gioco di prestigio in cui il testo di origine da cui proviene dispa-re, anche se mai completamente; piuttosto si fa opaco, dietro un testo nuovosplendente nella sua aria di coesa necessit. Chi accoglie la citazione, in realtsi nutre delle macerie, di un mucchio di rovine, direbbe Benjamin 2, infranteperch un discorso diverso si costruisca.
La citazione, nel momento in cui si d al lettore, non smette quindi ditradirsi mostrando le dinamiche che lhanno originata: da abbandono, separa-tezza, qualche volta rinnegamento del contesto di appartenenza, a rinascita informa di irrevocabile, sferica, infrangibile unit di senso, movenze di un pro-cesso segnato dal continuo nascere e disnascere 3 dei testi.
A essere indagata , dunque, quella inseparabile relazione tra il citabile elo scrivente, tra ci che volta a volta si concede, si presta, lasciandosi sedurredalla promessa di vita moltiplicata (la citazione coinvolge la modalit dellaripetizione differita), una reincarnazione del significato che pu salvare
1 Sulle modalit epistemiche della citazione (credenza, veridizione) si veda A.J.Greimas e J. Courtes, Semiotica: dizionario ragionato della teoria del linguaggio (1979), a c. di P.Fabbri, La Casa Usher, Firenze 1986.
2 Cfr. H. Arendt, Benjamin: lomino gobbo e il pescatore di perle (1968), in Il futu-ro alle spalle (1980), tr. it. di V. Bazzicalupo e S. Muscas, il Mulino, Bologna 1995. La praticadello scrivere per citazioni, sogno benjaminiano, somiglia per la Arendt alla passione delcollezionista. Benjamin sa bene che non si pu frantumare una tradizione in maniera piefficace che estraendone ci che raro e prezioso: i coralli e le perle (ci che non maistato tramandato e non tramandabile). La storia stessa, scrive la Arendt, cio la rottu-ra della tradizione compiutasi allinizio di questo secolo, lo ha esonerato proprio da questolavoro di distruzione e nello stesso tempo ha solo bisogno di chinarsi per raccogliere i pre-ziosi frammenti dal mucchio di rovine del passato, ivi, p. 93.
3 Cfr. M. Zambrano, Delirio e destino (1998), tr. it. di R. Prezzo e S. Marcelli, RaffaelloCortina, Milano 2000, pp. 15-28. Disnascere per Mara Zambrano la possibilit del-luomo di rinascere disattendendo e tradendo il disegno, il progetto di Dio dal cui sognonoi nasciamo, come ombre votate a rendere il sogno pi trasparente possibile, ivi, p. 16.Nei nostri termini, con il gesto della citazione, la morte del testo per la disgregazione, equindi negazione, della sua progettata unit di senso subito convertita nella rinascita inun nuovo testo.
-
Il gesto della citazione
Leitmotiv 2/2002http://www.ledonline.it/leitmotiv/
73
dalla caduta, dalloblio, e lurgenza di chi deve mascherare, dissimulare il ve-nir meno della parola, la stanchezza di dire, di significare in proprio, con la pa-rola altrui. E tutto il vuoto che a questa relazione si rapprende insidiato dallaminaccia del silenzio, dallorrore dellassenza, horror vacui della scrittura.
FINZIONE
Dietro le quinte di questa pratica sostitutiva di cui la citazione espressione esoluzione, una finzione. Finzione che non si compromette con la falsit pro-gettata della menzogna, ma che somiglia semmai alla dissimulazione, a unaprassi di velamento, in cui la verit impronunciabile (e qui la verit di segnonegativo, intendimento di una mancanza) appare adombrata 4; la si intra-vede nella semioscurit in cui le forme che assume la memoria del testo recu-perato, allorch si appresta a diventare citazione, si trasfigurano e a tratti sirendono irriconoscibili.
Mancanza, qui, non ha semplicemente a che fare con debolezza, con ilvenir meno del soggetto al cospetto di s, dinnanzi alla propria identit di scri-vente, non risolubile nel pensiero di una situazione abitata da caducit, deli-quio, rinuncia. Questa mancanza nasce dal travaglio della parola parola cieca che ricerca e insegue la cosa da nominare, che continuamente la manca, finoal punto da doversela inventare, oppure procurare fuori, altrove; accettandolaper come si offre, e cio nella veste di cosa gi nominata. La parola cos appa-gata parola cieca che ha trovato luscita si dunque pacificata nella ricercache stata daltri. Come il proposito di dire ci che , di non mancare lacosa nominata appartenga allutopia della parola, non al suo presente, vienesuggerito da Maurice Blanchot quando, nel proiettare lidea della caduta diogni totalit su un piano stilistico, parla di una noia per le parole che an-che desiderio di parole distanziate, frammentate nel loro potere che senso, enella loro composizione che sintassi o continuit del sistema 5.
In simili occasioni persino una scrittura dallandamento laconico indi-zio di un cedimento di quella totalit e continuit del sistema alle quali sipu reagire facendo appello a una scrittura gi fatta, alla sua citazione ap-
4 Lidea che la verit non debba mostrarsi mai a viso aperto ma celata dal velo della
dissimulazione appartiene a T. Accetto, Della dissimulazione onesta (1641), a c. di S. Nigro,Einaudi, Torino 1997.
5 M. Blanchot, La scrittura del disastro (1980), tr. it. di F. Sossi, SE, Milano 1990, p. 19.
-
Micla Petrelli
Leitmotiv 2/2002http://www.ledonline.it/leitmotiv/
74
punto, anche questultima, a ben vedere, di natura laconica. E se la laconica bre-vitas, nella retorica del Tesauro, una forma metaforica in grado di istituire unrapporto inversamente proporzionato tra il dire e lintendere, la citazione co-stitutivamente laconica proprio nella misura in cui le sue possibilit di signifi-care, sono ben maggiori di quanto la sua estensione, o meglio distensione 6,permetta di enunciare. Loscurit alla quale la brevit del dire laconico pupervenire (obscura brevitas), poi, rischiosa nel momento in cui si fa, come inTacito, stile e organizzazione del pensiero. Tacito che, stando a Tesauro, otace parlando o parla tacendo, e pi adorn di concetti le parole, che di pa-role i concetti 7. Poich laconismo e brevit sono invece garanzia di acutezzae profondit nella penetrazione del senso.
Lurgenza per lo scrivente di convocare un testimone, forte e inequivo-cabile, che confermi, sottoscriva, ci che a lui si sottrae e argini il laconismoche lo minaccia, insinua nellatto stesso del citare lintrigo della finzione: citan-do si finge di ribadire la propria posizione di soggetto autorevole della scrittu-ra, proprio mentre questa sta in realt venendo meno; finzione quella che ac-consente a scambiare, a barattare, linserzione stralciata di una parte di testocon la totalit del testo stesso (la pars pro toto della sineddoche). In entrambi icasi, tra ci che si cela e ci che si mostra si stabilisce un rapporto di convi-venza per sovrapposizione che vela senza mai nascondere, mai del tutto oscu-rare laltro.
finzione anche quella che si accompagna a ogni movimento di ripeti-zione. La speranza di unicit, autenticit e originariet che ogni atto di scritturaporta con s, nella ri-scrittura della citazione si compromette con duplicazionee serialit. Cos lo specchio borgesiano, figura che moltiplica, ripete, non soloriflette, fedelmente duplica le apparenze, ma insieme genera, attraverso tra-me illusorie, il sogno dellinfinito, instaura il dominio della finzione:
Luniverso visibile illusione []; gli specchi e la paternit sono abominevoli[] perch lo moltiplicano e lo divulgano 8.
6 Vedi E. Tesauro, Il cannocchiale aristotelico (1664), Editrice Artistica Piemontese, To-
rino 2000, pp. 434 e sgg. La Metafora sesta de Il cannocchiale aristotelico definisce la figuralaconica come un genere di metafora che consiste nel farti intendere pi di quanto dica eche si ottiene in due modi: Significando una proposizione distesa con unaltra distesa,bench coperta (la dissimulazione); oppure significando la proposizione distesa con bre-vit: che tanto pi acuta sar, quanto pi breve, p. 434. grazie al laconismo chelintelletto dal quel vestigio chei vede, profundamente penetri ci che non vede, p. 616.Vedi anche E. Puteano, Laconismi Encomium, Milano 1606.
7 Ivi, p. 153.8 J.L. Borges, Tln, Uqbar, Orbis Tertius, in Finzioni (1956), tr. it. di F. Lucentini,
-
Il gesto della citazione
Leitmotiv 2/2002http://www.ledonline.it/leitmotiv/
75
Io preferisco sognare che queste superfici argentate figurino e promettanolinfinito 9.
Come lo specchio, che nelle finzioni di Borges inquieta il fondo dun corri-doio, oppure spia i protagonisti instradandoli nei percorsi labirintici e cir-colari dellidentit, la citazione pone, in quanto funzione della ripetizione, laquestione dellidentit dellautore. Ovvero il tema diviene quello delle relazioniche possono intercorrere tra lo scrivente e il suo Autore 10, e tra di esse,lequivoco dellidentificazione che viene a crearsi, segretamente, in ogni prassiesplicita o implicita di citazione, mentre le marche di separazione dal testo, nelcontempo, ne continuano a segnare e conclamare la differenza, lalterit. Am-biguit che, anche se solo per un istante, a ogni lettore dato avvertire: in si-mili circostanze, esso pu imbattersi nellindecidibilit 11 circa lappartenenza deltesto, soprattutto nelle forme di citazione implicita o sbagliata. Lidentificazio-ne, per, almeno in questa occasione, cosa dello scrittore, esperienza dallaquale attraversato nel momento in cui ripetendo, riscrivendo ci che ad altri appartenuto, di questi usurpa il posto, ricompra la propriet e il ruolo discrivente, perch si ripeta la scena:
Al destino piacciono le ripetizioni, le varianti, le simmetrie; diciannove secolidopo [dopo Cesare e Bruto, e Shakespeare e Quevedo] nel sud della provincia diBuenos Aires, un gaucho aggredito da altri gauchos e, nel cadere, riconosce unsuo figlioccio e gli dice con mite rimprovero e lenta sorpresa (queste parole bi-sogna udirle non leggerle): Come, tu! Lo uccidono e non sa che muore perch siripeta la scena 12.
ci che accade al vero autore di biografie che, per Ortega, consapevole delfatto che una vita umana costituita esclusivamente da fatti interni a essa Einaudi, Torino 1978, p. 8.
9 J.L. Borges, La biblioteca di Babele, ivi, p. 69.10 Il riferimento allespressione dantesca non alieno dal produrre conseguenze in
questa riflessione. Nella Commedia il confronto tra Dante e (lopera di) Virgilio invita a unainterpretazione che coinvolge subito il tema dellidentit/identificazione degli autori.
11 chiaro che, in fondo, il testo finisce con lappartenere al suo lettore e che quindilindecidibilit diviene un problema che coinvolge prioritariamente la capacit di riconosceree ricordare del soggetto interpretante. In questo caso, per, la pratica della citazione impo-ne losservazione di ci che accade nel testo e di cosa ne del testo in quanto luogo com-partecipato, integrato di pi testi, sistema sinaptico complesso pi che modello euclideodella contiguit.
12 J.L. Borges, La trama, in Lartefice (1960), tr. it. di F. Tentori Montalto, Rizzoli,Milano 1982, p. 34.
-
Micla Petrelli
Leitmotiv 2/2002http://www.ledonline.it/leitmotiv/
76
scrive di quella vita rivivendo internamente a essa 13. E se citare un testo mettecomunque in gioco un confronto con il suo autore, anche se si tratta di unconfronto che si risolve in una sovrapposizione di identit, adottare un clich,figura anchessa della reiterazione del gi detto, significa risparmiarsi questoincontro: lautore del clich ogni autore, tutti e nessuno. Si potrebbe dire dilui ci che Borges scrive degli abitanti di Tln e dei loro abiti letterari: raro che i libri siano firmati. La nozione di plagio non esiste: s stabilito chetutte le opere sono opere dun solo autore, atemporale e anonimo 14, cosic-ch: Tutti gli uomini che ripetono un verso di Shakespeare sono William Sha-kespeare 15.
Osservata in controluce, questa poetica della citazione rivela una filigranadoppia, illusiva. Per un verso tende a mostrare laspetto eccedente, esuberantedella citazione, che per natura ripetibile, moltiplicabile a pi livelli; per laltroverso ne denuncia lorigine difettiva: l dove dimora una citazione, una man-canza, una insufficienza si era infiltrata. La citazione dunque in grado di cu-rare il laconismo in cui il testo versa pur essendo essa stessa fatta di materia la-conica: qualsiasi sia lo spazio che occupa e la sua dimensione, la citazione diceil testo di originaria appartenenza sostituendosi a esso, anche se mai del tutto;allo stesso modo, del testo che la ospita e che contribuisce a salvare, occupersempre solo una parte. Un destino di incompiutezza le permette di concedererinunciando. Ancor pi partecipa di questo rimedio omeopatico alla scritturamancante lallusione che tace parte del suo referente, anche il suo nomeproprio a volte che meno visibile e distesa della citazione ma sa signifi-care pi di qualsiasi forma discorsiva diretta e descrittiva. Lallusione, che sipresenta quando il laconismo fa correr la mente ingegnosa a cose passate, olontanissime 16, complica la questione dellappartenenza autoriale (chi il re-ferente di quellallusione?) fino a renderla ininfluente, mentre fa della ricono-scibilit del testo cui si allude un problema di significato, ritagliando e coinvol-gendo specifiche e selezionate connotazioni di senso di questultimo 17.
13 J. Ortega y Gasset, Sulla leggenda di Goya, in Goya (1980), tr. it. di R. Rossi Te-sta, SE, Milano 2000, p. 73.
14 J.L. Borges, Tln, Uqbar, Orbis Tertius, cit., pp. 18-19.15 Ivi, p. 17.16 E. Tesauro, op. cit., p. 618.17 Per un approccio semantico e pragmatico al problema dellallusione in letteratura
si veda C. Perri, On alluding, in Poetics, 7, 1978, pp. 289-307. La Perri rifiuta la tradizio-nale definizione di allusione come tacita referenza intendendola invece come una speciedi referenza che coinvolge il livello semantico del discorso. La sua tesi sullallusione rias-sumibile nel verso dellinvocazione a Urania del poema di Milton: The mining, not thename I call.
-
Il gesto della citazione
Leitmotiv 2/2002http://www.ledonline.it/leitmotiv/
77
Finzione, mancanza, sostituzione. Il discorso della citazione sembrerebbecostituirsi su quello che la psicoanalisi chiama un atto mancato di scrittura, e ren-dersi evidente e leggibile grazie al fatto che a quella mancanza fa prontamenteseguito una sostituzione. Formazione di compromesso tra il conscio e il ri-mosso, latto mancato , nellinterpretazione psicoanalitica, il risultato di unanegazione, anzi di una negazione che, cos facendo, paradossalmente ammetteci che nega. Sappiamo da Freud come un contenuto rimosso di rappresenta-zione o di pensiero pu introdursi nella coscienza a condizione che si faccianegare. Ma non qui evidente, si interroga Benveniste, che il fattore lingui-stico ha una funzione decisiva in questo processo complesso, e che la nega-zione in un certo modo costitutiva del contenuto negato, e quindi delle-mergere di tale contenuto nella coscienza e nella soppressione del rimosso?[] Il discorso pu profondersi di dinieghi, ma non annullare la proprietfondamentale del linguaggio, cio limplicita assunzione che a ci che enun-ciato corrisponde qualcosa, qualcosa e non niente 18. E questo qualcosa,nel processo che ha generato il bisogno di citazione, quel qualcosa che ve-nuto meno, che sfuggito, scivolato via, per negarsi, non corrisponde forse aci che avremmo scritto in proprio se una formazione gi pronta e compiuta,gi esistente, non si fosse presentata al cospetto della nostra coscienza di scri-venti con la promessa di un immediato risarcimento?
Ecco, lorizzonte negativo entro il quale il ricorso alla citazione si ge-nera, non accoglie, e dunque non spiega del tutto, lallusione. Lallusione nonsi d in sostituzione di un assente, non pu neppure risolversi in un gesto dinegazione in quanto essa atto immediatamente poietico: produce un di-scorso in cui la finzione, cos come la sostituzione, vengono trasferiti allin-terno della relazione testo/testi di referenza e soggetto alludente. Chi scriveallusivamente, sul discorso altrui, su selezionate connotazioni di senso diquel discorso, sperimenta le possibilit di articolazione del proprio.
TOLLERANDO, TACENDO, ASPETTANDO
Si istituisce dunque la citazione: perch si vuol far spazio a una diversa pro-nuncia del discorso, inserire una variazione al tema, perch la memoria pen-
18 E. Benveniste, Note sulla funzione del linguaggio nella scoperta freudiana
(1956), in Problemi di linguistica generale (1966), tr. it. di M.V. Giuliani, il Saggiatore, Milano1994, pp. 103-104.
-
Micla Petrelli
Leitmotiv 2/2002http://www.ledonline.it/leitmotiv/
78
sante, approfittando di un momentaneo allentamento della tenuta delpresente scrivente 19, reclama i propri diritti. Oppure perch essa viene a col-mare il vuoto di una sopraggiunta assenza, a sostituire con altre parole quelleche eventualmente, in quel preciso momento e luogo, mancano. L dove siannuncia la possibilit (il rischio, la minaccia, la salvezza) di uno spazio biancoe silente, allora la citazione pu consentire a chi scrive di tacere, di prenderetempo, nutrendo lattesa di nuove tensioni e desideri, e tollerare meglio quella (lapropria) mancanza: poich la parola non sopporta mai una genesi del tuttoinventiva. Che ci si avventuri alle soglie del plagio 20, delleponimia, o si rical-chino le orme di immagini gi trascorse o di clich, levento-citazione (nome,parola, pagina che sia) la deriva vischiosa e redditizia di ogni atto creativo,esperienza ininterrotta di scrittura che a ogni occasione si trova a decidere dis.
Se vero che le parole agiscono anche quando tacciono (Cos amatordi pace chi dissimula [] tollerando, tacendo, aspettando), cos come sugge-risce Torquato Accetto nella sua retorica della dissimulazione onesta 21, allora ilricorso alla citazione dimostra ogni volta come le parole che tacciono (inquanto vengono meno), le parole in-audite, agiscono lasciando il posto adaltre parole, si ammutoliscono per restituire udibilit a unaltra voce. Intuire edecifrare ci che si nasconde in ci che appare dunque preciso atto retoricoancor pi che gioco illusionistico. chiaro che nella citazione, che inserzio-ne per estrapolazione, si tratta, soprattutto per chi legge, di recuperarelinvisibile (il testo integro, il testo mancante) nel visibile, mettendo cos ingioco la propria memoria, la memoria che si migliora e si esercita per fram-menti, ripercorrendo segmenti 22.
19 Indubbiamente listituzione della citazione nasce da un atto volontario di tentataconnivenza a tre memoria pensante, presente scrivente, lettore prossimo . B. Brando-lini DAdda, Citatio expuncta, in Anterem, 29-30, 1985, p. 26.
20 J.L. Borges, Pierre Menard, autore del Chisciotte, cit.21 Pazienza, tolleranza, cautela e sobriet Accetto prescrive, perch la verit, debita-
mente adombrata, nascosta, possa essere espressa senza generare odio. Il velo della dissi-mulazione, a questo proposito, pi onesto della nebbia della menzogna, deve perci avva-lersi della virt del silenzio, dellomissione, della brevitas, dellarte retorica del lasciar solointravedere, intuire, ci che si dovrebbe tacere. T. Accetto, op. cit., p. 4. Sul tema della men-zogna retorica vedi anche: C. Calcagnini, C. Malespini, G. Battista, P. Rossi, Elogio dellamenzogna, a c. di S. Nigro, Sellerio, Palermo 1992.
22 Cfr. A. Compagnon, La seconde main ou le travail de la citation, Seuil, Paris 1979: Il ya un objet premier, pos devant moi, un texte que jai lu, que je lis; et le cours de malecture sinterrompt sur une phrase. Je reviens en arrire: je re-lis. La phrase relue devientformule, isolat sans le texte. La relecture la dlie de ce qui prcde et de ce qui suit. Lefragment lu se convertit lui-mme en texte. Ma lecture procde dj dun acte de citation
-
Il gesto della citazione
Leitmotiv 2/2002http://www.ledonline.it/leitmotiv/
79
Lo scrivente si eclissa, dunque, senza rinunciare a esistere, convinto cheattraverso ci a cui sta restituendo voce (il citato), anche un semplice sintag-ma, il lettore possa sempre indovinare un testo, ritrovare un libro, intuire unaltro, figure dellintegrit. I gesti della scrittura che hanno ceduto alle seduzionidella citazione, consegnano in realt al lettore un testo cosparso di cicatrici,segni evidenti delle amputazioni, dei prelievi e degli innesti, delle cuciture ap-portate al corpo del testo originario 23. E proprio dallispezione del corpo diquel testo, delle sue ferite, pu aver inizio la lettura, una lettura a ritrosoche attraverso il travaglio della memoria guadagna (e disperde) dal meno (ildiscorso della citazione) il pi (il supposto testo originario). Muovendo dallacitazione, scrittura della brevitas, la lettura si fa esorbitante: dovendo questul-tima ricostruire per cicatricem il libro grande a partire dal libro piccolo, il testoprimo dalle sue emorragie.
Valgano per noi come esempio di una operazione di riduzione/violenzadel/sul testo (per effetto della censura) le parole di Accetto:
Ha un anno chera questo trattato tre volte pi di quanto ora si vede, e ci noto a molti; e sio avessi voluto pi differire il darlo alla stampa, sarebbe statavia di ridurla in nulla, per le continue ferite da distruggerlo pi chemendarlo. Siconosceranno le cicatrici da ogni buon giudizio, e sar scusato nel far uscire il
qui dsagrge le texte et dtache du contexte, pp. 18-19. E alla memoria, lo sappiamo daQuintiliano, si trasmettono meglio proprio i testi frantumati, sbriciolati, sui quali abbiamoavuto la possibilit di sostare, ritornare, ripetendo il gesto della lettura.
23 Nellambito di una grammatica della citazione, il testo poetico, al contrario del te-sto scientifico o giuridico, quando integra elementi testuali precostituiti tende ad alterarli, atrasformarne la struttura superficiale o profonda. Le deviazioni prodotte al livello di super-ficie possono essere addizioni, sottrazioni, sostituzioni, permutazioni e ripetizioni, e coin-volgere segmenti linguistici come fonemi, morfemi, sintagmi. A livello della sua strutturaintertestuale profonda, la struttura del senso, la citazione letteraria pu ammettere diversedimensioni di significanza interrelate o dialoganti, come direbbe Bachtin (nella scelta diun titolo, ad esempio, ci si pu riferire in maniera esplicita, letteralmente, al contenuto in-terno dellopera e, nel contempo, alludere o parafrasarne unaltra, caricando quel titolo di unsenso addizionale), con lo scopo di creare un accumulo di significati, ambiguit, polisemia.Per una poetica della citazione cfr. H.F. Plett, The Poetics of Quotation, in J.S. Petoefi T. Olivi (a c. di), Von der verbalen Konstitution zur symbolischen Bedeutung, H. Buske, Hamburg1988, pp. 316-317. Per la tradizione classica della retorica, citare voleva dire richiamareprincipi di autorit. Nella citazione musicale, la presenza, seppure implicita, di un soggettofortemente innestato che autorizza la citazione stessa (lAutore appunto) molto pidebole rispetto a quella letteraria. Nel testo musicale il frammento della citazione deve ab-bandonare il proprio profilo di appartenenza a un mondo altro, originario, ed essere inte-grato, come dissimulato nel testo che lo ospita, perch funzioni. Cfr. P. Terni, Giorgio Man-ganelli ascoltatore maniacale, Sellerio, Palermo 2001, pp. 59 e sgg.
-
Micla Petrelli
Leitmotiv 2/2002http://www.ledonline.it/leitmotiv/
80
mio libro in questo modo, quasi esangue 24.
Attraverso un lacerto di libro, dunque, ammicca un altro libro, o meglio lamemoria di esso, non garantita nemmeno dalla pi fedele delle trascrizioni: dalmeno si scorge il pi che pur sempre un pi insufficiente, manche-vole, insoddisfatto da quel sogno di integrit originaria che sostiene ogniscrittura. Poich, scrive Borges, noi possiamo menzionare o alludere manon esprimere dal momento che ogni libro non mai uno specchio delmondo, ma una cosa aggiunta al mondo 25.
Allora accadde la rivelazione. Marino vide la rosa, come pot vederla Adamo nelParadiso, e sent che essa stava nella propria eternit e non nelle sue parole e chenoi possiamo menzionare o alludere ma non esprimere e che gli alti e superbivolumi che formavano in un angolo della sala una penombra doro non erano(come la sua vanit aveva sognato) uno specchio del mondo, ma una cosa ag-giunta al mondo 26.
Il recupero, a partire da un frammento di testo, del corpo unitario preesistenteda cui esso stato prelevato 27, recupero che nel lettore passa attraverso lefunzioni dai confini incerti e mobili dellimmaginazione, della memoria, delsogno, sembra poter prendere avvio dalle suture, le ferite si diceva, di cui il te-sto porta i segni. Ma loperazione di amputazione di cui queste sono lindizionon attribuibile solo a chi, per citare, lavora sul testo altrui, scomponendo ericombinando (lars combinatoria del citante). Anche il testo proprio, quel testocos discontinuo perch continuamente manchevole, virtualmente (perch nonancora scritto) il mio testo, quel progetto che il mio io/testo, parafrasandoOrtega y Gasset 28, il corpo di un sacrificio. La stessa cicatrice che accusa un
24 T. Accetto, op. cit., pp. 6-7. Si veda anche la nota 13 a p. 7 di S. Nigro.25 J.L. Borges, Una rosa gialla, in Lartefice, cit., p. 37.26 Ibidem.27 Tale operazione di recupero dellintegrit del sistema al quale il frammento
appartenuto operazione che nelle prassi scientifiche, archeologiche ad esempio, procedeper via di ipotesi, di tentativi che mirano a una ri-costruzione dellintero che in absentia. Inquesti casi lunit riconfigurata permette di spiegare il frammento. Nel discorso per fram-menti, quale pu dirsi la scrittura per citazioni, il testo preesistente, il referente del fram-mento-citazione, in quanto oggetto in s esiste ed reperibile, in quanto oggetto di letturache un soggetto ne ha fatto, che ne continua a fare, al contrario viene spiegato ogni volta inmaniera diversa dal frammento.
28 Vedi J. Ortega y Gasset, Carte su Velzquez e Goya, tr. it. di C. Vian, Electa, Milano1984, p. 152: Il nostro io in ogni istante quello che sentiamo dover essere nellistantesuccessivo, p. 149, e ancora: Lio si protende sullavvenire, va oltre tutto ci che gi ,oltre dunque il nostro presente, dal quale costantemente scatta verso quello che ancora
-
Il gesto della citazione
Leitmotiv 2/2002http://www.ledonline.it/leitmotiv/
81
intervento del tutto arbitrario effettuato sul corpo altrui 29 anche la tracciadella espunzione a priori, della auto-cancellazione di quello che avrebbe po-tuto essere, e non stata, scrittura propria, anche solo il movimento della miascrittura, movimento solo pensato, origliato, magari condotto sino ai limitidellintenzione, mai comunque confluito in quella serie di segni strutturata informa di parola. Il linguaggio della citazione ha verosimilmente una versionepositiva, concreta, piena, il citato, ma anche un (ris)volto negativo, una versio-ne vuota, sorda, il vuoto lasciato da una operazione di sottrazione che ha tolto,ha preferito eliminare ci che non esistito se non in un cenno, una epifania,semplicemente una parola non (ancora) scritta, una parola mai (prima) scritta.Citando laltro espongo me stesso mancante. E sulla natura delle mie parolemancanti pu valere quanto Mara Zambrano scrive a proposito delle paroledellidiota:
A volte scaturisce dalle labbra dellidiota, come se nascesse allora, una parola. Leparole dellidiota nascono. Sono parole, appunto, nate e non formate, n indiriz-zate, n, come sarebbe possibile?, pensate. Bianche parole senza peso alcunodespressione: pure parole che manifestano cose che sono evidenti a tutti. [] IlSole, il Sole 30.
Qualche volta linsistenza di un clich, di un frammento stralciato dalla quoti-dianit, una frase udita per caso durante una conversazione, la memoria preca-ria di tutto quel materiale felicemente anonimo e comune su cui nessuno trar-rebbe vantaggio a reclamare diritti di propriet, pu offrirsi alla citazione. Cita-re lanonimo, lassente, scelta di situazione ma molte volte necessit di lin-guaggio, comunque sia rimedia a quel vuoto del mio testo colmandolocon un oggetto preciso, anche se non anagraficamente identificabile: lo strap-po creatosi sulla pagina presto ricucito. Ma quella zona continua a trattenere non . Pertanto il modo di essere nel presente nostro io un costante stare venendo a luidal futuro.
29 Sulla scorta di Benveniste, secondo cui disponiamo di solito di una grande varietdi espressioni per enunciare, come si dice, la stessa idea (. Benveniste, Problemi di linguisti-ca generale, cit., II, pp. 61 e sgg.), Compagnon sottolinea come la relazione interdiscorsiva al-linterno della quale la citazione costituisce segno una relazione contingente, che pu onon pu essere. Perci, avendo la citazione carattere arbitrario, non necessario e motivato(al contrario del segno linguistico che ha natura contrattuale, necessaria e immotivata) sipu parlare, da un punto di vista logico, se non etico o politico, di un diritto e non di undovere di citare, atto libero e unilaterale del citatore. Cfr. A. Compagnon, Structureslmentaires, in op. cit, pp. 65 e sgg.
30 M. Zambrano, Spagna. Pensiero, poesia e una citt, tr. it. di F. Tentori, Vallecchi, Fi-renze 1964, p. 29.
-
Micla Petrelli
Leitmotiv 2/2002http://www.ledonline.it/leitmotiv/
82
una vibrazione, rimane un non risolto punto di incandescenza in cui il testoansima per una indecisione patita: non ho citato me stesso, non un altro. Laferita suppura. La non identificazione dellautore del citato, uno sconosciuto,uno e plurale, apparenta questo genere di soluzione a quella citazione in nega-tivo in cui a essere realmente citato non nientaltro che il gesto stesso di cita-re. Vacante di senso, distante dalle pressioni del contenuto 31, carico solo delpeso che unimpronta pu lasciare, citare un luogo comune a tutti, ma che nonappartiene a nessuno, uno sconfinamento oltre il tradizionale orizzonte delcitare letterario, molto pi prossimo a ci che si dice citare la vita 32.
Cos come latto del citare in s celebra il rito della ripetizione nellascrittura, e nel riscrivere adesca il passato (anche se solo un passato prossimo),comunque lesistente, per innestarlo sul presente, citare il luogo comune, unmotto, una sentenza, espressioni per eccellenza della ripetizione, citazione alsecondo grado e un re-citare. Il gi-detto, in questo caso diffuso e semprecontemporaneo, nel divenire testo citato acquisisce una evidenza che neutra-lizza ogni effetto anestetico generato dalluso e dallusura e, in un certo senso,si sovrespone, si esprime, si recita.
Quanto la prassi del citare possa veicolare, attraverso il gesto tuttaltroche sterile della trascrizione, i pensieri di carattere pi intimo e personale escoprire, riconoscere, affinit e idiosincrasie, la saggezza di un romanzo asuggerirlo:
In questepoca il diario dOttilia segna raramente fatti e pi spesso invece mas-sime e sentenze riferite alla vita e dalla vita ispirate. Ma poich la maggior partedi esse non pu esser frutto di riflessioni sue, probabile chella abbia trascrittoda qualche quaderno datole da altri ci che pi rispondeva al suo animo. I pen-sieri di carattere pi intimo e personale si potranno riconoscere da quel tale filorosso 33.
31 La citazione di un clich, di un proverbio, di una qualsiasi figura della ripetizione
che rinvia a un patrimonio acquisito, condiviso e somatizzato di conoscenze, affranca illettore da quei requisiti di erudizione necessari al riconoscimento del testo e dellautore acui la citazione appartiene. Certo viene meno, in questo caso, quel piacere per la riscopertadi qualcosa di conosciuto che accompagna ogni lettura in presenza di una citazione, ancorpi di una allusione.
32 Lossessione del clich ha certo trovato il suo eroe in Flaubert; se il romanzo del-lOttocento ha avuto lambizione di esporsi alla totalit del reale, anzi, di costituire il realecome totalit leggibile, dotata di senso, cos da farsi scrittura, histoire della vita stessa, Flau-bert, con il Bouvard e Pcuchet, ha riversato nella forma della totalit il linguaggio del luogocomune (la non-letteratura), rappresentando la vita stessa, ovvero il linguaggio del ro-manzo, attraverso il linguaggio delle ides reues. P. Bagni, Circostanze della letteratura: riflessidi saperi, in Studi di estetica, 23, 2001, p. 78.
33 J.W. Goethe, Le affinit elettive, tr. it. di C. Baseggio, Rizzoli, Milano 1962, p. 133.
-
Il gesto della citazione
Leitmotiv 2/2002http://www.ledonline.it/leitmotiv/
83
TRA LETTURA E SCRITTURA
Lidea di integrit del testo si nutre di una illusione di unit e unicit che illettore pu non aver mai conosciuto (non esiste affatto una lettura ogni voltauguale a se stessa, ma molti diversi e parziali ritorni a essa), e che lo scrittoreesperisce semmai sotto forma di intenzione, sogno di unit. La ripetizione,come movimento proprio del citare, dunque sempre ripetizione differente,risignificazione, in bala delle evenienze di memoria e oblio. E la citazione chesi realizza attraverso la riscrittura, il ritorno del gi letto, quasi una traduzione, effetto di una lettura che riposa su di una operazione iniziale di depredazio-ne e di appropriazione di un oggetto che la dispone al ricordo e allimita-zione 34. Ma non per questo si pu isolare la citazione in uno spazio perifericodelle attivit discorsive, credendola inoffensiva. Essa nascendo si separa, sislega, dal suo contesto di appartenenza che, da quel momento, non pi lostesso. Laver fatto di una unit di discorso citazione, e di questultima unnuovo vettore di senso, modifica la percezione del testo di origine, lo trasfor-ma, lo risveglia.
Il senso del citare non cos riducibile alle semplici, per quanto appas-sionate, operazioni di decoupage e collage 35, prassi dallapparenza seriale, reversi-bili, che presumono una conservazione dei testi (quello di provenienza ma an-che il nuovo che si sta facendo) in uno stato di inalterata verginit. La citazio-ne ha il potere di insidiare, provocare, la pagina condizionandone profonda-mente la natura, turbandone, come dire, la quiete. Mentre lo spazio del citatosembra acquisire, rispetto al contesto, un rilievo quasi scultoreo, si esponecome una sua emergenza che non vuole riassorbirsi 36, ed difficile da farrientrare, la scrittura intorno si accende, precipitano gli intenti, saltano i pro-getti: lindecisione si fa possibilit di convertire la stanchezza in ec-citazionedel dire.
Lavvento della citazione, certo, pu produrre gli effetti di una passioneche scardina lordine dei ruoli, dei livelli, delle funzioni dellenunciazione, cherimette in circolo lelemento della scrittura, limmaginazione, che smuove qual-cosa in pi della significazione. Essa riversa nel testo tutte le sollecitazioniproprie della lettura, ne riproduce persino movenze, tempi, modi. C lettura,non solo scrittura, in ogni citazione, c incontro, contatto di due identit, una
34 A. Compagnon, op. cit., p. 18.35 A. Compagnon, Ciseaux et pot colle, in op. cit.36 Condizione necessaria affinch un enunciato contenente citazione possa essere
intelleggibile lo stabilirsi di una omogeneit a diversi livelli, di una conformit, una conti-nuit tra testo citato e testo ospitante.
-
Micla Petrelli
Leitmotiv 2/2002http://www.ledonline.it/leitmotiv/
84
delle quali, quella anteriore, non ha il profilo di un convitato di pietra, di unestraneo, semmai dimora come un interlocutore accuratamente scelto, madalle mosse imprevedibili, con cui stabilire un dialogo, una relazione. Ammes-so che la citazione attecchisca.
Quando il romanzo, con tutta la straordinaria facolt di inclusioneche lo connota, ad aprirsi alla citazione, allinserzione di un altro romanzo, dialtri generi (il saggio), altri saperi (quello dellautore), allora il testo che l die-tro, sfondando la forma continua della narrazione, apre nel muro del roman-zo una finestra segreta 37.
Milan Kundera, La lentezza: un esempio di come il movimento interno diun romanzo la sua stessa ideazione, il senso pi intimo, il suo destino pos-sa dipendere dallinsistenza su di esso di un altro romanzo, dalla sua ombraquando non dalla sua concreta presenza; di come questombra possa esseredetta in forma di citazione. Il deittico di ingresso che apre le porte allaltra vo-ce, la voce di Vivant Denon, presunto autore di Senza domani, laltro romanzo(e dietro di esso intravediamo Le relazioni pericolose di Laclos, e ancor dietro ilromanzo settecentesco) che non abbandoner pi La lentezza, anzi ne diverrla ragione segreta, la rievocazione (o la finzione) di un viaggio e del suo rit-mo rallentato, il ritmo del ricordo, introdotta da: E a me viene in mente unaltro viaggio da Parigi verso un castello di campagna, il viaggio, avvenuto pidi duecento anni fa, di Madame de T. e del giovane cavaliere che laccompa-gnava 38.
Qui la citazione indiretta, lo stratagemma della rimemorazione, talesolo in un primo momento, apparente, perch la storia settecentesca narratain Senza domani, lunit della sua storia, non solo levocazione dei singoli eventi,non tarda a invadere e condizionare il testo di Kundera, a deciderne snodi nar-rativi e struttura. Nessuna concessione alleffetto-ricordo o riemersione delpassato poich tutto, in questo romanzo, come in ogni testo citante, pre-sente e simultaneo e obbedisce a una unica legge: laltrove qui, il gi letto,scritto, ora. Kundera sceglie dunque di accordare la tonalit del suo romanzoa quella di Senza domani attraverso una forma di citazione integrale e continua.Se a risultare infastidita da tale procedimento la cosiddetta unit dazione dellastoria, di certo il campo delle possibilit del romanzo come forma risulta libe-rato 39.
37 Le citazioni sono tutte tratte da M. Kundera, Larte del romanzo, tr. it. di E. Marchi,Adelphi, Milano 1986, pp. 96 e 125.
38 M. Kundera, La lentezza, tr. it. di E. Marchi, Adelphi, Milano 2001, p. 12.39 La storia del romanzo ha preso la strada che sappiamo. Avrebbe anche potuto
prenderne unaltra. La forma del romanzo libert pressoch illimitata. Nel corso della sua
-
Il gesto della citazione
Leitmotiv 2/2002http://www.ledonline.it/leitmotiv/
85
Il racconto di Denon subito citato da Kundera attraverso lenunciazionesintetica e lanalisi della sua trama, agir come una profezia per il futuro delsuo romanzo. Trama pi volte ripetuta, riscritta a tranches, come a voler crea-re una sorta di interpunzione ritmata del testo: ripetizione (della citazione)della ripetizione (quella interna al citare), re-citazione, figura di una riscritturadi secondo grado. La trama del racconto di Denon, la sua struttura tripartita, laconversazione che decide degli eventi, funzionano da modello, rappresentanolimpianto topografico per lintero romanzo di Kundera. Il racconto lo percor-re pervasivamente, non vi allusione. Il citato, in questo caso, il suo contestodi appartenenza, non conosce gli effetti della disaffezione al testo da cui pro-viene, disaffezione dovuta al trauma dellasportazione, del distacco, alla ferita.Di fatto Kundera che convoca (cita) Denon. Ma alla fine leggiamo La lentez-za interamente nei tempi e secondo la razionalit che presiede alla logica diSenza domani.
Sono chiari gli indizi che segnalano la funzione nientaffatto parassitariadel racconto settecentesco rispetto a quello novecentesco. InnanzituttoVivant Denon non ha mai reclamato la propriet artistica del racconto; [] ildestino di questo racconto assomiglia dunque curiosamente alla storia che es-so narra: rimase avvolto nella penombra del segreto, della discrezione, dellafinzione, dellanonimato 40, e ci agevola la possibilit per Kundera di lasciarpassare con maggior scioltezza il testo di Denon nel proprio, senza lobbligodi stabilire i termini dei suoi rapporti con Denon. Ripensare a ( questaloccasione che conduce a Denon), ritornare ai luoghi del suo racconto, allemosse dei suoi protagonisti, mette in gioco la memoria, fattore che in ogniprassi di citazione si insinua tra desiderio e possibilit stessa di rievocare men-tre si sta riscrivendo. Si ripensa in questo caso non alla realt, a eventi ap-partenuti al passato, non si cita la realt, bens un altro testo, dal suo interno 41.Ricordare il racconto di Denon, le sue situazioni, rievocare la messa in scenadi Madame de T., possibile in virt della trasportabilit al presente della storia, il romanzo non ne ha approfittato. Ha perso loccasione di questa libert. M. Kun-dera, Dialogo sullarte della composizione, in La lentezza, cit, p. 122.
40 Ivi, p. 46.41 Nella citazione poetica, secondo Plett, a differenza della citazione autorevole, eru-
dita o ornamentale, lautore non si rivolge a un immediato confronto con la realt ma solocon lo specchio della realt. Il testo letterario con una alta frequenza di citazioni porta a unparadosso: la realt della letteratura fatta di letteratura letteratura. Lo dimostra il casodella citazione nella citazione in un testo letterario, dove la realt della finzione per trevolte sottratta alla realt fattuale. Es.: realt (r)
-
Micla Petrelli
Leitmotiv 2/2002http://www.ledonline.it/leitmotiv/
86
scrittura di La lentezza: il presente indicativo il tempo verbale in cui Kunderaaccoglie il citato, avvicinando il passato fino ad assottigliare le distanze e aneutralizzare ogni effetto prospettico.
La conversazione non un modo di riempire il tempo, tuttaltro: ciche organizza il tempo, che lo governa e impone leggi che vanno rispettate 42.Lo stesso potrebbe dirsi di questo stile del citare del romanzo moderno, inquanto la conversazione testuale che la citazione in simili occasioni instaura anchessa fatta dellorchestrazione di tempi, di tensioni e peripezie, sospen-sioni e precipitazioni. Purch i silenzi siano banditi e la memoria non taccia.La riflessione quando entra a far parte del corpo del romanzo cambia essenzaperch, scrive Kundera, nel territorio del romanzo non si fanno affermazioni: il territorio del gioco e delle ipotesi. La meditazione romanzesca quindi,per essenza, interrogativa, ipotetica 43. Ma quando un romanzo a insistere suun altro romanzo nei modi della citazione, allora nessuna certezza sostitutiva(introvabile persino nella lunga serie dei romanzi gi scritti) si offre a sanare lemancanze di chi scrive, la finzione si fa lecito, necessario paradigma inventi-vo, la ripetizione diviene pi che mai internamente instabile e soggetta adaritmie; perch solo al di fuori del romanzo ognuno sicuro della sua paro-la 44.
42 M. Kundera, La lentezza, cit., p. 38.43 Ivi, p. 114.44 Ibidem.