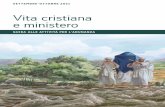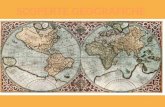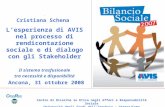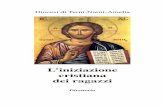CARTHAGO CRISTIANA
-
Upload
alfredo-corrao -
Category
Documents
-
view
214 -
download
1
description
Transcript of CARTHAGO CRISTIANA

"CARTHAGO CRISTIANA"
I limiti della città tardo antica nelle evidenze archeologiche
A cura di: Emanuela Livia Ranieri - Gabriella Cetorelli Schivo - Carla Termini Foto ed apparato iconografico: Alfredo Corrao Pubblicato il 30 novembre 2009

Emanuela Livia Ranieri - Gabriella Cetorelli Schivo - Carla Termini "Carthago Cristiana"
www.imagoromae.com – All Rights Reserved Pagina 2
E’ certamente compito arduo quello di definire i limiti topografici della città di Cartagine in età tardo antica, limiti che, come vedremo, sono strettamente connessi agli eventi storici, economici e culturali che caratterizzarono gli anni di decadenza dell’impero romano. Molto, in questo campo, si deve all’apporto di studi ed indagini realizzati in tal senso, negli anni passati, dalle scuole archeologiche italiane e francesi , che hanno consentito di riconoscere, nella superficie esplorata, gli ambiti della città nella ripartizione delle vestigia antiche , evidenziandone al contempo le varie fasi di urbanizzazione sia dei quartieri centrali che periferici, a partire dall’età repubblicana per poi procedere all’età classica e ancora nel tardo impero e giungere, infine, alle soglie della conquista musulmana , quando “il Dio delle vendette inviò l’Arabo per liberarci dal Romano”. Prendendo le mosse dal fallito tentativo di C. Gracco del 122 a.C. e da quello di Cesare, la nuova città di Cartagine, la colonia Julia Concordia Karthago, venne edificata al tempo di Ottaviano, nel 29 a.C., secondo un piano regolatore che è stato ricostruito anche da Saumagne e da Davin, i quali hanno individuato la città augustea nella forma di un quadrato di circa 315 ettari, il cui punto centrale si localizzava nella collina di Saint Louis, l’antica acropoli.

Emanuela Livia Ranieri - Gabriella Cetorelli Schivo - Carla Termini "Carthago Cristiana"
www.imagoromae.com – All Rights Reserved Pagina 3
Un angolo del quadrato era tagliato a nord da costruzioni che seguivano l’orientazione della colonia cesariana del 44-42 aC. I sondaggi effettuati hanno evidenziato, a più riprese, come i limiti dei campi sembrino seguire l’orientamento della centuriazione rurale ed i risultati degli scavi stratigrafici hanno dimostrato come la colonia non sembri essersi mai estesa, nel suo impianto regolare, in quest’area, sia per la sua posizione estremamente periferica, sia per ragioni morfologiche, data la natura scoscesa del terreno. Le due grandi strade assiali, cardo e decumanus maximus, si tagliavano ad angolo retto, determinando 440 insulae rettangolari di m. 148x35,50. In età cristiana l’agglomerato urbano si stendeva certamente al di là di questo nucleo catastato ed i cimiteri rinvenuti a Cartagine ci permettono di determinare i limiti della città propriamente detta. Questi limiti non dovettero allontanarsi molto dal probabile tracciato della cinta muraria elevata da Teodosio II nel 425 per proteggere la città da un eventuale attacco dei barbari. Di queste mura si sono rinvenuti alcuni tratti durante gli scavi francesi del secolo scorso, ed ancora nelle campagne di scavo ad opera di missioni polacche, inglesi, canadesi ed italiane. J. Ferron e G. Lapeyre , riprendendo una tesi dell’Audollent, hanno ritenuto che la cinta muraria partisse dal mare all’altezza di Bordj- Djedid, arrivasse ad ovest dietro le grandi cisterne di La Malga e, dopo aver cinto l’anfiteatro ed il quartiere di Duar ech-Chott, all’altezza di Le Kram, volgesse infine verso il mare. Il Picard ha peraltro ritenuto sostenere che le mura avessero inglobato anche le basiliche più frequentate di Cartagine, ed in particolare la collina di Sidi bu Said, proponendo anche in prossimità de La Marsa tracce di questa muraglia, sebbene non abbia valutato come tali basiliche, erette su aree funerarie, fossero per questa ragione situate esternamente alla città propriamente detta. Sotto i Vandali gran parte delle mura erano crollate, come ci attesta Procopio (Bell. Vand. I, XXI). Sappiamo tuttavia che Belisario, dopo la sua entrata in Cartagine, iniziò a ripararle nel 533. Secondo le testimonianze di autori antichi e studi ad esse connessi, lungo il perimetro delle mura si aprivano nove porte, la cui posizione non è dato, ad oggi, determinare ancora con esattezza.

Emanuela Livia Ranieri - Gabriella Cetorelli Schivo - Carla Termini "Carthago Cristiana"
www.imagoromae.com – All Rights Reserved Pagina 4
P. Falbe ne segnala una tra Sidi Bu Said e Bordj-Djeid presso il mare, il cardinale Lavigerie riteneva che la basilica di Damus el Marita fosse situata presso una delle antiche porte, ed infine i cimiteri di Bir Zitun e Bir el Djebbana costeggiavano una strada in cui le indagini lasciano supporre la presenza di una porta in prossimità dell’anfiteatro. Secondo la nota legge romana, che vietava la sepoltura intra moenia, i cimiteri tanto pagani che cristiani erano situati alla periferia e circondavano la città con una cintura di sepolcri, che andava dalla parte meridionale dei porti fino ai cimiteri di Bir el Djebbana, di Bir Zitun, di Kudiat-Tsalli e da qui fino alla Marsa ed a Sidi bu Said. Queste località segnano i limiti dell’agglomerato urbano al momento della massima estensione. Lo spazio cittadino nel quale si installa e si organizza, a partire dall’età costantiniana, l’istituzione cristiana , riguarda soprattutto la zona periferica a nord. In questo sito dell’antico sobborgo di Megara si estendevano le necropoli e le basiliche più importanti, il cui limite estremo occupato è segnato da una linea che parte da Kudiat Zateur e raggiunge l’estremità meridionale di Sidi bu Said.

Emanuela Livia Ranieri - Gabriella Cetorelli Schivo - Carla Termini "Carthago Cristiana"
www.imagoromae.com – All Rights Reserved Pagina 5
Ad ovest esse occupavano una superficie che va dalle grandi cisterne di La Malga e al Kudiat Tsalli, fino al terreno di Bir el Djebbana. Nelle vicinanze sono state trovate anche due importanti necropoli pagane, una del II-III secolo d.C., riservata agli officiales, schiavi affrancati del Procuratore residente a Cartagine, l’altra, a nord della precedente, risalente al II secolo d.C. A sud della città il limite estremo occupato dai sepolcreti era segnato dal Kudiat el Hobsia, non lontano dagli antichi porti. Ad est due areae situate l’una nel quartiere di Bordj-Djedid, l’altra nel quartiere di Dermech rasentavano la fascia costiera della città. La presenza di tombe bizantine nel quartiere di Dermech, all’interno della città, ci mostra come durante il VI secolo d.C. la legge che vietava di seppellire all’interno delle mura urbiche fosse ormai caduta in disuso. Così i fedeli si facevano deporre all’ interno della basilica e dei monasteri che occupavano questo quartiere, sotto la protezione dei martiri venerati, come S. Stefano ed i Sette Monaci di Gafsa. Già a partire dal secondo quarto del V secolo, con l’occupazione vandala, si cominciava infatti ad assistere ai primi abbandoni dei quartieri periferici che circondavano la città. C. Lepelley sottolinea come prime cause di questo incipiente declino cittadino fossero da attribuirsi all’espropriazione ed al conseguente esilio dell’aristocrazia voluti da Genserico. La presenza di una fossa comune addossata alle mura teodosiane, in prossimità de La Malga, sta ad indicare il disinteresse nella manutenzione di queste fortificazioni, come confermato anche da Procopio, (Bell. Vand., III-XXI, 11-12) il quale ricorda che parte delle fortificazioni erano crollate durante l’occupazione vandala e che al momento della conquista bizantina la città era accessibile da più parti. In tale periodo vi è una defezione quasi generalizzata dai quartieri suburbani, segnata dall’abbandono delle necropoli fuori le mura e dalla conseguente invasione di sepolture all’interno della città, vista l’ampia possibilità di seppellire intra moenia. Le sepolture datate alla fine del VI inizi VII secolo rinvenute durante le campagne di scavo delle scuole canadese ed italiana sull’altopiano dell’Odeon e a La Malga provano infatti che in questo periodo la città, ormai alla decadenza ed alla vigilia delle prime invasioni arabe, si restringeva sempre di più verso il centro ed i suoi abitanti utilizzavano come cimiteri gli spazi abbandonati all’interno di essa. Anche nei quartieri a sud le sepolture sono disposte senza un ordine apparente e possono essere considerate come l’inizio di un rimaneggiamento avvenuto nella topografia della Cartagine del VI-VII secolo, al momento in cui la città si ridusse a semplice borgo. Le tracce di questo sconvolgimento si possono intravvedere anche in altri punti all’interno delle mura teodosiane: sepolture cristiane sono disseminate presso il teatro, mentre sulla collina di Giunone frammenti di epitaffi cristiani testimoniano anche qui la presenza di sepolture. Pertanto, dopo la fase di massimo splendore, che coincide con il secolo IV, quando Cartagine era la maggior espressione cristiana dell’Africa romanizzata, la città tende a poco a poco a restringersi e le deposizioni al di fuori delle mura cessano, allorché si comincia a seppellire, per i motivi già addotti, all’interno di esse. Le cause dello spopolamento, con il concentrarsi della vita urbana intorno la collina di Byrsa, devono essere viste in rapporto alle vicende politiche ed economiche che caratterizzarono la storia di Cartagine negli ultimi anni della sua vita.

Emanuela Livia Ranieri - Gabriella Cetorelli Schivo - Carla Termini "Carthago Cristiana"
www.imagoromae.com – All Rights Reserved Pagina 6
Le frequenti incursioni delle tribù dei Mori, le cruente rivolte militari di cui fu, a più riprese, teatro la città, la peste degli anni 542-543, che dimezzò il numero degli abitanti portando ad una situazione di distruzione e rovina anche dal punto di vista economico e commerciale, da ultimo le invasioni musulmane cui seguì l’abbandono della città anche da parte di numerosi membri del clero, posero drammaticamente fine alla sua espansione, il cui declino, individuato anche nella corruzione dei costumi, era evidente, come ricorda Salviano di Marsiglia, già dalla metà del V sec.d.C : “Mentre le armi dei Barbari sferragliano attorno alle sue mura, la comunità cristiana di Cartagine si trastulla, ridendo nei circhi e nei teatri. All’esterno una parte della popolazione è prigioniera dei nemici, all’interno dei vizi”. Emanuela Livia Ranieri[1] - Gabriella Cetorelli Schivo[2] - Carla Termini[3] [1] Ministero dell’ Istruzione, Università e Ricerca [2] Ministero per i Beni e le Attività Culturali [3] Sovraintendenza ai BB.CC. Comune di Roma
“...forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti,
e che tutta questa tristezza in realtà non è mai esistita…”
a Nunzio

Emanuela Livia Ranieri - Gabriella Cetorelli Schivo - Carla Termini "Carthago Cristiana"
www.imagoromae.com – All Rights Reserved Pagina 7

Emanuela Livia Ranieri - Gabriella Cetorelli Schivo - Carla Termini "Carthago Cristiana"
www.imagoromae.com – All Rights Reserved Pagina 8
Bibliografia essenziale
A. Audollent, Carthage romaine, Paris 1910
A. Ben Abed, I Vandali a Cartagine, Roma e i barbari:la nascita di un
nuovo impero, Catalogo della mostra, Milano 2008, pagg. 331-333
S.Bullo, Provincia Africa: le città e il territorio dalla caduta di Cartagine
a Nerone, Roma 2002
P. Davin, Études sur la cadastation de la Colonia Julia Carthago, dans
Revue Tunisiénne I, Tunis 1930
P. Donati Giacomini , M. L. Uberti, Fra Cartagine e Roma, I Seminario
di studi italo-tunisini, Bologna 2002
P. Donati Giacomini, M. L. Uberti, Fra Cartagine e Roma, II Seminario
di studi italo-tunisini, Faenza 2003
L. Ennabli, Carthage. Une métropole chrétienne du IV à la fin du VII
siècle, in Ėtudes d’Antiquités Africaines par CNRS Editions, Tunis 1997
C.T.Falbe, Recherche sur l’emplacement de Carthage, Paris 1983
G.Lapeire et alii, Carthage latin et chrétienne, Paris 1960
C.Lepelley, Les cités de l’Afrique romaine au Bas Empire, Paris 1979
S. Mazzarino. La fine del mondo antico, Milano 2002
G.Picard, Carthage. Rapport sur l’archéologie romaine en Tunisie, in
B.A.C.H.T. Paris 1948 ss.

Emanuela Livia Ranieri - Gabriella Cetorelli Schivo - Carla Termini "Carthago Cristiana"
www.imagoromae.com – All Rights Reserved Pagina 9
Procopio di Cesarea, De Bello Vandalico, in J. Haury, Bibliotheca Teubneriana I, Lipsiae 1905
E.L. Ranieri, Tipologia delle areae cimiteriali cristiane a Cartagine, Roma 1985
Salviano di Marsiglia, De Gubernatione Dei, in J. P. Migne, Patrologia latina, LIII, Parigi 1844 ss.
C. Saumagne, Colonia Julia Karthago, in B.A.C.H.T, Paris 1924
G. Zecchini, Cesare e il “mos maiorum”, Stuttgart 2001, pagg.137-145
Cartagine, 1 shekel e mezzo (?), 270-264 a. C. ca. D/ Testa di Tanit a d., con collana, orecchino a pendente, corona di spighe.
R/ Cavallo retrospiciente, a d. AV; mm 24; gr 12,45
(da http://monetaoro.unicatt.it/)
Questo/a contenuto è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons