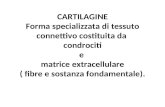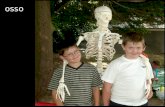Capitolo 1:Le Metalloproteasi della Matrice Extracellulare ... · Fig.1: Struttura della proMMP-2....
Transcript of Capitolo 1:Le Metalloproteasi della Matrice Extracellulare ... · Fig.1: Struttura della proMMP-2....

Capitolo 1:Le Metalloproteasi della Matrice Extracellulare. (MMPs)
1.1. Introduzione.
Le Metalloproteasi di matrice, conosciute anche come Matrixine, sono una famiglia di enzimi
strutturalmente correlati caratterizzati dal fatto di presentare al loro interno degli ioni Zinco.
L'attività di tali enzimi consiste nella degradazione di vari componenti della matrice extracellulare,
ruolo che comporta il loro coinvolgimento in processi fisiologici di sviluppo, rimodellamento,
omeostasi della matrice extracellulare e riparazione tissutale.
In virtù dell'importanza dei processi a cui prendono parte, la loro attività è strettamente regolata in
condizioni fisiologiche normali; alterazioni nell'attività regolatoria comportano l'insorgenza di stati
patologici di varia natura.
1.2. La Famiglia delle MMPs.
1.2.1. Generalità e classificazione.
Una delle prime osservazioni sulle MMPs fu fatta nel 19491, quando furono descritte come enzimi
depolimerizzanti che avrebbero potuto facilitare la crescita di tumori rendendo più fluido lo stroma
del tessuto connettivo.
Negli anni a seguire vari enzimi, appartenenti a tale famiglia, furono isolati e parzialmente purificati,
ma fu solo nel 1985 che si rese evidente l'omologia strutturale tra alcuni degli enzimi identificati
che vennero quindi raccolti in uno specifico gruppo.
Ad oggi si contano più di 24 MMPs conosciute e, per la maggior parte, sono state spesso
classificate in base alla loro specificità per un dato substrato.

Si parla infatti di gelatinasi, collagenasi, stromelisine, metalloelastasi, matrilisine e membrane- type
MMPs. (Tab. 1)
Appartengono alla classe delle Gelatinasi la gelatinasi A (MMP-2) e la gelatinasi B (MMP-9),
enzimi in grado di degradare il collagene di tipo IV della membrana basale come anche proteine
quali la fibronectina e la laminina.
Alla classe delle collagenasi appartengono invece la MMP-1, MMP-8, MMP-13 e MMP-18 una
collagenasi non presente nell'uomo, mentre tra le stromelisine si trovano la MMP-3 o stromelisina-1,
la MMP-10 o stromelisina-2 e la MMP-11 o stromelisina-3.
Infine troviamo la matrilisina o MMP-7, in grado di degradare fibronectina e laminina, la
metalloelastasi MMP-12, enzima relativamente non specifico poiché in grado di degradare vari tipi
di substrato tra cui l'elastina, e le MMPs membrane-type, o MT-MMPs, caratterizzate dall'avere un
dominio transmembrana che permette loro di rimanere ancorate alla membrana cellulare.
Queste ultime sono in grado di degradare vari tipi di substrati tra cui il collagene (MMP-14, MMP-
15, MMP-16, MMP-17).
Oltre a tale classificazione è possibile suddividere le MMPs in due grandi categorie: MMPs secrete
(collagenasi, gelatinasi, stromelisine e matrilisine) e MMPs legate alla membrana o membrane-type
MMPs.

Tab.1: Composizione strutturale delle varie MMPs.2
1.2.2. Struttura delle MMPs.
La struttura generale della MMPs è tipicamente costituita da:
- una sequenza segnale ammino-terminale (peptide segnale), appartenente ad un propeptide di circa
80 amminoacidi che possiede un frammento altamente conservato con una cisteina mutata avente
un gruppo tiolico in grado di interagire con lo Zinco del sito attivo;
- un dominio catalitico di circa 170 amminoacidi contenente lo Zinco catalitico;
- un linker peptidico di lunghezza variabile;
- un dominio emopexinico costituito da circa 200 amminoacidi che sembra avere importanza per il
legame con il substrato e con gli inibitori endogeni tissutali (Fig. 1).

Fig.1: Struttura della proMMP-2. E' possibile notare le rappresentazioni del dominio catalitico, dove le sfere di colore
blu rappresentano gli ioni Ca e le sfere di colore verde i due atomi di Zn, e del dominio emopexinico.2
A tale regola generale troviamo varie eccezioni come nel caso delle MMP-7 (Matrilisina-1), MMP-
26 (Matrilisina-2) e MMP-23, poiché queste mancano del linker peptidico e del dominio
emopexinico.
Altre differenze si trovano nelle MT-MMPs3, che presentano un linker transmembrana, un dominio
transmembrana che attraversa la membrana citoplasmatica verso il citoplasma e un dominio
citoplasmatico (MMP-14, MMP-15, MMP-16 e MMP-24) o nel caso delle MMP-17 e MMP-25, un
linker transmembrana legato a una sequenza "glicosilfosfatidilinositolica" che le ancora alla
membrana cellulare.

All'interno del dominio catalitico delle MMPs si trovano due atomi di Zinco di cui solo uno ha
attività catalitica e da uno a tre ioni Calcio che garantiscono stabilità all'enzima.
Lo Zinco catalitico ha la caratteristica di coordinare tre residui di istidina presenti all'interno della
sequenza altamente conservata -VAAHEXGHXXGXXH- del dominio catalitico, mentre lo Zinco
strutturale si trova legato da tre residui di istidina e un residuo di acido aspartico.
Oltre allo Zinco e al Calcio, il dominio catalitico presenta anche un residuo di Metionina che crea
una porzione idrofobica intorno allo Zinco catalitico.
Affiancate allo Zinco, all'interno del sito catalitico si osservano delle tasche di vario genere a cui è
stato dato il nome di S3, S2, S1 e S1', S2' e S3' posizionate rispettivamente alla sinistra e alla destra
dello ione4.
Tra queste la tasca S1' (Tasca di specificità)è quella che si differenzia maggiormente nelle varie
MMPs (Fig. 2), sia per quanto riguarda la composizione amminoacidica, sia per la sua profondità.
a) b) c)
Fig.2: Rappresentazione della superficie della tasca S1' a) nella MMP-7 ,superficiale, b) nella MMP-8, intermedia e c)
nella MMP-3, profonda.4
Nel caso delle MMP-1 e MMP-7, la tasca S1' è piuttosto superficiale, mentre nelle MMP-2, MMP-8
e MMP-9 S1' risulta avere una profondità intermedia, infine nelle MMP-3, MMP-11, MMP-12,
MMP-13, MMP-14 assume la forma di un canale molto profondo.
E’ quindi possibile classificare le MMPs in base alla profondità della tasca S1' del sito catalitico.
Le tasche S2' e S3', risultano essere più superficiali.

La tasca S2' è una fessura esposta ai solventi con una preferenza per sostituenti di tipo idrofobico.
La tasca S3' si trova in una regione parzialmente esposta ai solventi e generalmente ha
composizione amminoacidica variabile nelle diverse MMPs.
A livello del dominio propeptidico si trova un'ulteriore sequenza altamente coservata -PRCGXPD-
ed il gruppo tiolico del residuo di cisteina, appartenente al propeptide, coordina lo Zinco catalitico
conferendo così a tale ione una conformazione stabile tetracoordinata che ha la funzione di garantire
la latenza, quindi l'inattività, dell'enzima bloccando l'ingresso al sito catalitico da parte dei substrati.
1.2.3. Regolazione delle MMPs.
Per questa particolare famiglia di enzimi è possibile distinguere due principali meccanismi di
regolazione:il controllo dell'espressione genica e l'attivazione della proteina.
Nel primo caso l'attivazione della trascrizione dei geni delle MMPs è indotta, a livello extracellulare,
da citochine, fattori di crescita di vario tipo, dall'interazione cellula-cellula o cellula-matrice; quindi
si ha un significativo aumento dell'espressione dell'mRNA delle MMPs in risposta a tali fattori.
La regolazione delle MMPs tramite l'attivazione è mediata da altre proteasi tra cui altre MMPs, le
quali tagliando il propeptide dell’enzima inattivo fanno si che la cisteina di questo non coordini più
lo zinco catalitico rendendolo disponibile all’interazione con il substrato (cysteine switch).
1.2.4. Meccanismo d'azione.
A seguito dell'attivazione delle MMPs tramite scissione proteolitica, lo Zinco catalitico si trova a
mantenere la sua stabilità tramite la coordinazione con una molecola d'acqua, creando così
l'ambiente ideale per consentire all'enzima di svolgere la propria attività.
Appena dopo il legame del substrato1, la molecola d'acqua che coordina con lo Zinco, legata tramite
due legami a idrogeno ad un residuo di acido glutammico, attacca il carbonio carbonilico del
substrato (Schema1), quindi dona un protone al residuo di acido glutammico che lo trasferisce
all'azoto dell'ammide da scindere.

A seguire, il residuo di acido glutammico trasferisce il rimanente protone dalla molecola d'acqua
all'azoto ammidico, permettendo la scissione del legame peptidico.
Schema 1: Rappresentazione schematica del meccanismo tramite cui avviene l'idrolisi del legame peptidico
all'interno del sito attivo delle MMPs.1
La presenza dello ione Zinco, grazie alla sua carica positiva, permette di stabilizzare la carica
negativa che si genera sul carbonile del legame peptidico da scindere.
1.2.5. Gli inibitori tissutali delle MMPs. (TIMPs)
Una volta attivate, le MMPs a livello extracellulare sono soggette ad un ulteriore controllo dovuto
alla presenza di inibitori endogeni: gli inibitori tissutali delle MMPs (TIMPs).
Tali inibitori costituiscono una famiglia di proteine omologhe (TIMP-1, TIMP-2, TIMP-3, TIMP-4),
aventi vari tipi di funzioni di cui la principale è appunto l'attività inibitoria nei confronti delle
MMPs.
I TIMPs esibiscono attività biochimiche e fisiologiche di vario tipo5, tra cui la promozione della
crescita cellulare, inibizione dell'angiogenesi e l'induzione del processo apoptotico.

Per quanto riguarda la loro struttura questi sono costituiti da un dominio ammino terminale
costituito da circa 125 aminoacidi e un dominio carbossi terminale, di dimensioni inferiori, formato
da circa 65 residui aminoacidici; ciascun dominio è stabilizzato dalla presenza di tre legami
disolfurei.
L'inibizione delle MMPs avviene tramite il legame del dominio ammino terminale del TIMP
all'enzima al livello del dominio emopexinico.(Fig.3)
Fig.3: Rappresentazione del legame dell'enzima MMP-2 con l'inibitore tissutale endogeno TIMP-2; sono poste in
evidenza la porzione N-terminale e C-terminale dell'inibitore biologico TIMP-2.6
Come per le MMPs, l'espressione dei TIMPs è soggetta a controllo in condizioni fisiologiche al fine
di mantenere l' equilibrio metabolico della matrice extracellulare.

Nel caso in cui i meccanismi di regolazione descritti per le MMPs vengano meno, o risultino alterati
a qualsiasi livello, si osserva l'insorgere e il progredire di vari disturbi quali, ad esempio, artriti,
fibrosi, ulcere croniche, nefriti e ancora, sclerosi multipla, osteoporosi, rottura della barriera
ematoencefalica con gravi conseguenze a carico del cervello e non ultimo lo sviluppo di tumori e
metastasi.
Proprio grazie all'importante ruolo da loro ricoperto e alla varietà di processi in cui sono coinvolte,
le Metalloproteasi di matrice sono state individuate come validi target per lo sviluppo di possibili
farmaci utilizzabili per la cura delle patologie sopracitate; la possibilità di inibire l'azione di tali
enzimi contrasterebbe l'evolversi dei disturbi di cui questi sono responsabili.
Gli studi condotti su questa famiglia di enzimi hanno permesso di distinguere quali tipologie di
MMPs siano realmente coinvolte nei diversi processi patologici e di dimostrare che alcune MMPs
possono svolgere funzioni di tipo protettivo in determinati stages di evoluzione di una malattia.
(Schema 2)
E' stato infatti recentemente osservato7 che la MMP-8, MMP-12 e MMP-14 hanno la capacità di
contrastare il progredire del tumore a vari livelli.
Inizialmente la ricerca di validi inibitori per tale categoria di enzimi aveva come obbiettivo la
scoperta di composti che fossero sempre più potenti; tuttavia osservazioni di questo tipo, nel tempo,
hanno spinto sempre di più la ricerca verso lo sviluppo di inibitori che fossero sufficientemente
selettivi da garantire un'azione di tipo mirato sulle MMPs strettamente coinvolte nelle patologie,
così da ottenere un effettivo vantaggio terapeutico dalla loro eventuale somministrazione.

Schema 2: Schema dei diversi ruoli che le MMPs possono avere nella cancerogenesi. Alcuni tipi di MMPs possono
avere effetti cancerogeni (MMP-1, MMP-2, MMP-7), altri hanno invece effetti anticancerogeni (MMP-8, MMP-12,
MMP-14), altri ancora hanno entrambe questi effetti (MMP-3, MMP-9).7
1.3. Inibitori sintetici delle MMPs.
Inizialmente, come potenziale terapia, fu preso in considerazione l'utilizzo di piccole molecole
naturali e di inibitori endogeni macromolecolari, quali TIMP-18 e TIMP-2
9, nei casi di patologie che
implicavano l'eccessiva attività delle MMPs.
Tuttavia le difficoltà dovute alla sintesi e all'utilizzo di queste proteine ha portato all' abbandono di
tale strada.
Il primo approccio alla scoperta di nuovi inibitori fu basato comunque sulla sintesi di derivati
peptidici che rispecchiassero la struttura del substrato naturale di tali enzimi.
Quindi si è passati alla ricerca di composti che non fossero di natura peptidica, grazie anche
all'ottenimento di informazioni strutturali precise fornite dall'analisi del complesso MMP-inibitore.

Sono molti gli inibitori delle MMPs sviluppati nel tempo, tuttavia è possibile raggrupparli in alcune
tipologie di composti aventi la caratteristica di agire sull'enzima utilizzando meccanismi diversi.
Esistono infatti inibitori in grado di andare a chelare lo Zinco catalitico grazie alla presenza di
particolari gruppi che prendono il nome di Zinc binding group (ZBG), inibitori che agiscono senza
andare ad interagire con lo ione zinco catalitico e inibitori che vanno ad interferire con il
meccanismo d'azione ( mechanism-based MMP inhibitor)
1.3.1. Inibitori delle MMPs che chelano lo zinco.
Storicamente il disegno di nuovi inibitori per le MMPs (MMPI) è stato incentrato sulla presenza di
un gruppo in grado di chelare lo ione zinco catalitico, poiché l'enzima di fatto agisce sul suo
substrato tramite un meccanismo che coinvolge tale ione.
All'interno di questa categoria di inibitori si ritrovano composti contenenti gruppi in grado di
chelare adeguatamente lo Zinco; tra questi hanno un ruolo rilevante composti contenenti acidi
idrossammici, carbossilati, tioli e acidi fosfonici.
In particolare gli acidi idrossammici, chelanti monoanionici bidentati, emergono come i gruppi
chelanti favoriti anche grazie alla notevole forza del loro legame con lo Zinco (Fig.4).
Fig.4: Rappresentazione generale del legame di un MMPI contenente un gruppo idrossammico (evidenziato dalla
cornice) con lo Zinco catalitico nel sito attivo di una MMP. I sostituenti descritti come P1', P2' e P3' rappresentano le
porzioni dell'inibitore che possono interagire con le tasche presente nel sito attivo, rispettivamente S1',S2' e S3'.10

Un fattore che contribuisce all'efficacia di questi composti è la loro capacità di instaurare legami ad
idrogeno con i residui aminoacidici vicini allo Zinco catalitico (Fig.5); in particolare il gruppo NH e
il gruppo OH deprotonato formano legami ad idrogeno con residui rispettivamente di Alanina e
Acido Glutammico all'interno del sito catalitico.
Fig.5: Schema del legame di un inibitore contenente un gruppo idrossammico (Batimastat), all'interno del sito attivo
delle MMPs. Sono posti in evidenza i legami ad idrogeno che si formano tra il gruppo idrossammico e due residui
amminoacidici (Glu e Ala) situati in prossimità dello Zinco catalitico.4
A questa categoria di composti appartengono il Batimastat11
(a) e il Prinomastat12
(b) (Fig.6),
inibitori non selettivi che caratterizzano rispettivamente la prima e la seconda generazione di MMPI.
a) b)
Fig.6: a) Struttura del Batimastat; b) struttura del Prinomastat.

Vari inibitori moderatamente selettivi, contenenti gruppi idrossammici, sono stati sviluppati negli
anni seguenti (Tab.3), nella maggior parte dei casi variando i sostituenti situati nella porzione di
molecola che va ad inserirsi nella tasca S1' (porzione P1').
Modificando tale porzione della molecola, in virtù di quanto precedentemente esposto, si va ad
incrementare la selettività di un inibitore per una certa classe di MMPs poiché queste differiscono
notevolmente per forma e posizione della tasca S1'.
Un esempio è il composto 1, inibitore con buona selettività per la MMP-213
(Tab.3); l’introduzione
di un gruppo alchilico sul carbonio adiacente all’acido idrossammico consente la formazione di
interazioni idrofobiche con la regione del sito attivo in cui si trova la tasca S1, incrementando la
selettività per la MMP-2.
Altro esempio è il composto 214
, avente buona selettività nei confronti della MMP-3; al fine di
favorire la selettività della struttura è stato invertito il gruppo solfonammidico, ossia è stata invertita
la posizione dell’atomo di azoto e di zolfo rispetto al legame col gruppo idrossammico.
Questo comporta un aumento di volume nelle vicinanze del gruppo idrossammico, cosa che
migliora la selettività per la MMP-3, avente un ampio ingresso alla tasca S1’.
Per quanto riguarda il composto 315
, questo ha mostrato buona selettività per la MMP-2; la
realizzazione di analoghi N-idrossiureici (4)16
ha permesso di osservare una notevole diminuzione
della potere inibitorio.
In questi derivati l’N-idrossiurea ha la capacità di adottare la conformazione trans per il legame
ammidico e tale conformazione permette l’instaurarsi di legami ad idrogeno all’interno dello stesso
ZBG, compromettendo così la capacità di chelare lo ione zinco catalitico.
Nonostante rappresentino la categoria dei Zinc binding group più studiata e sebbene siano potenti
inibitori, gli acidi idrossammici risultano avere alcuni limiti.
Molti idrossammati MMPI hanno indotto reazioni muscoloscheletriche avverse4 in studi clinici,
probabilmente a causa dell'inibizione di altre metalloproteine, evidenziando così problemi di
tossicità.

STRUTTURE
Valori di IC50 ( µM )
MMP-1 MMP-2 MMP-3
1
0.147
0.00009
0.050
N
NS
O
NH
HO
O
O
OOH
2
14
0.529
0.001
CN
O
O
NHHO
3
3.3
0.032
0.057
4
>50
>120
80
Tab.3: Esempi di inibitori contenenti gruppi idrossammici.

Inoltre gli acidi idrossammici risultano avere scarsa biodisponibiltà se somministrati per via orale,
poiché possono essere metabolizzati in vario modo dal nostro organismo, evento che comporta la
loro inattivazione e quindi una diminuzione della loro efficacia.
E' anche per tale motivo che la ricerca di nuovi ZBG è divenuta un importante aspetto nello
sviluppo di nuovi inibitori delle MMPs.
Recentemente sono infatti stati descritti in letteratura una notevole quantità di Zinc binding group
alternativi all'idrossammato quali tioli, tiodiazoli, idrossipiridoni, idrossipiridintioni,
carbamoilfosfonati, gruppi β-lattamici, acidi squarici e pirimidintrioni (Tab.4), aventi caratteristiche
di chelanti monodentati, bidentati e tridentati10
.
Essendo caratterizzati da un unico legame di coordinazione con lo ione Zinco, i composti
appartenenti alla categoria dei chelanti monodentati risultano essere generalmente inibitori più
deboli se confrontati con chelanti bidentati.
All’interno di questa categoria i tioli potrebbero essere i più potenti inibitori in vitro, tuttavia si
tratta di gruppi abbastanza instabili, facilmente soggetti ad ossidazione.
Inoltre è altamente probabile che in vivo possano andare a formare legami disolfurei osservazione
che ne limita notevolmente le possibilità di utilizzo a livello clinico.
Tra i chelanti bidentati, chelanti eterociclici come gli idrossipironi, idrossipiridoni e i tioni analoghi,
si sono dimostrati potenti inibitori delle MMPs rispetto ad un acido idrossammico di riferimento10
(acido acetoidrossammico); inoltre hanno mostrato una tossicità relativamente bassa nei confronti di
una coltura cellulare pur mantenendo il loro potere inibitorio.
Tra i vari ZBG riportati si trovano anche carbamoilfosfonati, proposti come valida alternativa agli
acidi idrossammici in virtù della loro buona attività inibitoria; inoltre sembrano non essere tossici in
vivo.

Tab.4: Nella tabella sono riportati vari tipi di Zinc Binding Group e la modalità con cui questi vanno a coordinare lo
Zinco catalitico.10
Tale varietà di ligandi offre un ampio raggio di possibili affinità con il sito attivo contenente lo
Zinco, favorendo la scoperta di nuove interazioni che consentano un incremento dell'attività
inibitoria e un aumento della selettività dei composti sviluppati.(Tab.5)
Analoghi di acidi idrossammici sono stati sintetizzati a partire dall'acido squarico, con l'idea di
ottenere un inibitore che fosse particolarmente selettivo per la MMP-1. (5)17
Questo tipo di Zinc binding group è particolare poiché pur chelando lo Zinco come chelante
bidentato, si lega formando un "anello di legame" a 6 termini (Fig.7), diversamente da quanto
accade per gli acidi idrossammici che formano un anello tipico a 5 termini.
Acido squarico Acido idrossammico
Fig.7: Rappresentazioni schematiche delle modalità di legame dei due ZBG acido squarico e acido idrossammico con
lo Zinco catalitico.

Proprio tale particolarità potrebbe essere molto utile per lo sviluppo di nuovi inibitori poiché
potrebbe garantire una specifica posizione del derivato squarico all'interno delle tasche dell'enzima
leganti il substrato.
Altro gruppo di inibitori contenenti un particolare zinc binding group è quello dei pirimidin-2,4,6-
trioni. (Fig.8)
Strutture cristallizzate di tali inibitori18
con la MMP-3 e MMP-8 hanno permesso di osservare che il
legame con lo Zinco avviene grazie all'azoto in posizione 3.
Pirimidintrione
Fig.8: Rappresentazione del legame dello ione Zinco con il ZBG Pirimidintrione.
L'ossigeno carbonilico adiacente all'azoto che lega lo Zinco si trova generalmente nella forma
enolica poiché in questo modo è stabilizzato attraverso un doppio legame a idrogeno tra l'idrogeno
enolico e i due ossigeni che appartengono all'acido glutammico, situato nelle immediate vicinanze.
Sostituzioni di vario genere a livello della posizione 5 di tale zinc binding group ha consentito di
ottenere inibitori che riuscissero ad inserirsi all'interno delle tasche S1' e S2' del sito catalitico.
Esempio di questo gruppo di inibitori è il composto 619
(Tab.5), che ha dimostrato efficacia
antitumorale in vari modelli in vitro e in vivo.
Ulteriore gruppo di inibitori molto studiato è quello che presenta composti con Zinc binding group
contenenti fosforo.

Gran parte degli studi pubblicati hanno focalizzato l'attenzione sullo sviluppo di α-
bifenilsulfonilammino fosfonati, analoghi di inibitori delle MMPs noti, che contenevano come Zinc
binding group idrossammati e carbossilati.
Si è osservato che nella struttura cristallizzata del composto 720
(Tab.5) all'interno della MMP-8,
utilizzata come modello, lo zinco viene legato da tale tipologia di chelanti tramite i due ossigeni del
gruppo fosfonico.
Inoltre, andando a valutare l'attività dell'enantiomero del composto 7, è stato possibile notare che lo
stereoisomero R mostrava interazioni migliori tra il gruppo isopropilico e i residui amminoacidici
all'interno della tasca S1' e consentiva di penetrare maggiormente all'interno di tale tasca.
Sulla base dei risultati ottenuti in seguito a questo studio è stato possibile giungere alla sintesi di un
potente inibitore (8)20
che presenta notevole selettività per la MMP-8.

Valori di IC50 µM
STRUTTURA MMP-1 MMP-2 MMP-8
5
15
_
_
6
16
0.01
0.015
7
_
0.005
0.0006
8
0.160
0.02
0.0011
Tab.5: Esempi di MMPI contenenti vari ZBGs.

1.3.2. Inibitori non leganti lo Zinco.
La strategia alla base di questo tipo di approccio allo sviluppo di nuovi inibitori riguarda la
possibilità di andare a migliorare la selettività dei composti proprio eliminando la capacità di legare
lo Zinco catalitico.(Fig.9)
Minimizzando o eliminando tale interazione è possibile andare a valutare e quindi incrementare altri
tipi di interazioni all'interno del sito catalitico.
Di fatto tutti i composti appartenenti a questa tipologia di inibitori21
sembrano dimostrare una
notevole selettività per un unico tipo di MMP (es. MMP-13), promettendo buoni risultati
nell'utilizzo terapeutico.
a) b)
Fig.9: a) Rappresentazione dell'inibitore all'interno del sito catalitico: sono in evidenza i residui amminoacidici
all'interno della tasca S1' che formano legami ad idrogeno con l'inibitore; lo ione catalitico Zn è rappresentato come una
sfera color porpora. b) Esempio di inibitore delle MMPs che agisce non chelando lo Zinco catalitico.4

1.3.3. Mechanism-Based MMP Inhibitor.
Il primo inibitore per le MMPs appartenente alla categoria dei Mechanism-based inhibitor è stato
l'SB-3CT22
(Tab.6)
Questo inibitore va a legarsi a livello del sito attivo, formando un legame covalente a seguito
dell'attivazione dell'enzima; il legame covalente che si genera impedisce la dissociazione
dell'inibitore a causa di meccanismi di tipo competitivo, cosa che permette di utilizzare minori
quantità di inibitore per ottenere la saturazione dell'enzima. (Schema 4).
Lo scheletro di tale molecola è un difeniletere, porzione comune a molti inibitori delle MMPs
appartenenti a varie categorie; l'anello tiranico consente all'inibitore di coordinare con lo Zinco
catalitico tramite l'atomo di Zolfo.
L'SB-3CT è un inibitore selettivo della MMP-2 e MMP-9 e sembra promettere buoni risultati, a
livello pre-clinico, per l'inibizione della formazione di metastasi nel tumore alla prostata e come
cura per prevenire i danni causati da ischemia cerebrale.
Valori di Ki (µM)
STRUTTURE MMP-1 MMP-2 MMP-3 MMP-7 MMP-9 MMP-14
SB-3CT
73
0.028
4
67
0.400
0.110
Tab.6: Esempio di Mechanism-based inhibitor.
Come mostrato nello schema (schema 4), l'inibitore ha la capacità di promuovere la formazione di
un legame covalente con il gruppo carbossilico dell'acido glutammico presente all'interno del sito
catalitico in prossimità dello ione Zinco, legame che comporta il blocco della normale attività
enzimatica

Schema 4: Rappresentazione schematica del meccanismo con cui il Mechanism-based MMPI SB-3CT agisce;
L'attacco nucleofilo da parte del residuo di Acido Glutammico consente l'apertura dell'anello tiranico e la successiva
formazione del legame covalente.4