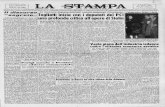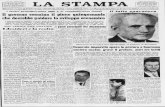Bruno Trentln e Antonio Plzzlnato AUTONOMIA E...
Transcript of Bruno Trentln e Antonio Plzzlnato AUTONOMIA E...
ITALIA
Bruno Trentln e Antonio Plzzlnato
II primo intervento del nuovo segretario generale
AUTONOMIAE PROGETTO
di Bruno Trentin
Le linee per la ricostruzione dell'identità politicae sindacale della Cgil nel discorso al direttivo confederale
N on voglio nascondere che so-no animato da sentimentimolto contrastanti nel mo-
mento in cui accetto la proposta del-la segreteria della Cgil, sentimentimolto contrastanti anche perché esi-ste in me la volontà di dedicare tuttele energie che conservo al lavoro cheattende tutti noi: la ricostruzionepiena di una trasparente identità
politica e sindacale della Cgil, in pri-mo luogo di fronte ai lavoratori chevogliamo rappresentare, e la tessitu-ra di un nuovo rapporto di ricerca,di confronto e solidarietà nel gruppodirigente di cjuesta organizzazione.Dobbiamo affrontare con maggiorerigore e audacia i problemi ineditidella condizione e dei diritti delledonne e degli uomini che lavorano
in un rapporto di subalternità, inuna fase di sconvolgente trasforma-zione degli assetti economici e socialie degli stessi valori di questa società.Nello stesso tempo non mancano inme i dubbi sulla capacità di reggerea una prova così complessa. Unaprova che richiede la massima aper-tura alla comprensione del nuovo,del diverso; modestia di fronte a sug-
Nuova Rassegna Sindacale 14 TI. .$'} del 12 dicembre 19R8
gestioni che sembrano contraddireconvinzioni sedimentate; rispettopieno del pluralismo delle opzioni edelle proposte. Una prova che ri-chiede insieme una capacità di svol-ta nel breve periodo; intendo non so-lo di decisione pratica, ma di orien-tamento trasparente, di condottaoperativa conseguente con rigorosacoerenza. Anche perché avverto co-me, da molti anni a questa parte, laprassi del sindacato, e non solo dellaCgil, sia andata spesso indirezioni diverse e si sia di-laniata tra giuramenticonservatori e pragmati-smo senza princìpi.Voglio dire ancora che av-verto questa mia scelta co-me un fatto personalmentedoloroso perché essa av-viene dopo l'amara deci-sione di Antonio Pizzina-to. Una decisione che hasanzionato anche un miopersonale fallimento e,credo, un giudizio di ina-deguatezza che coinvolgel'intero gruppo dirigentedella Cgil.
Io penso che Antonio ab-bia commesso anche deglierrori nella sua esperienzadi direzione. E chi non liavrebbe commessi? Erroriche forse, in alcuni casi, hanno potu-to involontariamente contribuire aesasperare più che a liberare la do-manda di cambiamento che ci inve-ste tutti. Ma sono anche convintoche la sua personale — e ne sono si-curo del tutto contingente — espe-rienza sfortunata non ha dietro unoscuro complotto, come scrive anco-ra qualcuno, o il bisogno dell'orga-nizzazione di praticare un rito sacri-ficale per esorcizzare la nostra inca-pacità di cogliere i fasti del decisioni-smo modernista, ma l'accumularsidi un malessere e di una sorta di crisidi identità che, nell'ambito della cri-si generale del vecchio modello disindacato, hanno colpito in modoparticolare la Cgil nel corso dei ioanni che stanno alle nostre spalle.Antonio Pizzinato ha tentato di farei conti con questa crisi di identità,scommettendo con grande generosi-tà e senza risparmio sulla rifondazio-ne della Cgil, sulla sua capacità dirimettersi in questione senza fare —forse — tutti i conti con gli errori del
ITALIApassato. Le ambiguità, e doppiezze,le forme di burocratizzazione chehanno inquinato lo stesso processo diformazione delle decisioni in questianni, lo hanno così esposto — più diogni altro, non è un paradosso a benvedere —, a una reazione critica cheinvestiva responsabilità precedentialle sue e che coinvolgeva noi tutti,come gruppo dirigente della Cgil.Voglio ribadire la mia convinzioneche Antonio Pizzinato, proprio per
II nuovo segretario generale
UNA VITA NELLA CGIL
Bruno Trentin nasce il 9 dicembre del 1926 in Francia.Dal 1941 al 1945 partecipa ai movimenti di resistenza inFrancia e in Italia. Nel 1944 è comandante di una briga-ta partigiana delle formazioni di Giustizia e Libertà.Sino al 1946 milita nel Partito d'Azione. Nel 1950 siiscrive al Partito comunista italiano, di cui è membro delComitato centrale dal i960 sino al 1973, quando si di-mette per motivi di incompatibilità con le sue responsa-bilità nel sindacato. Deputato al Parlamento nazionaledal 1962 al 1966, cessa l'attività parlamentare sempreper motivi di incompatibilità.Dal 1949 lavora all'ufficio Studi economici della Cgil.Nel 1958 è eletto vice segretario della Cgil. Nel 1962 vie-ne eletto segretario generale della Fiom e poi della Fede-razione unitaria dei metalmeccanici (Firn). Nel 1977viene eletto segretario confederale della Cgil.È laureato in giurisprudenza a Padova. •
queste ragioni, è ancora un patrimo-nio prezioso per questa organizza-zione, è una forza utile e necessariaal suo rinnovamento. Difendo, quin-di, la proposta avanzata da Ottavia-no Del Turco (la permanenza nellasegreteria, ndr) in tutta la sua porta-ta e nel suo preciso significato.Credo che possa essere di qualcheutilità, almeno per chiarire lo statod'animo con il quale assumo questaresponsabilità, affrontare fin da que-sto intervento un problema che nonabbiamo lasciato alle nostre spalle,che non abbiamo superato: fare iconti — farli fino in fondo — conquello che ho chiamato il rischio diuna crisi di identità della Cgil, venu-ta a maturazione nell'ultimo decen-nio, un pericolo che si è andato pre-cisando negli anni più recenti mal-grado il fatto che la Cgil abbia avutoil grande merito di cimentarsi con laquestione generale della crisi del sin-dacato e, in alcuni momenti, comenell'ultimo suo Congresso nazionale,cogliendo alcuni elementi fonda-
mentali per indicare anche le primelinee di recupero.Ereditiamo un periodo difficile nelquale le trasfomazioni oggettive esoggettive dell'universo che rappre-sentiamo, o che tentiamo di rappre-sentare — il mondo del lavoro su-bordinato con tutte le sue crescentidiversità — si sono intrecciate conerrori e soprattutto con esitazioni econtraddizioni nostre, le quali han-no messo duramente alla prova la
credibilità di un sindacali-smo dei diritti e della soli-darietà.È con questi errori, conqueste contraddizioni, conqueste esitazioni che dob-biamo fare i conti se vo-gliamo dare credibilità,innanzitutto di fronte anoi stessi, alla nostra ricer-ca, alle nostre proposte, al-la richiesta di fiducia cherivolgiamo ai lavoratorisulla trasparenza e la se-rietà dei nostri intenti.Solo con gli anni si è venu-to precisando il tentativodi un fronte composito diinteressi imprenditoriali eanche di burocrazie ope-ranti nell'amministrazionedello Stato, di configurarenei fatti un nuovo tipo di
compromesso sociale in questo pae-se, dopo che la sorta di compromessosociale che si era venuta instaurandoverso la metà degli anni sessanta,sotto l'egemonia di un nuovo ciclo dilotte sindacali - - nuovo anche dalpunto di vista qualitativo, dei suoicontenuti — era stato travolto daigiganteschi processi di ristruttura-zione e di riconversione e dai muta-menti repentini nella stessa composi-zione sociale e culturale, anagrafica,sessuale del mondo del lavoro dipen-dente, così come era stato travoltodall'impotenza propositiva dei sin-dacati e delle forze di sinistra.Si tratta di un nuovo tipo di com-promesso sociale ed è forse la primavolta che parti rilevanti di forze pa-dronali sono protagoniste di unaproposta di questo genere che oggiappare più definita nei suoi obietti-vi, nei suoi confini e che, abbando-nando le velleità reazionarie che nonsono mancate in passato di liquidarela forma sindacato, intende però mo-dificare drasticamente le frontie-
\uova Rassegna Sindacale n- 43 del r 2 dicembre 198R
ITALIA
II momento della votazione che ha sancito all'unanimità l'elezione di Trentin
re della contrattazione collettiva. Sivuole occupare quella terra di nessu-no, rappresentata dalle condizioni dilavoro, dalla organizzazione del la-voro, dalla professionalità, dalla for-mazione professionale, dalla parteci-pazione dei lavoratori al governodelle trasformazioni, dalle grandi,inedite occasioni di progettualità edi sperimentazione offerte dalle nuo-ve tecnologie e dalla crisi potenzialedei sistemi tayloristici di gestionedell'impresa.È un compromesso sociale che rico-nosce il sindacato, ma che tende arespingere la contrattazione colletti-va in senso lato e quindi la stessapratica della concertazione, dellacodecisione che non ci fa pauraquando ne conosciamo gli obiettivi,le finalità e gli strumenti entro i con-fini dell'area meno garantita, menoretribuita e meno diversificata dellavoro salariato occupato. Al sinda-cato si riconoscerebbe quindi la rap-presentanza — magari anche esclu-siva e garantita — e il governo, siapure solo salariale non dell'universodelle diversità del mondo del lavoro,come noi diciamo, ma di una sola diqueste diversità.Se volete si può pensare, caricatu-rando ma non troppo l'ipotesi delprofessor Mortillaro, ad esempio, al-l'appalto di una riserva che lascereb-
be al sindacato il ruolo di una sortadi «commissario agli Affari indiani»,cooptandolo così nel ceto politico digoverno, ma scontando la sua sepa-razione radicale dall'universo molte-plice dei lavoratori subordinati, an-che di quelli meno remunerati e me-no garantiti. Una separazione chepuò diventare con il tempo culturalee umana che si tradurrebbe nel di-vorzio con le tensioni specifiche,concrete, sempre mutevoli, espresseda questa massa enorme di lavorato-ri e di cittadini.Non sottovaluto affatto i momenti ditenuta, e in alcuni casi di reattivitàpositiva, che il movimento sindacalee la Cgil hanno dimostrato di poteresprimere anche nei periodi più bui,di fronte a questa contro-offensiva ea questa che può bene definirsi unaproposta politica del grande padro-nato.Se questi momenti di grande reatti-vità e iniziativa non ci fossero stati, epenso alla grande battaglia sul fiscoche ancora continua, non saremmoqui a discutere dell'avvenire di unaorganizzazione di quasi 5 milioni diiscritti.Ma come non riconoscere che vi fu,di fronte a queste trasfomazioni pro-fonde, nella stessa cultura di gover-no delle associazioni imprenditoria-li, dei grandi apparati dello Stato,
una risposta politica povera di pro-poste alternative da parte del movi-mento sindacale?Un'incapacità sostanziale, cioè, a fardiventare senso comune tra i lavora-tori una cultura di governo delle tra-sformazioni, capace di occupare ilcampo lasciato sguarnito da vecchidiritti, vecchie certezze, vecchie con-quiste che i fatti avevano, oramai,travolto. Come non riconoscere cheil nostro è stato per molti, troppi an-ni, l'alternarsi di un massimalismodifensivo e conservatore — «la scalamobile non si tocca», la demonizza-zione della flessibilità del lavoro, laretorica dell'egualitarismo, tutti glislogan unitariamente gridati nellepiazze mentre tutto cambiava difronte alla nostra impotenza nei luo-ghi di lavoro — e di un pragmati-smo, ormai, senza linee guida, senzaprincipi rivisitati e convalidati. Co-me negare che abbiamo dato tante,troppe volte, lo spettacolo di un di-vorzio incomprensibile per i lavora-tori fra la demagogia dei proclami el'opportunismo spicciolo dell'azionedi tutela e di contrattazione.Scusatemi questo ricordo che ancorami scotta: l'assemblea unitaria diMontecatini resterà, nella storia mi-nore del sindacalismo italiano, comeil momento in cui si sprigionò unita-riamente un'orgia di massimalismo ri-
Nuova Rassegna Sindacale '2 dicembre
vendicativo, fragoroso quanto impo-tente, e come l'atto che precedette laritirata scomposta del movimentosindacale verso le battaglie sulla sca-la mobile. Lasciando così sgombroper molti anni il fronte vero delle ri-strutturazioni, delle riconversioni,del decentramento, dei diritti e dellesperanze dei lavoratori e delle lavo-ratoci in carne ed ossa.Non credo di parlare solo della Cgil,quando rievoco questo periodo e lanostra sostanziale impotenza cultu-rale e politica, ma non siamo qui perdare voti, ognuno può scegliere trala riflessione critica e l'autogratifica-zione narcisistica.Emblematica è stata, senza alcundubbio — e questa è una ferita checi portiamo dentro tutti — la vicen-da dell'accordo separato dell'84.Una vicenda nata su un confrontovoluto dalla Confindustria al qualesiamo andati senza un progetto di ri-forma della scala mobile davveroelaborato, deciso e sostenuto dagliorganismi dirigenti della Cgil, senzaun'idea di rilancio dell'iniziativa ar-ticolata del movimento sindacale, sesi escludono alcune proposte più omeno improvvisate, che hanno vis-suto soltanto un momento nel corsodelle trattative di quei mesi.Non si è colta in quella occasione,non l'abbiamo colta noi — affannatinella difesa ravvicinata di questo odi quel meccanismo della contingen-za — non credo che l'abbiano coltacon lucidità le altre organizzazioni,quella che era la questione di fondo:il tentativo di mutare in quel modoil sistema complessivo — altro che lascala mobile! — della contrattazionecollettiva. E questo, all'occorrenzaanche con un decreto legge che, san-zionando un accordo separato, face-va a pezzi tutta una cultura dellaCisl sulla autonomia contrattuale diun sindacato libero.La cosa più grave, nella Cgil, è chenon ci siamo divisi, allora, sulla ri-forma del salario e della scala mobi-le. Né, successivamente, sui pateticitentativi — possiamo ormai chia-marli così — di recuperare a poste-riori i 4 punti tagliati, sottovalutan-do l'enorme portata che ebbe invecela modifica del decreto sulla scalamobile che cancellava un sistema dicontrattazione annua della retribu-zione, il quale avrebbe certamentedeterminato un cambiamento epo-
ITALIAcale e una regressione forse irrime-diabile del sistema di relazioni indu-striali. Ci siamo invece divisi, volentio nolenti, su una logica di schiera-mento determinata dal rapporto conle altre organizzazioni o sulle valuta-zioni rispetto alla politica del gover-no in carica. Si avvia da lì — e neportiamo tutti pesanti responsabilità— un processo che vede affermarsisempre di più, anche al nostro inter-no, quella politica degli schieramen-ti che noi spesso additiamo come illimite fondamentale della culturapolitica dei partiti italiani. Una poli-tica degli schieramenti che si sganciadalla ricerca sui contenuti, dalla cul-tura sindacale, dalla ricognizionedelle trasformazioni e dei problemiinediti che esse pongono. Si avvia dalì un processo in cui le culture sinda-cai lasciano sempre più il posto adideologie di organizzazione o digruppo, ideologie intese come scato-le vuote che si possono riempire conqualsiasi contenuto.Avverto questo limite anche quandosento la possibilità che risorga fra dinoi la diatriba tra istituzione e movi-mento, tra centralizzazioni indefini-te, indeterminate e movimenti di ba-se. Tra concertazione e contrattazio-ne senza sapere su quali contenuti siconcerta, su quali contenuti si con-tratta. Avverto questo stesso rischiodi involuzione, tutta ideologica,quando si ripropone la vecchia e an-tica discussione sulla distinzione chepassa fra l'unità che vince e l'unitàche perde.
Questo è già il riflesso, a mio parere,di un processo tipico di tutti i mo-menti di crisi. Una crisi come quelladel sindacato è prima di tutto crisi dicontenuti e di cultura. Sono il pri-mato di organizzazione, il bisogno diautolegittimazione dei gruppi diri-genti o dei gruppi in genere che si ri-trovano all'interno di una grandeorganizzazione di massa a dettare lelinee di condotta e non la ricerca inmare aperto, l'assillo e la propostacapace di costruire consenso.Io penso che proprio in questo con-testo è venuto maturando non sol-tanto un vuoto di proposta, ma unvero e proprio imbarbarimento cul-turale della vita sindacale, un pres-sappochismo crescente che ha finitoper indebolire e mettere in questionele stesse capacità professionali delsindacato nella negoziazione del
nuovo. Questo in un momento in cuiinvece le stesse culture managerialiregistravano evoluzioni di grandeportata e di grande ricchezza e, con-sentitemi, anche di grande libertà diindagine, lasciando a noi, a secondadei casi, la possibilità di trastullarcicon i fondi di magazzino della cultu-ra manageriale di 30-40-50 anni fa.Eppure non sono mancati grandicontributi alla definizione di unanuova capacità progettuale del sin-dacato e della Cgil in primo luogo.Basta rievocare le nostre fatiche, lenostre sofferenze, le nostre battagliesulla riforma del salario e della scalamobile cinque anni prima degli ac-cordi che hanno spaccato il movi-mento sindacale. Basta rievocare lebattaglie e le discussioni su un nuovotipo di democrazia economica, cer-tamente imperfetto, ma che rompe-va vecchi schemi anche della Cgil,come fu la discussione intorno al pia-no di impresa. Basta ricordare glisforzi ricorrenti di darci non soloun'elaborazione ma anche proposteconcrete sui temi dell'organizzazio-ne del lavoro e quindi della ricollo-cazione radicale delle politiche ri-vendicative del sindacato, assuntecome strumento non di risarcimen-to, ma di governo delle trasforma-zioni, variabili dipendenti vere, mariferite a progetti e a compatibilitaaccettate dal sindacato.Ho ricordato gli anni non troppolontani in cui, con alle spalle studiapprofonditi, parlavamo di riformadella pubblica amministrazione, disuperamento del consociativismocorporativo che regna nella maggiorparte delle amministrazioni delloStato; di riforma e di destatalizza-zione dello Stato sociale; di politicaattiva del lavoro; di riforma dellapolitica dell'intervento straordinarioe dei sistemi di spesa; di riforma fi-scale come strumento non meramen-te distributivo, ma di governo e diorientamento delle risorse e delle lo-ro destinazioni; di diritti dei lavora-tori delle piccole imprese, dei giova-ni, delle forze emergenti. Se riflettia-mo bene, si è trattato sempre di pro-poste che hanno inciso solo margi-nalmente, salvo in parte per quantoriguarda la riforma fiscale, sulla con-dotta concreta dell'organizzazione,sull'orientamento di massa dei lavo-ratori. Si è trattato sempre di ele-menti di supporto della linea sinda-
Nuova Rassegna Sindacale »• 43 dfl 12 dicembre i<)88
ITALIA
Trentln con Ottavlano Del Turco
cale, di argomentazioni a sostegnodi una politica di schieramento incui primeggiavano il patriottismo diorganizzazione, l'intesa di verticetra i sindacati — senza mediazionetrasparente sul piano dei contenuti— la logica dello schieramento par-titico fortemente condizionata, comeè stato in questi anni, dai rapportiparlamentari tra maggioranza e op-posizione.Si tratta, quando elenco questi limi-ti, di problemi reali, ma a ben vede-re non risolvibili nell'autonomia enell'unità di un sindacato se le pro-tagoniste di un'elaborazione, diun'iniziativa unitaria anche nellaCgil, non diventano le culture sinda-cali. Se il dibattito, anche aspro, nonè libero sui contenuti e nella ricercadi un'unità che salvi sempre i valori,i princìpi fondanti delle organizza-zioni sindacali diverse, e il futuro diuna proposta, di un obiettivo, se
questo è ritenuto giusto e irrinuncia-bile. Questo vuoi dire per un sinda-cato saper volare alto, non accumu-lare dossier a sostegno di un'iniziati-va politica che poi può andare nelledirezioni più diverse rispetto al pun-to di partenza.Se non ci abituiamo a questo rispet-to per le idee, le proposte, le cultureche noi stessi abbiamo suscitato osollecitato, distruggiamo le forze vi-ve che ne sono state tra le portatrici— e penso anche alle generazioni diintellettuali vicini o militanti nelmovimento sindacale che non hannovoluto e non vogliono essere «consi-glieri del principe» ma che hannodato il loro contributo, animati dauno spirito di milizia —. Nello stessotempo conduciamo l'intero confron-to unitario in un vicolo cieco.Abbiamo bisogno, invece, di unatrasparenza del confronto unitarioche si può avere soltanto nella chia-
rezza delle diverse opzioni rivendi-cative, delle diverse culture sindacalie delle loro ragioni. Abbiamo biso-gno dell'assunzione del dissenso co-me un problema da risolvere, anchecon compromessi alla luce del sole.Abbiamo bisogno di dimostrare suquesta base una grande flessibilitàsulle quantità e sulle tattiche datoche come sindacato rivendichiamoun diritto alla coerenza sui princìpi.È così e non diversamente che si evi-tano le rotture drammatiche chespesso nelle vicende di questi annisono apparse improvvise, inspiega-bili, perché clande'stine nella loro ge-nesi e nella loro formazione. Così sievitano anche i compromessi incom-prensibili.La prova che ci attende è proprioquella di riportare al centro del di-battito politico della Cgil e quindi sene siamo capaci, se abbiamo tela datessere, anche al centro del confron-
Nuova Rassegna Sindacale 19 n. 43 del 12 dicembre 1988
to con le altre organizzazioni sinda-cali, una cultura di progetto, a par-tire dalla quale misurarci con i no-stri interlocutori sociali e con il siste-ma delle imprese. Sarà questo ilcompito della Conferenza di pro-gramma. Ma è già il nostro impe-gno, a partire da domani, se si pensaalle scadenze che ci attendono con lacontrattazione nella funzione pub-blica, alle trattative aperte nel setto-re privato su un tema come quellodei contratti di formazione-lavoro,alla necessità di dare un divenireconcreto alla grande battaglia per lariforma del sistema fiscale, per la ri-forma dello Stato sociale, per l'avviodi un nuovo corso dell'iniziativa nelMezzogiorno per l'occupazione.Non parlo evidentemente dell'accu-mularsi delle proposte che portanosoltanto alla convergenza nella con-fusione, alla quale succedono, comeè accaduto nel passato, o la diasporadevastante delle esperienze concreteo la divisione e l'impotenza. Parlo dipriorità inderogabili, una volta chesono state condivise, e quindi di pro-poste rivendicative che diventino daun certo momento in poi anche vin-coli. Si tratta di rivendicazioni cheattengono alla sfera dei diritti collet-tivi e individuali nel governo deiprocessi di riconversione della flessi-bilità del lavoro fondati sull'unità diopportunità per tutti i lavoratori di-pendenti pubblici e privati e rom-pendo le barriere che oggi dividonoqueste categorie di lavoratori: sitratti della riforma del sistema dellerelazioni contrattuali, e delle rela-zioni che in questo ambito intendia-mo valorizzare, si tratti di assumerecoerentemente tutte le implicazioniimmediatamente operative e anchequi vincolanti della scelta europea.Si tratti, infine, di definire grandiobiettivi di riforma dello Stato socia-le, di stabilire in modo non opinabilele regole della solidarietà e della rap-presentanza di un sindacato che, inquanto organizzazione confederale,più di altri è chiamato a far rispetta-re, nell'interesse generale dei lavora-tori.
Non saranno scelte indolori perchéquesti dieci anni non sono passati in-vano e perché queste scelte incide-ranno, quindi, su privilegi relativi,su prerogative acquisite dalle orga-nizzazioni, dai gruppi di interesse oanche dagli individui e soprattutto
ITALIAsulla prassi inerziale che ha guidatoper molti anni la nostra stessa espe-rienza contrattuale. Di questo c'è bi-sogno, però, se vogliamo rilanciareuna politica di rifondazione, comegrande politica, così come ci ha ri-cordato Antonio Pizzinato.Una politica di rifondazione diventagrande politica se si fonda prima ditutto su una strategia rivendicativachiara nei suoi obiettivi e nelle sue fi-nalità, su nuove forme di rappresen-tanza, di democrazia rappresentati-va, su nuove culture sindacali, piùche su una politica dei cjuadri spessocondotta da noi in termini di piccolocabotaggio e separata da questa ri-cerca di carattere più complessivo.Una politica di rifondazione è unagrande politica se approda alla defi-nizione di princìpi condivisi e di unanuova eticità del sindacato che diaragione di una scelta di vita perognuno dei suoi militanti.Abbiamo bisogno non di ideologiedi organizzazione o di un sindacatomercificato, ridotto allo spettacolodei suoi dirigenti su tutto lo spettrodei mass media, dalle interviste araffica ai café concert, ma di un'identi-tà di organizzazione per un sindaca-to come la Cgil che sia anche fonda-ta su princìpi etici e su impegni an-che morali nei confronti dei suoiiscritti e dei suoi rappresentati, iquali possono essere seriamente mes-si alla prova in tutti gli aspetti del-l'attività sindacale.Anche qui, non facciamoci illusioni:abbiamo da precisare, da meditare,da definire insieme, se non vogliamolimitarci soltanto alla retorica e allapropaganda.
Un impegno di questa natura do-vrebbe costituire lo sforzo principaledel gruppo dirigente della Cgil. Essocomporta di necessità anche la defi-nizione di regole chiare e, una voltacondivise, rigorosamente rispettatedal gruppo dirigente, in primo luo-go, dalla segreteria nazionale al Co-mitato direttivo. Parlo di tre prin-cìpi che mi sembrano fondamentali,da recuperare fino in fondo in questafase. Prima di tutto la difesa irriduci-bile, intransigente, anche all'internodei gruppi dirigenti, del pluralismopolitico e culturale della Cgil, a co-minciare dalla presenza in questaorganizzazione di componenti ditradizioni diverse. Questo plurali-smo, quello vecchio e quello nuovo,
è una ricchezza, è la condizione del-la vitalità di una organizzazione,della possibilità costante di una veri-fica critica delle decisioni dei gruppidirigenti. Quindi dobbiamo garanti-re sempre la pubblicità del dibattitoche investe le grandi opzioni strate-giche della Cgil senza scandalo, an-che quando esse esprimono dissensirilevanti. Dobbiamo abituarci cioè anon confondere mai più gli attacchialle idee con gli attacchi alle perso-ne. Nello stesso tempo abbiamo bi-sogno, con drammatica urgenza, diuna solidarietà effettiva nel momen-to delle decisioni e della loro realiz-zazione operativa, anche quandoqueste sono prese a maggioranza, sitratti di uno sciopero, di una tratta-tiva, di un accordo sindacale.L'emergere di diverse anime è solol'espressione di un'organizzazioneallo sbando, che recita a soggetto eche si governa sulla base degli umoridei suoi dirigenti: c'è bisogno di unrigore vero, ce lo chiedono i compa-gni.
Noi dobbiamo farla finita, e parlo inprimo luogo per me stesso, con ilmalcostume della fuga di notizie.Appena costituiamo una commissio-ne riservata sempre regolarmente,inflazioniamo l'afflusso di notizie aimass media e quando scompaiono lecommissioni riservate, allora cadeanche l'attenzione dei mass medianei confronti del sindacato. Dobbia-mo farla finita con i commenti diva-ricanti di fronte a una stessa decisio-ne che abbiamo assunto magari inmodo sofferto. Dobbiamo ridurre lanostra smania di protagonismo, per-ché queste cose sono avvertite daimilitanti come una mortificazioneloro e una loro personale umiliazio-ne di fronte all'organizzazione.Dobbiamo garantire sempre la pos-sibilità reale di una verifica demo-cratica, innanzitutto nell'organizza-zione, attraverso gli strumenti dellademocrazia rappresentativa, ma an-che con i lavoratori che rappresen-tiamo. La democrazia di mandatonon è una brutta parola; essa ci da,così come la democrazia rappresen-tativa, la possibilità di correggeredelle decisioni che dobbiamo pren-dere molte volte in termini di assolu-ta rapidità perché siano efficienti.Abbiamo bisogno di momenti di ve-rifica democratica che ci consentanoanche di cambiare, di adeguarci,
Nuova Rassegna Sindacale ( 'e ' l2 dicembre 19H8
L'Intervento di Trentln
senza mettere nessuno di fronte alfatto compiuto o senza porre auto-maticamente un problema di fiducianei confronti del gruppo dirigente.Per questa via saremo lenti, dimo-streremo — come è andato a spiega-re qualche dirigente sindacale inun varietà televisivo di non sa-per scegliere? Ce ne scusiamo. Chie-diamo soltanto rispetto per le ragio-ni non ignobili di questa nostra len-tezza, delle nostre cautele, perchésono ragioni che hanno origini anti-che quanto quelle della democrazia.Si potrebbe ben dire con una para-frasi «no negotiation without rapre-sentation».In questo processo di formazionedelle decisioni che intreccia demo-crazia rappresentativa e democraziadi mandato il ruolo delle componen-ti, a mio parere, è e resta fondamen-tale, e non lo si modifica con gli esor-cismi. Si tratta di un connotato ge-netico della nostra organizzazione,di un aspetto rilevante del nostropluralismo. È alla base del patto difondazione della Cgil. Scusatemil'ovvietà, ma l'unità della Cgil è laCgil. Chiunque la insidi, o la facciadecadere a precario compromesso,
opera ne deve essere consapevole— per distruggere questa Cgil. Se mieleggerete, io mi impegno — è unodei pochi impegni che mi sento di as-sumere - - a essere garante con Otta-viano Del Turco di questa unità e diquesto patrimonio.Si può pensare, certo, a un'evoluzio-ne delle componenti, possibile sol-tanto attraverso l'allentarsi delle di-scipline e delle omogeneità di orien-tamenti dettati spesso, anche se inmodo non coercitivo, da considera-zioni esterne al sindacato. Si puòpensare e si può lavorare soprattuttoall'affermarsi di una dialettica tra leculture di un sindacato di progettoche non rispetti i confini delle com-ponenti e che non si limiti a raschia-re i fondi di barile delle loro culturepassate.Se questa dialettica dell'autonomiasindacale si accompagnerà semprepiù alla consapevolezza crescente diognuno di noi di essere dirigenti ditutti gli iscritti, di tutte le anime del-la Cgil e responsabili verso tutti, an-che verso quelli nei confronti deiquali dissentiamo, allora possiamosperare che un sistema di lottizzazio-ne temperata dei gruppi dirigenti
potrà essere superato senza dar luo-go all'emergere di maggioranze piùo meno occulte o precostituite cheromperebbero, appunto, il patto diunità che la Cgil incarna.Questa prima esperienza di consul-tazione — lo ricordava OttavianoDel Turco — va nella direzione giu-sta; su questa strada nessuna compo-nente potrà accampare il monopoliodella massima responsabilità dellaConfederazione. Anche riflettendo suquesto nuovo modo di dirigere chevogliamo tentare di sperimentare,potremo forse affrontare con più faci-lità i compiti immani che ci at-tendono, in modo particolare comesegreteria e come Comitato direttivo— così come risulta dalla consulta-zione —, rivedendo la divisione deicompiti all'interno della segreteria edell'apparato confederale; immagi-nando nuove responsabilità di segre-teria anche nel quadro di un processodi rinnovamento; coinvolgendo il co-mitato direttivo nelle aree, nei di-partimenti di lavoro della Confede-razione, determinando una collegia-lità reale, ma agile, nella conduzionedelle vertenze. Togliendo, cioè, ai«ministeri» di Corso d'Italia la lottiz-
Nunva Rassegna Sindacale n. 43 del \-l dicembre l()8H
zazione delle vertenze e delle tratta-tive, realizzando un comitato esecu-tivo più efficiente e un comitato di-rettivo che recuperi pienamente lasua funzione di direzione politica.Potremo così con grande franchezza,ce n'è bisogno, ridefinire i confiniche segnano l'attività e la scelta diognuno di noi. Non sto parlando quidi ingegnerie istituzionali, di prero-gative, di terreni riservati a questa oa quella istituzione sindacale. Spessoun approccio di questo genere ciporta e ci ha portato a risolvere iconflitti che esistono all'interno dellaConfederazione con invasioni dicampo, ripartizioni più o meno for-zose del potere contrattuale di cuidispone la Confederazione nel suoinsieme. No, parlo di funzioni, dicompiti raccordati al patto costi-tuente della Cgil, Anche se si trattadi un patto che dobbiamo certamen-te rivisitare e precisare. Intendo direche la ragione d'essere della Confe-derazione generale italiana del lavo-ro •-• che non è e non deve essereuna federazione di strutture — èquella di garantire prima di tutto uninteresse generale riconosciuto cometale dall'insieme dei suoi iscritti edall'insieme delle sue strutture. Nonuno spazio contrattuale o un dirittodi rappresentanza, ma un interessegenerale di cui la Confederazione inprimo luogo è depositarla e garante,una volta che si è convenuto su certidiritti, su certi poteri di contratta-zione, su certe forme di solidarietàoperante che attengono a questo in-teresse generale. Di questo in primoluogo il gruppo dirigente della Cgildeve essere garante, rinunciando al-la figura spesso fastidiosa del con-trollore, dell'ispettore sulle sceltecontrattuali delle singole strutturedella Confederazione. E la difesa, laverifica di questo interesse generaleche costituisce innanzitutto il terre-no di direzione della Confederazionee dei suoi grupi dirigenti, ne defini-sce i suoi obblighi e i suoi doveri.Questo e non la contesa di spazi dicontrattazione con le categorie o lestrutture territoriali.A tale proposito c'è il problema cheavvertiamo tutti di una riforma delsistema contrattuale che va prepara-to, meditato, non improvvisato, mache rappresenta un compito urgen-te; parlo — lo ripeto ancora — del-l'individuazione delle regole nel-
ITALIAl'ambito delle quali per la Cgil an-che questo sistema di relazioni indu-striali deve collocarsi. E quando par-lo di regole intendo molte cose. In-tendo la necessità di garantire il ri-spetto delle decisioni che abbiamopreso in materia di sciopero nei pub-blici servizi, intendo la coerenza trale decisioni che prendiamo e l'impe-gno a non promuovere azioni disciopero che non siano rigorosamen-te unitarie, intendo la contrattazio-ne di diritti che noi tutti insiemeavremo riconosciuto essere diritti in-dividuali indisponibili, intendo lavalutazione in comune delle impli-cazioni generali che può avere unadeterminata rivendicazione o unadeterminata intesa per l'insieme delmovimento sindacale italiano e perl'insieme delle strutture della Confe-derazione.
Badate bene, con queste regole tra-sparenti di direzione che difendonol'interesse generale della Confedera-zione non sopprimeremo il conflittofra le diverse istanze dell'Organizza-zione. Forse ne sorgeranno di nuovi.Basta immaginare il caso, non pro-prio impossibile, in cui un'intesa sin-dacale, aziendale o di categoria, tro-vi il sostegno maggioritario dei lavo-ratori interessati e nello stesso temporappresenti una violazione di un in-teresse generale di cui la Cgil devefarsi garante. Ma diamo al conflittoil suo contenuto politico esplicito e,quindi, la possibilità di risolverlonella trasparenza; togliamo, cioè, alconflitto — anche dentro le organiz-zazioni — ogni carattere di lotta fracentri di potere o interessi categoria-li o regionali.
Infine è necessario uno sforzo di ri-definizione della nostra autonomiaprogettuale, dei princìpi fondanti,anche in termini di eticità del nostrostare insieme; un progetto che sap-pia elevarsi al di sopra dell'interessemeschino di organizzazione, o di vo-lontà di primato, potrà rendere piùcomplessa e più impegnativa la no-stra azione per l'unità rivendicativaoggi e per l'unità sindacale domani.È più facile, infatti, mediare fra ap-parati che fra diversi approcci cultu-rali e rivendicativi, ed è ben più dif-ficile in questo modo costruire dav-vero un'unità che regga. Ma se ilconfronto sarà vero, non ridotto apochi iniziati, non immeschinito inpattuizioni occulte, non solo esso ri-
sulterà più ricco e più vivificante pertutti, ma sarà anche il solo, a mioparere, suscettibile di approdare arisultati concreti, niente affatto pre-cari.Molte cose sono cambiate negliorientamenti pragmatici delle altreorganizzazioni sindacali in questianni, anche se, a mio giudizio, nonin modo così radicale dal Congressoad oggi, quando abbiamo assuntolucidamente determinate scelte. Ilconseguimento di intese unitarie,malgrado la grande esperienza rap-presentata dai rinnovi contrattualidel 1987, appare a volte più difficile,persino nel momento in cui si trattadi formulare piattaforme rivendica-tive comuni. Un nostro sforzo, unnostro impegno in tale direzione ri-chiederà una maggiore trasparenzadelle nostre posizioni di partenza,una maggiore enfasi nella nostra vo-lontà di cercare un'intesa che salvi ivalori delle organizzazioni e non leindebolisca di fronte alle contropar-ti. L'impegno che dovremmo pren-dere con noi stessi è quello di esseregli ultimi ad abbandonare un nego-ziato o la ricerca di un'intesa, di es-sere quelli che non promuoverannomai azioni di lotta che escludanoun'altra organizzazione sindacale, ameno che non si tratti di scioperarecontro un accordo separato, conclu-so contro la nostra volontà, l'impe-gno di non dare mai per concluso unconfronto sulla strategia unitariacon le altre confederazioni.Non è un'attitudine umile, questa, èla scelta responsabile che spetta inprimo luogo alla più grande orga-nizzazione sindacale italiana chenon ha paura di vincolare se stessa auna norma di condotta che ritienegiusta, anche se altri si ritengono li-beri di decidere in modo diverso oanche opposto. In questo senso pen-so ancora che con l'autonomia pro-gettuale e la democrazia sindacale,l'unità fra le organizzazioni rappre-senti sempre per noi non un mezzo,ma un valore in sé; come un valorein sé è la forza contrattuale dei lavo-ratori, impossibile senza l'unità fra isindacati, quindi un vincolo per lanostra stessa concezione di sindacatodi classe — o di solidarietà, se si pre-ferisce usare questo termine piùblando. Dico questo con molta chia-rezza, anche se ciò può dispiacere aqualcuno o essere visto come un'a-
Nuova Rassegna Sindacale n. 43 del 12 dicembre 1988
ITALIAstrattezza. Per me è una scelta di mi-lizia sindacale.Non condivido per questo le tesi re-centemente esposte da Franco Mari-ni secondo il quale quando si ritienedi essere trascinati verso l'abisso, al-lora si può «lasciare la mano» e farea meno dell'unità. Al di là delle me-tafore, che valgono quello che valgo-no, quando, non in astratto, in que-sto periodo difficile, vi sono difficoltàfra Cgil, Cisl e Uil, io domando contutta sincerità se davvero l'unità conla Cgil può portare la Cisl verso l'a-bisso, o spingere la Uil a passare leAlpi dimenticando le sue passatepassioni libiche sulle sponde del Me-diterraneo. Ottenere più formazioneper i giovani e destinare a questoscopo il denaro pubblico dei con-tratti di formazione-lavoro: è questol'abisso? Acquisire nuove possibilitàdi garantire la retribuzione all'uni-verso dei lavoratori e non solo ad al-cuni di qualche grande azienda,estendere i sistemi di informazione,di controllo sulle condizioni di lavo-ro, di formazione di professionalità,come è avvenuto alla Olivetti: è que-sto l'abisso?
Da questo punto di vista mi sento diaggiungere all'elogio fatto recente-mente da Ottaviano Del Turco allaFiom, l'elogio alla Firn e alla Uilm,che hanno saputo — durante la ver-tenza Olivetti — sormontare molteesitazioni e seguire una strada diver-sa da quella perseguita alla Fiat co-gliendone così i frutti - altro cheabisso! — insieme alla Fiom. A que-sto proposito voglio dire anche, datoche sarebbe finzione non parlarne,che va reso merito all'avversario diclasse, all'azienda, di aver saputoscegliere e volere il confronto contutte le organizzazioni sindacali, as-sumendone le conseguenze: sapendoche trattare con la Fiom voleva diretrattare il governo consensuale dellecondizioni di lavoro. Di ciò va datomerito all'intelligenza, ma anche aqualcosa di più, alla sensibilità de-mocratica di un gruppo imprendito-riale.Quali princìpi o valori fondanti ri-schia di perdere la Cisl in questi ca-si? lo credo nessuno. A meno che, edè qui una difficoltà che insidia tuttinoi, in gioco sia soltanto il primato oil privilegio di organizzazione. E,questo lo vediamo, purtroppo, inpiù di una circostanza, quando si
Antonio Plzzlnato
presenta la possibilità di migliorareun accordo preconcluso e sorgonoassurdi problemi di prestigio perun'organizzazione che riteneva ora-mai queste questioni definitivamen-te omologate. Credo, invece, che bi-sogna superare una concezione incui al primo posto vi siano i patriot-tismi, il prestigio di organizzazioneo, dio non voglia, forme di finanzia-mento del sindacato o di organisminei quali il sindacato opera, che pos-sono essere in alcuni casi esplicita-mente incentivanti della neutralitàdel sindacato nei confronti dei dirittifondamentali dei lavoratori.Insieme, di questo siamo convinti —e non è uno slogan —, se non si vin-ce, si perde sicuramente di meno; edivisi invece si perde sempre. Nessunsindacato può voler scambiare uninteresse di bottega con un sia purpiccolo miglioramento che spetta al-l'insieme dei lavoratori interessati.Vogliamo discutere di queste cosecon gli amici, con i compagni dellaCisl e della Uil nel rispetto che ab-biamo per i loro valori e nel rispettoche chiediamo loro per i nostri.Quando c'è questo rispetto recipro-co il confronto è sempre possibile edè sempre costruttivo, ne guadagna-mo tutti, anche se alla fine non citrovassimo d'accordo. Superiamo,comunque, questa immagine di rissafra sensali che troppo spesso il sinda-cato ha dato di sé di fronte all'opi-
nione pubblica e ai lavoratori.Ho sentito come un dovere di lealtàil bisogno di esprimere, da compa-gno ai compagni, lo stato d'animo,le intenzioni, forse le velleità con lequali intendo assumere questa pe-sante responsabilità. Non ho maiambito né pensato di diventare se-gretario generale della Cgil e oggisono soprattutto stati d'animo dipreoccupazione, di angoscia, quelliche mi animano. La mia ambizioneè sempre stata, e la ritengo un'ambi-zione molto grande, quella di dareun contributo alla politica e all'espe-rienza concreta di questa organizza-zione che è tutta la mia vita. Conquesta nuova responsabilità cerche-rò di continuare in tale ambizione:di dare di più e meglio, difendendole idee in cui credo, rispettando leidee degli altri, cercando quindi innome dell'unità di questa organizza-zione tutte le intese e le mediazioniche la rendano più forte, più efficacee più credibile.
Chissà che da ciò, dall'impegno ditutti noi, non scaturisca anche la ri-nascita di una concezione molto an-tica — ma quanto indispensabileoggi! —, quella della milizia sinda-cale come educazione ed emancipa-zione degli uomini. Questo nostronon è un mestiere come gli altri. Èstato nel passato e deve tornare adessere una missione e una ragione divita. •
Nuova Rassegna Sindacale n. 43 del 12 dicembre 1988