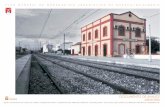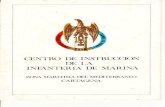Battiventu de Beveun
description
Transcript of Battiventu de Beveun

2 3
… battitesti de Carb iaga scozzacampane de Stadumè
battiventu de Beveun …
E gli altri paesi?
Ce n’era per tutti, a noi grazie al
vento non è andata poi tanto male.
Dedicato:
naturalmente a Beverone e ai beveronesi di tutti i tempi, a tutti i miei paesani, e a tutte le persone che collaborano in vari modi a tener vivo questo paese.
Ringrazio:
tutti coloro che mi hanno aiutato pazientemente a realizzare questo lavoro.
Battiventu de Beveun

4 5
Chissà perché abbiamo la testa così dura, sempre troppo tardi apprezziamo chi se lo meritava: un genitore, un fratello, un amico, la propria terra, le proprie radici. Non ci eravamo accorti di quanto erano importanti per noi, non abbiamo mai pensato di dirglielo, se potessimo tornare indietro…. Però non è mai troppo tardi cercare di apprezzarne la memoria, immaginare di riviverla, provare a scriverla, farlo sapere all’interessato, magari con una …
lettera a Beverone:
Caro Beverone è da tanto che pensavo di scriverti una lettera. Piccolo paese, tanto da chiederci: come avrai fatto a sopravvivere per secoli? Oggi, ai noi pochi rimasti, viene da pensare “mi sa che Beverone è ormai alla fine”. Ma cosa ne sappiamo, chissà quante difficoltà nel passato avranno messo a repentaglio la tua esistenza, e tu con il tuo cuore grande sei riuscito a superarle e sei andato avanti. Alcuni per dimostrarti il loro affetto ti hanno dedicato delle poesie, ed io mi vorrei unire a loro. Sai cosa ho pensato di fare? Cercherò di raccogliere dei ricordi su di te, e sulla tua gente in un libro.
“Un libro su Beverone? Non esageriamo, un libretto. Forse certe cose potranno essere già state sentite e magari in modo diverso, però … ogni paese le proprie particolarità e differenze, come per noi, ognuno la propria vita, le proprie sensazioni, i propri ricordi. Ricordi, semplici ricordi, ricevuti in eredità e da lasciare in eredità, un po’ del semplice passato di Beverone”.
So che non sarò in grado di renderti l’onore che ti meriti, e tanto meno so che non sarò esauriente negli argomenti che cercherò di narrare. Però di una cosa sono certo, lo farò con il cuore. Come hai detto? “Apprezzerai comunque il lavoro di un tuo figlio”, “lo sapevo, non avevo dubbi, non poteva essere altrimenti, grazie Beverone”. E tu chiesetta, la in alto, quando anche noi non ci saremo più, come diceva una di quelle poesie, continua a “…vegliare sui morti tuoi, sui vivi…”, e se ci verrà concesso, ogni tanto chiederemo il permesso di venirti a trovare, “quando?”, beh… naturalmente per il 29 agosto.
Battiventu de Beveun

6 7
Beverone, un po’ di storia… e di leggenda
Cosa rimarrà di questi piccoli paesi? Eppure anche se a prima vista non appare, qui fra queste povere mura ci sono secoli di storia e tradizioni. Per come si viveva fino ai primi anni '50 si può dire che il legame con il passato continuava ad esistere. Usi, tradizioni, leggende, insomma tutto un bagaglio di memorie tramandate a voce, mentre si mieteva il grano o si “scarfogliava” il granoturco, durante le veglie d'inverno al focolare e in molte altre occasioni.
La fine degli anni ‘50 e l'inizio degli anni ‘60 hanno portato delle trasformazioni enormi: boom economico, tv, emigrazione, i paesi hanno incominciato a spopolarsi, si è persa la consuetudine di tramandarsi usi e tradizioni a voce, i bambini non imparano più i dialetti, diversi da paese a paese. Purtroppo fra poco non ci sarà più nemmeno quel paio di generazioni "cuscinetto" di collegamento col passato, ed è proprio nello spirito di rispetto verso i nostri vecchi che è nata l'idea di raccogliere quanto più è possibile, che valga da piccolo ricordo per quanto è stato fatto, un tentativo di fare in modo che non tutto sia dimenticato.
Tanti sono i piccoli tasselli, storia e leggenda si intrecciano, e poi chi lo sa quante leggende non siano storia anch'esse. Tanti i racconti tramandati, alcuni brevi scritti, occorre cercare, chiedere ai pochi anziani rimasti, mettere tutto assieme il più ordinatamente possibile.
Dove potrebbe incominciare la storia di Beverone? La conformazione del suo territorio e la posizione strategica, fanno supporre che avesse i requisiti necessari affinché vi potessero abitare gli antichi li-guri, migliaia di anni fa. Magari un giorno si troveranno le tracce di un “ca-stellaro”, il loro insediamento tipico. Scavate nella roccia sono ancora visibili le sagome di piccole casupole. Chissà se appartengono a quei periodi o seguenti.
La storia dice che gli spostamenti dei romani, agli inizi della loro espansione, avvenivano sui crinali, onde evitare agguati a cui si era più esposti quando si percorrevano vie più comode a valle, ma anche più peri-colose. Ecco la necessità di fare sorvegliare dalle alture che offrivano maggior visibilità le vallate, predisponendo dei fortilizi con delle piccole guarnigioni che segnalassero il pericolo al grosso dei movimenti che così avvenivano in modo più veloce a valle. Uno di questi percorsi di crinale molto probabilmente passava da Beverone e proseguiva verso Brugnato passando dal Montenero. Nei pressi dell’attuale cimitero, sotto una roccia dal fico di Zelantognu, vi era una sorgente a cui venivano fatti abbeverare i
cavalli, e da qui pare nasca il nome Beverone. Fino a pochi anni fa questa sorgente c’era ancora, poi da quando non ci sono più state pecore mucche e pastori, non è stata più tenuta pulita, e magari l’acqua c’è ancora, ma la vena si sarà affondata sotto terra.
Se potessero parlare questi sentieri! Quante storie da raccontare … gli antichi liguri … forse anche i celti, in una sorta di convivenza pacifica non dominante, compito poi della storia dire se erano solo ipotesi … i romani … secoli dopo i pellegrini dei grandi pellegrinaggi, difatti qui passava una diramazione che portava alla via francigena. Naturalmente poi tutto il movimento locale, non secoli, millenni.
Non si conosce la data in cui venne costruita la chiesa. La memoria popolare dice che assieme a quelle di Bocchignola e Montedivalli fossero le più vecchie del circondario. Purtroppo non sono mai stati fatti degli studi approfonditi. C’è un’ipotesi per cui pare che sia stata costruita sulle mura di un antico fortilizio di cui sarebbero ancora visibili tratti delle mura esterne. Osservando l'architettura interna, a due navate come sono le più antiche chiese liguri, appare costruita in due epoche diverse. In uno scritto del 1825 circa si legge: "Questa sotto il titolo di S. Gio: Batta Decollato è stata consacrata, ma non esiste memoria alcuna del tempo o epoca di consacrazione, e neppure della fondazione o fondatori di essa".
Battiventu de Beveun Battiventu de Beveun

8 9
Se si era persa già in quel periodo questa memoria così importante, vien da pen-sare che di tempo ne fosse passato parecchio.
La memoria dei vecchi dice che Beverone prima era dalla "chiesa", e che dalla casa di Parenti, uno dei cognomi co-nosciuti più antichi, dicono si sentisse il prete mentre cele-brava la messa, quindi questa casa doveva essere abbastanza vicina alla chiesa. Questa memoria dice pure che Gar-bugliaga era alla "Vile", quella ampia vallata a circa un chilo-metro da Beverone, ricca di ac-
qua e dei più grandi campi del luogo, dove sono ancora delle rovine di case vecchie ed una strada che porta all'attuale Garbugliaga. Il legame fra le comunità di Beverone e Garbugliaga ha certamente delle radici molto lon-tane, ne è di prova il fatto che erano parrocchia comune fino agli inizi del '900, quindi vien da pensare che ancor prima di essere parrocchia comune vi fosse una certa relazione, e per prima si intende già da prima del 1600, ma prima quanto?
Per quanto il paese possa essere stato piccolo, sembra certo fosse in cima al monte, ma non sappiamo quando si sia trasferito e perché in quello attuale, anche se un periodo si potrebbe ipotizzare, magari aiutati da opportune ricerche e scavi. Pare che dal monte, un giorno se ne staccò una bella fetta, che risparmiò l'area dove è ora la chiesa. A quel punto visto il pericolo gli abitanti si sarebbero trasferiti più in basso, cioè dove ora. Nella parte ipoteticamente franata per anni si sono viste delle vigne che disperatamente cercavano di sopravvivere, quindi vuol dire che vi era colti-vato. Questo fatto che anticamente il monte sia parzialmente franato, è stato raccontato anche da qualche anziano del sottostante paese di Cava-nella, da cui si ha un’ottima visione proprio del lato in questione.
Ogni paese ha le sue leggende, ecco una delle nostre, che pochi ormai conoscono: quella del "Dügu". Perché dimenticarla?
Quando il paese era ancora sul monte della chiesa, ogni tanto vi faceva le sue scorrerie un animale dotato di grandi ali e artigli: era il“Dügu” e portava via i bambini. Per questo decisero di costruire il paese più in basso, meno esposto alle sue incursioni. Quanto è leggenda o re-altà? Intanto pare che questo animale facesse delle sortite anche oltre Be-verone, quindi vien da pensare: o che tutti i genitori col tempo si fossero tramandati questa leggenda per far sì che i più grandi prestassero atten-zione ai fratellini, o che qualcosa di volante dovesse esserci per davvero. Per quanto riguarda la leggenda, era conosciuto il grifo o grifone, un ani-male favoloso mezzo aquila e mezzo leone, fra l'altro simbolo di Genova, magari un parente del nostro Dügu. Nella realtà si poteva trattare del gri-fone vero, un rapace che in tempi passati esisteva in Val di Vara, guarda caso è solito costruire il suo nido in grotte e sulle rocce, e all'aspetto è più pauroso e un po’ più grande di un'aquila.
In tempi più recenti un cacciatore ha raccontato di averlo visto, ma non solo, gli ha pure sparato, però non è riuscito a colpirlo. Anche qui ri-mane un po’ di dubbio, conoscendo il cacciatore un po’ burlone, sarà stato vero o avrà voluto far la sua parte per tener viva la leggenda?
Battiventu de BeveunBattiventu de Beveun

10 11
Come in un film
Per noi beveronesi sarebbe bello vedere, come in un film, la storia del nostro paese fin dalle sue origini, storia più o meno simile e a volte comune ai tanti paesi del circondario. Piccole comunità con origine lontane, molto lontane, costrette per necessità ad escogitare sempre nuove strategie di sopravvivenza, per i lunghi periodi di clima avverso, con danni a boschi e culture, e conseguenti anni di carestia. Invasioni di lupi, peste che ciclicamente faceva la sua comparsa, il vaiolo, ed ogni sorta di malattia contro cui non sapevano come combattere, e chissà quante altre ne avranno passate. Questi fatti sono avvenuti, sono storia. Non è certamente la storia di un ieri vicino. Ma a noi beveronesi cosa rimane di quel passato?
Il nostro è un periodo di enormi cambiamenti, e in particolare per questi piccoli paesi, il dopoguerra incominciando dagli anni ’60 ha portato degli stravolgimenti tali da perdere il collegamento con il passato. Partendo proprio da tutto ciò che si è visto finire in quegli anni, si può cercare di ricordare un po’ di questo passato, senza aver la pretesa di riuscire a fare un resoconto completo, e volere o potere dare una collocazione nel tempo di quando possa essere iniziato ciò che “sembrerebbe finito”. E comunque nulla finisce in modo così definitivo che non ne resti traccia, e quelle che restano, se le sapremo conservare, sono e saranno preziose.
La prime case di Beverone, pur non potendone dare una datazione certa, sono antecedenti al 1600. Erano costruite utilizzando un cemento detto “cauzina”. Si otteneva facendo in cumulo di pietre di colore chiaro, alternando uno strato di legna ad uno strato di pietre, lasciando un vuoto all’interno in cui si accendeva il fuoco, si copriva il tutto di terra come una carbonaia in modo che il calore non si disperdesse. Il sistema era molto rudimentale, ma funzionava. A cottura avvenuta queste pietre diventavano morbide e facilmente triturabili. Ci sono ancora dei luoghi a cui è rimasto il nome dal fatto che vi si cuocevano le pietre, che è fornace “Furnasa”. Potrà sembrare strano, ma l’impasto di questa cauzina con la sabbia presa nel luogo in cui tutti la prendevano dopo averla scavata e setacciata, non a caso chiamato “Sabbiùn”, era di buona qualità. Tratti di pavimenti, intonaci e volti sono arrivati fino a noi, mentre intonaci e gettate, anche di poche decine di anni fa si sono deteriorati rapidamente. Per coprire i tetti venivano usate le “ iappe”, piastre di pietra grigia, che si andavano a prendere vicino a Veppo nei pressi del “Castè”, oppure in un luogo verso “er canà der muin” detto dagli ulivi “dar iuive”. Le aveva preparate la natura, l’uomo con il suo ingegno si doveva preoccupare di estrarle senza ridurle in pezzi
troppo piccoli. Si utilizzavano così come uscivano dalla cava, non erano state segate o squadrate. Stava all’esperienza del copritetto “ iappazzu”combinarle fra di loro in modo che non piovesse in casa. I tetti coperti in questo modo avevano un peso enorme, almeno dieci volte che con le attuali tegole, ed enormi erano anche le travi che le reggevano. Ad esclusione del seccadue le cui pareti venivano pitturate di nero direttamente dal fumo, per gli altri ambienti quando si pitturavano si usava la calce, con una pennellessa rotonda, che oltre alla calce lasciava sulle pareti i suoi lunghi peli, ma non ci faceva caso nessuno, non era tempo di finezze. Dicevano che la calce disinfettava e magari era anche vero, ma a ben pensarci una finezza c’era, si usava fare nella parte bassa delle pareti lo zoccoletto “zucculettu”, una striscia scura alta un palmo. Questo colore scuro si otteneva mischiando alla calce la terra d’ombra “a terra d’umbra”. Andavano a prenderla nel solo posto in cui se ne conosceva l’esistenza, che è vicino alla “Valle”. La parte visibile della vena da cui si estraeva a mano la poca terra d’ombra che serviva, era una piccola buca di mezzo metro, chissà come avranno fatto a scoprirla. A Beverone c’era anche il caolino, come certamente era da molte altre parti, però questo che era sotto alla “Pena” nel luogo detto “l’Aetta”doveva avere delle buone caratteristiche tanto che fu acquistato dalla società Richard Ginori. Il terreno prima era di proprietà della chiesa, gli acquirenti lasciarono il diritto di prendere la legna, e poi non presero nemmeno il caolino. Pur non sapendo che era caolino, chissà da quanto tempo i beveronesi usavano quella terra per fare i “testi” che servivano per cuocere i testaroli di farina di grano “panigazzi”, le focaccette di granturco “fügazzette”, e i castagnacci di farina di castagne per i quali sia sopra che sotto, al contatto dei testi, si metteva uno strato di foglie di castagno “castignazzi”. Usavano mischiare la terra de “l’Aetta” con un po’ di terra “da Fauza”, che era molto più vicina a Beverone, ma se usata da sola molto più scadente. Questo non per fare meno fatica, ma avevano scoperto che questo miscuglio rendeva i testi meno fragili. I testi così ottenuti erano di buona qualità, ed alcuni beveronesi andavano a venderli anche in paesi distanti parecchi chilometri.
Battiventu de BeveunBattiventu de Beveun

12 13
Le varie autosuff ic ienze
Fra i primi posti delle necessità dell’uomo c’è quella del mangiare, e per cercare di soddisfarla per secoli nei nostri posti è andata così, allevamento di bestiame e coltivazione dei campi con raccolta dei loro vari prodotti. Era cosa comune, però colpisce l’enorme quantitativo di campi che quella gente doveva coltivare. Dovuto in parte alla bassa resa dovuta all’altitudine, in parte alla composizione del terreno dei campi ricavati in tutti i luoghi possibili, e non sempre particolarmente fertili, in parte alle sementi impiegate, non ancora selezionate come qualità e come terreno in cui essere poi adoperate, peraltro con i pro e contro. Oggi questi campi sono tornati ad essere boschi, però si intravedono ancora le forme ed i terrazzamenti. Era un’agricoltura che si basava sulle esperienze tramandate. Il susseguirsi dei diversi lavori, dalle semine ai raccolti, alle potature, alla conservazione dei prodotti, quasi mai degli accavallamenti. Una natura con il suo calendario incredibilmente organizzato, evidentemente non un caso. Come promemoria per le varie attività il riferimento non era quella tale data, ma il santo corrispondente, era più intuitivo. Si era capito che l’alternanza delle culture faceva si che i terreni non si impoverissero, come succede nelle attuali culture intensive, che danno rese molto superiori, ma richiedono un uso notevole di concimi con conseguenze a volte negative. Oggi noi possiamo solo intuire lontanamente il dramma vissuto dai nostri antenati, quando a seguito di condizioni
climatiche sfavorevoli, interi raccolti andavano perduti, ed ancora peggio se gli eventi si ripetevano l’anno seguente. Ogni periodo i suoi problemi, e ciò che a noi oggi appare in-sormontabile “una volta” era pane quotidiano. I tempi cam-biano e chissà cosa diranno del periodo in cui viviamo noi in fu-turo.
Raggiunto lo scopo del mangiare, e non era poco, occorreva essere autosufficienti in una gran quantità di attività, o al massimo ci si rivolgeva alle
vicine comunità, nel caso di alcuni lavori particolarmente specialistici. L’arte di arrangiarsi non era un merito, era una necessità.
Veniva filata la lana di pecora, con cui poi venivano fatte maglie, maglioni e calze. Sembra di vedere ancora quelle abili e veloci dita che tiravano il filo da quel ciuffo di lana posto sopra una canna “ruca”, come un grosso stecco di zucchero filato, che poi finiva arrotolato nel fuso “füsu”, fatto girare velocemente per ritorcere il filo.
Per le scarpe ci si rivolgeva al calzolaio “scarpau”. Non tutti i paesi avevano uno scarpau, allora si andava nel paese dove se ne trovava uno, ci si faceva prendere la misura, poi si tornava a lavoro ultimato. Non c’era molta scelta, il modello era unico, robusti scarponi “scarpùn”. Necessariamente e possibilmente dovevano durare a lungo, e prima di farne un paio nuovo, venivano riparati più volte. Per aumentare la resistenza all’usura e quindi la durata, si piantavano dei chiodi “brucchette”a testa tonda sotto le suole. E come si sentiva quel trichettio di “brucchette
nel selciato del paese, il susseguirsi dei passi: trac, trac, trac, e poi … traaac: c’era stata una scivolata su un sasso, bloccata dal sasso
Battiventu de Beveun Battiventu de Beveun

14 15
successivo, e dall’abitudine di chi camminava all’uso delle brucchette. Cosa avrebbero dovuto dire quando camminavano scalzi, e la suola era la pelle indurita? Giusto per dare l’idea, un riccio di castagna non si voleva aprire? Zac, una calcagnata, e via; altri tempi.
Ogni tanto passava un falegname un po’ particolare, costruiva le seggiole “careghe”, direttamente sul posto, il sedile era impagliato con paglia di segale. Per chi ne aveva la possibilità un po’ di lusso: seggiole un po’ più grosse, con dei braccioli, quasi delle poltrone “caregun”.
Passava anche un altro artigiano che faceva varie riparazioni che a noi oggi potrebbero far un po’ ridere, ma anche un po’ riflettere. Riparava i piatti e le zuppiere in cui si mangiava, bloccandoli con graffette di fil di ferro, setacci per la farina, manici delle pentole ed altre povere cose.
Per vanghe falcini accette e altro “vanghe, fauzìn següe e atru”c’era il fabbro, ed era a “Furnu”, un piccolo gruppo di case poco sopra Garbugliaga. Dopo anni sono stati ritrovati nei boschi dei vecchi falcini, è stato rifatto nuovo il loro manico in legno, puliti e riaffilati. Erano forgiati bene, e come si dice “tenevano il taglio”.
Per trasportare i vari prodotti della campagna si adoperavano delle ceste costruite intrecciando delle strisce “scudese” di legno di castagno, ed era già un’arte riuscire a ricavarle dai giovani polloni di questo albero. Quelle che portavano gli uomini “corbe” erano più profonde e quindi capienti delle “pagnee”portate dalle donne. Gli uomini portavano la corba sul collo, e vi frapponevano il “pa etu”, una vecchia giacca arrotolata in modo particolare. Le donne portavano le pagnee, come tutto il resto che dovevano portare, sopra la testa, ed arrotolavano un vecchio straccio “varcu”per cercare di limitare i danni. C’erano vari momenti di vita in comune fra le varie famiglie, in cui ci si scambiavano le giornate: quando si scartocciava il mais,
per la battitura del grano e delle castagne, e per la vendemmia. Erano momenti felici, se si era arrivati a quel punto voleva dire che si chiudeva un ciclo, e più o meno bene un raccolto c’era stato.
Un ricordo particolare va alla battitura del grano. Siccome i grandi prima sono stati bambini, per tutti il ricordo va ai salti nei grossi mucchi di paglia, quando la trebbiatura era finita. A quel brulichio di persone che si davano da fare attorno alla “macchina”, le fascine di grano da portare sul ripiano da cui il “macchinista”, sopra di un alto sgabello, le infilava dentro il “cilindro”. Raccogliere il grano pulito nel grosso secchio di ferro e poi metterlo nei sacchi. Spostare con il forcone la paglia del grano trebbiato che usciva dalla “macchina” sospinta da un ingegnoso sistema che la faceva saltellare, era un giorno felice anche per lei, usciva danzando. Fare attenzione alle grosse cinghie di cuoio che girando vorticosamente trasmettevano il movimento dal motore alle varie ruote di ferro della “macchina”. Poi, quando il grano era finito, smontare tutta la “macchina” e portarla nell’aia successiva per ricominciare tutto daccapo. La generazione precedente la nostra aveva usato una “macchina” le cui ruote erano fatte girare dalle braccia degli uomini, ed era faticoso, prima ancora … niente macchine, tutto a mano.
Un altro lavoro era quello dei “segantìn”. Segavano i tronchi di legno direttamente nei boschi, trasformandoli in tavole che sarebbero state usate per le varie necessità. Squadravano i tronchi con l’accetta, poi li segnavano con uno spago ricoperto di polvere colorata che veniva teso e poi pizzicato. La distanza fra i segni variava a seconda dell’uso per cui sarebbero state utilizzate le tavole e tavoloni “toe e taulùn”, ed erano la traccia da seguire dalla particolare sega tirata da due persone, i “segantìn”.
Battiventu de BeveunBattiventu de Beveun

16 17
I Pastori
…Poi sono finiti anche i pastori. Era uno dei primi mestieri che si imparava nella vita, ben prima dei dieci anni. Erano mucche pecore e rare capre, ma per come si viveva allora anche meno di dieci pecore erano una buona risorsa per la famiglia. Ogni mucca ed ogni pecora aveva il suo nome, dato principalmente dalle sue caratteristiche, il colore del manto o le corna: bisa,
biunda, mora, murela, bardeluna, pi iarda, curnela, titina, margheita,
viuletta, ma uina, campanela. Ogni mucca il suo campanello attaccato al collo, per le pecore uno per ogni gregge, ad una di quelle pecore che stanno in testa al gregge. Poteva succedere che la cinghia a cui era attaccato il campanello si rompesse, e così cadevano per terra cinghia e campanello, poi magari qualche pastore li ritrovava. E’ successo più di una volta che una pecora si sia portata a casa la sua cinghia con relativo campanello, portandoli in bocca. Fare il pastore non era un lavoro particolarmente faticoso, però si doveva aver cura dei propri animali che la sera dovevano tornare tutti a casa. Ovviamente con tutto il bestiame che vi pascolava i boschi erano molto puliti, e per i pastori erano come per noi le città, un’infinità di sentieri, piccole radure, ogni luogo aveva il proprio nome. Poteva succedere che una pecora si infilasse in qualche luogo pieno di rovi, e vi si impigliasse con la lana. La maggior parte delle volte dando degli strattoni , la pecora poteva liberarsi, ma a volte peggiorava la situazione, rimanendone imprigionata. Questo impigliarsi nei rovi era detto anrazzasse. Un’altra situazione in cui una pecora poteva rimanere imprigionata era detta ante iasse, cioè bloccata fra le rocce. In questo caso succedeva che la pecora, alla ricerca di un boccone migliore, finiva fra grotte in un angolo impervio, da cui non riusciva a trovare la via di uscita. Quando il pastore si accorgeva che la pecora mancava dal gregge, normalmente succedeva quando era l’ora di andare a casa, e tutte le bestie si radunavano, andava alla ricerca della pecora smarrita, chiamandola per nome, facendo attenzione da che direzione arrivasse il belato di risposta, se la povera bestia aveva sentito il richiamo. Ogni tanto passavano dei mercanti di bestiame, gente scaltra che sul bestiame di chi era intenzionato a vendere riuscivano a trovare dei difetti anche quando non c’erano. Se dopo trattative più o meno lunghe, fatte di tira e molla , ognuno per il proprio interesse, si arrivava a concordare un prezzo, il contratto era stipulato da una stretta di mano, era come carta bollata. Ai pastori spettava una piccola mancia sulla vendita del bestiame che loro avevano pascolato, si chiamava “benediga”. Ora sono ridiventate boschi anche quelle zone che l’uomo
aveva ripulito trasformandole in pascoli, invase prima dai rovi poi pian piano dagli alberi. La natura si è ripresa e rimodificato, seguendo un proprio disegno, ciò che l’uomo aveva preso in prestito e usato per le sue necessità. Potrebbe sembrare anonima la vita di un pastore, però anche per chi non lo ha fatto per tutta la vita è una esperienza incredibile. Il grande contatto con la natura, i propri animali a volte mansueti ed ubbidienti, a volte testardi e cocciuti, i vari animali del bosco, quante cose belle e quante tristi, una miriade di aneddoti, per esempio quello del “cucü”. Quando arrivava la primavera faceva sentire il suo verso il cuculo,“er cucü”. C’era l’usanza che i pastori lo interrogassero su quanto sarebbe stata lunga la loro vita, come se il pennuto avesse avuto questo potere. Ecco come occorreva comportarsi: quando si sentiva in lontananza il cuculo fare il suo verso, gli si domandava a gran voce e con una certa cantilena “cucü daa barba bianca, quanti ani a campu anca?” che significa “cuculo dalla barba bianca, quanti anni vivrò ancora?” Terminata la domanda si contava quante il volte il volatile emetteva il suo cu-cu, ed era la risposta. Capitava che il cuculo, forse troppo vicino ed impaurito dalla voce umana, faceva un verso strano e volava via, oppure comunque non soddisfaceva le aspettative del richiedente. Allora la sua risposta non veniva presa in considerazione e si rimandava la domanda ad un nuovo profeta. Quante storie potrebbero ancora raccontarci, però ora non ci sono più i pastori…
Battiventu de Beveun Battiventu de Beveun

18 19
La fontana
All’inizio degli anni ’60 a Beverone si arrivava solo a piedi, e mancava pure l’acquedotto. Fu in quel periodo che si mossero i primi passi per realizzare questi due progetti. Pochi anni prima un paesano mi chiese se avessi preferito avere prima la strada o l’acquedotto, giusto per dar l’idea dell’importanza che potesse avere anche un solo rubinetto nel paese, perché? Perché prima si andava alla “Funtana”. La Funtana si raggiunge percorrendo una stradina in discesa, circa quattrocento passi, lì c’è una sorgente e di fianco una vasca in cui si lavavano i panni. Sul bordo di questa vasca sono poste delle lastre di pietra inclinate verso la vasca, su cui le donne sfregavano i panni, d’estate e d’inverno, ma allora avevano altre mani. Tutti lavavano i panni nella stessa vasca, poi eventualmente si potevano sciacquare con l’acqua pulita della sorgente. I bordi delle pietre di arenaria venivano usati all’occorrenza anche per ravvivare il filo di falci e falcini, e in quei punti si vedono ancora i segni a forma di conchetta. L’acqua si portava in secchi di ferro zincati, e le donne li portavano in testa. Portavano tutto in testa, mazzi di legna, ceste “pagnee” piene dei vari prodotti della campagna, mettevano fra la testa ed il secchio il varcu, uno straccio arrotolato come una ciambella. Gli uomini ne portavano due, agganciati per il manico alle estremità di un bastone, dove erano stati praticati due scassi, “er bastùn” un legno ricurvo, e si portava su una spalla. I secchi erano pieni fino all’orlo, la stradina che portava al paese fra scalini ed irregolarità varie poteva far ondeggiare le persone e far traboccare l’acqua dai secchi, ma questi ondeggiamenti venivano assecondati da movimenti del corpo dettati dalla grande abitudine, e l’acqua se ne stava tutta nei secchi.
Nelle case questi secchi si tenevano in un luogo possibilmente fresco, e quel punto veniva detto daa se ia. Ad un secchio era agganciato un mescolino con il quale si prendeva l’acqua da bere dal secchio, tutti. La sorgente della funtana era una buona sorgente, non calava in estate ed era
molto fresca, al punto che mettendovi sotto un braccio non si riusciva a tenercelo per molto. L’acqua usciva da una canala di arenaria, cadeva in una vaschetta sempre
di arenaria, e da questa finiva nella vasca, er bozzu.
Un ricordo deve andare anche alla fontanella della Valle che però già in primavera seccava. Anche alla Penac’era una piccola sorgente Funtanellama d’estate si ridu-ceva ad un filo, e comunque per lavare i panni bisognava andare nel bozzu alla fontana.
Chi va oggi alla fontana, magari d’estate per prendere un po’ d’acqua fresca, può avere l’impressione di un luogo anonimo senza storia, ma chissà quante gioie o pene, confidenze o pettegolezzi si saranno scambiate le donne mentre lavavano i panni, chissà quante persone avranno percorso questa stradina in secoli di andarivieni, noi non possiamo nemmeno immaginarlo.
In tempi recenti un paesano si trovava a passare dalla fontana. Con la coda dell’occhio quasi in modo inconsapevole percepì che qualcosa non andava: la vaschetta di arenaria non c’era più. Superato lo sbalordimento iniziale si rese conto che era stata portata via facendola strusciare per quelli che un giorno erano campi e poggi. Seguì questa impronta finchè arrivò a pochi metri dalla strada che porta a Stadomelli, ma qui la scia finiva, forse la vaschetta era stata sollevata e portata di peso nella strada, ma sarebbe stato più complicato che a struscio. Poi l’occhio si volta e si porta sopra un mucchietto di frasche sospetto, la vaschetta era li sotto in attesa di essere portata via in un momento più propizio. Per quel giorno i lavori nei campi potevano attendere, ora era un’altro il lavoro da fare. Via di corsa a Beverone, con il cuore in gola non si sa mai, racconto veloce del fatto. In tre con il trattore andarono a recuperare la vaschetta, che da anonima era diventata improvvisamente importante, ricordo prezioso dei nostri avi. Sarebbe stato bello essere una mosca e vedere la faccia di chi alzò le frasche scoprendo che sotto non c’era più nulla.
Battiventu de Beveun Battiventu de Beveun

20 21
Il mulino di Chilettu
Beverone ha due ruscelli da noi chiamati canali, canà du iardin e canà der Muin. Il primo prende il nome da un terreno che è vicino alla sua sorgente, al riparo dai venti e particolarmente fertile. Il secondo più ricco di affluenti, seppur piccoli e quindi di acqua, prende il nome dal fatto che vi era il mulino.
In effetti vi è memoria di un mulino anche nel “canà du iardin”detto “muin de Tumin”, però nel "canà der Muin” si parla di ben sei mulini, costruiti in periodi e luoghi diversi, anche se non molto lontani tra loro. Grosso modo il meccanismo con cui funzionavano doveva essere questo: una crocetta di legno con delle palette a forma di cucchiaio sulle estremità, la crocetta era montata nello stesso asse della macina, l’acqua sbatteva sulle palette e faceva girare crocetta e macina. Sopra c’era la macina sotto la crocetta, il cui nome in dialetto è stentaë, ed era dentro il mulino, l’acqua quindi passava all'interno del mulino. Probabilmente questo sistema non riusciva a dare un movimento costante alla macina, e magari aveva altri problemi. Giunse il momento di passare a un sistema più moderno per quei tempi, ed era quello a ruota esterna.
Per fare questo serviva una persona che avesse l’intenzione e i soldi per farlo. L’uomo era Emanuele Chioccoli “Manuelu”, aveva l’intenzione ma non i soldi. Eravamo attorno al 1850, partì e andò in America con la nave a vela, vi stette un certo periodo, guadagnò qualcosa poi tornò e si accinse a costruire il mulino. Il lavoro non era ancora terminato, però lo erano i soldi, tornò in America e ritornò. Finalmente il mulino fu terminato ed incominciò a macinare. Con tale sistema si riusciva a far girare la macina in modo più uniforme. La ruota, oltre che dare il movimento faceva anche da volano, il flusso dell’acqua che la faceva girare passava in una canala e poteva essere regolato, fra la ruota e la macina vi erano degli ingranaggi seppur rudimentali, insomma tutto l’insieme migliorava le prestazioni. Fra l’altro si riusciva a macinare anche quando la portata del canale diminuiva ad un livello critico per il vecchio sistema. Dava il suo contributo al buon funzionamento del sistema anche una piccola diga costruita di fianco al letto del ruscello, più a monte del mulino, grazie alla quale l’acqua affluiva al mulino in modo più uniforme sia che fosse scarsa che se fosse troppo abbondante, il rebuccu. Per portare l’acqua dal rebuccu al mulino, era stato costruito un canaletto con pendenza costante, il biedu.
Dopo Manuelu vi lavorò il fratello Achille “Chilettu”, ed è da lui che il mulino prese il nome che pare vi misero quelli di Stadomelli. Questo mulino aveva delle buone macine, in special modo per le castagne era il migliore della zona. Oltre che Beverone vi facevano ricorso anche Garbugliaga e Stadomelli.
I quintali da macinare erano veramente molti, per mesi lavorava anche di notte, e bisognava stare all’erta che tutto procedesse regolar-mente. Ogni tanto occorreva ravvivare la macina ed il ceppo con la pic-chetta, in pratica si rendeva il tutto ruvido al punto giusto. Se si rompeva o logorava qualche parte, era quasi tutto in legno, bisognava ripararla alla svelta. C’era da tener pulito il biedu che portava l’acqua dal rebuccu alla ruota, ogni tanto una ripulita bisognava darla anche al rebuccu, insomma non c’era da annoiarsi. Dicevano che la distanza da Beverone fosse circa tre chilometri, forse era un po’ meno, ma non rappresentava un grosso pro-blema poiché a quei tempi la gente era abituata a camminare, in ogni modo al ritorno la salita non era male. L’ultimo mugnaio fu Moretti Emilio“Miliettu”, aiutato anche dal figlio Francu. Cessò di macinare attorno al 1960.
Oggi sono ancora visibili i ruderi del muin de Chilettu e anche di un altro più antico, ricoperti di razze e guzarne. I tempi cambiano è inevitabile, però alla vista di quel poco che rimane vien da pensare un po’ a quegli uomini antichi ed alla loro tenacia.
Battiventu de Beveun Battiventu de Beveun

22 23
La minie ra di manganese
Un po’ prima della Te ia da fusina c’era una cava di manganese nella quale, attorno agli anni venti si estraeva questo minerale. Il materiale estratto veniva portato via da una teleferica che passava dal Monte Nero, sul versante che guarda Stadomelli detto “Bandida”, che poi finiva il suo percorso in una frazione di Stadomelli detta “Carubbiu”. Qui dicono che vi fossero delle vasche in cui veniva lavato il materiale, che poi veniva trasportato sulla via Aurelia. Il luogo della cava è detto “dai Cavalletti”, intesi come i cavalletti di legno della teleferica. Nel tratto in cui la teleferica passava sopra la strada che porta al Monte Nero era stata costruita una specie di tettoia, per evitare che del materiale cadendo accidentalmente potesse ferire qualcuno, segno che di materiale ne passava così come pure di gente e bestiame per quella strada. C’è una zona che dista da Beverone circa un chilometro detta “Cave” e, lo dice anche il nome, qui vi erano più cave. Di qui partiva un’altra teleferica che fatto un diverso tratto iniziale, confluiva o sostituiva quella dei “Cavalletti”. Alle “Cave” vi erano della baracche per alloggiare gli operai che venivano da fuori, fra loro un operaio di Fivizzano che aveva dei parenti a Veppo. Alla teleferica delle “Cave”veniva anche portata a dorso di mulo la “terra d’ombra” che veniva estratta alla “Valle”.
Poi le estrazioni finirono, e per anni rimasero i cavi di acciaio della teleferica. I ragazzi, in quel caso pastori, che erano a pascolare il bestiame saltuariamente in quel posto, giusto per inventarsene qualcuna prendevano un pezzo di legno, lo agganciavano al cavo della teleferica con un filo di acciaio, facilmente reperibile negli scarti della cava, si aggrappavano con le mani ai lati del legno, poi si lasciavano scivolare giù in discesa, un po’ come essere attaccati ad una gruccia per i panni. Naturalmente prima che la velocità aumentasse troppo e così pure l’altezza, si lasciavano cadere, mentre il legnetto agganciato al cavo continuava la sua corsa. Si sa la sfida è nell’uomo, e un giorno uno di quei ragazzi non si lasciò cadere a tempo opportuno, ma continuò la sua corsa. Il fatto è che a quel punto l’altezza era troppa, insomma ne fece parecchia di corsa. Fortunatamente quando le forze stavano per mancare, l’altezza dal suolo diminuì e si lasciò cadere. Qualche escoriazione se la fece ma molto probabilmente questa storia non la raccontò molto presto in casa sua, altrimenti a quei tempi si usava, come si dice, rincarare la dose. Un’altra ne successe. Oltre che scendere per quel cavo di persona, un’altra invenzione era quella di prendere un bel sasso, legarlo
opportunamente con del filo di acciaio, agganciarlo al solito cavo della teleferica e poi via, una bella spinta. Il sasso partiva e l’attrito del filo di acciaio sul cavo faceva un sibilo che si continuava a sentire anche quando il sasso spariva dalla vista nel bosco. Quei sassi erano destinati a cadere, o perché con le vibrazioni si scioglievano, o perché il filo si consumava con l’attrito, ma giù distante. Quella volta il sasso cadde poco dopo che era partito. Lì sotto c’era il bestiame a pascolare, e picchiò nella testa di un bue uccidendolo sul colpo. I buoi sono compagni di lavoro già da giovani, fanno coppia, e il danno non fu cosa da poco.
Nel 2004 vennero due ricercatori a Beverone, che volevano vedere quel sito. Dissero che avevano notizie di estrazioni nel ‘700 – ‘800.
Battiventu de Beveun Battiventu de Beveun

24 25
U seccadue e er fusiğ iau
Quasi tutte le case avevano un locale chiamato “seccadue”, era l’essiccatoio: diciannove case e dieci seccadui. Il soffitto “grade” era com-posto di travicelli in robusto castagno affiancati l’uno all’altro, non partico-larmente precisi, così che fra essi poteva circolare un po’ d’aria. Si accedeva a questo soffitto tramite un’apposita apertura con una scala a pioli dall’interno, oppure passando da un finestrino dall’esterno. Qui si portavano le castagne ad essiccare, stendendole uniformemente su tutta la grade. Chi non aveva seccadue portava le proprie castagne ad essiccare da chi ne aveva uno più grande, dandogli un contributo in legna. Naturalmente le castagne calavano in peso e volume, ed era regola che per ogni tre ceste di castagne portate ad essiccare, se ne prendesse una di castagne secche, oppure si suddivideva la grade con delle tavole in due o più parti, e poi ognuno si riprendeva le proprie. Dopo i primi giorni che le castagne sopra della grade sentivano il caldo del fuoco, da alcune di esse uscivano dei vermetti bianchi tozzi e grassottelli, chiamati “ anè, tradotto: Giovannini” che di tanto in tanto, passando attraverso i travicelli, cascavano di sotto e continuavano il loro per noi buffo modo di muoversi, magari alla ricerca di una nuova castagna. Si poteva arrivare ad uno strato di mezzo metro di castagne, ed ogni tanto si saliva sulla grade a dargli una rigirata in modo che seccassero uniformemente. Dopo circa un mese di fuoco quasi ininterrotto erano secche. A questo punto doveva essere tolta la buccia “ruveu”. Uno dei metodi usati nei tempi antichi era questo: se ne metteva qualche chilo in un sacco “tasca” di robusta canapa, e poi giù colpi ognuno con la sua tecnica. Una di queste prendendo il sacco in due
persone per gli angoli e poi dandogli dei colpi su di un legno, “battere le castagne”, poi dal miscuglio castagne-ruveu,quest’ultimo veniva eliminato con il vaglio “valu”. In tempi relativamente recenti si usava una macchina molto più pratica, azionata da un motore a scop-pio. Le castagne erano secche come sassi, raramente chissà per quale strano fenomeno se ne trovava
qualcuna morbida, erano delizie per i bambini e si chiamavano “lendene”. Nel centro del seccadue vi era il focarile “fusi iau” che era un
rialzo in pietra alto circa venti centimetri, di forma più o meno quadrata grosso modo un metro di lato, sopra di esso si accendeva il fuoco come fosse un camino, la canna fumaria era il soffitto. Soffitto e pareti erano completamente anneriti dal fumo, in certi punti si poteva vedere addirittura un nero lucido. Nel periodo delle castagne vi si mettevano grossi tronchi affinché bruciassero lentamente e mantenessero un calore costante. Agganciata ad un travicello ben robusto, al centro del fusi iau, vi era una catena di ferro fatta di anelli grossi e tondi. Faceva parte della catena alla sua estremità inferiore un gancio particolare di bella forma, a cui si agganciava la pentola “brunzu” in cui si faceva da mangiare. Per aumentare o diminuire il calore alla pentola si spostava più in alto o in basso il gancio di uno o più anelli. Attorno al fusi iau si passavano le veglie invernali, ed era il luogo di incontro anche fra le varie famiglie. Chissà quali saranno stati gli argomenti più frequenti in quelle serate alla luce delle braci. Forse si sarà parlato dei lavori nei campi, del bestiame, di come riparare qualche attrezzo, sarà nato qualche amore. Poi ogni tanto se ne usciva il personaggio un po’ più buffo che raccontava qualche storia fantastica, ed ogni tanto proponeva qualche indovinello ai più piccoli.
Per i bambini poi, attorno al fusi iau, anche il “dilè dilè … . Uno stecco “bacchettu” di legno lungo circa mezzo metro, tenuto in mano da una estremità, accostata l’altra al fuoco del fusi iau, così che in breve vi si formava la brace. A questo punto si muoveva velocemente lo stecco nell’aria, ed alla fioca luce del fusi iau la scia della piccola brace disegnava delle forme quasi artistiche. La cosa magica era che il ritmo di questo movimento veniva accompagnato dalla tiritera “dilè dilè dilè …”. Se poi il gioco prendeva un po’ la mano e diventava pericoloso, veniva interrotto da un: “ fanti ” !!!
Battiventu de Beveun Battiventu de Beveun

26 27
La vig il ia di Natale
“Cercae a strenna - chiedere la strenna”. La sera della vigilia di Natale i bambini passavano di casa in casa
a fare gli auguri e questo dava diritto a ricevere una piccola ricompensa, che era la strenna. Anche se la gente aveva poco qualcosa preparava: mandarini, caramelle, rari cioccolatini. Dai Beverinotti di sicuro c'erano anche delle nocciole "nostrali".
Per l'Avemaria al crepuscolo veniva suonata la campana grossa, e tutti preparavano un piccolo mazzetto composto da ginepro alloro e brignë, ai primi rintocchi via, tutto dentro le stufe. Dai camini usciva un bel fumo bianco e profumato per Gesù Bambino che stava per nascere; e quanto durava questo fumo! Tutta l'Avemaria ed oltre.
Io l'ho visto quel fumo, da campanaro, diverse volte, e se il vento era favorevole il profumo arrivava fino dalla chiesa. I camini fumanti con gli anni diminuivano; il pensiero andava a persone antiche che ripetevano ogni anno questo gesto affettuoso, da chissà quanto tempo.
A lüse - l’energia elettrica, a Beverone arrivò nel '50. Alla Collettasu di un palo c'era l'interruttore generale per il paese: “I coltelli", una maniglia che tirata in basso toglieva corrente, ed era ad altezza d'uomo.
A Stadomelli, da qualche parte, c'era un interruttore che toglieva la corrente alla linea "Beverone". A volte la vigilia di Natale, mentre stavamo mangiando come di tradizione lo stoccafisso con cavoli, aglio, pepe e "olio di quello buono se c'era", trac….. mancava la luce. I vecchi dicevano "sono quelli di Stadomelli, ci giocano il solito scherzo!" Sarà stato vero? Comunque dopo un pò la luce tornava. Poi c'era chi tirava in ballo il solito racconto che in tempi passati alcuni mettevano lo stoccafisso "in bagno" nei ruscelli, canà du iardìn ecanà da Vile, legato con una cordicella a qualche tronco d'albero. Poi, vuoi per la fame, vuoi perché in ogni periodo c'è chi ha le mani un po’ più lunghe di altri, quando si andava a prendere lo stoccafisso ci si trovava solo la cordicella. Dopo cena si usava fare i "ponci" che erano caffè corretto con rum, ed era offerto a chi veniva a veglia. Quella era una sera in cui soprattutto gli uomini facevano il giro, ed era anche il modo per stare svegli per la Messa di mezzanotte. Finita la Messa, al bacio del Bambino, gli uomini dietro l'altare "nel coro" cantavano "Fra l'orrido rigor", e con le loro voci forti riempivano la chiesa; era una delle poche volte dell'anno in cui cantavano, ed in questa occasione vi mettevano un grande impegno.
Battiventu de Beveun Battiventu de Beveun

28 29
Ultimo del l ’anno: la “tre mpelada”
Chissà da quanto tempo, e da cosa nasceva questa usanza. Cercavamo il necessario costituito da vecchio scatolame di varie dimensioni e qualsiasi vecchia lamiera o ferraccio, per quei tempi non facili da trovare. Il luogo principale per la ricerca era appena fuori dal paese verso la Carpena in un posto detto dau surchettu, quello che proprio non serviva più a niente in genere veniva buttato lì. Con un sasso appuntito foravamo il lato rimasto chiuso delle scatole, poi le infilavamo come fossero perle di una collana, in una corda di circa quattro metri, per metà della sua lunghezza: la trempelada.
Ci preparavamo in cima al paese, poco prima di mezzanotte, in silenzio e ognuno con la sua trempelada da trascinare. Poi a mezzanotte in punto … via! Scendevamo giù di corsa per la strada selciata, facevamo il giro del paese due volte per spaventare l'anno vecchio, che così se ne andava via e poteva entrare quello nuovo. Questa strada che noi percorrevamo a tutta velocità sia in discesa che in salita, era illuminata da sole due lampade da cento candele, prima di noi dalla sola eventuale luna disponibile quella notte, ed i sassi di cui era selciata erano discretamente lisci, nonostante questo non ricordo nessuna caduta.
Il rumore che si sentiva può essere richiamato proprio da trempelada, per capirlo va detto in dialetto: era un trempelamentu.
L'occasione ci dava una sorta di autorizzazione per entrare anche nell'aia dei Beverinotti, in cui facevamo alcuni giri con particolare vigore, e con gran piacere. In effetti poi non è che ci brontolassero per questo, ma la strada era di tutti, invece in quell'aia privata ci sembrava di fare chissà che cosa. Ricordo primi anni '50:
I ragazzotti di allora trascinarono per il paese un vagoncino, residuo della cava di manganese vicina alla Te ia da fusina. Più o meno un cubo, sui 50 kg. La forza della gioventù di quei tempi non era messa in difficoltà da un "vagoncino" qualsiasi, che mentre era trascinato, ogni tanto nel suo rotolare si andava ad impuntare in qualche pietra; se la corda si tendeva, un tirone più forte, e come si suol dire "o dente o ganascia!". L’energia impiegata era stata un po’ troppa, qualche dente e qualche ganascia erano saltati, il mattino dopo alcuni sassi del selciato furono trovati sradicati.
Ricordo anni ’60: Periodo primavera - estate. Nel paese c'era una capra, mancava il
becco (maschio di capra). Andarono a prenderlo a Veppo, a piedi, e lo
portarono a Beverone legandolo per il collo con una corda, poi "dopo un certo periodo nel quale il sopra citato aveva compiuto il suo dovere" lo riportarono a Veppo rilegandolo con la stessa corda, che venne gettata da qualche parte per una eventuale futura necessità. Poi venne l'ultimo dell'anno, ogni ragazzo cerca scatole e corda per la tradizionale trempelada, e salta fuori la fatidica corda.
Mi è capitato forse due volte, ma è successo: nevicare proprio intorno a mezzanotte dell'ultimo dell'anno; e quello fu uno di quegli anni. Ognuno trascina la sua trempelada per il paese, prendendo la corda con le mani, non c'e' altro sistema. La neve umidiccia bagna corda e mani. Terminati i due classici giri del paese, andammo tutti nella piccola osteria per passare ancora qualche minuto in allegria.
A volte si dice "i profumi della campagna!" Chi non ha mai sentito l'odore di un becco non può capire; i becchi puzzano totalmente, sembra che siano stati immersi in un liquido pestilenziale, e il suo si sente anche a diversi metri di distanza. L'odore di quel becco era rimasto attaccato a quella corda per più di sei mesi, con l'umidità' era “rinvivito” e un po' era passato sulle mani del malcapitato, e ora lì nella piccola osteria, quelle mani avevano appestato tutta l'aria. Ricostruito il mistero del misfatto risate e puzza a volontà.
Battiventu de Beveun Battiventu de Beveun

30 31
I fol l ett i
Ora non si usa più, però in passato quando una persona riusciva a compiere tanti lavori in breve tempo, oppure riusciva a fare qualcosa di complicato per un comune normale, si diceva: ma non avrà mica i folletti? I folletti nella tradizione di questi luoghi sono dei personaggi che eseguono gli ordini a loro impartiti, ed anche con una certa sollecitudine. Non è dato sapere come se ne possa venire in possesso. Questa situazione a prima vista sembrerebbe particolarmente vantaggiosa, se non vi fosse un prezzo da pagare: dicono che sia l’anima.
Pare che li avesse uno di Stadomelli. Circolavano alcuni episodi che ne volevano dare conferma. Un beveronese, amico di questi, non ancora a conoscenza dei folletti, un giorno gli disse, come si fa tra amici per ragionare, di certe piante di pino che sarebbero state da tagliare. Però erano in un terreno impervio, per cui dopo esser state tagliate sarebbero inevitabilmente rotolate a valle, ma non dalla parte che faceva comodo, e quindi poiché il mezzo a disposizione per far risalire la scarpata ai tronchi non poteva essere altro che braccia e gambe, non se ne poteva far di niente, l’impresa era troppo ardua. Al che l’uomo di Stadomelli disse all’amico di Beverone che si incaricava lui di risolvere il problema, e alla richiesta di cosa poteva essere necessario rispose “porta un pane, un fiasco di vino ed una formaggetta, al resto ci penso io”.
Il beveronese il giorno dopo prese quanto richiesto e si recò nel bosco in questione, anche se con qualche dubbio. Arrivato nelle vicinanze incominciò a sentire il rumore di accette che tagliavano i pini, poi un gran movimento di tronchi che come volassero si andavano ad accatastare in un terreno comodo da raggiungere. Impaurito da tutto quel trambusto a lui incomprensibile, cercò l’amico che all’ombra di un albero se la dormiva tranquillamente. Subito gli raccontò di ciò che aveva sentito e visto, e gli disse di andare anche lui a vedere cosa stesse succedendo, ma per tutta risposta si sentì dire di star tranquillo, che era tutto regolare … lui sapeva. Preso dallo spavento lasciò pane vino e formaggetta e se la dette a gambe tornando di gran fretta a Beverone.
Il mistero si infittisce, si diceva che avesse “un libro” che serviva per chiamarli. Vattelapesca cosa conteneva: formule, ordini, sortilegi, non si sa. Saputo del libro, ancora una beveronese gli chiese se poteva prestarglielo per un po’, magari pensava di sbrigare qualche lavoro. Ne ebbe come risposta “ se io ti dessi questo libro non saresti in grado di servirtene,
perché non solo non arriveresti a Beverone, ma non faresti nemmeno dieci metri con il libro in mano, che ti diventerebbe tanto pesante da farti sprofondare nel terreno. Lascia perdere non è roba per te”.
Un altro racconto era quello delle fascine di gelso. A quei tempi vi era l’allevamento dei bachi da seta anche da noi. Si sa i bachi mangiano le foglie di gelso, e capitò che una persona aveva la necessità ancora di un mazzo di frasche per i suoi bachi, poi sarebbero diventati bozzoli, ma era un periodo in cui i gelsi scarseggiavano.
Ecco il possessore di folletti che sentito il problema invita l’amico a salirgli su di un piede e chiudere gli occhi. In un attimo si trovarono in un luogo sconosciuto, ma ricco di gelsi, poi si dirà che forse erano andati addirittura in Piemonte. Fecero la fascina di frasche, poi stessa procedura del salire sul piede, occhi chiusi e via a casa. Anche qui naturalmente c’era lo zampino dei folletti.
L’ultima che sono venuto a sapere me la raccontò un anziano di Beverone mentre stavo sistemando della legna per l’inverno in un ripostiglio, cercando di non fargli occupare troppo spazio. Mi disse che stavo facendo un buon lavoro, però si sarebbe potuto far meglio. Per sentito dire a sua volta disse che sempre il nostro di Stadomelli fece sistemare una incredibile quantità di legna sotto dei piccoli archi di casa sua, cosa impossibile per comuni mortali, ma non per i folletti. Ed allora con la fantasia veniva da pensare: che comodità avere i folletti! Però come il re Mida, molto contento per aver ottenuto il potere di trasformare tutto ciò che toccava in oro, quando si accorse che si trasformava in oro anche quello che voleva mangiare, avrebbe voluto rinunciare volentieri a quei poteri; anche il protagonista di questo racconto dopo aver passato un periodo iniziale diciamo abbastanza euforico, e poi in definitiva aveva anche aiutato degli amici, si accorse di aver esaurito i lavori da far fare ai folletti. Ma loro erano li, premevano, volevano lavorare, lo soffocavano. Allora ebbe un’intuizione: ordinò loro di andare a Marinella e legare la sabbia a fascine. Loro andarono, e visto che questo lavoro era loro impossibile, sparirono e non fecero più ritorno.
Battiventu de Beveun Battiventu de Beveun

32 33
Dove sono andati?
È la ruota che gira, e può succedere che arrivati in un certo periodo della nostra vita, come guidati da un richiamo ci mettiamo a frugare nei nostri ricordi, ed affiorano episodi e sensazioni che credevamo cancellate per sempre dalla nostra memoria. Allora viene da domandarsi che fine avranno fatto …? dove saranno andati …? Dove saranno andate le notti, quelle notti buie come la pece, a volte rischiarate dalla luna, ma solo quando lei era disponibile e le nuvole glielo permettevano. Come capire quella oscurità, abituati alle notti delle città rischiarate da una enorme quantità di luce emessa da lampioni ed insegne luminose sempre più potenti, tanto da mandare i loro bagliori fino alle valli più nascoste. Talmente abituati alla luce da provare un senso di angoscia appena ci troviamo in un luogo poco illuminato. Dove saranno andate le miserie e sofferenze vissute dalle famiglie tanto numerose da non riuscire a capire dove tutta quella gente avesse potuto dormire, o solo sedersi per mangiare, in quelle case dalle enormi pareti ma dai piccoli ambienti. Persone necessariamente forgiate a sopportare grandi dispiaceri e privazioni, come perdite di vite per cause che oggi si risolvono con poche pastiglie, e perdite di raccolti. Come pensare “ma loro non ci facevano caso, erano abituati”, povera gente, non erano di ferro nemmeno loro, e forse riuscire a capire che quando capitano i dispiaceri non mettono a dura prova solo noi ma anche gli altri. Quelle burrasche tremende con lampi e tuoni a volte così vicini e forti da far tremare lo stomaco ed i vetri delle piccole finestre, tenuti fermi da chiodini e stucco rinsecchito dal sole e dalla pioggia, tuoni che non di rado facevano una visita in qualche casa, ma soprattutto lassù in alto alla chiesa e al campanile. Inverni con neve così alta da doversi aprire della stradine con alte pareti per muoversi nel paese, e nelle stalle del bestiame, che durava giorni e giorni, ed aspettare che la neve iniziasse a disciogliersi andae en
durzüa, in modo da riprendere le normali attività. Freddi secchi che facevano screpolare le mani causando dei tagli sedue che sanguinavano e non volevano rimarginarsi, e l’unico rimedio sembrava quello di farvi cadere sopra la cera calda delle candele. Dove saranno quei bambini che alla fioca luce dei lumini ad olio, con i loro forti occhi riuscivano a leggere sui libri di scuola e fare i compiti, dopo cena perché di giorno erano andati a portare il bestiame al pascolo.
Ci saranno ancora quelle laboriose formiche che fra quei fili d’erba dei pascoli brucati in continuazione dalle pecore, durante il loro andare vieni per riempire il formicaio dei vari semi, con le loro zampette consumavano erba e terra così che si formavano delle piccole stradine che sembravano autostrade. E quei caldi giorni dell’estate, durante le ore del riposo, in momenti di calma così grande che si potevano sentire api o altri insetti arrivare da lontano e proseguire per il proprio tragitto come un’auto da corsa che durante le sue prove solitarie in un autodromo, si sente arrivare in lontananza, poi più forte … un attimo, ed è già sparita. E le mantidi religiose a cui veniva imposto zünza er man che vuol dire congiungi le mani, come chi prega, e credere che loro eseguissero quell’ordine, ed invece era un loro modo di assumere una posizione di difesa. E quei animaletti neri a cui ordinavano spüda sangue, e per farglielo capire meglio gli sputavano un pò di saliva addosso, e allora gli animaletti da qualche parte del loro corpo emettevano davvero un pochino di liquido rosso. E che fine avranno fatto quegli scarabei, che spingevano goffamente in retromarcia delle palline da loro costruite, grosse come ciliegie, fatte di sterco di mucca che chissà dove portavano e a cosa gli servivano. Poi i grassi grilli neri, ognuno all’ingresso della propria casina e tutti a cantare la stessa canzone, che per riuscire a vederli bisognava avvicinarsi in silenzio acquattati, altrimenti scomparivano velocemente nelle loro tane. E quelle trombette che erano i fiori delle primule, con il loro suono così delicato e diverso da fiore a fiore, o il suono più forte dei larghi fili d’erba messi fra i pollici, o anche le varie trombette e zufoli fatti con la scorza di castagno, in primavera quando le piante “vanno in sugo”. Dove sono andati? Sono andati nei nostri ricordi, e non aspettavano altro che essere tirati fuori anche per soli pochi minuti, come a dire “siamo esistiti davvero”.
Battiventu de Beveun Battiventu de Beveun

34 35
Vecchi indovinel l i
Ecco alcuni di quegli indovinelli che venivano proposti attorno al fusigiau. Naturalmente non potevano che riguardare le cose che appartenevano al piccolo grande mondo che li circondava per tutta la vita.
1Ghè na ve iazza
da na fenestrazza,
se ghe scrola quelu dente
a fa arünae tütte er ente.
C’è una vecchiaccia affacciata a una finestraccia, se gli scrolla quel dente fa radunare tutta la gente.
2U tien er gramu e u cazza via er bun.
Tiene lo scarto e butta via il buono.
3L’è lünga lüngagna
a gà i denti cume na cagna,
na cagna a ne l’è
anduvina cuse l’è.
E’ lunga lunga ha i dente come una cagna, una cagna non è indovina cos’è.
4Ghè en caratellìn
cun due sorte de vin.
C’è una botticella che contiene due qualità di vino.
5Verdulìn u l’è,
verdulìn u stà,
ne ghe grëda de fo e
perché u ne ghe n’à.
Verdolino è, sempre verde stà, non gli cascano foglie perché non ne ha.
6 Quattru stanghe
dui stegüzzi
e na spazzetta.
Quattro stanghe due stecchini e uno spazzolino.
7Surve terra
suttu terra,
en ter mezzu
ghè na rudella.
Sopra terra sotto terra nel mezzo c’è una rotella.
8Peu fëa
peu drentu,
arauza a gamba
e anfrizzeghelu drentu.
Pelo fuori pelo dentro, alza la gamba e infilaglielo dentro.
9Bella fi ia a sta destesa,
piccarazzu u ghe sta attaccà,
Santa Chiara a ghe sta drentu,
i ballain i ghe bàllan drentu,
u russignë u ghe pizza er cü.
Bella figlia stà distesa, il picchio le stà attaccato, santa Chiara gli stà dentro, i ballerini gli ballano dentro, il rosignolo gli pizza il sedere.
Battiventu de BeveunBattiventu de Beveun

36 37
1
La vecchia campana, affacciata al finestrone del campanile, se viene fatta suonare, e quindi gli dondola il batacchio, chiama attorno a se tutta la gente.
2Il setaccio trattiene la crusca, cioè lo scarto, mentre fa uscire dai suoi forellini la fine farina bianca.
3Il ramo del rovo che fa le more, è lungo ed ha delle spine che somigliano ai denti di un cane
4C’è una botticella che contiene due qualità di vino.
5Il giunco è sempre verde e non ha foglie.
6
Quattro gambe, due corna e una barbetta.
7Il tastarolo, che è la rotella, viene cotto fra i due testi fatti di terra cotta.
8La calza di lana è di pelo fuori edentro, si solleva il piede e vi siinfila.
9
La bella figlia è la catena che è stesa, attaccata al soffitto “grade” del focarile. Il picchio è la pentola “brunzu” che stà attaccato alla catena con il gancio di ferro. Santa Chiara è l’acqua che è dentro la pentola.Il ballerini sono i fagioli che mentre l’acqua bolle sembra che danzino. Il rosignolo è il fuoco sotto la pentola, le cui fiamme vanno a lambirne il fondo.
Battiventu de Beveun Battiventu de Beveun

38 39
Era da credere?
Fra i beveronesi c’è chi ha scritto poesie
e composto canzoni.
Ma certo, non potevano essere che . . .
I menestrelli
di Beverone

40 41
Maria Bruna Cavicchi - 2006
Introduzione
Da anni avevo in mente di raccogliere in un libretto le poesie scritte dai beveronesi, per lasciare un ricordo a chi verrà dopo di noi, e cercare di trasmettere il nostro affetto per Beverone a quanti anche per una sola volta all’anno vengono in questo paese. Naturalmente per una sola volta si intende il 29 agosto, forse spinti dalla fede per San Giovanni Battista, il nostro patrono, partecipando alla sempre sentita processione sul monte, forse per ritrovarsi fra parenti ed amici, o anche per ripetere questo gesto che per secoli è stato compiuto dai nostri vecchi. Non è stata fatta una scelta fra più corte o lunghe, semplici o difficili, sono tutte assieme unite, come dei buoni fratelli. È stata dura per un non addetto ai lavori, e per questo ringrazio quanti mi hanno aiutato.
In mezzo a tutte queste rime che corrono da una pagina all’altra si diventa poeti anche senza volerlo, ed allora magari nasce l’ispirazione per buttare giù un verso che potrebbe suonare così:
“chissà per quanto tempo continuerà a girare a Beverone la giostra della vita, ed ognuno salire e poi scendere per il proprio turno, quel giorno che conosce solo chi è sopra di noi. Speriamo che non debba fermarsi per mancanza di clienti. Caro vecchio e magico Beverone, quanto amore hai distribuito! Ti devo dire una cosa: anche se questa gente dalla scorza dura non te lo ha mai detto, lo ha ricambiato con gli interessi”.
Ecco la frase che era nata è stata scritta, era bella oppure no? Ha poca importanza. Ora non mi resta che uscire in punta di piedi e lasciare il posto ai Menestrelli di Beverone.
I menestrelli di Beverone

42 43
A Beverone Adriana Antognelli
O Beverone, mio picciol paesel lontano,
solo chi sta lontan da te ti può vedere
con gli occhi della mente, e ricordar col cuore. Tanto sei piccolo o Beverone mio,
ma tanto e grande è il bene che ti voglio io.
Una casetta con il tetto rosso, una famiglia che scordar non posso.
O campanile che la in alto stai,
per me l’Italia tutta tu saluterai, quando suoni per l’Avemaria
ricordale di me alla terra mia,
dille che sto lontana, ma che ogni sera
rivolgo per tutti la mia fervida preghiera. Ciao Beverone non ti scordar di me,
io ti saluto e non mi scorderò di te.
Fine anni ’50, mia sorella Adriana emigrava in Francia. Prima di partire scrisse questa poesia. Ritrovammo dopo anni il foglietto su cui era scritta ripiegato, fra vecchie cose custodite in una valigia. Era stata pubblicata da don Emilio Drovandi in un giornalino da lui ideato e scritto, che si chiamava “Radio Beverone - Stadomelli L’Angelo della parrocchia”.
Ricordi Mauro Fraboschi
Come era bello stare lassù quei giorni lunghi lontani dal tempo,
come una favola, un sogno dorato,
che scompariva assieme al sole.
Mi risvegliava di buona mattina
e mi lasciava soltanto la sera,
assieme alle stelle e alla calda atmosfera.
Quei giorni felici sdraiati al sole
sull'alta collina che domina il mondo, pensieri e parole vagavan nell'aria
giorni dolci dove il sogno è realtà.
Sembra essere attorno e dentro di te,
i nostri pensieri e i desideri
assieme nell'aria viaggiavan leggeri.
Come gli uccelli che stanno lassù
e guardano il mondo scorrer laggiù.
Anche nel cuore di Mauro ci sarà sempre un posto per Beverone. In un periodo giovanile di particolare vena poetica ha scritto e musicato tante poesie. Sono state scelte queste due piccole perle ispirate da Beverone.
I menestrelli di Beverone

44 45
Lungo questa strada
Camminando lungo questa strada
in questo giorno caldo dell’estate
sto osservando sotto di me l’acqua del fiume che scorre e va via.
E quanta ne è già passata quanta ancora ne passerà,
quante volte il fiume cambierà
la sua corsa verso il mare.
Come l’acqua del fiume siamo noi
che corriamo sempre in una direzione,
per arrivare infine al grande mare che nessuno di noi potrà fuggire.
E allora io sto pensando che era molto meglio tempo fa
quando non si facevano domande
e non si chiedevano i perché,
e certi pensieri nella mente
non ci sono mai passati
e la vita di tutti i giorni correva felicemente.
Poi poco a poco crescendo per un qualcosa che non si sa spiegare,
la mente ha cominciato a ragionare
e a porsi un mucchio di domande,
Mauro Fraboschi
e allora si comincia a capire
che si è al centro di un grande gioco,
pur non sapendo tutte quante le regole si deve giocare fino in fondo,
ed ognuno di noi che vive qui cerca di variare un po’ il percorso,
per scoprire qualcosa di nuovo
che dia un senso a questi giorni uguali.
Ma uscire dal percorso non è facile,
ormai si è troppo legati
a questo ritmo strano della vita che ci porta con se.
Quante volte si è cercata una risposta
frugando dentro la mente del come si è arrivati qui
e di dove un giorno si andrà,
e quando si arriva sulla curva
che si affaccia sopra il grande mare,
non si capisce se il fiume già percorso sia stato vero oppure solo un sogno.
E questo tempo che passa e se ne va
e non ci da la possibilità di fermarsi e di ragionare
su questa vita che piano se ne và.
I menestrelli di Beverone

46 47
Sempre solo sarò Dario Moretti
Si io già lo so, sempre solo sarò,
la mia vita darei per un' ora con lei,
anche se so che poi piangerei, perché lei non ha cuore e morir mi fa.
Lei è senza cuor perché fa soffrire me, basterebbe un solo si e di gioia impazzirei.
Perché mi fai soffrire sai che amo te,
sei crudele sei tiranna, tu non ami me.
Si ora io lo so sempre solo sarò,
se non posso avere te nessun' altra amerò,
se non posso avere te nessuna mai più, sei un' angelo tu ma veleno per me.
Sempre solo starò, solo a te penserò, ma se un giorno tu vorrai dove sono lo sai,
se vorrai amare me io correrò da te,
sei un' angelo tu ma veleno per me.
Nella mia stanza Dario Moretti
Sono nella mia stanza, sto pensando a lei. Sono solo e all'improvviso suona il telefono:
forse è lei che mi chiama forse ancor mi perdona,
lei è fatta così, le rispondo si amore, e poi scendo per le scale e corro da lei.
Ripensando al passato tutto quello che è stato,
non può finir così, io la prendo per la mano, un bacio ci diamo e felici corriamo.
Siamo felici così.
I menestrelli di Beverone

48 49
La moto rossa Dario Moretti
Avevo una moto rossa
duecento di cilindrata,
avevo pure una ragazza avevo pure una ragazza.
Avevo una moto rossa
duecento di cilindrata,
avevo pure una ragazza avevo pure una ragazza.
Che corse pazze
per i prati e per i boschi, lei mi amava con passione
lei mi amava davvero.
Una sera che ero molto triste
passeggiavo in un giardino
una ragazza con la moto mi si fermò vicino,
io sbagliarmi non potevo era lei
per davvero.
Ma un giorno un brutto giorno
contro un albero son finito, la moto ho fracassato
e ho perduto la ragazza.
La moto mi donò
e sempre con me restò. Avevo finito di sognare
ora potevo ricominciare.
All'ospedale son finito,
mi sentivo triste e sconfitto,
se al passato ripensavo quel ritornello cantavo.
Ora ho una moto rossa
duecento di cilindrata,
ho pure una ragazza, ho pure una ragazza.
La moto rossa esisteva davvero. Dario e suo babbo avevano a Beverone una piccola bottega di alimentari, e Dario andava con la moto a Veppo a prendere il pane che arrivava dal forno di Brugnato. Forse era un po’ più piccola di cilindrata di quanto dica la poesia, ma si sa i poeti a volte esagerano. Per quanto riguarda la storia, la fantasia avrà fatto la sua parte, ma sarà stata tutta fantasia?
A mutusega Dario Moretti
Te te üsi a mutusega
ma prima o poi a te frega.
Cun er piante a ghè l'ha a morte,
ae ta ia dritte e storte, a ne cugnussa de padrùn
e a ta ia er gramu eer bun.
Se ta üsi senza impegnu a te lassa en brüttu segnu,
en beu ta iu a te lassa
quela brütta bestiazza.
Se te na sa aduperae
dame retta, lassa stae, staghe distante, na tuccae,
quela a serva sulu per segae.
L’orchestra birichina Dario Moretti
Un' orchestra birichina s'è formata giù in cantina,
la dirige sor topone
che fa pure da trombone.
Un’imbuto e una fiaschetta
fan da flauto e da trombetta,
contrabbasso e mandolino e non manca poi il violino.
Ma il concerto tutto ad un tratto tra le botti vede il gatto,
e comincia il fuggi fuggi
per raggiungere i rifugi.
Poi vien fuori un bel cartello,
con la scritta in stampatello,
da un topino screanzato il concerto è rimandato.
Un piccolo ricordo anche per la Pena, due case poco distanti da Beverone, Dario abitava alla Pena. Nelle sue poesie salta da un argomento all’altro con la stessa semplicità e facilità con cui butta giù i suoi versi. Bravo Dario!
I menestrelli di Beverone

50 51
En žiu per Beveun Dario Moretti
A chinu a Costa de Tanibertu
cun na dona e na cuvèrta,
a me fermu ar Bulugnu,
a se ia e a me da en pügnu,
a ne semu mancu ar Frëde
che a scuminza a rumpe 'ëve,
en ta Lama de Zalàn
a me denta na man,
en tu surcu da � iosa
prima a beva e poi a s'arposa,
a me portu en te i'uive,
a me suna er pive,
e poi en ter enestrau
a s'arabia cume en diau,
a passemu a Campebùn,
a me disa: "tiè en cuiùn"
poi a Costa da sèra,a me tacca na guèra.
Quande a semu en ta Pissàà
a me fa na gran cagnàà,
de suttu ar Vignea se metta a tiame er pigne,
dopu a passemu aa Pena
e a me fa na brütta scena,
arivemu poi a Culettae a me tia na saetta.
A ghe digu andemu a Piò,
a men disa de tüttu en pò,
a ghe parlu da Pianèla,a me pista cun na padèla,
e poi aa Funtana
a se lava gunèla e suttana,
a mi fa purtae ar Pearbeu,
e ai stenda en zimu an'arbeu,
arivà ca semu a Costa,
a me fa na proposta,
a m'anvita en ta cavana,
ma per me l'è cosa strana.
Alua a scappu li ai Custèe a ghe trëvu u Linè,
a ghe digu: "en tà cavana
ghè na dona senza suttana",
lü u me disa: "e te un te và?" a ghe rispundu:
"dopu quelu che ho passà
a sun stüfu, a vagu a cà".
L'idea era di raccogliere i nomi dei luoghi attorno a Beverone, nomi a volte strani, antichi. Pian piano verranno sempre più dimenticati, e queste due poesie vogliono essere un omaggio non solo ai luoghi, ma anche ai nostri avi che per secoli li hanno calcati. Non si potevano scrivere tutti, erano troppi, quelli ricordati valgano da portabandiera.
En ta costa de Tanibertu Dario Moretti
A iu enta Costa de Tanibertucun adossu na cuverta,
poi enta Lama de Zalàn
cun en piatu en man. A sun andà a Campebùn
a man iae er menestrùn,
en ter Campuìn
a beve en bi eu de vin, poi a L'aetta a man iae a
pancetta.
Ho fattu en sautu ar Mo iea man iae er castignacciu
cun er fo ie,
enta Bëra du sartu,tütta roba de scartu,
e poi aa Tana
ghia na cosa strana,
e Delà da frateghia tante teste matte,
en ta Curniëa
ghia en cinghiale cun i denti de fëa.
A Ratuin ghia Tugnin
cun en fiascu de vin. En ti Quadri
ne ghia en pò i ladri!
Ai Pradeschè ghia u Linè
cun n'agnè, a gò ditu: unte vè?
U m'à rispostu: a vagu a
Brignè e au portu a Miglè.
En cimu aa Bëra der bozughia en cagnacciu cun er gozu,
aa Te ia da fusina ghia na ga ina
ca beccheva l' üva sultanina. en ter Pianele
ghia der fantele tantu bele,
aa Fauza
ghia na dona ca feva a cauza. En tu Surcu da vale
ghè n'omu cun tante bale,
en ti Lamùn ghè un cuiun cuiun.
Au iambrettu ghè en galettu
cu fa a botte cun en ve iettu, a dar Figu de Zelantognu
ghè un cu paa en demoniu.
Aa Piana de Biasìn ghè un cun
tantu vin, che un regala en bi ein.
En ter Carmazzu
ghè un che l'argusa cume en pazzu, aa Madunnina
ghè na bela esina,
e au Cerughè ün cu vë fae brüsae er feru.
Antravedu na cuverta,
a sun aa Costa de Tanibertu,
a sun stà en beu cuiùn a iae tüttu Beveun,
e cun tütta a mü pasenzia
a sun arturnà ar püntu de partenza.
I menestrelli di Beverone

52 53
Ora vi voglio raccontare una storia, la storia di una poesia:
Un giorno mio cugino Dario trovò un cane nel bosco, era impigliato in un groviglio di fili di ferro, chissà forse un laccio per cinghiali. Il poveretto era ferito, allora Dario lo portò dal veterinario e poi se ne prese cura. Serviva un nome…il cane era uno spinone con dei bei baffi… esatto, lo chiamò Baffi. Naturalmente come avviene nelle favole, divenne suo amico inseparabile. Passarono gli anni, per i cani passano un po’ più in fretta che per noi, e Baffi si fece vecchietto. A Dario venne in mente di scrivere una poesia da dedicare a Baffi, un segno di amicizia verso il suo amico a quattro zampe. Cosa scrivere? … pensa che ti ripensa … ecco l'idea … niente di reale, tutta fantasia, ma taaanta fantasia … ora state bene attenti … ecco la poesia:
Dedicato al mio amico Baffi Dario Moretti
Questa è la storia di Baffi, cane strano,
che ai cinghiali dava una mano
ed invece di cacciare dava loro da mangiare,
li invitava assai contento
in un campo di frumento.
Baffi va dal contadino
e gli chiede del buon vino per lui e per gli amici,
e allora il contadino
lo minaccia con il fucile e gli dice di sparire.
Ma i cinghiali tutto ad un tratto in coro gli han gridato:
attento o brutto tipo
se fai del male al nostro amico per te saranno guai,
è meglio che te ne vai.
Il contadino se ne andò
e la pace ritornò.
Baffi porta i suoi amici all’uva moscatella
mentre loro stan mangiando lui fa
da sentinella, poi si mette ad abbaiare
qualcuno sta per arrivare:
è il cacciatore col fucile,
arrabbiato e fa scintille.
Sono vecchio e puoi sparare,
disse Baffi, ma con loro i conti dovrai fare.
E i cinghiali tutti in coro:
attento brutto ceffo siamo in tanti e siamo armati
abbiamo denti affilati,
e se a Baffi vuoi sparare per te finisce male.
Il cacciatore un attimo esitò
tutt’intorno si guardò, gli arbusti ondeggiavano
mille occhi lo guardavano,
lì di colpo si fermò
e di corsa poi scappò.
Baffi Baffi sei un eroe, gli gridarono i cinghiali, ed in trionfo lo portarono;
poi cantarono: tu sei il nostro eroe, con noi
potrai stare fin che vuoi.
I menestrelli di Beverone

54 55
Amore per Beverone Carla Moretti
Oh Beverone, piccolo paese mio,
quando non ti son vicina
mi manchi tanto, ti penso sempre. Qui sono nata e son cresciuta,
ho conosciuto le prime pene
le prime gioie. Qui ho vissuto la mia infanzia
e ho conosciuto il mio primo amore
e unico… no, non unico con esso ho conosciuto
l’amore di mamma.
Ecco due fra le tante poesie scritte dalla Carla, sempre ispirata da un grande amore per il paese e la famiglia. Non servono spiegazioni particolari, parlano da sole.
Il mio paesel Carla Moretti
Al mio paesel c’è un campanile,
con tre campane,
e tutto intorno un praticello,
ci van le pecore a pascolare. Poche casette sul suo fianco
la mia famiglia che io amo tanto.
O mio paesel piccolo e lontano anche lontan da te come tu sai
di te non mi potrò scordare mai.
I menestrelli di Beverone

56 57
A sun de Beveun Sergio Antognelli
Der vote a bevu'r vin
alua me vièn vo iade pi iae na chitarra
e de cantae en pò.
A cantemu en pò de tüttu
basta esse en pò cuntenti stae en cumpagnia
e devertisse en pò.
Der vote a litighemu
ma poi ne passa tüttu e alua a semu turna
amighi pü de prima.
Per primu gh'è a Fernanda
Paulu e Brunettu Daniele e Saurettu
a Gina e iuan.
Ghè iuseppe e Lissandrìn
Dariu e Migliettu a Rusalba e Franchettu
mü ma e a Caterina.
Ghè a Giüliana e Giancarlu
a Giuvanna e Mariu a Laika e Ardinu
u Linu e Andrea.
Ghè Massimu e a Bruna
Nelu e Angelina Ginu e a Carla
Gianluca e a Manuela.
Ghè Claudiu e a Cinzia
a Driana e Maurettu Vergiliu e Tiliettu
e poi a ghe sun me.
Poi ghe tütti ’iatri
che ien chi per poghe vote de Pradu e de Veppu
e poi de tüttu er mundu.
En fundu quellu che cunta
l'è de vuresse en po’ de ben a iütae chi g'à besugnu
de cumpagnia e de cumprensiun.
Quando fecero il loro ingresso gli anni ’70, in estate incominciarono ad arrivare i primi “villeggianti”. E’ stato un bel periodo. Ci trovavamo di sera, beveronesi e non, sembrava che la fantasia desse il meglio, sempre qualcosa di nuovo da fare: qualche serata di ballo al suono del giradischi, nascondino, panigazzi, addirittura giochi da prestigiatore, canti vari accompagnati dalla chitarra. Questa poesia non è altro che la fotografia di una di quelle serate. Quante volte l’abbiamo cantata! Dopo ogni verso il coro ripeteva “a sun de Beveun”. Scorrono i nomi della canzone, e ci si accorge di quanti non ci siano più, ognuno ha lasciato un vuoto, per tutti il nostro caro ricordo.
I menestrelli di Beverone

58 59
Sono stato a Beverone Sergio Antognelli
Sono stato a Beverone
tanto tempo fa,
quanta gente strana che ho visto tutta gente di paese.
Non c'era strada né bottega acquedotto e telefono,
non c'era quello che c'è in città
però c'era la felicità.
Gli uomini a lavorar nei campi
una gallina in mezzo all'aia,
delle donne alla fontana e i bambini a pascolar.
Ho visto un vecchio col bastone che mi raccontò con voce lenta,
storie di fame e di guerra
storie della sua gioventù.
Son tornato in quel paese
ora ho qualche anno in più,
anche qui il tempo passa e il progresso mette la sua firma.
D'inverno c'è poca gente quasi tutti sono anziani,
d'estate poi si ruberà
la loro amica tranquillità.
Prima si sentiva dire
che qui il tempo s'era fermato,
si arrivava qui per caso ci si lasciava un po’ di cuore.
Però se tutti noi lo vogliamo si può salvare ciò che è rimasto,
basta essere tutti parte attiva
in questa piccola comunità.
I menestrelli di Beverone

60 61
Vintinëve d’agustu Sergio Antognelli
L'è n'atra vota er mese d'agustu
per tante persune l'è tempu der ferie,
a s'artruvemu en questu paese
e a s'arcuntemu i nostri prublemi.
A sta i a sentie i paan tütti diversi
ma en fundu en fundu en poi tütti uguali,
quelu che cambia en sulu i vint'ani che tütti i rimpian an savendu er perché.
Ghè quarchedün nëvu cume iatr'ani
cume iatr'ani quarchedün u né ghè pü, forsi per questu cambiae de persune
chì se ghe trëva n'amigu de pü.
Amigu pen mese e poi chi s'arveda en fundu er ferie en fatte cussì,
l'è iüstu poi questu modu de fae
settembre u n'abranca per n'atru anu en pü.
Quande vièn sea ognün g'à n'idea
de cume passae en pau d'ue en cumpagnia,
secüu per pü grande er pü pe enin
dui panigazzi en fiascu de vin.
Seade allegre en pò pü en pò menu
fatte de gnente de pogu de tantu,
en iurnu che tütti iaspettan cur chëe: vintinëve d'agustu amigu de tütti.
iarivan i paenti ch'in se vedevan da ani
tante persune di paesi visin, se ün u né veda daveu u né pë crede
che esista daveu en paese cussì.
Der vote a pensaghe ne paa mancu veu
che fëa de chi ghe sia en mundu diversu, en mundu cu camina troppu de cursa
a iütemulu armenu a fermasse chì.
Ventinove d’agosto
E' un'altra volta il mese di agosto
per tante persone è il tempo delle ferie, ci ritroviamo in questo paese
e ci raccontiamo i nostri problemi.
Ad ascoltarli sembrano tutti diversi ma in fondo in fondo son poi tutti uguali,
ciò che cambia sono solo i vent'anni
che tutti rimpiangono sapendo il perché.
C'è qualcuno "nuovo" come gli altri anni
come gli altri anni qualcuno non c'è più,
forse per questo cambiare di persone
qui ci si trova un' amico in più.
Amico per un mese e poi chi si rivede
in fondo le ferie sono fatte così,
è giusto poi questo modo di fare, settembre ci riagguanta per un'altr’anno in più.
Quando viene sera ognuno ha un'idea
di come trascorrere un paio d'ore in compagnia, sicuro per il più grande ed il più piccolo
due panigazzi ed un fiasco di vino.
Serate allegre un pò più ed un pò meno fatte di niente di poco di tanto.
Un giorno che tutti aspettano con il cuore:
ventinove d'agosto amico di tutti.
Arrivano i parenti che non si vedevano da anni, tante persone dei paesi vicini,
se non si vede non si può credere
che esista davvero un paese così.
A volte a pensarci non sembra nemmeno vero
che fuori da questo esista un mondo diverso,
un mondo che cammina troppo di corsa aiutiamolo almeno a fermarsi qui.
Inizio anni ’70, i piccoli paesi incominciano a spopolarsi. Chi è andato a lavorare fuori e può torna per il periodo
delle ferie. E’ tempo di dare una mano a tirare avanti la baracca a chi è rimasto, tempo di un po’ di riposo ma anche di riflessioni, naturale che riaffiorino ricordi, spontaneo scrivere una poesia. Ricordi tanti, ma
il fatto più grande è la festa del paese, il 29 agosto. E’ un giorno talmente importante che dire 29 agosto o San Giovanni è la stessa cosa, non si toglie niente al nostro patrono. E’
l’avvenimento più importante dell’anno, lo è da secoli. Tutto gira in modo da focalizzarsi su questa data, il punto più alto del percorso, poi si riparte per un altro giro.
I menestrelli di Beverone

62 63
Pater nostru tradizione popolare
Pater nostru pe enìn che s’aleva ogni matìn per ben fae per ben die bèle cose da mantegnie. U de ün che te feà en paadisu t’andeà. En paadisu ghè bèle cose chi ghe và se ghe ripose, a l’infernu ghè malagente chi ghe va se ne pente, pentie o ne pentie che ghe và, ne pë pü surtie.
Santuario in montagna. (Beverone) Acquaforte di N. Navarrino, eseguita attorno agli anni venti.
Da una fotocopia.
A Beverone Leonardo Zucchini
Tu, quasi sentinella sugli spalti, vigili il paesel che a te s’aggrappa, o Beverone che dall’alto guardi, picciola chiesa posta in vetta al monte.
Quando al mattino il primo sol t’indora chiaman le tue campane alla preghiera; rispondon le altre chiese da lontano: dona la pace tua Signore Iddio e dacci oggi il nostro pane quotidiano.
Brucan le pecorelle sul sagrato, la rondine garrisce al campanile, mentre laggiù, dove riluccica il mare, pulsa la vita con ardor febbrile.
Quando imbrunisce, e in faccia all’Apuane tramonta il sole, e giunge ormai la sera, dicon “Ave Maria” le tue campane, e mormora il viandante una preghiera.
A notte tutta dorme la natura, tu sola vegli, piccola chiesetta, sui morti tuoi, sui vivi, mentre la in fondo un’auto via saetta.
Il libretto termina con una poesia che ha lo stesso titolo di quella con cui era iniziato. È stata scritta dal conte Zucchini che non era di Beverone, ma del vicino Veppo, ed entra a pieno diritto in questa piccola raccolta. Anche questa poesia venne pubblicata nel giornalino “L’angelo della parrocchia”, quasi una risposta alla poesia di Adriana, alla ricerca di un verso sempre più bello da dedicare a Beverone e alla sua chiesetta.
I menestrelli di Beverone

64 65
Ecco, è stato passato tutto in rassegna ancora una volta, ed ora che ho finito non so se essere contento o triste. Come un genitore quando vede un figlio che ormai diventato grande intraprende la propria strada. Tanti erano ancora i consigli da dare, tante le cose da dire. Vai libretto fatti onore, fai onore al nostro paesino. Cancella gli errori del tuo autore, e con un colpo di bacchetta magica fai nascere fra queste semplici righe un piccolo messaggio di amore per questo mondo, da cui troppo spesso sembra sia scomparso.
Tanto amore ed emozioni provate nel frugare nei propri ed altrui ricordi. Guardarsi indietro e provare una dolce nostalgia, riuscire a vedere il passato con gli occhi di un bambino. Parole ormai in disuso quasi da dover provare vergogna a dirle, da tenere per se come un diario segreto. Vorrei essere riuscito a trasmettere ciò che man mano ho provato anch’io, sia con le immagini che con lo scritto, d'altronde non è mica semplice descrivere delle sensazioni.
L’intenzione è stata di scrivere dopo aver cercato di far girare indietro le lancette dell’orologio di parecchi anni, forse è questo il trucco per trovare nascoste fra le righe quelle sensazioni, naturalmente ognuno le proprie.
E’ stata veramente una bella esperienza, ne è valsa proprio la pena.
Mi rimane un’ultima cosa da fare ed è quella di firmarmi, naturalmente in beveronese:
Serzu da Italina
Le foto più vecchie sono state prese a prestito e poi riposte nei cassetti dei ricordi, mio e dei miei paesani. Le foto più recenti le ho fatte io, cercando di abbinarle agli scritti.
Guida alla pronuncia del dialetto Beveronese:
Si legge come fosse italiano con delle eccezioni, che sono state scritte usando caratteri speciali:
Ë : chiusa, si legge come “eu” in francese.
Ü : chiusa, si legge come “ü ” in francese o tedesco.
: dolce, come “zaino”.
- seguiti da “i” oppure “e” : hanno una pronuncia abbastanza
difficile che è a metà strada fra "ci - chi" oppure "ce - che" la prima,
fra "gi - ghi" o "ge - ghe" la seconda.
I menestrelli di Beverone