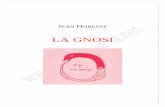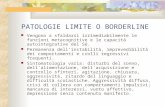autismo - Katawebdownload.kataweb.it/mediaweb/pdf/espresso/scienze/2000... · 2011-09-16 ·...
Transcript of autismo - Katawebdownload.kataweb.it/mediaweb/pdf/espresso/scienze/2000... · 2011-09-16 ·...

Le cause dell'autismo
Questo misterioso disturbodel comportamento sembra abbia originein una mutazione dei geni che controllano
lo sviluppo embrionale precocedi una particolare regione del cervello
di Patricia M. Rodier
L5 autismo lascia perplessi gli scienziati da più di mezzo seco
Questo complesso disturbo del comportamento comprende
un'ampia varietà di sintomi, la maggior parte dei quali fa la
sua comparsa prima che il bambino abbia compiuto tre anni. I bambini affet-
ti da autismo sono incapaci di interpretare le emozioni degli altri, non riesco-
no a riconoscere la rabbia, la tristezza o l'inganno. Le loro capacità verbali
sono spesso limitate, e riesce loro difficile incominciare o sostenere una con-
versazione. Inoltre manifestano di frequente un interesse eccessivo e quasi
esclusivo nei confronti di un soggetto, di un'attività o di un gesto.
Questi comportamenti possono essere incredibilmente invalidanti: come si
può essere inseriti in una normale classe scolastica se nessuno riesce a dissua-
dervi dallo sbattere la testa sul banco? Come potete farvi degli amici se il vo-
stro unico, smodato interesse sono i calendari? Quando un bambino malato di
autismo soffre anche di ritardo mentale - come accade in molti casi - la pro-
gnosi è addirittura peggiore. Le terapie comportamentali intensive migliorano
lo stato generale per molti pazienti, ma i sintomi che essi presentano impedi-
scono loro di vivere in maniera autonoma, anche se il loro QI risulta normale.
LE SCIENZE 380/ aprile 200078
Questo bambino autisticodi sette anni cerca di
afferrare una bolladi sapone in un momento
di gioco all'Eden Institute,una scuola specializzata
per soggetti affettida autismo che si trova aPrinceton (New Jersey).
tg.
79

Come e quando agisce il talidomide
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37Età dell'embrione
(giorni)
ORECCHIE ASSENTI ORECCHIE MALFORMATE
MANCANZA O RIDUZIONE DEL POLLICEo
o
Eo
BRACCIA FOCOMELICHE O MALFORMATE
GAMBE FOCOMELICHE O MALFORMATE
Danno causatodall'esposizione
al talidomide nelperiodo indicato
POLLICI CON UNA FALANGE IN PIO
TRONCO CEREBRALE TRONCO CEREBRALEDI SOGGETTO AUTISTICO
TRONCO CEREBRALEDI SOGGETTO NORMALE
L'autismo è associato ad alcune alterazioni nel tronco cerebrale, laregione che si trova immediatamente sopra il midollo spinale. Iltronco cerebrale di un soggetto autistico è più corto rispetto a
quello di una persona normale: nel punto di giunzione fraponte di Varolio e midollo allungato (o bulbo) le struttu-
re cerebrali come il nucleo facciale e il corpo trapezoida-le sono più vicine alle strutture del midollo allungato
(come il nucleo ipoglosso e il nucleo olivare inferiore).È come se mancasse un'intera striscia di tessuto.tronco cerebrale di una persona malata di autismo,inoltre, è privo del nucleo olivare superiore e pos-siede un nucleo facciale più piccolo del normale.Simili alterazioni possono verificarsi solamentedurante le fasi iniziali della gestazione.
/?-
CORPO
TRAPEZOIDALE
IT
FNUCLEOAL
0,2 MILLIMETRI
DISTANZA:
1-TNUCLEO OLIVARE
INFERIORE
NUCLEO FACCIALE
NUCLEOOLIVARE
SUPERIORE
CORPO
TRAPEZOIDALE
CERVELLETTO MIDOLLOALLUNGATO
NUCLEOIPOGLOSSO DISTANZA:
,1 MILLIMETRI
NUCLEO OLIVARE
INFERIORE
rg=
I difetti congeniti provocati dal talidomide variano a seconda del periodo di gestazio-ne durante il quale è avvenuta l'esposizione al farmaco. Uno studio del 1994 ha di-mostrato che le vittime del talidomide affette da autismo avevano anche anomalie al- g 2
le orecchie, ma arti normali. Questo farebbe pensare che il farmaco causa la malattiada 20 a 24 giorni dopo il concepimento, quando il sistema nervoso dell'embrione sta 13-ìappena cominciando a svilupparsi.
E
E
3
Un bambino malato di autismo ha unaspetto normale, almeno agli occhi deinon specialisti. Tuttavia, possiede alcuneanomalie fisiche tipiche della malattia: gliangoli della bocca sono più bassi rispettoal centro del labbro superiore, mentre leorecchie hanno un'attaccatura più bassadel normale e una forma più squadrata.
Ho incominciato a interessarmi allericerche sulle cause dell'autismo soloda poco tempo, e in verità abbastanzacasualmente: da embriologa quale so-no, le mie ricerche precedenti si eranofocalizzate sui difetti congeniti del cer-vello. Nel 1994, durante un congressoin cui si parlava proprio di tali difetti,mi è capitato di assistere a un semi-nario interessantissimo. Due oculistipediatri, Marilyn T. Miller, dell'Uni-versità dell'Illinois a Chicago, e Ker-stin Stremland dell'Università di Gite-borg, in Svezia, descrissero un risultatosorprendente emerso da uno studio suiproblemi di motilità oculare nelle vitti-me del talidomide, il farmaco usatocome tranquillante e anti-nausea cheaveva provocato un'epidemia di difetticongeniti negli anni sessanta. I sogget-ti dello studio erano adulti che eranostati esposti al farmaco mentre si tro-vavano nel ventre materno. Dopo averesaminato queste persone, Miller eStrórnland fecero un'osservazione chein qualche modo era sfuggita ai ricer-catori precedenti: quasi il 5 per centodelle vittime del talidomide era affettada autismo: una percentuale 30 voltepiù elevata di quella che si ritrova nellapopolazione generale.
Questi risultati furono per me una
vera e propria rivelazione e ne rimasifortemente impressionata. Nel tentati-vo di identificare le cause dell'autismosi era a lungo cercato di individuare ilmomento preciso in cui insorge la ma-lattia. Secondo le ipotesi che erano sta-te proposte, il disturbo avrebbe origi-ne durante l'ultimo periodo di gesta-zione o nei primi mesi di vita postnata-le, ma non si era trovata alcuna provaa sostegno dell'una o dell'altra delledue teorie. Il legame con il talidomidegettò all'improvviso una luce nuova epiù intensa su questo soggetto: indica-va infatti che l'autismo avesse originedurante le prime settimane di gravi-danza, quando il cervello e tutto il si-stema nervoso dell'embrione stannoappena incominciando a formarsi. Fuproprio il lavoro di Miller e di Stróm-land a convincermi del fatto che si sa-rebbe potuto svelare ben presto il mi-stero dell'autismo.
Fattori genetici eambientali
Almeno 16 bambini su 10 000 na-scono affetti da autismo o da una dellemalattie a esso collegate. Da quandol'autismo venne identificato, nel 1943,sono stati compiuti molti passi avanti
nella descrizione dei suoi sintomi. Lebasi biologiche dell'autismo, invece, sisono rivelate sfuggenti e questo ha im-pedito non solo di identificare i princi-pali fattori di rischio per l'autismo, maanche di mettere a punto nuovi farma-ci per curarlo. Esaminando il modo incui questo disturbo viene ereditato, si èosservato che l'autismo colpisce interefamiglie, anche se in un modo nonsempre chiaro. I figli degli individui af-fetti da autismo hanno una probabilitàche va dal 3 all'8 per cento di presenta-re i sintomi della malattia. Questa pro-babilità è di gran lunga superiore al ri-schio dello 0,16 per cento presente nel-la popolazione generale, ma è moltomeno di quel 50 per cento che rappre-senta la probabilità di sviluppare unamalattia genetica causata da una sin-gola mutazione dominante (in cui ungene difettoso ereditato da un genitorebasta da solo a provocare la malattia),o del 25 per cento relativo a una muta-zione recessiva (in cui è necessario cheuna copia del gene difettoso venga ere-ditata da ciascun genitore). I risultaticoncordano meglio con quei modelliche prevedono che alcune varianti disingoli geni contribuiscano al manife-starsi della malattia. Per complicare ul-teriormente le cose, i parenti dei malati
di autismo possono non presentaretutte le caratteristiche della malattia,ma solo alcuni dei suoi sintomi. Sebbe-ne queste persone possano recare alcu-ne delle varianti geniche legate all'auti-smo - qualunque esse siano - per qual-che motivo in loro i fattori geneticinon sono completamente espressi.
Studi effettuati nel Regno Unito sucoppie di gemelli confermano la com-ponente ereditaria dell'autismo, madepongono a favore di un ruolo daparte dell'ambiente. Per esempio, sefossero coinvolti solamente fattori ge-netici, i gemelli monozigoti (identici),che possiedono lo stesso patrimoniogenico, dovrebbero avere una probabi-lità del 100 per cento di essere affettidalla malattia. Invece, quando un ge-mello è autistico, la probabilità di unadiagnosi identica anche per l'altro ge-mello è solo del 60 per cento, mentresale all'86 per cento nei confronti di al-cuni dei sintomi tipici dell'autismo. Si-mili percentuali indicano che devonointervenire altri fattori a modificare lapredisposizione genetica alla malattia.E, in effetti, si conoscono già diversifattori di rischio ambientale: per esem-pio, l'esposizione in utero al virus del-la rosolia, o a sostanze che causano di-fetti alla nascita, come l'alcool etilico o
l'acido valproico (un farmaco antiepi-lettico), aumenta la probabilità che simanifesti l'autismo. Anche le personeaffette da alcune malattie genetiche,come la fenilchetonuria e la sclerosi tu-berosa, hanno una probabilità mag-giore di sviluppare autismo.
Nessuno di questi fattori da solo,tuttavia, si presenta con una frequenzatale da poter essere considerato re-sponsabile di molti dei casi di autismo.Per di più, è logico pensare che la mag-gior parte delle esposizioni a malattie oa sostanze pericolose agirebbe su en-trambi i gemelli di una coppia, e nonsolamente su uno dei due. Alcune del-le influenze ambientali devono dunqueagire in maniera più sottile di quelleidentificate finora. Non sappiamo an-cora in che modo fattori multipli sicombinino tra loro per far sì che i sin-tomi si presentino in certe persone, manon siano evidenti in altre, e ciò com-plica ulteriormente le ricerche sullecause dell'autismo.
L'embriologiadell'autismo
Nel loro studio del 1994, Miller eStriimland avevano evidenziato, comedetto, un altro contributo ambientale
all'autismo: l'esposizione al talidomi-de in utero. Tutti i soggetti indagati -adulti svedesi nati alla fine degli annicinquanta e all'inizio degli anni ses-santa - mostravano alcune delle mal-formazioni per cui il talidomide è tri-stemente famoso: braccia e gambe po-co sviluppate, orecchie e pollici mal-formati o mancanti, nonché disfunzio-ni neurologiche degli occhi e dei mu-scoli facciali. Siccome si conosce conesattezza lo stadio della gravidanzadurante il quale si sviluppa ciascun or-gano, si può stabilire precisamente ilgiorno in cui una malformazione puòessere indotta: il pollice viene colpitomolto precocemente, appena 22 giornidopo il concepimento; le orecchie so-no colpite dal ventesimo al trentatree-simo giorno, mentre braccia e gambedal ventiquattresimo al trentatreesi-mo giorno. Ciò che rese così interes-sante ai miei occhi questo nuovo stu-dio fu il fatto che Miller e Strómlandavessero scoperto che tutte le vittimedel talidomide affette da autismo mo-stravano anomalie nei padiglioni del-l'orecchio, ma nessuna malformazionedelle braccia o delle gambe. Questa di-stribuzione delle malformazioni indi-cava che i soggetti erano stati danneg-giati nei primissimi stadi della gesta-
80 81LE SCIENZE 380/ aprile 2000 LE sciENzE 380/ aprile 2000

La gamma dei disturbi collegati con l'autismo Categorie diagnostiche
na diagnosi di autismo richiedeche il paziente manifesti compor-
tamenti anomali in tre categorie com-portamentali e che mostri deficit parti-colarmente evidenti nella categoriadelle interazioni sociali. Sono stati i-dentificati diversi disturbi associati al-l'autismo, accomunati da alcune carat-teristiche comportamentali che però simanifestano con intensità diversa ocon sintomi aggiuntivi. Per esempio, ilcosiddetto «disturbo diffuso dello svi-luppo-non altrimenti specificato» (a-cronimo inglese PDD-NOS) individuaquei pazienti che non soddisfano com-
pletamente ai criteri diagnostici dell'auti-smo relativamente a una delle tre catego-rie. Così come accade nell'autismo, il PDD--NOS comprende pazienti con un'ampiagamma di QI. La sindrome di Aspergerdescrive invece pazienti con un QI norma-le e nessuna manifestazione di ritardo nellinguaggio. Due sindromi ancora più raresono il disturbo distruttivo dell'infanzia, incui il normale sviluppo infantile è seguitodalla regressione a una condizione di di-sabilità grave, e la sindrome di Rett, unamalattia neurologica progressiva che simanifesta solo nelle femmine.
L'autismo è stato ritenuto per molto
tempo una malattia ereditaria, ma studirecenti su base familiare compiuti dalgruppo di Peter Szatmari, della McMasterUniversity in Ontario, suggeriscono che sitratti di una gamma di sintomi che posso-no colpire in maniera variabile i membri diintere famiglie, piuttosto che di casi sin-goli. Per esempio, un bambino autisticopuò avere un fratello con la sindrome diAsperger, o una donna autistica potrebbeavere un nipote con il PDD-NOS. Questistudi fanno pensare che almeno tre dellediagnosi - l'autismo, il PDD-NOS e la sin-drome di Asperger - dipendano daglistessi fattori ereditari.
Incapacità di stabilire relazioni sociali:il soggetto non riesce a mantenere uncontatto visivo, né a utilizzare una qual-che forma di espressività facciale o digestualità per regolare i rapporti sociali;il soggetto non va in cerca di compa-gnia o di situazioni che lo confortino.
Incapacità di comunicare: il soggettonon riesce a utilizzare il linguaggio par-lato senza accompagnarlo con mo-vimenti stereotipati; non riesce a inizia-re o a sostenere una conversazioneanche quando è dotato di proprietàlessicali; i suoi dialoghi sono aberranti(per esempio, ripete una domandainvece di rispondere a essa).
Interessi limitati e comportamentiripetitivi: è presente una preoccupa-zione profonda e anormale nei con-fronti di un singolo soggetto o di unaspecifica attività; i cambiamenti sonofonte di gravi turbamenti; il soggetto siintestardisce in comportamenti abitu-dinari o in rituali privi di scopo; sonopresenti movimenti ripetitivi come ilbattere le mani.
La terapia comportamentale puòaiutare i bambini autistici a inserirsinella società. All'Eden Institute gliinsegnanti valutano attentamente isingoli casi e studiano un pianod'intervento personalizzato. Spessoincoraggiano i bambini a dedicarsiad attività ludiche stimolanti. L'Isti-tuto ospita anche adulti autistici co-me il trentasettenne in questa fotoche ha decorato la parete dietro illetto con bobine di videocassette.L'interesse ossessivo per certi ogget-ti è un tipico sintomo di autismo.
zione, da 20 a 24 giorni dopo il conce-pimento: addirittura prima che moltemadri scoprissero di essere incinte.
Agli occhi di un embriologo, per ca-pire che cosa è successo a un embrioneè fondamentale sapere quando questoqualcosa è accaduto. Nel caso dell'au-tismo indotto dal talidomide, il pe-riodo critico è molto più precoce diquanto molti ricercatori avrebberomai pensato. I neuroni che si formanodurante la quarta settimana di gesta-zione sono pochissimi e per la mag-gior parte si tratta di motoneuroni deinervi cranici: quelli che innervano imuscoli degli occhi, delle orecchie, delvolto, delle mascelle, della gola e dellalingua. I corpi cellulari di questi neu-roni sono situati nel tronco cerebrale,la regione che sta fra il midollo spina-le e il resto del cervello. Siccome que-sti motoneuroni si sviluppano contem-poraneamente all'orecchio esterno, sipuò prevedere che le vittime del ta-lidomide affette da autismo mostre-ranno anche disfunzioni dei nervi cra-nici. Miller e Stromland confermaro-no questa previsione: tutti ì soggettiautistici da loro studiati soffrivano dianomalie dei movimenti oculari o del-l'espressione facciale, o addirittura dientrambi.
La successiva, ovvia domanda fu: «Icasi di autismo da talidomide avevanoavuto un'esposizione simile ai casi diorigine sconosciuta, o si trattava didue situazioni differenti?». Al di là deisintomi comportamentali, i malati diautismo sono stati sempre descritti co-me dotati di un aspetto normale o ad-dirittura attraente: la statura è norma-le e la testa proporzionata o solo lie-vemente grande. I pochi studi che sisono occupati delle caratteristiche noncomportamentali delle persone conautismo, tuttavia, sono giunti allaconclusione che in molti casi sono pre-senti minime anomalie fisiche e neuro-logiche, e che si tratta delle stesse os-servate nell'autismo indotto dal ta-lidomide. Per esempio, alcune lievimalformazioni dell'orecchio esterno -e precisamente la rotazione posteriore,in cui la sommità dell'orecchio è ruo-tata all'indietro di oltre 15 gradi - so-no più frequenti nei bambini con auti-smo che nei bambini con uno sviluppotipicamente normale, nei bambini conritardo mentale o nei fratelli di bambi-ni autistici.
Le disfunzioni nei movimenti ocula-ri sono state associate con l'autismogià prima dello studio sul talidomide,e la mancanza di un'espressività fac-ciale è uno dei tratti comportamenta-li utilizzati per diagnosticare questacondizione patologica.
La neurobiologiadell'autismo
È possibile che tutti i sintomi del-l'autismo derivino da alterazioni nellafunzione dei nervi cranici? Probabil-mente no. È più verosimile che le di-sfunzioni nervose nelle persone malatedi autismo riflettano una lesione pre-coce del cervello che non solo interessai nervi cranici, ma ha anche effetti se-condari sullo sviluppo successivo delcervello. E cioè possibile che la lesionedel cervello possa in qualche modo in-terferire con il corretto sviluppo o conla funzionalità nervosa di altre regionicerebrali, comprese quelle coinvoltenelle funzioni superiori come il lin-guaggio, e produca i sintomi compor-tamentali dell'autismo. O forse le mal-formazioni dell'orecchio esterno e ledisfunzioni dei nervi cranici sono soloeffetti collaterali di una lesione che nonconosciamo ancora. Qualunque sia lacausa effettiva, le anomalie nei pazien-ti con autismo di origine ignota eranogrosso modo uguali alle anomalie ri-scontrate negli autistici vittime del ta-lidomide. La conclusione era chiara:molti casi di autismo, se non tutti, ave-vano inizio molto precocemente du-rante la gestazione.
La regione del cervello coinvoltanello studio del talidomide - il troncocerebrale - è stata raramente presa inconsiderazione negli studi sull'autismoo in studi di altra natura sui danni con-geniti al cervello, proprio per questaragione. Al tronco cerebrale si associa-no in genere le funzioni più basilari: larespirazione, l'alimentazione, l'equili-brio, la coordinazione motoria e cosìvia. Si pensa che molti dei comporta-menti che risultano alterati nell'auti-smo, come il linguaggio e la pianifica-zione e l'interpretazione dei segnali so-ciali, siano controllati da regioni delcervello situate a un livello superiore,come per esempio la corteccia cerebra-le e l'ippocampo.
Tuttavia, alcuni sintomi frequentinell'autismo - come la mancanza diespressività, l'ipersensibilità al contattoe ai suoni e i disturbi del sonno - sem-brano proprio quelli che probabilmen-te hanno origine nelle regioni del cer-vello associate con le funzioni di base.Per di più, l'anomalia osservata più re-golarmente nel cervello dei malati diautismo non è un cambiamento nellaparte anteriore del cervello, ma piutto-sto una riduzione nel numero di neuro-ni del cervelletto, la regione cerebraleche funge da centro di controllo dell'e-quilibrio e dei movimenti volontari.
Una delle cause delle difficoltà chesi incontrano nello studio dell'autismo
può dipendere dal fatto che tuttoranon conosciamo esattamente le regio-ni che controllano le funzioni disturba-te in questa malattia. Per esempio, ilgruppo di ricerca di Eric Courchesnedell'Università della California a SanDiego ha dimostrato che alcune regio-ni del cervelletto vengono attivate du-rante lo svolgimento di certi compi-ti che richiedono un elevato livello diprocessi cognitivi. Un'altra difficoltàè data dal fatto che i sintomi dell'au-tismo sono così complessi. Se si potes-se dimostrare che alla base del distur-bo vi sono semplici anomalie compor-tamentali, sarebbe più facile identifica-
re la loro origine nel sistema nervoso.Nel 1995, il nostro gruppo di ricer-
ca ebbe l'opportunità di seguire per uncerto tempo lo studio sul talidomide,esaminando il tronco cerebrale di unapersona con autismo. I campioni ditessuto provenivano dall'autopsia ese-guita su una giovane donna che ave-va sofferto di autismo dovuto a causeignote. La donna era morta negli annisettanta, ma i campioni del suo tessutocerebrale erano stati conservati. Quan-do ci mettemmo a esaminare il troncocerebrale del soggetto, fummo colpitidall'assenza di due strutture vicine: ilnucleo facciale, che controlla i muscoli
che permettono la mimica del volto, eil nucleo olivare superiore, che rappre-senta una stazione di relè per le infor-mazioni uditive. Entrambe le struttu-re hanno origine dallo stesso segmen-to del tubo neurale dell'embrione, lastruttura da cui prende origine il siste-ma nervoso centrale. Un calcolo delnumero di neuroni del nucleo faccialenel cervello della donna rivelò l'esisten-za di sole 400 cellule, mentre normal-mente i neuroni del nucleo facciale so-no quasi 9000.
Eppure il cervello della donna avevadimensioni normali: era infatti appenapoco più pesante di un cervello medio.
L'ipotesi che io formulai fu che il tron-co cerebrale fosse privo solamente deineuroni specifici già identificati - quel-li del nucleo facciale e del nucleo oliva-re superiore - e per verificare quest'i-dea decisi di misurare le distanze fraun certo numero di strutture neuro-anatomiche di riferimento. Con miagrande sorpresa l'ipotesi si rivelò deltutto sbagliata. Sebbene le distanze insenso trasversale fossero assolutamen-te normali, quelle lungo l'asse antero--posteriore risultavano sorprenden-temente ridotte nel tronco cerebraledella donna autistica. Era come seuna striscia di tessuto fosse stata a-
o
o
o
o
oo
LE SCIENZE 380/ apri le 2000
8382
LE SCIENZE 380/ aprile 2000

Un sintomoDecentemente ricercatori della York
University e dell'Hospital for SickChildren di Toronto hanno identificatoun comportamento collegato all'auti-smo molto più semplice da riconoscererispetto ai comportamenti tradizional-mente usati per diagnosticare questapatologia. Susan Bryson e il suo dotto-rando Reginald Landry hanno scopertoche i bambini autistici rispondono inmaniera anomala a un compito checoinvolge le loro capacità di reazione astimoli visivi. Poiché quest'attività men-tale è probabilmente mediata da unaregione primitiva del cervello - il troncocerebrale o il cervelletto, o forse en-trambi - la scoperta ha importanti impli-
a
n
BAMBININORMALIE AUTISTICI
BAMBININORMALI
BAMBINIAUTISTICI
BAMBININORMALIE AUTISTICI
Che cosa comporta una diagnosi di autismo
Quando a un bambino che presenta disturbi del comportamento vienefatta la diagnosi di autismo, tutti gli equilibri della famiglia ne risultano
sconvolti. Questo accade, in realtà, nei confronti di tutte le forme di handi-cap, ma nel caso dell'autismo c'è un'aggravante. Si scopre che un bambinodall'aspetto apparentemente normale trascorrerà tutta la vita chiuso in unmondo soltanto suo, senza cercare né contatti né manifestazioni di affetto,anzi sfuggendoli.
Ma non basta. Benché oggi si sappia che la malattia ha chiaramente basineurobiologiche - e genetiche, come spiega l'autrice di questo articolo - tut-tora molti genitori si sentono messi sotto accusa per le turbe comportamen-tali del figlio autistico. Infatti, come testimonia Cinzia Raffin, responsabilescientifica della Fondazione «Bambini e autismo» di Pordenone, accade spes-so che ai genitori venga proposta una psicoterapia famigliare, mentre essiavrebbero soprattutto bisogno di un aiuto pedagogico e riabilitativo per il fi-glio. In effetti, non è vero che non si possa fare nulla per integrare gli autisticinella società, come descrive molto bene Oliver Sacks in un suo libro.
Proprio per porre rimedio a questa situazione è sorta la Fondazione sopracitata, che vuole fornire ai genitori tutti gli elementi che li aiutino a capire co-me funziona la mente autistica e quali strategie siano più adatte per affronta-re i problemi che questo handicap comporta. I recapiti della Fondazione so-no: Galleria Asquini,1, 33170 Pordenone; tel. 0434 29187, fax 0434 524141.
ADRIANA GIANNINI
sportata dal cervello, e i due pezzi ri-manenti fossero stati ricuciti assieme,senza una giunzione visibile dove il tes-suto mancava.
Per la seconda volta nella mia vita,questa scoperta mi emozionò moltissi-mo. A turbarmi non fu tanto il risulta-to inatteso, ma l'avere capito che ave-vo già visto un fenomeno simile in unarticolo che riportava foto di cervellianormali di topo.
Quando recuperai quell'articolo dal-la pila dì carte che si ammucchiavanonel mio studio, trovai che la corrispon-denza fra il cervello che stavo studian-do e quelli dei topi descritti nell'artico-lo era addirittura più sorprendente diquanto avessi ricordato all'inizio. En-trambi i casi mostravano un accorcia-mento del tronco cerebrale, un nucleofacciale più piccolo del normale e l'as-senza del nucleo olivare superiore. Eanche altre caratteristiche dei topi e-rano chiaramente collegate con certeanomalie presenti nell'autismo: anche itopi presentavano malformazioni delleorecchie ed erano privi di una dellestrutture cerebrali che controllano imovimenti oculari.
Che cosa aveva modificato cosìprofondamente il cervello di quei to-polini? Non si trattava certo dell'espo-sizione al talidomide, né del contat-to con qualcuno degli altri fattori am-bientali associati all'autismo, ma del-l'eliminazione delle funzioni di un ge-ne. Si trattava di topi transgenici deltipo knock-out, modificati in mododa non poter più esprimere il geneHoxa1, e da permettere così ai ricer-catori di studiare il ruolo di questo ge-ne durante le prime fasi dello svilup-po embrionale. La domanda ovvia era:«Potrebbe trattarsi dì uno dei genicoinvolti nell'autismo?».
Il ruolo del gene HOXA 1
I dati in letteratura rafforzavano l'i-dea che Hoxal fosse un candidato ec-cellente per le ricerche sull'autismo.Gli studi sui topi knock-out dimostra-vano che Hoxal svolge un ruolo diprimo piano nello sviluppo del troncocerebrale. Diversi gruppi a Salt LakeCity e a Londra avevano studiato cep-pi differenti di topi knock-out, otte-nendo risultati simili. I ricercatori ave-vano trovato che il gene è attivo neltronco cerebrale quando i primi neu-roni si stanno formando: lo stesso pe-riodo che Miller e StrOmland aveva-no identificato come quello in cui il ta-lidomide provoca l'autismo. Hoxa1produce un tipo di proteina chiamatofattore di trascrizione, che modula l'at-tività di altri geni. Ma quel che è più
importante è che Hoxa1 smette di es-sere attivo dopo l'inizio delle prime fa-si dell'embriogenesi. Se un gene è atti-vo durante tutto il corso della vita, co-me accade per molti geni, un'alterazio-ne nella sua funzionalità porta solita-mente a problemi che si accentuanocon l'età. Un gene che sia attivo solodurante lo sviluppo rappresenta uncandidato migliore per spiegare un di-sturbo congenito come l'autismo, chesembra essere stabile dopo l'infanzia.Hoxa1 è ciò che i genetisti chiama-
no un gene «altamente conservato»,intendendo con ciò che la sequenza dinucleotidi che costituisce il suo DNAnon è cambiata significativamente du-
,rante il corso dell'evoluzione.Secondo noi questa dovrebbe essere
una caratteristica dei geni che risulta-no critici per la sopravvivenza: an-ch'essi vengono colpiti da mutazioni,come gli altri geni, ma è verosimile chela maggior parte dei cambiamenti siafatale, cosicché raramente queste mu-tazioni vengono trasmesse alle genera-zioni successive. Sebbene molti altrigeni si manifestino in diverse forme -per esempio, i geni che codificano peril colore degli occhi o per il grupposanguigno - quelli altamente conserva-ti non si presentano di frequente sottoforma di versioni multiple (conosciuteanche come polimorfismi allelici, o va-rianti alleliche). Il fatto che nessunoabbia mai scoperto una variante diHoxa1 in alcuna specie di mammiferofaceva pensare che potesse risultareproblematico trovarne una responsa-
che semplifica la diagnosicazioni per la neurobiologia dell'autismo.Il lavoro di Bryson e Landry potrebbe an-che servire a mettere a punto un sempliceprotocollo per diagnosticare la malattia.
Nel loro studio, i due ricercatori hannoosservato le reazioni di due gruppi dibambini, uno affetto da autismo e uno sa-no, mentre osservavano luci lampeggian-ti su uno schermo. L'età dei bambini an-dava da quattro a sette anni. Nel primotest, a ogni bambino messo di fronte auno schermo composto da tre pannelliveniva mostrata una luce lampeggiantenel pannello centrale. Lo stimolo induce-va i bambini a concentrare la propria at-tenzione sul lampo luminoso (a). In un se-condo tempo il pannello centrale si spe-
bile dell'autismo. D'altro canto, sem-brava plausibile che, se mai si fossetrovata una variante allelica, questasarebbe stata responsabile del manife-starsi del disturbo.
La versione umana del gene, chia-mata HOXA1, è situata sul cromoso-ma 7, ed è relativamente piccola: con-tiene appena due regioni che codifica-no per la proteina, o esoni, assieme aregioni che regolano il livello di sintesiproteica o che non hanno una funzio-ne apparente. Ogni mutazione che col-pisca qualunque parte del gene e che lomodifichi rispetto alla sequenza nor-male può anche modificarne il com-portamento; tuttavia la gran parte del-le mutazioni che causano una malattiasi trova proprio nelle regioni codifi-canti: perciò, incominciammo a cerca-re le varianti alleliche concentrandocisugli esoni di HOXA1. Utilizzandocampioni di sangue ottenuti sia dasoggetti autistici sia da soggetti di con-trollo, estraemmo il DNA e andam-mo a cercare le mutazioni nucleotidi-
gneva, e compariva una luce lampeggian-te sul pannello esterno, a destra o a sini-stra. Entrambi i gruppi di bambini sposta-vano lo sguardo verso quel pannello (b).Nel secondo test, però, le luci del pannellocentrale continuavano a lampeggiare an-che mentre sugli altri pannelli compariva-no le nuove luci. I bambini sani spostava-no lo sguardo per concentrarlo sul nuovostimolo (c), ma i bambini autistici rimane-vano «incollati» al primo stimolo e nonvolgevano lo sguardo su quello nuovo (c1).I due test sono stati ripetuti più volte suogni bambino.
Bryson e Landry hanno scoperto che ibambini con un diverso tipo di danno ce-rebrale risultano perfettamente normali
che rispetto alla sequenza normale.li dato positivo è che, in questo mo-
do, siamo riusciti a identificare due va-rianti alleliche di HOXA 1. Una di essecontiene una mutazione minore nellasequenza di uno degli esoni del gene:ciò significa che la proteina codificatadalla variante genica è lievemente dif-ferente dalla proteina codificata dalgene normale. Abbiamo allora studia-to nei dettagli questo nuovo allele,quantificandone la prevalenza fra di-versi gruppi di persone per determina-re se esso potesse avere un ruolo nelcausare l'autismo. (L'altra variante al-lelica è più difficile da studiare perchécoinvolge un cambiamento nella strut-tura fisica del DNA del gene.)
Abbiamo scoperto che la frequenzadella variante allelica nei malati di au-tismo era significativamente più ele-vata di quella che si riscontrava neimembri della loro famiglia che nonerano colpiti dal disturbo, ma era an-che più elevata di quella che si registra-va in individui non imparentati e sani.
in quanto a capacità di spostare l'attenzio-ne da uno stimolo all'altro. I bambini auti-stici, invece, sebbene più intelligenti, nonriescono proprio a distogliere la loro at-tenzione dal primo stimolo. I due ricerca-tori ipotizzano che la capacità di spostarel'attenzione da uno stimolo all'altro siauna funzione basale del cervello, poichécompare tipicamente già a tre-quattromesi dalla nascita anche nei bambini conun basso QI.
Anche gli animali vengono attratti dainuovi stimoli e quindi possono rappre-sentare un valido modello per verificare laresponsabilità delle manipolazioni geneti-che o dell'esposizione a sostanze tossichenell'insorgenza dell'autismo.
Le differenze erano molto più marcatedi quanto potesse essere attribuito allapura casualità.
L'aspetto negativo è dato dal fattoche, proprio come previsto dagli studisu base familiare, HOXA1 è solamen-te uno dei molti geni coinvolti nellagamma di disturbi dell'autismo. Per dipiù, l'allele che abbiamo studiato indettaglio risulta espresso a un gradovariabile, il che significa che la sua pre-senza non comporta necessariamenteche si manifesti l'autismo. Dati preli-minari indicano che la variante allelicasi presenta all'incirca nel 20 per centodelle persone che non sono malate diautismo, e nel 40 per cento circa diquelle che lo sono. Questo allele quindiapprossimativamente raddoppia il ri-schio di manifestare la patologia. Tut-tavia, circa nel 60 per cento delle per-sone con autismo l'allele non è presen-te, e questo significa che altri fattori ge-netici devono per forza contribuire allamalattia.
Per definire chiaramente questi fat-
84 LE SCIENZE 380/ aprile 2000 LE SCIENZE 380/ aprile 2000 85

RISTAMPEPER L'ANNO 2000
La collana «I grandi della scienza» haavuto e continua ad avere successonon solo in Italia. L'edizione tedescadi «Scientific American» ha già tra-dotto e pubblicato i primi quattrovolumi, e il «Galileo» è già prontonell'edizione francese di «Pour laScience». Tenendo conto delle con-tinue richieste di arretrati, abbiamodeciso di ristampare e distribuirenelle edicole, nei primi mesi del2000 e al prezzo invariato di lire9000 al volume, i seguenti testi:
GALILEO. di Enrico Bellone
NEWTON. di Nicolò Guicciardini
LAVOISIFR. di Marco Beretta
••••~*OR. n•n••••••n
CO.,1011•••••to~•••••••••n••••
..1.1.1••nn••••••
n•n•••••• I/••••••••
iir•••••••,•• • 4..
ma.*
DIFESE IMMUNITARIE
g Mb" Mora..
Sempre allo scopo di soddisfare lerichieste di arretrati, abbiamo anchedeciso di ristampare e distribuire, alprezzo invariato di lire 11000. i se-guenti «Quaderni»:
DIFESE IMMUNITARIEa cura di Alberto Mantovani
SPAZIO. TEMPO E RELATIVITÀa cura di Fernando de Felice
tori, dobbiamo continuare a cercare al-tre varianti di HOXA1, poiché la mag-gior parte dei disturbi di natura gene-tica è causata da molte varianti alleli-che diverse dello stesso gene. Cambia-menti in altri geni coinvolti nelle fasiprecoci dello sviluppo potrebbero a lo-ro volta predisporre i portatori all'auti-smo. Abbiamo già scoperto una va-riante allelica del gene HOXB1, un ge-ne situato sul cromosoma 17 che deri-va dallo stesso antenato di HOXA1 eche, durante lo sviluppo del tronco ce-rebrale, codifica per simili funzioni, mai cui effetti nell'autismo sembrano piùcontenuti.
Altri ricercatori stanno scandaglian-do alcune regioni del cromosoma 15 edi un'altra porzione del cromosoma 7.Sebbene si stiano focalizzando sugli al-leli che aumentano il rischio di auti-smo, è probabile che altri alleli possa-no diminuire questo rischio. Ciò po-trebbe contribuire a spiegare l'espres-sione variabile della gamma di disturbicollegati all'autismo.
Anche una minima comprensionedelle basi genetiche di questa malattiasarebbe estremamente utile. Per esem-pio, i ricercatori potrebbero trasferiregli alleli associati all'autismo dall'uo-mo al topo, modificandoli in modo darendere gli animali suscettibili alla ma-lattia. Esponendo poi i topi alle sostan-ze sospettate di aumentare il rischio diautismo, si potrebbe studiare l'intera-zione di fattori ambientali con il corre-do genetico e forse produrre un elencopiù aggiornato di quelle sostanze dacui una donna deve stare alla larga du-rante le prime fasi della gravidanza.Inoltre, studiando Io sviluppo di questitopi modificati geneticamente, saremoforse in grado di scoprire nuovi ele-menti sul danno cerebrale che sta alla
base dell'autismo; se potessimo deter-minare esattamente che cosa non fun-ziona nel cervello dei malati, non do-vrebbe essere difficile trovare terapiefarmacologiche o altre forme di tratta-mento in grado di correggere gli effettidel danno.
Mettere a punto un test genetico perl'autismo - simile agli attuali test per lafibrosi cistica, l'anemia falciforme o al-tre malattie - è un compito molto piùdifficile. Infatti, poiché la malattiasembra dipendere da più geni, analiz-zando semplicemente una o due va-rianti alleliche nei genitori non è possi-bile prevedere con esattezza la proba-bilità di generare un figlio autistico.
Tuttavia si potrebbero allestire testper i fratelli dei malati di autismo, iquali spesso temono che i propri figliereditino la malattia. Se la persona ma-lata di autismo possiede diversi atleticonsiderati ad alto rischio, mentre ilfratello non li possiede, si potreb-be rassicurare quest'ultimo sul fattoche i suoi figli non andranno soggettiai problemi manifestatisi all'internodella famiglia.
Non c'è nulla che possa rendere piùsemplice la ricerca delle cause dell'auti-smo. Tuttavia ogni fattore di rischioche riusciamo a identificare eliminauna parte del mistero. Più importan-te ancora, nuovi dati alimentano nuo-ve ipotesi. Proprio come i risultati sultalidomide hanno spostato l'atten-zione sul tronco cerebrale e sul geneHOXA1, nuovi dati che derivasserodalla genetica dello sviluppo, dagli stu-di sul comportamento, dalle tecnichediagnostiche per immagini e da moltealtre fonti potrebbero fornire nuovespunti per la ricerca e, col tempo, con-tribuire ad alleviare le terribili sofferen-ze provocate dalla malattia.
PATRICIA M. RODIER è professore di ostetricia e ginecologia all'Università diRochester. La Rodier si è occupata dei danni allo sviluppo del sistema nervoso finda quando studiava embriologia all'Università della Virginia, ma ha incominciatoa interessarsi all'autismo solo dopo aver conosciuto i risultati degli studi sul talido-mide. Per approfondire le cause genetiche e ambientali del disturbo la Rodier ha or-ganizzato un gruppo multidisciplinare di ricercatori provenienti da sei istituti.
STROMLAND K., NORDIN V., MILLER M., AKERSTROM B. e GILLBERG C., Autism inThalidomide Embryopathy: A Population Study in «Developmental Medicineand Child Neurology», 36, n. 4, pp. 351-356, aprile 1994.
RODIER P. M., INGRAM J. L., TISDALE B., NELSON S. e ROMANO J., Embryologi-cal Origin for Autism: Developmental Anomalies of the Cranial Nerve MotorNuclei in «Journal of Comparative Neurology», 370, n. 2, pp. 247-261, 24 giu-gno 1996.
GRANDIN TEMPLE, Thinking in Pictures: and Other Reports from My Life withAutism, Vintage Books, 1996.
Si può inoltre consultare il sito Internet (in inglese) della National Alliance forAutism Research all'indirizzo: www.naar.org
LE SCIENZE 380/ aprile 200086


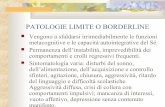



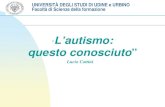
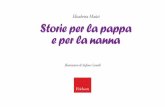
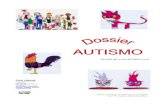


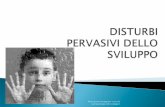
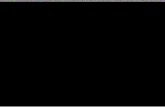

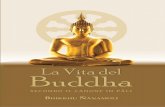
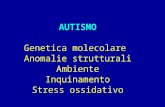
![[AAVV] Struttura Fondamentale Della Gnosi](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/577cdae31a28ab9e78a6cd44/aavv-struttura-fondamentale-della-gnosi.jpg)