Il percorso dei Giusti. La memoria del bene, patrimonio dell’umanità
ASSOCIATI PER CERCARE INSIEME DIO, SEGUIRE GESU’ …biblio.lasalle.org/bitstream/001/250/2/Carta...
Transcript of ASSOCIATI PER CERCARE INSIEME DIO, SEGUIRE GESU’ …biblio.lasalle.org/bitstream/001/250/2/Carta...
LETTERA PASTORALE AI FRATELLI
ASSOCIATI PER CERCARE INSIEME DIO,SEGUIRE GESU' CRISTO E LAVORARE
PER IL SUO REGNO
La nostra Vita Religiosa
Fratel Álvaro Rodríguez Echeverría, FSCSuperiore Generale25 dicembre 2005
25 dicembre 2005Natività del Signore
Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro GesùCristo, Padre misericordioso e Dio di ogni
consolazione, il quale ci consola in ogni nostratribolazione, perché possiamo anche noi consolare
quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizionecon la consolazione con cui siamo consolati noi stessi
da Dio (2 Co 1, 3-4).
Non c’è alcun dubbio che il Natale, l’incarnazione e la na-scita di Gesù, sia una delle più grandi consolazioni che ilPadre ci offre. E’ la manifestazione della sua immensa tene-rezza e del suo amore senza limiti né condizioni. Si tratta,nientemeno, che della manifestazione della umanità di Dio(Tit 3, 4). In tale manifestazione dell’umanità di Dio inCristo, possiamo comprendere meglio il sogno di Dio suciascuno di noi, la nostra vocazione originaria ad essere pie-namente umani come Gesù, l’uomo perfetto. Non possia-mo trattenere questa immensa grazia e questa straordinariaconsolazione solo per noi. Natale significa condividere contutti questo regalo che il Padre ci fa in Gesù e che rinno-viamo ogni anno come una tappa importante nel nostroimpegno per un mondo più umano.
Fratelli per vocazione, noi siamo chiamati a rendere visibi-le l’amore invisibile di Dio rivelato in Gesù, a lavorare in-
2
stancabilmente perché su ogni volto umano, soprattutto suquello dei ragazzi e giovani che educhiamo e su quello deipoveri che serviamo, l’immagine di Dio si manifesti piena-mente e il sogno di Dio si faccia realtà. In questo modo,come ci dice la Gaudium et Spes, saremo testimoni che stanascendo un nuovo umanesimo, in cui l’uomo è definito prin-cipalmente dalla responsabilità verso i suoi fratelli e di frontealla storia (55). BUON NATALE!
Il tema della presente Lettera Pastorale mi sembra corri-spondere molto bene alle precedenti parole. Il dono dellavocazione alla Vita Consacrata che abbiamo ricevuto, nonsoltanto dà pienezza alla nostra vita e ci riempie di consola-zione, ma esige anche che questo dono ricevuto lo condivi-diamo a favore dell’umanità. Come ci ha ricordato il Con-gresso della Vita religiosa del mese di novembre 2004, la no-stra passione per Cristo deve tradursi in passione per l’uma-nità. Non pretendo, nella seconda parte di questa Lettera,proporre un trattato sulla Vita Religiosa, ma solo ricordarealcuni aspetti che mi sembrano oggi di somma importanzae che personalmente mi hanno aiutato nel mio itinerariopersonale. “Associati per cercare insieme Dio, seguire GesùCristo e lavorare per il suo Regno” è un invito che mi faccioe che vi faccio perché possiamo vivere con maggiore auten-ticità la meravigliosa vocazione a cui siamo stati chiamati, fi-duciosi nella forza di Dio e non nei nostri meriti o sforzi.
Morte di Giovanni Paolo II ed elezione di Bene-detto XVI
L’anno che termina è stato testimone di momenti molto
3
speciali nella vita della Chiesa. La morte di Giovanni PaoloII ha avuto una ripercussione straordinaria a livello mon-diale, come anche l’elezione di Benedetto XVI. Senza dub-bio, noi ricordiamo tutti i messaggi che Giovanni Paolo IIci ha rivolto in occasione delle molteplici beatificazioni ecanonizzazioni di alcuni dei nostri Fratelli durante il suolungo pontificato o in occasione dei Capitoli Generali.Però, più che le sue parole, ci ha toccato il cuore la sua te-stimonianza di vita e il suo amore alla Chiesa, e in modoparticolare ai giovani. Come abbiamo detto nel messaggiodi condoglianze per la sua morte, raccogliamo come suo te-stamento le parole che ha diretto al Congresso della VitaConsacrata di novembre: “In questa situazione, ci diceva, iconsacrati e le consacrate sono chiamati ad offrire all’umanitàdisorientata, stanca e priva di memoria, la testimonianza in-credibile della speranza cristiana”.
Non dubito che tutti noi abbiamo chiesto allo Spirito Santoche accompagni ed illumini il nostro nuovo Pastore, chenella omelia di inizio della sua missione ci ha chiamato “te-stimoni della presenza trasfigurante di Dio”.
Visita agli Stati Uniti e al Canada
Durante quasi tre mesi, in gennaio-febbraio e aprile-mag-gio, accompagnato nella prima parte da Fr. Miguel Campose nella seconda da Fr. William Mann, ho avuto l’opportu-nità di realizzare la visita pastorale alle Province della Re-gione USA-Toronto e del Canada francofono, accompa-gnato in questa ultima Provincia da Fr. Claude Reinhardt.Alla fine abbiamo avuto l’incontro con il Consiglio Gene-
4
rale da parte di tutti i Visitatori della Regione USA-Toron-to e poi del Consiglio di Provincia del Canada francofono.
Malgrado le difficoltà che attualmente incontriamo in rela-zione alle vocazioni di Fratello, debbo testimoniare che lamissione lasalliana ha una grande vitalità, grazie all’associa-zione e alla missione condivisa con i laici e all’impegno ge-neroso degli stessi Fratelli. Particolarmente negli StatiUniti, più che in altri settori dell’Istituto, i Fratelli hannosaputo attrarre molti giovani-adulti che condividono oggi lanostra missione con una generosità straordinaria. Penso, inparticolare, ai nostri volontari con cui durante la visita hoavuto modo di incontrarmi; sono stati momenti indimen-ticabili in cui abbiamo condiviso sia la loro esperienza apo-stolica, sia la loro esperienza comunitaria con i Fratelli. Peròpenso anche ai numerosi incontri con diversi gruppi di gio-vani aperti al dialogo e capaci di condividere con semplici-tà e onestà le loro aspirazioni e difficoltà.
Un altro segno di vitalità e di servizio preferenziale ai pove-ri sono le scuole San Miguel e quelle di Cristo Re, in cui sirisponde con creatività ed efficacia alle necessità educativedi ragazzi e giovani emigranti di origine latina, afroameri-cana o asiatica, nelle periferie delle grandi città. Allo stessotempo, si fa uno sforzo nelle nostre altre scuole degli StatiUniti e Toronto per dare una formazione che sviluppi la so-lidarietà e la dimensione sociale degli alunni. Sono ancherimasto molto impressionato dai metodi di San Gabriel, diOcean Tides, di Tides Family Services e di La Salle ad Albany.Questi centri offrono un servizio incalcolabile a giovani chehanno problemi con la giustizia, in un ambiente capace di
5
trasformarli attraverso l’affetto e la vicinanza per comincia-re una nuova vita. Non voglio però dimenticare le altrescuole o forme di apostolato che, senza appartenere allestrutture suddette, realizzano un servizio a favore dei giova-ni in necessità o in situazione di rischio o con emigrantiadulti. Lo stesso possiamo dire dell’importanza che hanno inostri Colleges e Università, o Saint Mary’s Press, o il feno-menale servizio alla Vita Religiosa e alla Chiesa realizzato daChristian Brothers Services e da Christian Brothers InvestmentServices (CBIS).
L’ispirazione cristiana delle nostre scuole è molto chiara eho riscontrato negli alunni una grande apertura al religiosoe allo spirituale, che talvolta siamo timidi ad accompagna-re. Credo che sia interessante sottolineare la ricerca realiz-zata dal professor Mark M. Gray, dell’Università di Geor-getown, riportata dalla rivista Time di agosto di quest’anno,in relazione ai giovani nordamericani. I giovani nati dopo il1981 hanno una maggiore disponibilità ad assistere setti-manalmente alla messa, a pregare ogni giorno e ad aver fi-ducia nella Chiesa, rispetto alla generazione dei loro geni-tori. Questo studio mostra che il 50% dei giovani cattoliciassiste settimanalmente alla messa, rispetto al 39 % dellagenerazione precedente. Il 90% crede che la religione siaimportante in confronto al 77% della generazione che li hapreceduti. Questo non manca di essere sorprendente ecredo che sia un segno dei tempi per i Fratelli e i Lasallianidegli Stati Uniti, che non debbono trascurare.
Come si fa sempre, abbiamo inviato a ciascuna Provincia ealla Delegazione di Toronto una lettera con le nostre im-
6
pressioni e raccomandazioni a seguito della nostra visita;per questo, qui voglio solamente aggiungere che uno dei se-greti dell’eccellente coinvolgimento dei laici nella spiritua-lità e nella missione lasalliana sono stati i programmi di for-mazione locale, provinciale, regionale e nazionale. Come ri-sultato, abbiamo potuto constatare una coscienza più pro-fonda della loro vocazione rispettiva e la pratica vissuta deivalori lasalliani. In questo senso, una delle esperienze piùinteressanti è la partecipazione di ogni Provincia nordame-ricana al Consiglio della Missione Educativa Lasalliana,struttura che sta favorendo nuove iniziative e il carattere cri-stiano e lasalliano dei nostri centri educativi.
Non meno gradita è stata la visita alla Provincia del Cana-da francofono. In essa attira l’attenzione il numero di Fra-telli che hanno dedicato parte della loro vita a un serviziomissionario e la maniera previdente e generosa con cuihanno preparato la continuazione in settori come il Giap-pone e Haiti. Malgrado la loro età avanzata, i Fratelli hannosaputo mantenere lo zelo ardente e la creatività apostolicaper rispondere a nuove necessità. Così abbiamo Comunitàpastorali; una biblioteca di spiritualità aperta al pubblico;un “Café cristiano” che accoglie persone in cerca non solodi una tazza de caffè, ma della possibilità di condividere ipropri problemi e di trovare un aiuto; un centro di cate-chesi per ragazzi e giovani di moltissime scuole; residenzeper universitari; campi estivi… ecc. In tutte queste opereappare chiaramente il desiderio e la preoccupazione dievangelizzare. Ha attirato molto la mia attenzione anche lacura che i Fratelli hanno per i Fratelli infermi e anziani e l’a-bilità con cui la Provincia fa in modo che continuino ad es-
7
sere attivi apostolicamente, conservando gli ideali giovanilimolto al di là degli anni.
La qualità e la generosità dei giovani che appartengono aqualche movimento lasalliano sono meravigliose. Sono dasegnalare la nuova comunità di Québec, destinata a lavora-re con giovani-adulti e essere un centro di animazione vo-cazionale, e la nuova comunità di Montreal per il serviziodegli emigranti. Si spera di poter incorporarvi Fratelli degliStati Uniti e dell’America Latina, come risposta concreta daparte delle tre Regioni dell’America al progetto di lavorareinsieme in questa linea.
Visita alle Antille
Nel mese di luglio, per due settimane, assieme a Fr. MiguelCampos, ho visitato la Delegazione delle Antille in occasio-ne del Centenario dell’arrivo dei Fratelli a Cuba, con atten-zione alla creazione di una nuova entità amministrativa. In-fatti, negli ultimi tre anni la Delegazione sta studiando ilmodo migliore di dare impulso al processo di unificazionecon un’altra Provincia. Oltre a partecipare alle celebrazionidel centenario nelle diverse isole, Cuba, Repubblica Domi-nicana, Puerto Rico e Haiti, e condividere lo stesso cente-nario con gli ex-alunni di Miami, ho potuto partecipare al-l’Assemblea dei Fratelli della Provincia del Messico Sud, cheha avuto luogo a Città del Messico con la presenza di alcu-ni Fratelli delle Antille.
Da una parte, le celebrazioni del Centenario, come in tantialtri luoghi dell’Istituto, sono state una manifestazione della
8
traccia profonda lasciata dai Fratelli e Collaboratori in tantegenerazioni di giovani che riconoscono con gratitudine ciòche hanno appreso sui banchi di scuola. Vorrei sottolinearei nostri ex-alunni di Cuba che, malgrado la lunga assenzadei Fratelli, hanno saputo conservare lo spirito lasalliano.La celebrazione della festa del Fondatore durante questi de-cenni senza Fratelli nell’isola, ne è una prova, come lo è, pergli ex-alunni di Miami, l’impegno assunto ad Homesteadverso gli emigranti messicani e di altri paesi dell’AmericaLatina.
In secondo luogo, la mia presenza voleva essere un segno eun incoraggiamento per il processo di unificazione, non fa-cile ma certamente necessario, per assicurare la vitalità e lapresenza del carisma lasalliano in queste terre. All’inizio del-l’anno, il settore di Haiti si è integrato nella Delegazionedelle Antille e ora si sta continuando lo studio per una pos-sibile integrazione con la Provincia del Messico Sud, crean-do una nuova entità. Nella mia visita ai diversi settori dellaDelegazione ho potuto constatare con gioia la speranza rap-presentata dal numero e dalla qualità dei postulanti diCuba, Haiti e Repubblica Dominicana.
Giornata mondiale della Gioventù
Ancora una volta siamo stati testimoni dell’entusiasmo chela Giornata Mondiale ha donato ai giovani, questa volta aColonia e con Benedetto XVI. Qualcuno ha detto che i gio-vani, Giovanni Paolo II andavano a vederlo e BenedettoXVI vanno ad ascoltarlo. Senza dubbio, i suoi messaggi digrande profondità possono ispirare le nostre catechesi con i
9
giovani che ci sono affidati. Ha attirato molto la mia atten-zione l’intervista che hanno fatto al Papa il 15 agosto, in re-lazione con la ormai già prossima Giornata Mondiale dellaGioventù. Condivido con voi una delle sue risposte, chepuò darci delle indicazioni per rinnovare il linguaggio concui ci rivolgiamo ai giovani e recuperare la fiducia nel no-stro ministero apostolico, ispirato sempre da un profondoamore. “Vorrei mostrare la bellezza di essere cristiani, perchéesiste l’idea diffusa che i cristiani debbano osservare un grannumero di comandamenti, proibizioni, principi, ecc., e chepertanto il cristianesimo, secondo questa idea, sia qualcosa chestanca e opprime la vita e che si è più liberi senza tutti questilimiti. Vorrei invece mettere in risalto che essere sostenuti da ungrande Amore e da una rivelazione non è un peso, ma è avereali, e che è bello essere cristiani. Questa esperienza allarga l’o-rizzonte, ma soprattutto ci dà una comunità. E’ sapere che,come cristiani, non siamo mai soli: in primo luogo incontria-mo Dio, che sta sempre con noi; e poi ci incontriamo tra noi,formiamo una grande comunità, una comunità in cammino,che ha un progetto di futuro: tutto questo fa sì che viviamo unavita che vale la pena di essere vissuta. La gioia di essere cri-stiani e anche che è bello e giusto credere” (Intervista a Bene-detto XVI, 15 agosto 2005).
Il Fratello Roger Schutz
Senza dubbio tutti noi abbiamo appreso con molto dolorela notizia della tragica morte del Fratello Roger. Oltre almeraviglioso ecumenismo che ha saputo sviluppare attra-verso la vita monastica, vorrei segnalare l’influsso che hasempre avuto sui giovani. Durante molti anni, centinaia di
10
migliaia di giovani sono passati per Taizé, meditando iltema “vita interiore e solidarietà umana”. Cercando di sco-prire, nelle fonti della fede, un senso per la propria vita e unimpegno di servizio agli altri, lì dove vivono. Il filosofo PaulRicoeur, morto anche lui quest’anno, che ha visitato Taizédurante gli ultimi cinquanta anni, esprimeva così la propriaesperienza: Che cosa vengo a cercare a Taizé? Direi un tipo disperimentazione di ciò che più profondamente credo. Cioè, chequello che generalmente si chiama religione ha a che vedere conla bontà... E’ un po’ dimenticato, in modo particolare in varietradizioni del cristianesimo. Voglio dire che c’è un certo tipo dichiusura, di restrizione sulla colpevolezza e il male. Non è chesottovaluti questo problema, che mi ha tenuto occupato moltodurante vari decenni. Però ciò che ho bisogno di verificare, inqualche modo, è che per quanto il male sia molto radicale, maisarà così profondo come la bontà. E se la religione, le religioni,hanno un senso, è quello di liberare il fondo di bontà degli es-seri umani, andare alla sua ricerca là dove si trova completa-mente sotterrato. Ora, qui a Taizé, vedo irruzioni di bontànella fraternità tra i fratelli, nella ospitalità tranquilla e di-screta, e nella preghiera, in cui vedo migliaia di giovani, chenon hanno l’articolazione concettuale del bene e del male, diDio, della grazia e di Gesù Cristo, ma che hanno un’attrazio-ne fondamentale verso la bontà.
Vorrei chiudere il ricordo di quest’uomo meraviglioso,icona attuale di ciò che deve essere la nostra vita religiosa,con alcune parole del suo messaggio detto in occasione del-l’Incontro europeo dei giovani a Lisbona: “Dio prepara pervoi un avvenire di pace e non di tristezza; Dio vi vuole dareun futuro e una speranza” (cfr. Ger 29,11; 31,17). Moltitu-
11
dini aspirano oggi a un avvenire di pace, a una umanità li-berata dalle minacce della violenza. Se alcuni sono sopraf-fatti dall’inquietudine di fronte al futuro e si sentono im-mobilizzati, ci sono però anche, attraverso il mondo, giova-ni creativi, pieni di inventiva. Questi giovani non si lascia-no trasportare da una spirale di malinconia. Sanno che Dionon ci ha fatto per essere passivi. Per loro, la vita non è sot-tomessa ai capricci della fatalità. Sono coscienti del fattoche ciò che può paralizzare l’essere umano è lo scetticismoo lo scoraggiamento. Questi giovani cercano anche, contutta la loro anima, di preparare un avvenire di pace e nondi tristezza. Anche se non se lo immaginano, riescono a faredella loro vita una luce che illumina già il loro ambiente.
Sinodo dei Vescovi sull�Eucaristia
Con questo Sinodo abbiamo chiuso l’anno dedicato all’Eu-caristia. Ho avuto l’opportunità di partecipare a questo im-portante evento ecclesiale come uditore. Il primo giorno, ilPapa ha svolto una riflessione molto bella sulla lettura del-l’ora terza e il 10 ottobre ho avuto la possibilità di salutarlopersonalmente giacché ogni giorno riceveva due circoli mi-nori durante la sosta del lavoro della mattina. L’ho trovatomolto semplice e amabile e si è interessato alla situazionevocazionale del nostro Istituto. Il 12 ottobre, ho avuto l’op-portunità di rivolgermi all’Assemblea Sinodale. Ho parlatodei giovani e l’Eucaristia. In confronto con i Sinodi prece-denti ci sono state due novità. La prima è stata un’ora di in-terventi liberi dei Padri Sinodali, che non sempre ha rispo-sto alla sua finalità, visto che alcuni approfittavano per pre-sentare un testo scritto preparato previamente; la seconda è
12
stata l’autorizzazione a pubblicare le proposte del Sinodo alPapa, in modo che tutti possono già disporre sia del Mes-saggio del Sinodo che di queste proposte, in attesa dellaEsortazione Apostolica postsinodale.
Del Messaggio del Sinodo voglio sottolineare l’allusionefatta alla vita religiosa e il suo accenno ai giovani.
Salutiamo e ringraziamo tutte le persone consacrate, porzionescelta della vigna del Signore, che testimoniano gratuitamentela Buona Notizia dello Sposo che viene (cfr. Ap 22, 17-20). Lavostra testimonianza eucaristica di sequela di Cristo è un gridodi amore nella notte del mondo, una eco dello Stabat Mater edel Magnificat. Che la Donna eucaristica per eccellenza, coro-nata di stelle e immensamente feconda, la Vergine dell’Assun-zione e l’Immacolata Concezione, vi mantenga nel servizio diDio e dei poveri, nella gioia di Pasqua, per la speranza delmondo (Messaggio, 20).
Cari giovani, il Santo Padre Benedetto XVI vi ha detto e ripe-tuto che non perdete nulla dandovi a Cristo. Ripetiamo le sueparole forti e serene della Messa di inizio del suo ministero chevi orientano verso la vera felicità, rispettando completamentela vostra libertà: “Non abbiate paura di Cristo! Lui non pren-de nulla, e dà tutto. Chi si dà a lui, riceve il cento per uno. Sì,aprite, aprite completamente le porte a Cristo, e troverete lavera vita”. Abbiamo fiducia nelle vostre capacità e nel vostrodesiderio di sviluppare i valori positivi del mondo e di cam-biare ciò che è ingiusto e violento. Contate sul nostro appoggioe sulla nostra preghiera perché, uniti, ci possiamo confrontarecon la sfida di costruire il futuro con Cristo. Siate le “sentinel-
13
le dell’aurora” e gli “esploratori del futuro”. Non smettete dibere alla fonte della forza divina della Sacra Eucaristia perrealizzare le trasformazioni necessarie (Messaggio, 21).
Nel Sinodo sono stati toccati molti temi riguardanti l’Eu-caristia, alcuni dal punto di vista teologico, altri da quellospirituale, pastorale, normativo e disciplinare. Più che ideenuove, sono stati sottolineati aspetti che tutti conosciamo.Vorrei condividerne due che mi sembrano poter vivificare ilnostro essere eucaristico.
Il primo, riguarda i nostri Fratelli a riposo. Alcuni mesi faho ricevuto una lettera da due di loro che suggeriva chenelle nostre case di Fratelli anziani si potrebbe organizzarel’Adorazione eucaristica, permanente o in alcuni giorni,come un modo di rendere presente al Signore la missioneapostolica dell’Istituto e pregare per l’incremento delle vo-cazioni. Il Messaggio del Sinodo ha rivolto una parola dispeciale affetto alle persone che soffrono. Attraverso il dolo-re che sperimentate nel vostro corpo e nel vostro cuore parteci-pate in modo speciale al sacrificio della Eucaristia, come testi-moni privilegiati dell’amore che da essa deriva. Siamo sicuridel fatto che nel momento in cui sperimentiamo la debolezza ei nostri limiti, la forza della Eucaristia può essere un grandeaiuto (Messaggio, 23). Credo che questa iniziativa sarebbeun bel modo di aiutare l’Istituto nella sua conversione per-manente e una maniera concreta di rispondere ai desideridel Sinodo, che ha dato ampio spazio all’adorazione eucari-stica che nasce e non può essere separata dal mistero euca-ristico, in cui si concentra il massimo dell’adorazione e del-l’impulso a dare la vita per gli altri.
14
E pensando ai Fratelli di tutte le età, mi interrogo sul modoin cui celebriamo la domenica, giorno del Signore, che èstato un altro dei punti centrali della preoccupazione sino-dale. La proposta n. 30 ci ricorda: E’ necessario tornare ad af-fermare il carattere centrale della domenica e della celebrazio-ne dell’Eucaristia domenicale nelle diverse comunità della dio-cesi, in special modo nelle parrocchie (cfr. “Sacrosanctum Con-cilium” 42). La domenica è veramente il giorno in cui si cele-bra con gli altri il Cristo risorto, giorno santificato e consacra-to al Creatore, giorno di riposo e di disponibilità. La celebra-zione eucaristica domenicale è una grazia umanizzante perl’individuo e la famiglia, perché nutre l’identità cristiana conil contatto con il Risorto. Per questo, il dovere di partecipare ètriplice: in rapporto a Dio, a se stessi e alla comunità.
La testimonianza che ci presenta il Messaggio nella conclu-sione, non finisce di interpellarci: All’inizio del quarto seco-lo, il culto cristiano era ancora proibito dalle autorità impe-riali. I cristiani del nord Africa (49 martiri di Abissinia), le-gati fortemente alla celebrazione del Giorno del Signore, sfida-rono la proibizione. Morirono martiri dichiarando che nonpotevano vivere senza la celebrazione domenicale dell’Eucari-stia (Messaggio, 26).
Visita alla Grecia e all�isola La Reunión
Come inizio della visita pastorale alla Provincia di Francia,che avrà luogo in aprile e maggio dell’anno prossimo, hoavuto la gioia di visitare due dei suoi settori: la Grecia e LaReunión. Durante la visita alla Grecia ho potuto esserepresente nelle nostre due comunità e nelle nostre tre scuo-
15
le del Pireo, di Syros e di Tessalonica e partecipare ad uninteressante Congresso educativo che trattava il tema:Guardando verso il futuro e che ha riunito praticamente latotalità degli educatori lasalliani. Ciò che ha attirato mag-giormente la mia attenzione, una volta di più in un am-biente in cui il cattolicesimo è fortemente minoritario, èl’eccellente relazione e il lavoro insieme con la maggioran-za ortodossa, che si vive all’interno delle nostre opere.Come dappertutto, gli alunni si trovano bene nei nostricentri educativi e i valori lasalliani di fede, fraternità e ser-vizio vi hanno pieno spazio. Ne sono stati segni significa-tivi, ad esempio, la cena del Vescovo cattolico di Syros as-sieme al Metropolita ortodosso, alla comunità dei Fratellie a tutti i sacerdoti della diocesi; o la testimonianza dell’ar-chimandrita Metodio, nostro cappellano nella Scuola delPireo, che ha una spiritualità lasalliana straordinaria chenon ha paura di testimoniare e valorizzare.
Ha pure richiamato la mia attenzione lo spirito religioso chesi respira nei nostri centri educativi come anche l’interesseper l’apprendimento delle lingue straniere e l’apertura all’U-nione Europea. Ci preoccupa la diminuzione del numerodegli alunni, dovuta al calo della natalità e al fatto che le no-stre scuole non ricevono nessuna sovvenzione e questo rendedifficile l’accesso ai meno agiati. Un’altra preoccupazione èquella del limitato numero dei nostri Fratelli greci e dellamancanza di vocazioni negli ultimi anni, che speriamo possainvertirsi. D’altra parte, è da ammirare il modo in cui unbuon numero di laici vive la missione condivisa e l’associa-zione in un clima ecumenico. Durante il Congresso, a cuihanno partecipato anche i Fratelli Claude Reinhardt, Consi-
16
gliere, e Jacques d’Huiteau, Visitatore, è stata commovente lapresenza di un ex alunno della nostra Scuola di Sofia, in Bul-garia, che portava il saluto degli ex-alunni che vi avevano be-neficiato della presenza dei Fratelli prima del comunismo.
La mia esperienza a La Reunión non è stata meno interes-sante. Questa piccola isola dell’Oceano Indiano, di una bel-lezza sorprendente, ha una grande importanza nella nostrastoria lasalliana. Non solo per essere stata un nucleo diespansione dell’Istituto che ha permesso l’arrivo dei Fratelliin Madagascar e nell’Isola Maurizius, ma anche per il ricor-do del nostro Beato Fratello Scubilión, di cui ho potuto ve-nerare la tomba. Egli resta per noi un testimone che ci invi-ta a continuare l’opera di liberazione che lui intraprese intempi di schiavitù e che noi siamo chiamati a continuare inun mondo in cui si vivono altri tipi di oppressione. La Reu-nión è un miscuglio di etnie, culture e religioni armonica-mente integrate, in cui lo spirito religioso continua ad esse-re molto vivo. Le nostre quattro scuole, dirette attualmenteda laici lasalliani, continuano la missione di educazione cri-stiana che ci ha affidato la Chiesa, secondo quanto ha affer-mato Mons. Aubry durante la nostra visita all’Episcopio. Al-cune difficoltà recentemente vissute sono state pienamentesuperate. Anche qui il numero dei Fratelli diminuisce e nonpossiamo contare su nuove vocazioni di Fratelli, però lo spi-rito e la missione lasalliana godono di buona salute.
Mi ha impressionato principalmente la vitalità del “Consi-glio locale di animazione lasalliana” (CLAL), strutturanuova per me, che tra le altre cose vuole assicurare una ca-techesi e una pastorale di qualità nelle nostre scuole, se-
17
condo quanto hanno affermato alcuni dei suoi membri inun incontro con i rappresentanti delle quattro scuole aMaison Blanche. Altra cosa che mi ha commosso profon-damente è stata la presenza, durante la visita, dei due di-rettori laici e di un rappresentante del direttore, delle trescuole lasalliane che avevamo nell’Isola Maurizius, da cui iFratelli sono partiti nel 1992, e che attualmente sono sottotutela diocesana. La loro presenza e il loro desiderio di con-tinuare una relazione con noi attraverso La Reunión e laProvincia di Francia, mi sono apparse come un segno dellatraccia indelebile che La Salle lascia in coloro che sono statitoccati dal nostro carisma.
18
ASSOCIATI PER CERCARE INSIEME DIO,SEGUIRE GESU� CRISTO E LAVORARE PER IL
SUO REGNO
La nostra Vita Religiosa
Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia epace nella fede, perché abbondiate nella speranza
per la virtù dello Spirito Santo (Rm 15,13)
Il fatto di essere associati per cercare insieme Dio, seguireGesù Cristo e lavorare per il suo Regno, ci impegna inun’avventura appassionante, malgrado le difficoltà che laVita Religiosa sembra subire oggi. Il Congresso Internazio-nale della Vita Consacrata, celebrato a Roma nel mese dinovembre 2004, rappresenta una tappa importante nel pro-cesso di discernimento che, a partire dal Vaticano II e dainostri Capitoli di rinnovamento, abbiamo intrapreso percontinuare a scoprire ciò che lo Spirito di Dio sta facendo na-scere tra noi, per rispondere alle sfide del nostro tempo e co-struire il Regno di Dio. In questa Lettera Pastorale, vorreirafforzare e indirizzare verso il futuro gli sforzi che negli ul-timi decenni stiamo realizzando, per vivere con maggioreautenticità la nostra vita di Fratelli e rispondere alle sfideche ci interpellano all’inizio del nuovo millennio, per pote-re così essere testimoni dell’umanità nuova manifestata inGesù Cristo.
Oggi, più che mai, abbiamo bisogno di una speranza che cirenda testimoni fedeli. Trasmette speranza solo chi vive lasperanza, donandosi a colui che è la nostra Speranza (José
19
María Arnáiz). E la speranza ci deve portare a restituire allaVita Religiosa tutto il suo incanto, come dissi nelle parolefinali rivolte al Congresso. Più che con speculazioni, pos-siamo capire ciò che è e vuol dire “incanto” nell’attrazioneche Gesù ha prodotto nei suoi primi discepoli. La sua per-sona offriva ciò che Geremia aveva affermato parlando dellasua vocazione: una “seduzione” irresistibile che il profetaqualifica come “violenta”, per esprimere la forza con cui siimponeva. Quando i discepoli si sentirono attratti da Gesù,non importò loro lasciare quanto avevano per seguirlo edare una svolta alla loro vita. Per questo le domande che cidovremmo porre sono: la nostra vita religiosa di Fratelli haoggi il “fascino” sufficiente per richiamare l’attenzione e se-durre? E che cosa dobbiamo fare perché questo avvenga?
Oggi ci preoccupano molte cose, però il Signore ci dice cheuna sola cosa è necessaria. Stiamo vivendo un momento diincertezza, ma la risposta principale è quella di vivere conmaggiore autenticità ciò che siamo e ciò che Dio vuole chesiamo. Questo implica la lotta contro la mediocrità e la su-perficialità e il vivere appassionatamente la nostra vocazione.Anche per noi, il maggior ostacolo può essere la grazia abuon mercato come la descriveva Dietrich Bonhoeffer: Lagrazia a buon mercato è il nemico mortale della nostra Chie-sa. Oggi combattiamo a favore della grazia che costa cara. Lagrazia a buon mercato è la giustificazione del peccato e non delpeccatore. La grazia a buon mercato è la predicazione del per-dono senza pentimento, del battesimo senza disciplina, dell’eu-caristia senza confessione dei peccati. La grazia a buon merca-to è la grazia senza la sequela di Cristo, la grazia senza croce,la grazia senza Gesù Cristo vivo e incarnato. La grazia che
20
costa cara è il tesoro nascosto nel campo per il quale l’uomovende tutto ciò che ha. E’ cara perché chiama alla sequela diGesù Cristo, è cara perché costa la vita all’uomo. Soprattutto ècara perché è costata cara a Dio, perché è costata la vita del suoFiglio - “Siete stati comprati a caro prezzo” - e perché ciò che ècostato caro a Dio non può risultare a buon mercato per noi.
L’invito non può essere più esigente. Si tratta di una presadi coscienza delle due coordinate su cui ci dobbiamo muo-vere: Dio e la persona umana, mistica e profezia. Un atto difede nella nostra vocazione e nel suo valore oggi per ilmondo, in modo che possiamo continuare ad essere per igiovani prolungamento nella storia di una speciale presenzadel Signore risorto (VC 19). Una Vita Religiosa con “fasci-no”, che richiami l’attenzione per il suo modo di essere e divivere, in un’epoca di disincanto. Una Vita Religiosa alter-nativa ai valori che il mondo globalizzato oggi ci offre e cherenda realtà il comandamento di Gesù: Tra voi non deve es-sere così (Mc 10, 42-43).
Credo che valga la pena. Ci racconta il gesuita Manuel Al-calá che, poco tempo dopo essere stato eletto Papa, Giovan-ni Paolo II, in una Udienza all’Unione dei Superiori Gene-rali (USG), domandò se la Vita Religiosa aveva un futuronella Chiesa. Una domanda che lasciò perplesso il padreArrupe, allora Generale dei Gesuiti e presidente della USG,e i Superiori Generali presenti all’udienza. Santità, risposepadre Arrupe, se non lo credessimo, non saremmo qui. Pensoche questa dovrebbe essere anche la nostra risposta. Kafka ciha lasciato la descrizione di una vasta città in cui di notte ve-gliano solo poche persone. E quella di un immenso accam-
21
pamento in cui tutti dormono, eccetto alcune sentinelle.L’autore si chiede: Perché solo alcuni stanno svegli, mentretutti gli altri dormono? E si risponde: E’ necessario che qual-cuno vegli, che qualcuno stia lì. Forse questa dovrebbe essereanche la nostra risposta, come uomini consacrati a Dio perla vita del mondo, consacrati ai giovani, ai poveri e a tutticoloro che ci chiedono ragione della nostra speranza.
Itinerario personale
Non possiamo vivere una Vita Religiosa anonima. La nostraricerca di Dio, la nostra sequela di Gesù, la costruzione delRegno, implicano, oltre ad una esperienza comunitaria,anche un indispensabile itinerario spirituale personale. Parla-re del nostro itinerario vuol dire situarci di fronte al mistero;per questo non è facile e tutto ciò che possiamo dire non èaltro che un balbettio… In realtà, si tratta di un doppio mi-stero, quello di Dio e quello della persona umana, fatta a suaimmagine e somiglianza. Di fronte al mistero di Dio è me-glio tacere, è più facile dire ciò che non è rispetto a ciò che è.
E’ una scoperta sempre nuova che presuppone un continuotornare a ricominciare e non vivere di rendita, come dicemolto bene il vescovo ortodosso Anthony Bloom: Ancorarela nostra mente ad una grazia passata vuol dire perdere le gra-zie future. Il Dio che ho conosciuto ieri non sarà necessaria-mente quello che mi si rivelerà domani. Non ti puoi nutrire dimemorie. Le memorie sono morte, mentre Dio non è il Dio deimorti ma dei vivi. Dio è eternamente nuovo. Avvicinati a Luidisposto ad essere sorpreso. Convinciti del fatto che non lo co-nosci e che oggi può mostrare un volto diverso da quello che ti
22
immaginavi. Non mettere a posto di Dio le immagini di Dioche tu hai elaborato nel passato: questa è idolatria spirituale.Ripeti la preghiera: Signore, liberami da tutti i concetti passa-ti che mi sono formato su di Te. Ciò che dobbiamo fare quan-do ci avviciniamo a Dio è raccogliere tutti i concetti passati cheavevamo di Lui, depositarli nella cantina della nostra mente,e quindi avvicinarci a Dio, coscienti del fatto che stiamo fac-cia a faccia con un Dio vicino e insieme sconosciuto, infinita-mente semplice e infinitamente complesso. Dobbiamo guarda-re con la mente e il cuore aperti, senza cercare di dare unaforma a Dio o di racchiuderlo in concetti o immagini: solo al-lora possiamo bussare alla sua porta.
Di fronte al mistero della persona umana, ci troviamo da-vanti un essere paradossale di cui San Tommaso afferma cheè l’unica creatura che Dio ha amato per se stessa e che è unorizzonte tra due mondi, cioè, un essere frontiera tra l’uni-verso corporale e l’universo spirituale. I Salmi ci presentanocosì questa doppia valenza: Eppure l’hai fatto poco menodegli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato, tutto hai postosotto i suoi piedi (Sal 8). Il Signore sa che non siamo che fango(Sal 103). Creati da Dio, tendiamo all’infinito; provenientidal nulla, tendiamo al nulla. Parlare del nostro itinerariovuol dire certamente situarci di fronte al mistero.
Diceva il poeta León Felipe, nato in Spagna e morto inMessico:
Nessuno è andato ieriné va ogginé andrà domani
23
verso Dioper questo medesimo camminosu cui vado io. Per ogni uomoil soleha in serbo un raggio nuovo di lucee Dio un cammino vergine.
Il mio itinerario è unico, irripetibile, inedito, avventura sem-pre aperta, imprevedibile. Si traccia il cammino andando(Antonio Machado). E’ l’esperienza che visse il nostro Fon-datore: Dio che guida tutte le cose con sapienza e dolcezza e chenon è abituato a forzare l’inclinazione degli uomini, volendoimpegnarmi a prendere interamente cura delle scuole, lo fece inmodo totalmente impercettibile e in molto tempo; in manierache un impegno mi portava ad un altro, senza averlo previstoall’inizio (Memoriale delle origini).
Ciò che abbiamo detto non può essere estraneo alla nostravita religiosa. Da una parte, sono unico e prezioso per Dio.Basta ricordare due testi di Isaia: Ti ho chiamato per nome,tu mi appartieni (Is 43,1); Si dimentica forse una donna delsuo bambino? Anche se queste donne si dimenticassero, io in-vece non ti dimenticherò mai. Ecco ti ho disegnato sulle palmedelle mie mani (Is 49,15-16). Da un’altra parte, sono chia-mato a unificare la mia vita in Lui, come possiamo intuirenella esperienza di San Agostino: Tardi ti ho amato, Diomio, bellezza sempre antica e sempre nuova, tardi ti ho amato.Tu stavi dentro di me e io ero fuori e così da fuori ti cercavo e,deforme come ero, mi lanciavo sopra le cose belle che Tu haicreato. Tu stavi con me però io non stavo con Te. Mi chiama-
24
sti e gridasti e rompesti la mia sordità; brillasti e risplendesti ecurasti la mia ferita; esalasti il tuo profumo e io lo aspirai e orati cerco; Ti ho gustato e ora sento fame e sete di Te (Confessio-ni 10, 26, 38).
Siamo unici, certamente, però determinati in gran partedagli altri. In questo senso Pablo Neruda diceva: Mi sembradi aver vissuto la vita degli altri. E Salman Rushdie, nato aBombay e educato a Londra, nel libro “I figli di mezzanot-te” affronta lo stesso problema: Chi o che cosa sono io? Lamia risposta è che sono il risultato di tutte le addizioni che sonostate prima di me, di tutto ciò che io sono stato, ho visto e fatto,come di tutto ciò che mi è stato fatto. Io sono ogni persona edogni oggetto la cui esistenza nel mondo mi ha toccato o è statatoccata dalla mia. Sono tutto ciò che dovrà accadere dopo cheio me ne sarò andato, che non sarebbe successo se io non ci fossistato. Io non sono in questo una eccezione; ogni “io” alberga insé una moltitudine simile. Lo ripeto per l’ultima volta: per ca-pirmi hai bisogno di conoscere un mondo. Il problema filoso-fico dell’uno e del molteplice è, alla fin dei conti, il proble-ma fondamentale dell’essere umano.
Unificare la nostra vita è il nostro principale compito. Per-ché siamo qualcosa di più di una somma di esperienze. E’importante prendere coscienza del fatto che io sono causa enon solo un effetto, che posso e debbo essere un nucleo ir-raggiante e non solo un centro ricettivo. Se è vero, come di-ceva Ortega y Gasset, che io sono io e le mie circostanze, tut-tavia è vero che il nostro io è centro dinamico, punto dipartenza e non solamente di arrivo, e che la vita è attualiz-zazione di un ricco potenziale che portiamo dentro, spinto
25
da una forza divina, perché siamo esseri abitati da Qualcu-no che ci supera e trascende permanentemente.
Per raggiungere questo obiettivo, di conseguenza, debbopartire da una esperienza fondante e non da una teoria, perquanto bella possa essere. Esperienza rinnovata ogni giorno,che dia ragione di ciò che sono e di ciò che faccio, che uni-fichi in Dio tutto il mio essere.
Esperienza fondante
Esperienza personale e non teoria. Per questo possiamo par-tire dalla testimonianza di Pascal quando ci racconta il mo-mento fondamentale che ha cambiato la sua vita nella nottedel 23 novembre del 1654, il cui ricordo consegna ad un fo-glio di carta, il famoso “Mémorial”, che portò sempre consé cucito nella fodera della giubba: Anno di grazia 1654, lu-nedì 23 novembre, giorno di San Clemente. Dalle dieci di seracirca, fino a mezzanotte e mezza più o meno. Il fuoco! Dio diAbramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, non dei filosofi e deisapienti. Certezza, gioia, sentimento, allegria, pace.
La nostra vita religiosa, intesa sia come il nostro naturaletendere a Dio che come chiamata di Gesù Cristo a seguirela sua vita con lo stile di La Salle, non può avere altro fon-damento che quello di una esperienza personale. Si tratta diun’attrazione profonda, quasi irresistibile, verso Dio, di unaesperienza spirituale, del fatto che Dio è l’Assoluto e chetutto il nostro essere ha il suo riferimento ultimo in Lui. E’l’esperienza di amare e di essere amato; è la certezza delfatto che Dio è tutto.
26
Il gesuita brasiliano Joao Batista Libanio, in un articolo chemi ha molto aiutato durante i miei anni di formatore inCentroamerica nel momento di discernere con i giovani leloro motivazioni vocazionali, ci presenta questa esperienzacome una pietra inamovibile, una chiamata continua alprimo amore. In fondo, è l’esperienza evangelica di Gesù inrelazione col Padre da cui sgorga la sua donazione salvatri-ce a favore dei fratelli e sorelle, specialmente dei poveri epiccoli. E’ permettere a Dio di occupare lo spazio della no-stra affettività e di amare attraverso di noi. E’ lasciarci se-durre da Lui. Karl Rahner lo esprimeva con queste parolead una rivista europea in occasione dei suoi 80 anni, pochigiorni prima della sua morte: Il vero culmine della mia vitadeve ancora arrivare. E’ l’abisso del mistero di Dio, in cui unosi precipita con la speranza di essere accolto eternamente dalsuo amore. Che cosa spero? La luce di Dio, la sua eternità e lasua misericordia. Spero di poter pregare con Teresa d’Avila, il“Niente ti turbi… solo Dio basta”, e con Ignazio di Loyola:“Prendi Signore e ricevi… dammi il tuo amore e la tua gra-zia, perché questo mi basta”. Ambedue formano un’orazioneche si pregherà non solo con le parole, ma in pienezza di vitaper sempre.
Esperienza che è una grazia gratuita di Dio, certamente, mache suppone la nostra collaborazione. Nei Vangeli non pos-siamo separare la persona di Gesù dalla sua missione. L’unaè comprensibile solo con l’altra. La spiritualità lasalliana ciha insegnato, a sua volta, a non fare differenza tra i doveridel nostro stato e la nostra stessa salvezza. Per noi è chiaroche la migliore maniera di procurare la gloria di Dio è il no-stro servizio ai giovani che educhiamo, specialmente a quel-
27
li che hanno più bisogno di noi, come diciamo nella nostraformula di Consacrazione. L’esperienza fondante ci permet-te di vivere la nostra missione come un prolungamento del-l’azione salvifica di Dio e ci evita di cadere in un attivismoo in una mera professionalizzazione della nostra missione.
Fratel John Johnston, già nella Lettera Pastorale del 1990, cimetteva in guardia dal pericolo che corriamo di vivere l’atti-vità professionale e apostolica al margine della nostra vita re-ligiosa. Ciò è dovuto al fatto che l’impegno nell’apostolato nonè stato presentato con sufficiente chiarezza come parte integran-te della consacrazione del Fratello a Dio (R 7), e siccome non siè insistito sullo “zelo ardente” come su una dimensione essen-ziale dello spirito dell’Istituto, molti di noi non siamo stati glievangelizzatori che avremmo dovuto essere. Siamo stati uominidi scuola con moltissimo successo, però, a volte, ci siamo ritenu-ti eccessivamente soddisfatti per aver dato un’educazione diqualità, ma senza preoccuparci di essere ministri dei giovani edi fare delle scuole centri di effettiva educazione religiosa e ser-vizio pastorale, nello stesso tempo in cui ne facevamo centri dieccellenza accademica o tecnica (pag. 17).
Il problema può nascere quando viviamo la nostra azioneapostolica come un fine in se stesso o come una mera ricer-ca della nostra realizzazione, quando Dio in essa divienequalcosa di relativo o secondario o, nel peggiore dei casi,inesistente. In questi casi la nostra vocazione è in serio pe-ricolo, perché se ciò che mi sostiene è il carattere assolutoche ho attribuito alla mia azione, può arrivare il momentoin cui questa non mi dice più nulla, o in cui penserò cheposso realizzarla meglio fuori delle strutture della Vita Reli-
28
giosa, o in cui, visto che oggi viviamo l’associazione e lamissione condivisa con i laici, penserò che non ci sia biso-gno di continuare ad essere religioso per viverla efficace-mente. O posso cadere in una seria depressione quando, acausa della malattia o dell’età, non potrò continuare a rea-lizzarla.
Però, se Dio è la ragione ultima del nostro cammino, pos-sono pure arrivare tsunami e uragani: la nostra barca potràsembrare sul punto di naufragare, ma potremo andareavanti, non in virtù della nostra forza, ma perché, malgra-do le nostre debolezze, Dio continua ad essere la ragione ul-tima della nostra vita e sappiamo che ci sta accanto.
Qui potremmo porci la questione delle nostre motivazionivocazionali. C’è un testo del Fondatore che mi sembramolto pertinente, quando ci dice nelle “Considerazioni che iFratelli debbono fare di tanto in tanto, e soprattutto durante ilRitiro”: Riflettete sullo stato che avete abbracciato e su come cisiete entrati: se l’avete fatto, cioè, per ottemperare agli ordini ealla volontà di Dio. Se c’è stato qualcosa di male, ritrattatelo;se l’intenzione non è stata sufficientemente pura, formulatelabene adesso; immaginate, anzi, di entrarvi ora e protestate cheintendete restarvi, solo perché credete che questa è la volontà diDio (Raccolta, XI, 1-2).
Sappiamo che la motivazione iniziale non è necessariamen-te quella che deve sostenerci oggi. Nel nostro itinerario ènecessario in qualche momento avere sperimentato informa viva, come Pascal, quel fuoco incandescente che hatrasformato la nostra vita e l’ha centrata in Dio (il Novizia-
29
to sembrerebbe il luogo e il tempo più propizio, però lestrade di Dio sono misteriose e i ritmi personali diversi).L’importante non è quale sia stata la prima cosa che mi hamotivato, ma cosa è ciò che oggi mi motiva e mi spinge adonare la mia vita al Signore, totalmente e senza condizio-ni.
Fede viva e zelo ardente
In chiave lasalliana possiamo tradurre l’esperienza fondantenello spirito di fede e di zelo che ci viene proposto dal Fon-datore e che ci permette di integrare gli elementi costitutividella nostra vocazione: consacrazione, comunità e missione.
Identità-interiorità e Comunione sono le due dimensionibasilari della persona. Il mio itinerario mi deve permetteredi essere me stesso e di essere-per-gli-altri. La Scrittura illu-mina la nostra vocazione originale già fin dalla prima pagi-na della Genesi. Quattro aspetti appaiono come fondamen-tali per sviluppare la doppia dimensione costitutiva dellanostra persona:• Aspetto teologico: Facciamo l’uomo a nostra immagine e so-
miglianza. (Gn 1, 26). Nel più profondo del nostro es-sere incontriamo Dio. Come diceva Sant’Agostino: Dioè più intimo a me di me stesso. La nostra prima vocazioneè partecipare della vita divina. Siamo chiamati ad esserefigli di Dio.
• Aspetto sociale: Non è bene che l’uomo sia solo (Gn 2, 18).Come è stato detto, nessun uomo è un’isola. La relazio-ne con gli altri è parte costitutiva del nostro essere.Siamo chiamati ad essere fratelli degli altri.
30
• Aspetto cosmico: Riempite la terra e sottomettetela (Gn 1,28). La relazione con le cose è un’altra parte costitutivadel nostro essere. Siamo chiamati ad essere signori dellanatura.
• Aspetto storico: Yahvé Dio prese l’uomo e lo pose nel giardinodi Eden perché lo coltivasse e custodisse (Gn 2, 15). La crea-zione è posta in mano alla persona umana per essere con-tinuata attraverso la sua creatività e la sua libertà respon-sabile. Siamo chiamati ad essere costruttori della storia.
Lo spirito di fede e di zelo, che costituisce lo spirito del no-stro Istituto, ci permette di vivere, in modo integrato, que-ste quattro dimensioni: figlio, fratello, signore, costruttore.San Paolo sintetizzava questo doppio movimento con que-ste parole: l’unica cosa che conta è la fede che opera per mezzodella carità (Gal 5, 6). Il Fondatore parte da una logica ele-mentare. Il Fratello, chiamato a trasmettere lo spirito del cri-stianesimo, deve essere lui stesso un cristiano convinto cheincarna nella sua vita il Vangelo che vuole trasmettere. Fedee zelo sono inseparabili.
La fede e lo zelo ci aprono nuove prospettive, quelle di Dio,per avere uno sguardo contemplativo che ci permetta di sco-prire la trasparenza di Dio nel Vangelo, nella personaumana, nel povero, in noi stessi, nella natura, nella storia.La fede e lo zelo ci permettono di discernere alla luce dellaParola ciò che è più conveniente per la realizzazione delpiano salvifico di Dio. La fede e lo zelo ci invitano ad averefiducia nel Signore che dirige la storia umana con sapienza eamore e ad abbandonarci a Lui. E questo, a partire dalle trecertezze che illuminarono e sostennero la vita del nostro
31
Fondatore. La certezza della presenza di un Dio sempre vi-cino. La certezza della sua azione misteriosa ma efficacenella storia dell’umanità. La certezza del fatto che siamo im-pegnati nell’opera di Dio.
Il Fondatore, nelle Regole comuni del 1718, ci dice chequesto è lo spirito che deve animare tutte le nostre azioni edeve essere il motore di tutta la nostra condotta, e che co-loro che non l’hanno o che l’hanno perduto debbono con-siderarsi come membri morti; è ciò che la Regola attualetraduce nella seguente maniera: La conoscenza e l’acquisizio-ne dello spirito dell’Istituto sono il primo obiettivo della for-mazione iniziale dei Fratelli. La crescita in questo spirito pro-segue durante l’intera esistenza e si estende a tutte le dimensio-ni della loro vita (R 8).
Con un tale spirito si comprende come il Fondatore abbiaportato avanti l’ “impresa”, malgrado che spesso, come ripeteBlain: la barca stesse sul punto di naufragare o l’edificio sulpunto di crollare. Oggi, come ieri, anche noi possiamo guar-dare al futuro con fiducia se ci lasciamo portare da tale spiri-to. Non sarà questo il segreto di una fedeltà creativa e il mododi presentare ai giovani una vocazione che vale la pena?
Amare e essere amati
Fede e Zelo sintetizzano l’essenziale del Vangelo: amare Dioe amare il prossimo. Personalmente sono convinto del fattoche qui sta il cuore non solo della nostra vocazione di Fra-telli, ma anche della Vita Religiosa. E’ curioso che abbiamodato quasi sempre più importanza ai consigli evangelici che
32
al doppio comandamento dell’amore. In realtà i consigli sonoin funzione del comandamento dell’amore.
Vita Consecrata afferma che la Vita Consacrata manifesta ilcarattere unitario del comandamento dell’amore, nel vincoloinseparabile tra amore di Dio e amore del prossimo (VC 5). Eil Fondatore affermava, in un testo che abbiamo conserva-to come un tesoro nell’esergo della nostra Regola attuale,che è necessario che i Fratelli applichino a se stessi e prendanoper fondamento e sostegno della loro Regolarità ciò che dice S.Agostino all’inizio della sua Regola: che quelli che vivono inuna Comunità devono prima di tutto amare Dio e poi il Pros-simo, perché questi sono i più grandi comandamenti che Dio ciha dato... (R pag. 17). La Regola, che esprime la nostra vita,deve di conseguenza essere per noi uno strumento al servi-zio dell’amore. L’amore è la sua ragion d’essere e il suo fine.
Mi consacro fondamentalmente per Cristo. E per Cristo,alla maniera di San Paolo, si bruciano i giorni e le notti peril Vangelo. Nello stesso modo in cui i figli di Zebedeo la-sciano la loro barca e le loro reti, o Matteo il suo banco e isuoi conti, perché sono stati catturati da Gesù che passava,così anche noi facciamo la nostra consacrazione perché ab-biamo incontrato Cristo e perché Lui ci ha catturato. Siamonon tanto nell’ordine morale, ma nell’ordine teologale. E’questo il senso delle parabole del tesoro o della perla.
Di conseguenza, possiamo affermare che la base e il culmi-ne della Vita Religiosa, la sua radice e il suo frutto, il suoprincipio e la sua fine, è l’amore. Solo nell’amore e comepassione di amore questa scelta ha un senso. Il Congresso
33
della Vita Consacrata ce lo ha ricordato sintetizzando il suomessaggio nella passione per Cristo e nella passione per l’u-manità. Amore che, a sua volta, si capisce solo a partire dal-l’esperienza di fede. Essere cristiano significa vivere secondoCristo, far dipendere dalla verità di Cristo il senso della pro-pria vita; essere religioso significa portare ad un radicalismoparticolarmente impegnato la vita di fede, cioè, la giustifica-zione della propria vita e di tutta una serie di strutture (di po-vertà, di celibato, di obbedienza, di vita comune...) che inaltro modo non sarebbero assunte nella propria vita. Questa èla ragione per cui il religioso che dubita della sua fede, sente ilterreno venir meno sotto i suoi piedi, si sente fuori della real-tà... Mentre il cristiano laico che sente vacillare la propria fedepuò trovare ancora un senso nella vita di lavoro o nella fami-glia, il religioso, al contrario, lo percepisce come un rischio inu-tile per la sua vita, carente di senso, e questo fa crollare i valo-ri fino al punto di renderla insopportabile. Scopre che il cam-mino del mondo è più sicuro e se ne va. O, se non ha abba-stanza forza per ritirarsi, continua a viverci con la legge delminimo sforzo, facendo della sua vita religiosa non più unascelta per Cristo, bensì il risultato di un calcolo. ‘Mi conviene,visto e considerato tutto, rimanere dentro’, con una vita reli-giosa il più possibile tranquilla e imborghesita (Rovira).
Questa chiamata all’amore la esprimiamo in un modo par-ticolare attraverso il nostro voto di castità che, secondo laRegola, è il dono del nostro amore totale a Dio, che ci li-bera per servire le persone e dedicarci al Regno di Dio. Nonè un voto di disamore, ma di radicalismo nell’amore. Sgor-ga dalla esperienza stessa dell’amore umano, che nella suapiù profonda dimensione è aperto e chiede un amore asso-
34
luto. La castità non nasce da una assenza o privazione, madalla proiezione e dallo straripare di una sovrabbondanza.
Possiamo comprenderlo con un racconto di Albert Camusintitolato L’Adultera, incluso nel suo libro “L’esilio e ilregno”. Vi si parla di una donna che accompagna suo ma-rito attraverso il deserto algerino. Una notte, dopo essersiuniti e amati come fanno gli sposi, essa si scopre insoddi-sfatta. Dorme a lato di suo marito, però veglia abbandona-ta, come donna vicina ad un estraneo. L’amore matrimo-niale, vissuto ogni giorno in forma uguale, le risulta insuf-ficiente. Per questo, nel mezzo della notte stellata del deser-to, con i suoi occhi ben aperti sotto lo sguardo delle stelle edella luna, lascia che l’amore misterioso della notte la inon-di. Non fa niente. Semplicemente sente la presenza delcosmo nella sua anima: si lascia amare e lascia che il miste-ro della notte arrivi alla sua esistenza umana, femminile,come luce e torrente di amore. Solo così, attraverso l’estasidell’amore cosmico, può ritornare alla pensione in cui se-guita a dormire suo marito.
Nel nostro caso, non si tratta di un tipo di unione misticacon il cosmo. La nostra esperienza di insufficienza e la no-stra sete di pienezza si concentrano nella persona di Gesù.Lui mi ha amato (Cfr. Gal 2, 19-20) e il suo amore fonda esostiene per sempre la mia esistenza e la mia capacità didono. Questo vuol dire che dobbiamo avere il cuore pieno diDio come lo sposo ha il suo cuore pieno della donna che ama(San Giovanni Crisostomo).
Mi ispiro a una bella conferenza dell’Assistente Fr. Patrice
35
Marey, per vedere le conseguenze di questo tipo di amore.L’amore consacrato ci aiuta ad accettare la solitudine, comeelemento costitutivo della natura umana. L’amore nel celi-bato esige anche di rinunciare al paternalismo possessivo.L’amore nel celibato è capace di dire: Ti amo, però non persottometterti al mio servizio, non per farti essere un altro io. Tiaccetto come sei. Sii te stesso. L’amore nel celibato ha molto daimparare dagli sposati, dai padri e dalle madri che ci inse-gnano il valore della tenerezza, della fedeltà, dell’attenzionead una persona... L’amore nel celibato è un amore creatore.
Nel campo educativo un essere è posto di fronte a me. Nonho su di lui alcun diritto di possesso e il mio primo lavorocome educatore deve essere quello di cercare ciò che la suavita può rappresentare e arrivare ad essere agli occhi di Dio.La castità educa la nostra relazione educativa non soloproibendoci atti impuri, ma, soprattutto, orientando lanostra relazione affettiva in rapporto ai giovani che ci sonoaffidati. Non è il voto repressivo che ci chiude in un vico-lo senza uscita. E’ il voto dell’apertura dell’amore di Dioper la persona umana attraverso l’amore fraterno che le of-friamo. Qualcosa di simile possiamo dire anche in relazio-ne ai Fratelli della Comunità, della Provincia, della Regio-ne o dell’Istituto.
Da parte sua, il nostro voto di povertà afferma che solo Diobasta, che Lui è l’unico Signore e che non possiamo per-mettere che le cose o il denaro funzionino come divinitànella nostra vita. Di questo facciamo una professione, unaincarnazione visibile nella Chiesa e di fronte al mondo. E’ciò che ci dice la Regola: Con la povertà evangelica, i Fratel-
36
li si fanno poveri per seguire Cristo povero e per servire megliogli uomini, loro fratelli, soprattutto i più sprovvisti di mezzi”(32). La povertà, come la castità, in fondo sono questionedi amore. Una volta di più i voti si unificano. E’ l’esperien-za di Charles de Foucauld: Signore Gesù, come diventerà ra-pidamente povero colui che, amandoti con tutto il cuore, nonpotrà soffrire di essere più ricco del suo amato. Essere ricco amio agio, vivere dolcemente dei miei beni, quando Tu hai sof-ferto una vita sacrificata, vivendo penosamente di un duro la-voro! Io non posso; io non posso amare così.
Per mezzo dell’obbedienza ci poniamo al servizio del pro-getto del Padre: un disegno di amore totale alla personaumana, che comincia dall’emarginato e abbandonato e siestende a tutta l’umanità. Dio offre la vita in pienezza atutti i suoi figli e li rende fratelli. Obbedire a Dio, come èstato per Gesù e deve esserlo per noi, vuol dire amarloamando i giovani fino a dare la vita per loro. Però questodono non è solo un impegno in un tipo di lavoro, ma so-prattutto una relazione di amicizia con il Signore Gesù inuno stile di vita; un amore, che si fa desiderio di compierela sua Volontà, di amare ciò che Lui ama e di rischiare perquello per cui Lui ha rischiato. Si tratta di una consacrazio-ne totale alla sua Persona.
Come sappiamo molto bene, ed è stata una riflessione del-l’Istituto negli ultimi anni, i nostri voti specifici, cioè asso-ciazione per il servizio educativo dei poveri e stabilità,hanno la medesima finalità orientata all’amore. Amore percoloro che più hanno bisogno di noi e per i quali dobbia-mo essere disposti a dare la vita, come ci invita il Fondato-
37
re. Amore che ci fa scoprire, sotto i loro cenci, il volto diGesù. Amore che ci fa impegnare irrevocabilmente a rima-nere uniti al loro servizio, convinti che questa è la nostramaniera particolare di dare gloria a Dio.
Un nuovo linguaggio: Icone bibliche
Durante il Congresso si è ripetuto molte volte che qualcosadi nuovo sta nascendo. Non si tratta del tempo futuro, ma diuna realtà presente, certamente balbettante ma reale. Tra glialtri segni, potremmo segnalare quelli di una Vita Consa-crata più cosciente della sua diversità nella comunione, inatteggiamento di ascolto, di discernimento e di ricerca, cen-trata sul Vangelo e in funzione del Regno, serva, aperta al-l’universale (inculturazione-interculturalità), articolatasempre più attorno a famiglie carismatiche, con un’intensapassione per Cristo e per l’umanità, particolarmente l’uma-nità povera e sofferente.
Esprimere questo richiede un nuovo linguaggio. Un lin-guaggio che favorisca la comunione e accresca la passione;meno razionale e teorico, più intuitivo e vitale. Un lin-guaggio che renda più significativa la Vita Consacrata pergli uomini e le donne di oggi, soprattutto per i giovani. Unlinguaggio che non può limitarsi solamente alle parole.
Vita Consecrata parte dall’icona della Trasfigurazione comesimbolo esplicativo della vocazione speciale alla Vita Con-sacrata e dei suoi tratti essenziali. In fondo, questo linguag-gio vuole esprimere che Gesù ha un’enorme capacità di se-duzione e che può trasfigurare la vita dei suoi seguaci e con-
38
figurarla secondo lo Spirito e la volontà del Padre. L’iconadella Trasfigurazione offre una immagine poderosa e piena dirisorse per capire l’identità della vocazione alla Vita Consacra-ta. E’ una immagine trinitaria, capace di spiegare il senso piùprofondo di questa forma di vita, come seduzione da partedella bellezza e energia per la missione. La Vita Consacrataappare così come uno stile di vita che mira a confessare il Mi-stero della Trinità nel cui seno si sente avvolta (José Cristo ReyGarcía Paredes). Da più di trecento anni la nostra consa-crazione lasalliana è centrata sulla Santissima Trinità la cuigloria, per quanto ci sarà possibile e lei lo richiederà da noi,costituisce il fine ultimo della nostra vita di Fratelli.
La Trasfigurazione è un segno del potere di trasformazioneche Gesù ci offre. Un invito ad ascoltarlo e a seguirlo finoalle ultime conseguenze, un esigente invito a conformarci aLui. Sappiamo, d’altra parte, che uno degli aspetti caratteri-stici della spiritualità lasalliana è il suo cristocentrismo.Senza dubbio il Fondatore lo ereditò dalla Scuola francese dispiritualità del secolo XVII. Nel Direttorio spirituale del Se-minario di San Sulpizio, in cui il Fondatore è rimasto per 18mesi, questo era il principale obiettivo: L’obiettivo primo e de-finitivo di questo Istituto è di vivere totalmente per Dio in Cri-sto Gesù Nostro Signore, in modo tale che l’interiorità di suo Fi-glio penetri nell’intimo del nostro cuore e permetta a ciascunodi poter dire con fiducia ciò che San Paolo affermava di se stes-so: ‘Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me’ (Gal2, 20). Per tutti sarà questa l’unica speranza e l’unico pensiero,e anche l’unico esercizio: vivere interiormente della vita di Cri-sto e manifestarla con atti nel nostro corpo mortale.
39
Il Fondatore, nella Spiegazione del Metodo di Orazione, ciinvita a contemplare i misteri, le virtù e le massime di GesùCristo per incarnarle nella nostra vita. Così, per esempio,contemplando a Natale la persona del Verbo sotto forma dibambino, ci invita a conformarci a Lui: Oh Dio mio, sonoben convinto di questa verità: se voglio partecipare alla tua glo-ria nel cielo debbo farmi somigliante a Te sulla terra... Con latua estrema povertà e sofferenza, mi hai insegnato a preferirela povertà, il disprezzo del mondo e la mortificazione, alle ric-chezze, agli onori e ai piaceri. Questo intendo fare, Signore, se-guendo il tuo esempio (MO 9, 225, 4-5).
Il Fondatore mette in relazione quasi sempre questa con-formità a Cristo sofferente sulla Croce con la partecipazio-ne al mistero pasquale, come nella Meditazione per la festadella Trasfigurazione: Quando l’anima è trasfigurata conGesù Cristo è necessario che si intrattenga con piacere della suaPassione e della sua croce, per manifestare che ciò che desideradi più è conformarsi a Gesù Cristo sofferente (Med. 152, 3). IlFondatore ci invita a renderci conformi al Crocifisso: Met-tiamo, dunque, tutta la nostra gloria, con San Paolo, nel por-tare sul nostro corpo le sante stimmate delle sofferenze di Gesù,per renderci conformi a Gesù Crocifisso e per onorare la suasanta croce (Med. 165, 3).
Senza dubbio, la partecipazione alla croce di Gesù è condi-zione di vita e non ricerca di morte. Si tratta, quindi, di par-tecipare alla vita di Cristo Risorto e di far trionfare il Diodella vita sugli idoli della morte: La risurrezione di Gesù Cri-sto deve procurarvi anche un altro vantaggio: quello di risusci-tare spiritualmente… facendovi entrare in una vita del tutto
40
nuova e celestiale... Mortificate i vostri corpi terrestri, dice an-cora l’Apostolo, e spogliatevi dell’uomo vecchio, per rivestirequello nuovo (Med. 29, 3).
Il mistero della Trasfigurazione, con la presenza del misterodella croce, ci permette di cogliere che la vocazione alla VitaConsacrata, malgrado le sue rinunce e le sue prove, e ancor piùgrazie ad esse, è cammino di luce, su cui veglia lo sguardo delRedentore: Alzatevi, non abbiate paura (VC 40).
Il Congresso della Vita Consacrata, celebrato a novembredel 2004, accogliendo le aspirazioni e le inquietudini dimolti religiosi e religiose, ci ha presentato due icone: la sa-maritana e il samaritano sommamente rappresentative esuggestive per noi, religiosi dell’inizio del secolo XXI. Laprima ci indica, da una parte, la ricerca spirituale appassio-nata dell’acqua viva, la passione contemplativa che deve ani-mare la Vita Consacrata. Perché dobbiamo essere convintidel fatto che l’impegno per l’annuncio del Vangelo è conse-guenza dell’incontro con Dio. Questa sintonia o, meglio an-cora, identità, con l’unico necessario (Lc 10, 42), è il codiceda cui sgorgano le intenzioni, gli apprezzamenti e gli atteg-giamenti che vogliamo portare come alternativa alle sfideche presenta il mondo di oggi al Vangelo.
E, nella seconda icona, d’altra parte, con la tradizione teo-logica e pastorale della Chiesa, vediamo un riflesso dellaumanità ferita e abbandonata a se stessa, e della compassionedi Dio che, attraverso suo Figlio, si piega per curarla. Le pa-role di Gesù al suo interlocutore, fa’ anche tu lo stesso (Lc10,37), le consideriamo una sfida a cui vogliamo risponde-
41
re con la stessa sensibilità e audacia che ha mostrato Lui du-rante i suoi tre anni di vita pubblica. Ci sentiamo profon-damente toccati da tanti volti sfigurati di nostri simili neicinque continenti per molteplici cause: guerra, violenza,terrorismo, discriminazione, razzismo, esclusione, emigra-zione ed esilio, fame, ecc. Tutti loro deformano anche ilvolto di Dio a cui somiglianza siamo fatti. Questo non puòlasciare indifferenti noi che ci siamo proposti di ricostruirel’immagine di Dio perché sia riconosciuta e rispettata intutte e in ciascuna delle persone, senza distinzione di età, digenere e di posizione sociale.
Come dice il documento finale, la samaritana e il samarita-no diventano per noi annunciatori di una contemplazione im-pegnata e di una misericordia contemplativa. In queste due fi-gure si integrano armoniosamente contemplazione e azione: lasamaritana sperimenta Gesù e va ad annunciarlo; il samarita-no scopre nel prossimo che soffre il volto di Dio e lo soccorre.Questa integrazione tra contemplazione impegnata e mise-ricordia contemplativa è il modo migliore di vivere lo spiri-to dell’Istituto nelle sue due dimensioni di fede e di zelo,per continuare insieme la missione di Gesù come inviatodel Padre, fortificati dallo Spirito: Sono venuto perché abbia-no la vita e l’abbiano in abbondanza (Gv 10, 10).
Ognuno di noi può avere la propria icona biblica sul signi-ficato della Vita Consacrata. L’importante è di non mani-polarla secondo i nostri interessi particolari, ma di lasciarciportare dallo Spirito ed essere attenti a questo vento chenon sappiamo da dove viene né dove vada. Così, ad esem-pio, la Suora brasiliana Elsa Ribeiro, ex presidente della
42
CLAR, in una delle sue presentazioni condivideva la suaicona: Mi piace contemplare, come icona per la Vita Religiosadi questo momento storico, la parabola del banchetto: siamoserve e servi, a cui il Padrone della Festa ordina di uscire per lestrade, per i sentieri e i crocicchi, nelle baracche e nei tuguri,nelle periferie, nei deserti e nelle frontiere, nelle notti violentee violentate, per invitare coloro che il mondo ignora, esclude ediscrimina, ma che - sicuramente - sono i destinatari del gran-de progetto che il Padre riserva per il mondo e la Chiesa nelnuovo millennio.
Personalmente, un’altra icona biblica che mi interpella èquella di Emmaus (Lc 24, 13-35). Come consacrati possia-mo interiorizzare e fare nostri gli atteggiamenti di Gesù. • Vediamo come Gesù esce all’incontro con l’umanità in cam-
mino; cerca le persone e cammina con loro per condivi-dere e assumere le gioie e le speranze, le difficoltà e le tri-stezze della vita. E’ giorno, però quei discepoli che fug-gono da Gerusalemme portano l’oscurità dentro. Siamochiamati anche noi ad uscire all’incontro con tanti gio-vani, tanti contemporanei che non trovano né senso néluce nelle loro vite.
• Gesù condivide il cammino degli esseri umani e, con undialogo semplice e diretto, conosce le loro preoccupazio-ni e i loro sentimenti. Uscire all’incontro significa farenostre le preoccupazioni, i timori, le angustie dei nostrifratelli e delle nostre sorelle, accompagnare i nostri con-temporanei nel loro itinerario di fede, assumendo le lorodebolezze, i loro dubbi e le loro fragilità. Dobbiamo of-frire ai giovani e al mondo, cuori disponibili ad ascoltar-li, a comprenderli e a metterli di nuovo in cammino.
43
• Gesù illumina con la Scrittura il cammino degli uomini;illumina la loro situazione e apre loro orizzonti di spe-ranza. Noi, per vocazione, siamo chiamati ad essere am-basciatori e ministri di Gesù Cristo (MTR 195) e a por-tare il Vangelo nel mondo dell’educazione, ad annuncia-re la Parola di Dio, convinti che quando l’educazione ri-spetta la persona umana è già apertura alla grazia, che di-spone ad accogliere la fede (R 12).
• Gesù si fa conoscere nella frazione del pane rivelando la suaintimità ai compagni di viaggio che nel suo gesto di con-divisione riconoscono Colui che non ha fatto altro chedonarsi agli altri. Noi pure siamo chiamati a condivide-re insieme i lavori, le necessità e i beni legati alla vitaquotidiana. Condividere il pane degli affetti, delle rela-zioni e dei servizi. Condividere il pane dei progetti, delledecisioni, delle attività e delle funzioni. Condividere ilpane dell’Eucaristia, che ci converte in alimento dei no-stri Fratelli e dei giovani.
• Gesù è annunciato dai suoi discepoli. Gesù scompare; peròi discepoli, spinti da un nuovo ardore, escono gioiosi perintraprendere il loro compito missionario. Ora l’oscuritàè all’esterno e la luce la portano dentro, dopo l’incontrocon Gesù. Ritornare a Gerusalemme vuol dire riprende-re la causa di Gesù, ritornare nella comunità, che diven-ta uno spazio di fraternità; significa ravvivare la nostrafedeltà alla vocazione, essere inviati dalla comunità aportare il Vangelo a tutti gli angoli del mondo.
Le nostre icone lasalliane
Lo stile letterario del nostro Fondatore è molto austero, pre-ciso, chiaro e razionale. E’ evidente che è debitore dello spi-
44
rito cartesiano proprio della sua epoca. Senza dubbio, però,vi possiamo trovare anche alcune icone che ci permettono,più per intuizione che per deduzione, di scoprire alcuni trat-ti essenziali della nostra vocazione di Fratelli. In modomolto soggettivo, mi riferisco alle tre seguenti, che nel miocaso sono state di ispirazione per il mio itinerario personale.
La mia icona lasalliana preferita è quella del Buon Pastore,applicata dal Fondatore al Fratello nel suo ministero aposto-lico in varie Meditazioni. E’ una icona biblica, certamente,però il Fondatore ne fa un’applicazione molto concreta allanostra vita di Fratelli. Una icona biblica che ci presenta unaverità molto consolante, come avevano intuito già i Padridella Chiesa. Conoscere, nella Scrittura, non significa solamen-te il fatto di conseguire per mezzo della propria intelligenza lacomprensione di una verità; conoscere non è soltanto un proce-dimento astratto, ma anche arrivare ad avere con gli altri unarelazione esistenziale, fondata sul dialogo reciproco: conoscere èuna relazione personale. Cristo, Buon Pastore, ci conosce perchéha una relazione personale con ciascuno di noi, per mezzo del-l’amore: ci ha manifestato il suo amore morendo per noi. E noipossiamo sapere se siamo del suo ovile e del suo gregge, se lo cer-chiamo, se lo abbiamo incontrato, se lui è una persona viva concui siamo in relazione stretta, se gli offriamo il sacrificio dellanostra stessa vita. Incontrandolo, incontriamo la felicità (DalleOmelie di San Gregorio Magno).
Nella Meditazione 33, il Fondatore ci invita, ad esempio diGesù, a conoscere e discernere il modo di procedere conciascuno dei nostri alunni. Si tratta di un rapporto e di unaeducazione personalizzata perché, con alcuni è necessaria
45
maggiore dolcezza, e per altri maggiore fermezza; usare moltapazienza con alcuni, sollecitare e incoraggiare gli altri; alcuniè necessario rimproverarli e castigarli per correggerli dei loro di-fetti; su altri bisogna vigilare continuamente, per impedire chesi perdano o si smarriscano (Med. 33, 1).
Gesù nel Vangelo ci dice che è necessario che le pecore co-noscano il loro pastore, il che implica per San Giovanni Bat-tista de La Salle, che il Fratello debba essere un testimonedi vita e manifestare una speciale tenerezza per coloro chesono affidati alla sua guida, perché è proprio questo chespinge le pecore ad amare il loro pastore e a compiacersi diessere in sua compagnia. E’ importante anche che le peco-re ascoltino la voce del loro pastore. Qui il Fondatore ci invi-ta ad adattare il nostro linguaggio all’età e alle circostanzedei nostri educandi, a inculturarci nel loro mondo perché ilnostro linguaggio sia comprensibile.
Il Fratello, come Gesù, deve essere specialmente attento allapecora smarrita; per questo il Fondatore ci rivolge un insi-stente invito alla preghiera di intercessione. Pregate molto sevolete riuscire nel vostro ministero; esponete continuamente aGesù Cristo le necessità dei vostri discepoli, soprattutto le diffi-coltà che incontrate nel guidarli. E Gesù Cristo, vedendo che nelvostro ministero lo considerate come onnipotente e voi come unostrumento che non deve agire se non in dipendenza da lui, nonmancherà di accordarvi ciò che gli chiedete (MTR 196, 1).
E La Salle si compiace di ripetere ciò che Gesù diceva allepecore di cui era pastore: Sono venuto perché abbiano la vitae l’abbiano in abbondanza. Perché questo è lo zelo ardente che
46
dovete avere per la salvezza dei vostri alunni. E’ per essi che do-vete sacrificarvi e consumare tutta la vostra vita per dar loroun’educazione cristiana e per procurare loro in questo mondola vita della grazia e, nell’altro, la vita eterna (MTR 201, 3).
Un’altra icona lasalliana molto bella e ispiratrice è quelladell’amico importuno, che il Fondatore ci presenta nellaMeditazione 37. La cosa interessante di questa icona è che,se il Fratello è l’amico importuno, i giovani che educhiamo,specialmente i poveri e quelli che vivono situazioni partico-larmente difficili, sono rappresentati come l’amico viaggia-tore, stanco e affaticato…
Si tratta anche qui di una icona biblica letta nell’ottica delnostro carisma, commentando la parabola di San Luca (11,5-10). A favore dei giovani che educhiamo dobbiamo esse-re disposti ad essere importuni per ottenere ciò che può es-sere loro necessario, senza tener conto delle difficoltà o dellemolestie che questo ci può causare. Non si tratta solo dellacentralità del giovane nell’atto educativo, ma soprattuttodella preoccupazione primaria per la sua salvezza integrale apartire da uno sguardo pieno di compassione, visto chesiamo invitati a guardarli come orfani poveri e abbandona-ti… che Dio mette, in certo modo, sotto la nostra protezione,coscienti del fatto che Lui li guarda con compassione, e si pren-de cura di essi come fosse il loro protettore, il loro sostegno e illoro padre; ma affida a voi la cura diretta di essi (Med. 37,3).
Come ricorda Fr. Alfredo Morales, La Salle ha rivestito inuna visione di fede questi ragazzi, colpiti dalla povertà e feri-ti dal male morale. Per loro donò la sua vita, i suoi beni, il suo
47
prestigio sociale, e li ha lasciati come preziosa eredità ad unacomunità di educatori cristiani, dediti a loro “dalla mattinaalla sera”. Continuare questa missione spetta oggi a noi.
Infine, mi intenerisce anche l’icona lasalliana dell’angelo cu-stode. Oggi che il tema degli angeli è ritornato di attualità,questa icona può dirci più che nel passato. Il tema degli an-geli è molto presente negli scritti del Fondatore. Nelle “Me-ditazioni” incontriamo 76 citazioni e nei “Doveri di un cri-stiano” ne ritroviamo 90.
L’angelo custode vi è visto come modello della Vita Religio-sa del Fratello, particolarmente nel suo atteggiamento diadorazione. La sua presenza nei misteri della salvezza invitail Fratello a inserirsi anche lui nella storia personale dei suoialunni. Ed è proprio nell’azione educativa che il Fondatoreintuisce una interazione e identificazione tra l’azione del-l’angelo custode e quella del Fratello. In effetti il Fratello,allo stesso modo dell’angelo custode, è un mediatore tra Dioe i giovani. Non dimenticate che siete i mediatori, di cui Diosi serve per insegnare loro i mezzi per salvarsi. Adempite benenei loro riguardi il compito che Dio vi ha assegnato (Med. 56,3). La stessa idea la ritroviamo quando il Fondatore ci sti-mola a seguire l’esempio di S. Giovanni Battista come pre-cursore di Gesù. Anche voi, come S. Giovanni, siete gli angeliche Dio ha inviato per preparargli la via perché possa penetra-re nel vostro cuore e in quello dei vostri alunni (Med. 2, 1).
Però, è soprattutto nelle Meditazioni 197 e 198 che il Fon-datore ci rivolge una chiamata esplicita ad esercitare la fun-zione di angeli custodi nel nostro ministero. E per realiz-
48
zarlo ci offre una serie di raccomandazioni: essere guide vi-gilanti; studiare a fondo il Vangelo; riprendere e incorag-giare gli alunni; ispirare loro le massime evangeliche facen-dogliele conoscere e dirigendo i loro passi per la strada cheli conduca a metterle in pratica.
Soprattutto essere i loro intercessori presso Dio. Per questoil Fondatore parte dalla bella metafora biblica della scala diGiacobbe, sulla quale gli angeli salivano e scendevano, perinvitarci a procedere nello stesso modo: Voi dovete fare lastessa cosa nei confronti dei ragazzi che sono affidati alla vostracura. Dovete salire ogni giorno a Dio con la preghiera, per im-parare da Lui tutto ciò che dovete insegnare e poi discendereverso di loro e adattarvi al loro livello per insegnare loro le ve-rità comunicatevi da Dio (MTR 198, 1).
Cenerò con lui e lui con me (Ap 3,20)
Se la Vita Religiosa è fondamentalmente questione diamore, suppone, anzi esige, non come un imperativo mo-rale bensì come un imperativo esistenziale, dei momenti diincontro profondo, prolungato, frequente, con chi sappia-mo che ci ama. Lo amiamo perché Lui ci ha amato perprimo. Non si tratta di guadagnarmi l’amore di Dio, vistoche è un amore gratuito. Si tratta piuttosto di rispondere,di espormi alla sua luce, alla sua misericordia, al suo pote-re, come mi espongo al sole sulla spiaggia. E questo espor-mi al sole di Dio mi porta insensibilmente verso il mondo,verso i giovani, verso i poveri, miei simili. Kierkegaardesprimeva tutto ciò con l’immagine delle due porte. Quan-do apriamo la porta a Dio, automaticamente si apre la porta
49
del prossimo; se chiudiamo la porta al nostro prossimo, au-tomaticamente chiudiamo anche la porta a Dio.
La preghiera non può essere che unificatrice. Questo carat-tere è proprio della nostra spiritualità lasalliana, come benaffermava il 42º Capitolo Generale. Crediamo che l’atteggia-mento contemplativo del Fondatore, sempre attento alle situa-zioni concrete della sua storia e aperto al progetto di Dio ma-nifestato nella sua Parola, ci porti a vivere una spiritualità la-salliana unificatrice. E’ lo stesso Spirito che consacra i Fratellie converte il cuore dei giovani (Circ. 435, pag. 52).
Nel Simposio sulla preghiera, realizzato nel 1980, si dicevache la preghiera è dono e arte. Personalmente penso che hapiù del dono che dell’arte. Perché fondamentalmente sitratta di una preghiera che non sgorga dall’ io posso, perchéla mia preghiera non dipende fondamentalmente dalla ca-pacità di controllo mentale che io posso esercitare. Le tec-niche di autocontrollo mi possono aiutare, ma non sonopropriamente preghiera. Non dobbiamo dimenticare che lapreghiera anche se è un compito umano, prima di tutto èdono di Dio.
Una preghiera non si può ridurre neppure all’io penso, per-ché la preghiera non è il risultato della mia speculazione in-tellettuale, né della logica interna dei miei pensieri, né dellabellezza estetica degli stessi.
Una preghiera non si centra neppure nell’io sento, perché isentimenti possono essere utili, ma non costituiscono lapreghiera. Possiamo applicare alla preghiera ciò che ci dice
50
un proverbio arabo: Quanto è diverso andare al banchetto peril banchetto, dall’andare al banchetto per l’amico. E il Fonda-tore ci diceva che è più importante cercare il Dio delle con-solazioni piuttosto che le consolazioni di Dio.
La nostra preghiera deve nascere dall’io voglio. Non da unvolere che, almeno in spagnolo e italiano, è sinonimo di po-tere: Volere è potere, siamo soliti dire. Bensì da un volere diabbandono che nasce da un amore profondo e disinteressa-to. In fondo, è come dire al Signore Io voglio ciò che Tu vuoi.Aridità, consolazione o vuoto, poco importa, purché siaquello che tu vuoi. La preghiera è concentrarsi in Dio euscire da noi stessi. Nel caso in cui onestamente sentiamodi non essere in grado di volere ciò che Dio vuole, a causadelle esigenze e della croce che comporta, pregare è dire al-meno: Signore io vorrei volere quello che Tu vuoi. Come di-ceva in un poema Elizabeth Barret, parlando dell’amoreumano: Se mi ami, che questo non sia per qualche cosa, eccet-to che per l’amore solo.
Il grande modello della nostra preghiera è Gesù e l’argo-mento più convincente per pregare non è altro che il suoesempio. La nostra preghiera, più che basarsi su teorie o tec-niche, deve centrarsi sulla sua persona. La prima cosa che siosserva nei dati raccolti dalle diverse tradizioni evangeliche èche la preghiera non è qualcosa di accidentale o secondarionella vita di Gesù. Al contrario, dobbiamo dire che occupa unposto essenziale ed insostituibile. La preghiera accompagnatutte le grandi decisioni e gli avvenimenti importanti della suavita (J. A. Pagola).
51
Tre mezzi possono aiutarci a raggiungere ciò che si è detto1. Stare in ascolto, perché, come dice Santa Teresa: il Si-
gnore istruisce nell’orazione chi vuole farsi istruire da Lui.Per questo dobbiamo restare uniti a Lui, come sottolineail Fondatore: A chi dobbiamo essere uniti, se non a coluiche ci ha dato tutto, che è il nostro Padre e Signore, e che,come dice San Paolo, ha dato l’essere a tutte le cose, e ci hafatto solo per Lui? (Med. 90, 2).
2. Attualizzare la nostra cristologia. Se, come dice la Rego-la: Con lo studio delle scienze bibliche e teologiche, i Fratel-li alimentano la loro fede e la fortificano (R 6), questo si ri-vela fondamentale nello studio di Gesù. Una buona cri-stologia può essere una porta eccellente per arrivare a Cri-sto. La nostra lettura spirituale e la nostra formazione ini-ziale e permanente dovrebbero tenerlo molto presente.
3. Fare di Gesù l’oggetto della nostra preghiera contempla-tiva. La cosa più importante è arrivare ad una contem-plazione cristologica. Nella Raccolta il Fondatore loesprime così, quando parla degli effetti della fede: Ilprimo effetto della fede è farci affezionare fortemente allaconoscenza, all’amore e all’imitazione di Gesù Cristo, e al-l’unione con Lui: alla conoscenza, perché è proprio in essache consiste la vita eterna; all’amore, perché chi non amaGesù è un reprobo; alla imitazione, perché i predestinatidebbono essere conformi a Lui; all’unione, perché, rispetto aGesù, siamo come i tralci di una vite, che muoiono se sonoda essa separati (Raccolta X, 1). Questa è la meta di ogniautentica preghiera cristiana. Senza dubbio, il Fondatoreaveva fatta sua la spiritualità della scuola sulpiziana: Unospirito eccellente di questo secolo ha sostenuto che il sole, enon la terra, occupa il centro del mondo... Questa nuovaopinione, poco seguita dalla scienza degli astri, è utile e deve
52
essere seguita nella scienza della salvezza. Gesù, in effetti, èil sole immobile nella sua grandezza e quello che muovetutte le cose... Gesù è il vero centro del mondo, e il mondodeve essere in continuo movimento verso di Lui. Gesù è ilsole delle anime, che da Lui ricevono ogni grazia, ogni illu-minazione e influsso. E la terra dei nostri cuori deve girarecontinuamente attorno a Lui (Cardinale de Bérulle).
Testimoni della speranza Mi sembra che una delle dimensioni della nostra vita diFratelli, come religiosi, consista oggi nel mantenere viva lasperanza. Mantenere viva la speranza che la nostra vita valela pena ed ha futuro. Mantenere viva la speranza che la mis-sione lasalliana, aperta oggi alla missione condivisa e all’as-sociazione, continuerà ad essere per la Chiesa e per ilmondo, specialmente per quello dei giovani e dei poveri,uno strumento di salvezza. In una visione ancora più glo-bale, Teilhard de Chardin ci rivolge un urgente invito amantenere vivo l’atteggiamento di attesa. L’attesa, l’attesaansiosa, collettiva e operosa di una Fine del mondo, cioè, di unEsito per il mondo, è la funzione cristiana per eccellenza e,forse, il tratto distintivo della nostra religione. Storicamente,l’attesa non ha smesso di guidare, come una torcia, i progressidella nostra fede. Gli israeliti sono stati perpetui “aspettanti” ecosì anche i primi cristiani. Perché il Natale, che avrebbe do-vuto all’apparenza invertire i nostri sguardi e concentrarli sulpassato, non ha fatto altro che rivolgerli ancora più avanti. Ap-parso per un istante tra noi, il Messia non si è lasciato vedere etoccare se non per perdersi di nuovo, più luminoso e più inef-fabile, nelle profondità del futuro. E’ venuto. Però ora lo dob-biamo aspettare di nuovo, non un gruppo di eletti soltanto, ma
53
tutti gli uomini e più fortemente che mai. Il Signore Gesù nonverrà rapidamente se non l’aspetteremo molto. Ciò che faràesplodere la parusia è una accumulazione di desideri.
Bisogna, costi quel che costi, ravvivare la fiamma. Ad ognicosto è necessario rinnovare in noi il desiderio e la speranza delgrande avvenimento. Dove alimentare la fonte per questo rin-giovanimento? Nella percezione di una connessione più intimatra il trionfo di Cristo e la riuscita dell’opera che vuole edifica-re qui con lo sforzo degli uomini (L’ambiente divino).
Nella Scrittura incontriamo quasi ad ogni pagina la chia-mata ad una speranza che non delude. Io, infatti, conosco iprogetti che ho fatto a vostro riguardo - dice il Signore - pro-getti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pienodi speranza (Ger 29, 11).
Di fronte all’invecchiamento e alla diminuzione del nume-ro dei Fratelli in alcuni settori dell’Istituto, la tentazione èdi lasciarci prendere dal pessimismo e dallo scoraggiamen-to. Certamente, basandoci sulla fede, illuminati dalla spe-ranza e con un profondo amore per tutti coloro di cuisiamo a servizio, possiamo far nostra l’esperienza di Paolo inAsia, in un momento di profondo turbamento e pericolo.Abbiamo addirittura ricevuto su di noi la sentenza di morteper imparare a non riporre fiducia in noi stessi, ma nel Dio cherisuscita i morti. Da quella morte però egli ci ha liberato e cilibererà, per la speranza che abbiamo riposto in lui… (2 Cor1, 9-10). Ciò che stiamo vivendo non sarà piuttosto un’oc-casione propizia, un tempo di grazia, perché nella nostrafragilità, non confidiamo tanto in noi stessi, nei nostri
54
mezzi e nel nostro prestigio, ma confidiamo in questo Diocapace di risuscitare i morti e in cui abbiamo posto la no-stra speranza?
Possiamo applicare alla Vita Religiosa ciò che André Fos-sion dice del cristianesimo servendosi di un proverbio afri-cano: L’albero vecchio che cade fa più rumore della foresta checresce. Più importante dell’albero che cade, è la foresta chenasce e cresce. A livello di Vita Religiosa è difficile immagi-nare e programmare ciò che si sta sviluppando. Ciò chepossiamo e dobbiamo fare è favorire la sua crescita. La VitaReligiosa del futuro non sarà unicamente, né principal-mente, il risultato dei nostri sforzi; sarà soprattutto un frut-to nuovo, insperato, sorprendente dell’azione dello Spiritonel cuore del mondo.
Qui si radica la nostra speranza, in questi virgulti nuovi cheoggi in Africa, in Asia, in America Latina stanno spuntan-do… ma anche, e malgrado le difficoltà, in quei germoglinuovi che spuntano in Europa, in America del Nord, inOceania. E mi sembra importante tener conto, a questoproposito, di ciò che ci dice il claretiano Pedro Belderrainnella rivista spagnola Vida Religiosa: Con frequenza si gene-ralizza in eccesso e non resta tempo per le sfumature. Per esem-pio, né la Vita Religiosa di alcune nazioni è così morta, néquella di altre credo che incarni tanto perfettamente il Regnodi Dio. Mi immagino che c’è del ‘nord’ (imborghesimento, neo-liberalismo, resa…) nel Sud e ‘sud’ (impegno, inserimento, spe-ranza) nel Nord… Né tutto il futuro della Vita Religiosa è inAsia e Africa, né tutto il suo passato in Europa.
55
56
Siamo chiamati ad essere testimoni della speranza che por-tiamo in noi, secondo l’invito di San Pietro. Noi Fratelli,oggi, siamo chiamati ad essere uomini di speranza. Una spe-ranza che nasce dalla fede certamente, ma che ha le sue ra-dici anche nella enorme capacità che il nostro Istituto hasempre avuto di tornare a ricominciare dopo momenti dicrisi. Nel novembre 2004 mi hanno invitato a partecipare albicentenario delle nostre scuole a Lione. In realtà si trattavadi qualcosa di più: della ripresa del nostro Istituto dopo laRivoluzione francese. Solamente 80 Fratelli risposero allachiamata e l’Istituto nel 1804 ebbe la capacità di comincia-re di nuovo e di dare il via ad uno straordinario sviluppo.Cento anni più tardi, la crisi del 1904. In quel momentoeravamo più di 10.000 Fratelli in Francia. Fu un momentodifficile e si sarebbe potuto pensare ad altre alternative, comesappiamo dallo studio fatto da Fratel Pedro Gil. Senza dub-bio, malgrado tutti i limiti, siamo usciti da questa crisi raf-forzati con l’internazionalizzazione dell’Istituto. Oggi lopossiamo considerare un momento provvidenziale. E mipiace pensare che cento anni più tardi, nel 2004-2005, stia-mo vivendo ancora un momento privilegiato, protagonistidi un’avventura meravigliosa con la missione condivisa el’associazione con i laici che possono assicurare la vitalitàdella missione lasalliana del futuro a favore dei giovani.
Ma dobbiamo aprire e condividere la nostra speranza al dilà delle frontiere congregazionali e della nostra missioneapostolica. Non dobbiamo dimenticare che facciamo partedell’umanità, come ci ha ricordato il Congresso della VitaReligiosa. Di una umanità assetata di benessere in unmondo di consumo e di povertà, di amore in mezzo al caose al disordine amoroso, di trascendenza in un contesto di
disincanto politico ed esistenziale. Ci dobbiamo identifica-re con questo volto umano e non con quello della istituzio-ne sacra (sacerdote, levita, tempio) distante dai poveri e daidolori dell’umanità o con quello della sposa prostituitanelle alleanze di convenienza, rappresentate dai diversi ma-riti, come nel caso della samaritana. Per questo dobbiamolasciarci interpellare dalla sete di senso, dal dolore dell’u-manità, dall’amore e dalla compassione manifestata daGesù per questa stessa umanità.
Conclusione: Cercatori di Dio, seguaci di GesùCristo, costruttori del suo Regno.
Alla fine del Congresso della Vita Religiosa un piccologruppo di “uditori” cercò di fare una sintesi delle idee piùimportanti e coinvolgenti che vi erano andate nascendo, amodo di segni di vita che annunciano già un nuovo albeg-giare della Vita Consacrata. Tra gli altri, sono stati segnala-ti i seguenti:• Il desiderio di nascere di nuovo secondo l’ottica della In-
carnazione.• Il fascino esercitato oggi dalla persona di Gesù sulla Vita
Consacrata.• La centralità della “lectio divina”. • La passione per la missione che stimola la nostra immagi-
nazione e ci lancia in iniziative nuove, audaci, profetiche,di frontiera.
• La ricerca di una comunione più viva e di una vita di co-munità più autentica, basate su relazioni più profonde,inclusive ed evangeliche.
57
58
A noi ora spetta continuare ciò che è cominciato in questoCongresso. Accogliendo gli inviti dello Spirito che ci spingea descrivere, a raccontare, ad ascoltare e a vivere ciò che Luistesso manifesta nella compassione di coloro che rispondonoai più in necessità. A lasciarci trasformare da questa passionedi Cristo che ci fa abbracciare la sua passione per l’umanitàsofferente. A lasciarci guidare verso nuovi luoghi, senza fron-tiere, a iniziare una nuova prassi, in nuove strutture, a parti-re dalla doppia e unica esigenza dell’amore appassionato perCristo e dalla passione sempre viva per l’umanità; esse ci deb-bono portare alla conversione personale e comunitaria, allatrasformazione della società e delle sue strutture ingiuste e acelebrare, quotidianamente, lungo l’anno liturgico, la bru-ciante e poderosa forza della Risurrezione, già presente nelmondo e nella storia, che “fa nuove tutte le cose”.
Ha fortemente richiamato la mia attenzione il fatto che du-rante il Congresso tutti gli interventi dei religiosi e delle re-ligiose giovani abbiano fatto riferimento, precisamente, allaqualità che si aspettano dalla nostra vita di comunità.Credo che questo rappresenti un segno dei tempi a cui dob-biamo essere attenti. Si tratta, naturalmente, di una comu-nità che dia più importanza alle relazioni che alle strutture;che integri armonicamente il personale e il comunitario;che risponda e si apra alle nuove povertà; che ci aiuti a vi-vere i valori evangelici.
Oggi la passione per l’umanità vuol dire soprattutto solida-rietà, vicinanza, presenza, accoglienza, accompagnamento.La nostra missione essenziale è quella di essere portatori di tene-rezza e di misericordia, come ha fatto Gesù; di accoglienza e
59
comprensione, di perdono e speranza (Alejandro Fernández O.di M.). Siamo chiamati ad essere il volto più umano e com-passionevole della Chiesa o, come diceva il Padre Radcliffedurante il Congresso, una nicchia ecologica di libertà. Camusportava come esempio di amicizia vera quella di un uomo ilcui amico era stato incarcerato e che tutte le notti dormiva sulpavimento della sua casa per non godere di una comodità impe-dita a colui che amava. E il romanziere aggiungeva che lagrande domanda per gli uomini che soffrono è la stessa: Chidormirà sul suolo per noi? E Charles Péguy ci racconta di unuomo che era stato in cielo e un angelo esaminatore gli avevachiesto: Dove sono le tue ferite? Ferite? - aveva risposto l’uomo- Non ho nessuna ferita. E l’angelo gli aveva detto scoraggiato:Non c’era niente per cui valeva la pena lottare? Le nostre ferite,quelle che soffriamo per gli altri, ci rendono quello chesiamo. Ci identificano, dice il domenicano nordamericanoChrys McVey, commentando questo testo, nello stesso modoin cui gli apostoli poterono identificare Gesù dopo la Risur-rezione, quando mostrò loro le sue ferite (Cfr. Gv 20, 20).
La sfida è esigente, però vale la pena e non mancano testi-moni. Quando c’è la passione, possiamo anche essere sprov-visti di tutto, ma niente può impedirci di andare avanti. Loha espresso bene Armando Valladares, poeta cubano, che èstato 22 anni in carcere (1960-1982) per le sue convinzio-ni cristiane e politiche:
“Mi hanno tolto tuttole pennele matite
l’inchiostro
perché loro non vogliono che io scrivae mi hanno sepolto
in questa cella di castigoperò non soffocheranno così la mia rivolta.
Mi hanno tolto tutto- bene, quasi tutto -
perché mi resta il sorrisoe l’orgoglio di sentirmi un uomo libero
e nell’anima un giardinodi fiori eterni.
Mi hanno tolto tuttole pennele matite
però mi resta l’inchiostro della vita- il mio proprio sangue -
e con esso scrivo ancora versi”.
Credo che Maria debba essere per noi il modello della VitaReligiosa che oggi vogliamo vivere. Essa visse sempre orien-tata verso il Padre e proiettata verso i fratelli e le sorelle. Leiha saputo integrare fede e zelo; mistica e profezia, amore aDio e amore al prossimo; passione per Cristo e passione perl’umanità. Dimensioni che debbono essere presenti anchenella maniera di vivere il nostro dono totale al Signore.
Maria certamente ha vissuto nel suo essere vergine e madrequesta profonda realtà. Come vergine vive in totale ascoltodi Dio, nel silenzio in cui risuona la parola divina. KarlBarth ha sottolineato che la verginità di Maria è un inno alprimato assoluto di Dio, di questo Dio di fronte al qualedobbiamo restare assorti e meravigliati, lasciandoci trasfor-
60
mare da Lui. Come madre, in lei il silenzio si è trasformatoin parola, la verginità in maternità, che si caratterizza per ladelicatezza, la tenerezza e il dono. Che la Vergine Maria,icona dell’orante, ci insegni con il suo silenzio l’esperienza diDio e ci aiuti ad essere così ricettivi come lei all’iniziativa delMistero, ad essere come lei seno di Dio, accolto in noi per poteressere testimoni di fronte al mondo con la nostra vita, del fattoche Dio è il vero seno del mondo, che tutto è avvolto da Lui,che tutto viene da Lui e a Lui torna, che solo Lui è il senso, laforza e la speranza della vita dell’umanità! (Bruno Forte).
Fraternamente in De La Salle:
Fratel Álvaro Rodríguez EcheverríaSuperiore Generale
61






























































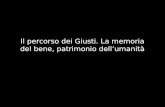


















![Antonio Gnoli-Franco Volpi I PROSSIMI TIT ANI...Antonio Gnoli-Franco Volpi I PROSSIMI TIT ANI CONVERSAZIONI CON ERNST JUNGER ' ADELPHI EDIZIONI PREMESSA Il 29 marzo 1995 Ernst ]unger](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5e6c6132410ae6722c4ba94f/antonio-gnoli-franco-volpi-i-prossimi-tit-ani-antonio-gnoli-franco-volpi-i-prossimi.jpg)