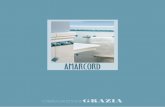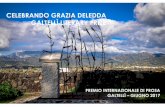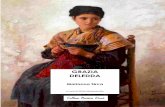Ceramiche Grazia a Sassuolo - Pavimenti e rivestimenti in ...
Arte e Grazia
-
Upload
marta-roberti -
Category
Documents
-
view
242 -
download
1
Transcript of Arte e Grazia
-
Arte e grazia di Marta Roberti , pubblicato in Aa.Vv.Legmi. Con Gregory Bateson, Editrice universitaria, Universit di Verona, Verona 2006
A Gregory piacerebbe che noi arrivassimo a parlare da scienziati (scienziati creaturali beninteso) dellestetica.
Lestetica e il problema del sacro sono stati i temi trainanti la ricerca di Gregory Bateson. Nellultimo libro postumo: Dove gli angeli esitano dichiara per lennesima volta che ha dovuto scrivere Mente e natura, libro dalle tonalit pi scientifiche, per rendere pi agevole il nostro cammino verso quella zona rispetto alla quale pi dignitoso esitare: lestetica.Bateson ha attraversato nei suoi studi campi che vanno dalla biologia alletologia, dalla psichiatria alla comunicazione tra mammiferi, e si reso conto che il filo rosso da lui stesso inizialmente inavvertito, ma che guidava la sua riflessione, era la questione dellestetica e del sacro.In Stile, grazia e informazione nellarte primitiva, saggio del 1967 contenuto in Verso unecologia della mente Bateson ricorda che per Huxley il problema pi importante dellumanit la ricerca della grazia e che gli animali sarebbero pi simili a Dio rispetto agli uomini, perch come Dio non sono corrotti dalla finalit e dallautocoscienza. Gli animali possiedono una grazia implicita poich non sono soggetti a confusioni intime. La ricerca della grazia avviene per luomo attraverso larte. Bateson non guarda agli animali e al mondo della natura per osservarne gli aspetti pi istintivi come si sarebbe portati a pensare, invece come spiega nellincipit di Mente e Natura: "Non era la mia avidit, la mia risolutezza, la mia cosiddetta animalit e cos via che io ravvisavo dallaltra parte di quello specchio, nella natura. Quello che vi vedevo erano invece le radici della simmetria umana, la sua bellezza e la sua saggezza, la grazia del suo corpo, persino la sua abitudine di fare begli oggetti sono altrettanto animaleschi quanto la sua crudelt. Dopotutto, la parola stessa animale significa: dotato di mente o spirito (animus).
La comunicazione relazionale. Occorre guardare alla comunicazione tra mammiferi cos come ce lha proposta Bateson per poter capire la logica che sottende anche il fare artistico. Bateson spesso ragiona abduttivamente, descrivendo un ambito per facilitare la sua spiegazione di un altro con caratteristiche simili. Faccio quindi mio il suo metodo e ripropongo lanalisi della comunicazione tra mammiferi per avere dei modelli in cui rintracciare regole formali simili a quelle del procedimento artistico, in modo tale da avere un sovrappi di conoscenza, che la sola analisi del fenomeno artistico non ci offrirebbe.
Il saggio Problemi relativi alla comunicazione tra cetacei ed altri mammiferi ci permette di osservare gli aspetti di una comunicazione che Bateson accomuna a quella dellartista e del sognatore, ossia la comunicazione relazionale. Bateson frequentava spesso lo zoo
-
Fleishacker di San Francisco con il fine di comprendere se in qualche modo gli animali fossero consapevoli che i segni del loro umore sono anche segnali e che possono quindi influire sul comportamento dei loro compagni. Ci era molto importante per Bateson perch sostiene Se si riflette sullevoluzione della comunicazione evidente che una fase molto importante viene raggiunta quando lorganismo cessa a poco a poco di rispondere automaticamente ai segni dello stato di umore dellaltro, e diviene capace di riconoscere che il segno un segnale, di riconoscere, cio, che i segnali dellaltro individuo, e anche i suoi, sono soltanto segnali, e che possono essere creduti, contraffatti, negati, amplificati, corretti e cos via.Bateson narra di aver osservato due scimmie che giocavano compiendo azioni simili al combattimento, ma che non erano combattimento. Pens che se degli animali giocano perch si scambiano messaggi del tipo: Questo un gioco. Tale messaggio un metamessaggio: incornicia cio tutti i messaggi emessi in quel contesto. Si rese conto che questo messaggio contiene tutti gli elementi necessari per generare il tipico paradosso di Epimenide il cretese, quello che sosteneva che tutti i cretesi mentono. Bateson era fortemente interessato ai paradossi della comunicazione: aveva lavorato in un ospedale psichiatrico e si era interessato di comunicazione tra schizofrenici, una comunicazione paradossale per eccellenza.
Grazie alle sue osservazioni del comportamento dei mammiferi Bateson intuisce che la comunicazione tra animali riguarda lambito delle relazioni. I mammiferi comunicano non sulle cose ma sulle relazioni. Lesempio pi tipico proposto da Bateson quello del gatto che quando si struscia sulle nostre gambe non appena ci avviciniamo al frigorifero non ci sta dicendo latte ma qualcosa di pi simile a mamma. Sta cio definendo la sua relazione con noi: la sua inevitabile dipendenza per la sua alimentazione. E tutta la comunicazione tra mammiferi non umani di questo tipo. Bateson propone numerosi esempi sparsi nei suoi saggi. Uno di questi quello del branco di lupi osservato sempre nello zoo Fleishacker di San Francisco. I canidi per svezzare i loro cuccioli usano premere al suolo con la bocca aperta la testa del cucciolo. Anche nel branco di lupi da lui osservato ha notato questo gesto svolto per dal lupo capobranco nei confronti di quel lupo insolente che si era avvicinato ad una femmina. E solo il capobranco infatti che pu possederle. Bateson commenta cos questo avvenimento: Il lupo asserisce o afferma la natura del rapporto tra se stesso e laltro. Se dovessimo tradurre a parole lazione del capo del branco, le parole non sarebbero Non fare questo ma tradurrebbero piuttosto lazione metaforica: Io sono il tuo superiore, il maschio anziano, cucciolo! Ci che sto cercando di dire sui lupi in particolare e sui mammiferi preverbali in genere che il loro discorso verte principalmente sulle regole e contingenze del rapporto. Il capo del branco ha usato una metafora colta nella relazione madre-figlio e lha spostata di contesto. Come in ogni metafora cambiano i termini della relazione ma la relazione resta immutata.Ci interessano questi esempi per cogliere i caratteri di una comunicazione iconica, che si serve di immagini e metafore per formularsi. Proprio come larte. Altro esempio chiarificante quello che narra di due cani che si incontrano e desiderano capire che tipo di relazione c fra loro. Per capire che entrambi vogliono giocare devono
-
trovare la maniera di esprimerlo. Poich nella comunicazione analogica non vi possibilit di negazione, ci che i due cani vogliono negare, il combattimento, deve essere menzionato attraverso una reductio ab absurdum : occorre compiere ci che non vogliamo compiere per far comprendere allaltro che lazione che stiamo compiendo non ci che vorremmo fare. I due cani devono prima accennare ad un combattimento per capire che non vogliono combattere.
La comunicazione relazionale e il processo primarioRicordiamo cos che la comunicazione tra mammiferi:-non pu valersi del non, -riguarda sempre la relazione con chi si sta comunicando - metaforica.Se osserviamo ora in Stile grazia e informazione nellarte primitiva il paragrafo intitolato Il processo primario notiamo quanto anche questultimo possieda le medesime caratteristiche della comunicazione relazionale. Il processo primario si configura nella terminologia freudiana come il modo in cui opera linconscio distinguendosi dal processo secondario o coscienza che formula pensieri verbalizzati. Dice Bateson Il processo primario caratterizzato (ad esempio da Fenichel) come privo di negazioni, privo di tempi, privo di qualunque identificazione di modo verbale (cio non ha identificazione di indicativo, congiuntivo, ottativo, ecc.) e come metaforico Osserviamo che queste caratteristiche sono le stesse che abbiamo prima individuato nella comunicazione tra mammiferi. Inoltre il testo incomincia con la famosa citazione di Pascal che dice Il cuore ha ragioni che la ragione non conosce; cio la ragione non pu accedere agli algoritmi del cuore perch si formulano attraverso logiche diverse. Se larte e il sogno oltre che la poesia, la religione e lebbrezza ci fanno entrare in questo spazio resta ancora, sostiene Bateson, un formidabile problema di traduzioneLe limitazioni del linguaggio relazionale dei mammiferi sono le stesse di quelle del sognatore e dellartista perch si servono di una comunicazione iconica. Ma a differenza degli animali luomo anche coscienza e linguaggio verbale e il problema quello di saperli mantenere in equilibrio.
Per Bateson il processo primario non da considerarsi freudianamente come la via per rimuovere i ricordi spiacevoli e paurosi. Linconscio o processo primario un luogo speciale che pu essere visto anche da un punto di vista evoluzionistico come spazio in cui vanno a stabilirsi quelle conoscenze generate dallabitudine o dalla nostra stessa conformazione fisica e biologica. Bateson ritiene importante discutere dei livelli mentali. Ha infatti detto che la grazia che si raggiunge con larte questione di equilibrio nei livelli mentali. Ci di cui siamo consapevoli e ci di cui non lo siamo e ci che avviene senza una nostra consapevolezza ma che sembra essere determinato da una conoscenza previa. Per esempio ricorda le scoperte di Adalbert Ames secondo cui le immagini visive tridimensionali consce che costruiamo di ci che vediamo sono costruite da procedimenti che implicano le premesse matematiche della prospettiva, del cui impiego siamo affatto inconsci. Essenziale anche ricordare la teoria di Samuel Butler, fatta propria da Bateson,
-
secondo cui pi un organismo conosce qualcosa meno conscio di questa conoscenza. Esempio sono lartista e lartigiano che pur essendo padroni della tecnica non sanno esprimerla a parole. La tecnica e lo stile sono qualcosa che si colloca in strati profondi del nostro essere ai quali non abbiamo accesso se non in situazioni di ebbrezza, nel sogno oppure nel fare artistico stesso. Ma alla coscienza non resta che una traduzione mutilata.
Bateson medita su come sia possibile conoscere qualcosa. E intuisce che il conoscere non riguarda solo livelli coscienti, ma comporta sia il ricordare che il riconoscere come anche labitudine. Sostiene che in ogni caso vi una particolare ridondanza o strutturazione molto complessa in cui la difficolt concerne lo stabilire quali parti della mente sono ridondanti rispetto al particolare messaggio sul sapere o conoscere. Una forma interessante di conoscenza quella chiamata adattamento. Dice: Uno squalo magnificamente conformato per muoversi nellacqua, ma certo il genoma dello squalo non contiene informazioni sullidrodinamica. Si deve piuttosto supporre che il genoma contenga istruzioni o informazioni che sono il complemento dellidrodinamica: non lidrodinamica ma ci che lidrodinamica richiede, stato strutturato nel genoma dello squalo. Analogamente un uccello migratore forse non conosce la strada per giungere a destinazione ()ma pu avere in s le istruzioni complementari necessarie a farlo volare nella direzione giusta.
Il processo primario e larteIsadora Duncan disse Se potessi dire che cosa significa non avrei bisogno di danzarlo. E Bateson a ricordarcelo e ad analizzare questa frase per restituircene il significato pi profondo: il messaggio che sta esprimendo la ballerina danzando un messaggio di un genere che ha a che vedere con linconscio e che sarebbe falsificato se fosse tradotto a parole perch il linguaggio verbale implica coscienza e volont. Bateson vuole sottolineare quanto nellarte e in questioni simili siano in gioco porzioni non consce della mente e che devono rimanere inconsce. La Duncan non sta dicendo che potrebbe dire le stesse cose a voce e che ci sarebbe pi rapido ma che non ne capace. La sua danza un linguaggio indipendente. La grazia del suo movimento ottenuta grazie anche allorigine inconscia del suo moto.La danza della Duncan come le pennellate di un artista possono creare metaforicamente gesti e movimenti. Tracce che il nostro inconscio conosce, ricorda. La grazia di certe cose proprio dettata dallinconsapevolezza da cui sorgono e dal legame che sanno trovare con la coscienza. Molto spesso la coscienza le rovina. Le desacralizza. Credo che a questo punto sia comprensibile la intensissima intuizione di Bateson: La poesia non un tipo distorto e ornato di prosa: piuttosto la prosa una poesia spogliata e inchiodata al letto di Procuste della logica. In un altro punto dice: la poesia, la metafora, labduzione seguono la logica che ha dato origine al mondo. Ci che si serve di questo tipo di linguaggio si avvicina al sacro. Larte ha a che vedere con la grazia perch usa un linguaggio iconico.
La natura correttiva dellarteNon che larte sia espressione dellinconscio, ma piuttosto essa si preoccupa del rapporto
-
tra i livelli del processo mentale[]Labilit artistica un combinare molti livelli mentali inconsci, consci ed esterni- per asserire la loro combinazione. Non questione di un unico livello.E molto facile rischiare di credere in una eccessiva celebrazione dellinconscio da parte di Bateson. Ci non dipende solo dallangolazione con cui io lo sto osservando, ma anche dal fatto che in una situazione come quella attuale la coscienza, con tutto ci che essa comporta sopravvalutata, cos che Bateson cerca di rivalutare esperienze diverse che possano correggere la nostra visione finalistica. Infatti la coscienza pu essere definita come sinonimo di unattitudine di fronte alla vita: la finalit, lagire per uno scopo. Quali sono i problemi della coscienza? Bateson parla di limiti quantitativi e limiti qualitativi. Vediamo brevemente entrambi. Dobbiamo innanzitutto pensare alla mente come ad un sistema. Non possibile pensarla diversamente per Bateson che, attraverso questa interpretazione, riuscito a uscire dalla dicotomia mente- corpo. In quanto sistema la coscienza una piccola parte ma appunto lunica di cui siamo consapevoli e perci tendiamo a considerarla come la maggiormente importante, la pi umana, la parte migliore del nostro essere in quanto ci distingue dagli altri esseri. Il fatto che sia una parte limitata del nostro sistema mentale indica che un sistema totalmente cosciente sarebbe inconcepibile. E dal punto di vista quantitativo una questione di economia, perch nessun organismo pu permettersi di essere cosciente di faccende che pu sbrigare a livelli inconsci.La coscienza ha anche dei limiti qualitativi e ci sostiene Bateson, connesso al tema dellarte. Fa lesempio di uno schermo televisivo e dice che limmagine da esso proiettata indice del buon funzionamento delle parti dellapparecchio. Il televisore che fornisce unimmagine distorta o altrimenti imperfetta, in un certo senso, genera messaggi sulle sue patologie inconsce, manifesta i suoi sintomi: e ci si pu chiedere se certi artisti non facciano qualcosa del genere.Ci che fanno larte, i sogni, la danza, la poesia scorgere oltre il limitato arco di visione della finalit e connettere la vita con una dimensione animale nel senso in cui abbiamo detto prima: paradossalmente legata ad una concezione estetica.Spiega per meglio Bateson in questo passo quale sia la natura della coscienza: Si notato sopra che la coscienza di necessit selettiva e parziale, cio che il contenuto della coscienza , tuttal pi, una piccola parte della verit sullio. []Ci che grave la resezione dei circuiti mentali. Se come dobbiamo ritenere, linsieme della mente una rete integrata (di proposizioni, immagini, processi, patologia nervosa, o quello che volete - secondo il linguaggio scientifico che preferite usare), e se il contenuto della coscienza solo un campionario di varie parti e luoghi di questa rete, allora, inevitabilmente, limmagine cosciente della rete come un tutto una mostruosa negazione dellintegrazione di quel tutto. Ci che appare sopra la superficie, in seguito alla resezione della coscienza, sono archi di circuito, e non i circuiti completi, o i pi vasti circuiti completi di circuiti.Ci che la coscienza non pu mai apprezzare senza aiuto (laiuto dellarte, dei sogni e simili) la natura sistemica della mente.(184)
La comunicazione analogica
-
In quanto mammiferi abbiamo dimestichezza con labitudine di comunicare sulle nostre relazioni. Ci indicativo del fatto che non percepiamo oscuro il linguaggio degli altri mammiferi. Ci appare invece pi oscuro il linguaggio verbale di persone di idiomi diversi dal nostro. Il fatto che la comunicazione verbale discreta e quella cinetica e il paralinguaggio sono analogici. Per questo motivo anche larte di una cultura pu essere goduta da coloro che appartengono ad unaltra quando espressione della grazia. La grazia fisica di un gatto profondamente diversa dalla grazia fisica di un cavallo, eppure un uomo, che non ha la grazia n delluno n nellaltro, pu apprezzare quella di tutti e due. Vediamo ora con le parole di Bateson come si distinguono la comunicazione iconica e quella discreta: Il nocciolo della questione che nella comunicazione discreta un certo numero di segni puramente convenzionali 1,2,3,X,Y,ecc- sono manovrati secondo certe regole dette algoritmi. I segni stessi non hanno alcun legame semplice (per esempio corrispondenza di grandezza) con ci che rappresentano: la cifra 5 non pi grande della cifra 3. [] Nella comunicazione analogica invece, si usano grandezze vere e proprie, ed esse corrispondono a grandezze reali nelloggetto del discorso. [] Il linguaggio verbale quasi (ma non proprio) del tutto discreto. La parola grande non pi grande della parola piccolo[]. Viceversa nella comunicazione cinetica e paralinguistica, lampiezza del gesto, la forza della voce, la lunghezza della pausa, la tensione del muscolo, e cos via, tutte queste grandezze corrispondono di solito (in modo diretto o inverso) a grandezze nella relazione che loggetto del discorso.
Il linguaggio, sostiene Bateson, non il sostituto di unarcaica forma di comunicazione della quale avrebbe preso il posto. Infatti la comunicazione cinetica non scomparsa con larrivo della comunicazione linguistica come accade quando nellevoluzione un metodo nuovo sostituisce uno vecchio. La comunicazione iconica e cinetica, ci ricorda Bateson, convive con il linguaggio verbale assolvendo compiti differenti. Nessuno pu solo parlare senza esprimere contemporaneamente altro attraverso il proprio corpo. Involontariamente si esprimono questioni concernenti la relazione tra chi sta parlando e lascoltatore: imbarazzo, timore, amoreSe dunque, il linguaggio verbale fosse in qualche senso un sostituto evolutivo della comunicazione cinetica e paralinguistica ci si dovrebbe aspettare che i vecchi sistemi prevalentemente iconici fossero notevolmente decaduti. Ma evidentemente non stato cos. Al contrario, la cinetica delluomo diventata pi ricca e complessa, e il paralinguaggio fiorito parallelamente allevoluzione del linguaggio verbale. Tanto la comunicazione cinetica che il paralinguaggio sono stati elaborati in complesse forme artistiche, musicali, poetiche, di danza e via dicendo. Comprendiamo che la comunicazione analogica attraverso cui esprimiamo i cosiddetti sentimenti e le relazioni che stabiliamo con chi ci sta intorno prelinguistica, una sorta di vincolo primordiale alla vita nella sua parte pi animale, termine da intendere nel senso che stiamo adottando sin dallinizio di questo testo, cio come relazionale-iconica.
Abbiamo gi visto che la comunicazione analogica o relazionale metaforica. E la metafora sorretta da un sillogismo particolare che Bateson chiama sillogismo in erba per
-
distinguerlo dal classico sillogismo in Barbara.
Lerba mortale. Socrate mortale.Gli uomini sono mortali. Socrate un uomo.Gli uomini sono erba. Gli uomini sono mortali
Il primo un sillogismo in erba. E questa la logica usata dai poeti, e anche dagli schizofrenici, ma sostiene Bateson che essa anche la logica su cui si costruito il mondo, perch questo sillogismo si occupa dellidentificazione di predicati e non di classi e di soggetti di proposizioni. A parte la lingua non esistono classi con nome, o relazioni soggetto predicato. Pertanto i sillogismi in erba devono essere la modalit dominante per comunicare le interconnessioni delle idee in ambito preverbaleIl sillogismo in erba ha affinit anche con labduzione. Labduzione infatti un ragionamento metaforico che consiste nellaccorgersi che certi fenomeni possiedono caratteristiche formali simili. Le relazioni tra le componenti di ci che struttura i fenomeni sono analoghe. Ci che cambia, proprio come nella metafora, sono i termini della relazione: In Mente e natura Bateson scrive. La metafora, il sogno, la parabola, lallegoria, tutta larte, tutta la scienza, tutta la religione, tutta la poesia, il totemismo, lorganizzazione dei fatti nellanatomia, comparata: tutti sono esempi o aggregati di esempi di abduzione nella sfera mentale delluomo.
Non il messaggio ma il codiceRitorniamo ora ad una questione lasciata temporaneamente in disparte. Avevamo detto che il problema della grazia un problema di integrazione e ci che deve essere integrato sono le ragioni del cuore con quelle della ragione, linconscio con la coscienza e tutti i livelli intermedi tra coscienza ed inconscio. La questione che Bateson definisce fondamentale Sotto quale forma contenuta o codificata nellopera darte linformazione relativa allintegrazione psichica?Dobbiamo scoprire sotto quale forma si esprime lintegrazione o grazia che ci permette di riconoscerla attraverso le barriere culturali. Per riconoscere la forma in cui codificata linformazione sulla grazia Bateson ci dice che occorre non occuparsi di ci che lopera darte rappresenta, del contenuto e della storia che essa sottende. La questione verter piuttosto sullo stile, i materiali, la composizione, il ritmo e labilit tecnica. Ci che interessa Bateson sono quindi Le regole della trasformazione, non il messaggio ma il codice. E noto che Bateson interessato pi alla forma che ai contenuti. La forma in cui un contenuto espresso contestualizza, incornicia il messaggio. Il messaggio pu essere espresso nelle forme pi disparate, ma ci che gli da una sorta di tonalit emozionale, la maniera in cui esso formulato. I codici usati ci riconducono ancora alle riflessioni fatte sulla particolarit della comunicazione paralinguistica che prima abbiamo detto essere analogica. Composizione, ritmo, materiali e abilit tecnica ci ricordano immediatamente lampiezza del gesto, la forza della voce, la lunghezza della pausa, la tensione del muscolo che sono le caratteristiche della comunicazione cinetica e che hanno a che fare con la reazione emozionale di fronte a ci da cui siamo stimolati e allo stesso tempo con i codici della
-
tradizione e quelli che si possono inventare.Intrecciando i fili di tutte le riflessioni fatte sino a questo ricordiamo che: la comunicazione tra i mammiferi fondata sulle relazioni, ossia i mammiferi non comunicano altro che sulle relazioni. Sopra quale tipo di relazione si struttura il fare artistico? O meglio, con chi si sta relazionando il poeta o lartista creando la sua opera? Tale relazione non detto sia consapevole. Ma in gioco, se continuiamo a seguire tutte queste tracce lasciate da Bateson sparse nei suoi vari testi fino a Dove gli angeli esitano, ci sono le sue idee di arte, di estetica e di sacro.
Per proseguire scendendo pi a fondo nella riflessione estetica batesoniana riprendiamo ancora una volta un passo importante del saggio che stiamo seguendo. Una volta detto che in unopera darte dobbiamo interessarci del significato del codice e non del messaggio, Bateson scivola in una interessante argomentazione circa il significato del termine significato. E dice: Significato pu essere considerato come un sinonimo approssimativo di struttura, ridondanza, informazione, e restrizione, entro un paradigma del tipo seguente: si dir che un qualunque aggregato di eventi o oggetti (ad esempio una successione di fonemi, un quadro, una rana, o una cultura) contiene ridondanza o struttura, se laggregato pu essere diviso in qualche modo mediante segno di cesura tale che un osservatore, il quale veda soltanto ci che sta da una parte della cesura, possa congetturare, con esito migliore del puro caso, ci che si trova dallaltra parte. Si pu dire che ci che sta da una parte della cesura contiene informazione o ha significato relativamente a ci che sta dallaltra parte.Qualcosa possiede una struttura, e dunque ha significato se ci d informazioni anche su ci che sta dallaltra parte rispetto ad un ipotetico segno di cesura. Bateson crede che occorra guardare allopera darte sia come qualcosa di internamente strutturato che come parte di una struttura pi ampia.La mia riflessione quindi ora si diramer in due. Dapprima penser allopera darte come struttura e poi alla stessa come parte di un tutto strutturato.
Lopera darte come struttura Si racconta che Picasso in treno, fu interpellato da uno sconosciuto che gli chiese con aria di sfida: Perch non dipinge le cose cos come sono? Picasso rispose mitemente che non capiva bene il senso di quella domanda. Allora lo sconosciuto estrasse una foto di sua moglie Voglio dire questo rispose. Ecco mia moglie cos. E Picasso, con un colpetto di tosse imbarazzato: E piccolina, no? E anche un po piatta
Per parlare dellopera darte come struttura mi sembra necessario ripercorrere alcune linee essenziali del concetto di struttura nel pensiero batesoniano. Per fare ci mi allaccer al capitolo XV di Dove gli angeli esitano: La struttura del tessuto. Ad un certo punto del capitolo; dopo aver delineato la distinzione proposta da Whitehead tra aritmetica ed algebra, Bateson sostiene: La struttura lalgebra di ci che si vuole descrivere. Laritmetica la scienza che si occupa dei numeri particolari mentre lalgebra nasce sostituendo ai numeri
-
particolari dei numeri qualsiasi. In questo senso si intende che lalgebra riguarda una presa di distanza dal particolare, unastrazione dal particolare. Per usare dei termini cari a Bateson e che ci provengono dal motto di Korzybski: La mappa non il territorio, lalgebra la mappa dellaritmetica. La struttura riguarda dunque la mappa, cio la descrizione che le creature possono discernere in ci che in s non possiede n mappe n classi. Pi avanti Bateson torna a parlare di logica matematica e dice E molto indicativo che i matematici accettino volentieri lidea che le relazioni tra le proposizioni possano essere autoevidenti, mentre non sono disposti a concedere questa propriet alle proposizioni stesse E come se sostenessero di saper parlare ma di non saper di che cosa parlano. E questa posizione esattamente parallela alla mia.Le due posizioni sono parallele se ci ricordiamo ci che Bateson pensava rispetto alla possibilit di conoscere le cose in s. La Ding an sich kantiana non pu essere colta, poich dentro di noi non ci sono, come amava ripetere, n palme da cocco n maiali, bens solo idee di palme da cocco e di maiali: ma, pur non potendo conoscere la Ding an sich, possiamo conoscere le relazioni tra le cose nonostante il linguaggio verbale non sia il metodo pi consono a provocare questa possibilit epistemologica. Bateson riassume alcuni criteri di ci che denomina struttura e per ci che concerne il rapporto tra struttura e linguaggio dice: Le lingue umane, in particolare forse quelle occidentali, possiedono la peculiarit di accentuare indebitamente le cose separabili. Esse sottolineano non le relazioni tra ma i termini della relazione: questa sottolineatura tende a far dimenticare che la parola struttura riservata alle relazioni. Se ci interessa la verit questa non pu che essere per noi, in quanto creature, una verit sulla mappa. Il territorio inconoscibile: per questo lunico ambito in cui possiamo rivendicare di poter essere nel vero lastrazione. La struttura una visione che astrae dal territorio, ma tutto ci che ci concesso.Bateson accetta il fatto che nessuna descrizione in s sia vera, ma ripete che forse vero nelleternit che la descrizione deve essere sempre ad una certa distanza dalle cose descritteche si pu tradurre unennesima volta con: la mappa non il territorio. La struttura una descrizione tratta dal flusso incessante delluniverso. Se la vita ci che vogliamo cogliere e descrivere non possiamo farlo che accettando limpossibilit di poter cogliere davvero quel processo che scorre indiviso, inclassificato, libero da qualsiasi maglia o ordito. La descrizione umana attraverso il linguaggio tenta come una rete di catturare quel processo ininterrotto. Ma, inevitabilmente, la rete attraverso cui la vita viene colta piena di buchi, infatti una rete. Vi sono lacune di dettaglio tra i dettagli. Per quanto fini siano le maglie della nostra rete descrittiva, i dettagli pi minuti sfuggiranno sempre alla descrizione. Questo non per distrazione o pigrizia da parte nostra, ma perch in linea di principio il meccanismo della descrizione, si tratti di una lingua o di un clich a mezzatinta digitale e discontinuo, mentre le variabili immanenti nella cosa da descrivere sono analogiche e continue. Se invece il metodo di descrizione analogico, scopriremo che nessuna quantit pu rappresentarne unaltra con precisione: ogni misura , sempre e inevitabilmente approssimata.
Per esemplificare linevitabile soglia o discontinuit tra struttura e processo Bateson cita il
-
frammento di una poesia di Robert Southey che descrive una bambina che osserva un oggetto trovato in un prato.
Cos grande, liscio e rotondoDice Wilhelmine
Leggendo questa poesia dobbiamo lasciarci trasportare dalla descrizione del poeta - la ricetta mentale che il poeta ci offre- che man mano ci fa scoprire, tracciando dei contorni, che quelloggetto di cui sta parlando il teschio di un soldato morto in battaglia. La poesia un tessuto con una sua propria struttura, che, se confrontato con la realt della cosa designata, con il territorio di cui sta tracciando la mappa, inevitabilmente un tessuto pieno di buchi.Sembra che larte e la poesia , a differenza di altre forme descrittive partono dal presupposto che la realt non pu essere colta che tramite una rete piena di buchi. Anzich pretendere di voler ricoprire tutto, larte e la poesia generano strutture autonome che raggiungono i massimi livelli forse proprio quando meno elementi sono presenti e nonostante ci la vita viene espressa intensamente nella consapevolezza dei propri limiti. Usare il termine limiti pu far generare fraintendimenti. Per limite intendo qualcosa di strutturale, di implicito alla natura stessa della creatura umana che come abbiamo visto, n attraverso una descrizione digitale, n attraverso una analogica, pu rappresentare il reale, inteso come Ding an sich.Il fatto che larte parte da questo presupposto strutturale non per tentare di rimuovere il limite, ma accettando questo limite, e dunque la natura umana in s, per riproporre la vita senza alcuna pretesa di esserne specchio fedele, ma rifuggendo da questa impresa, per poter essere specchio nellunica maniera che ci possibile: linfedelt.Passiamo ora ad un altro interessante saggio intitolato La creatura e le sue creazioni. In esso Bateson afferma che: La natura stessa e il fine dellarte e della poesia sono di esemplificare la creativit della mente e questo il teorema fondamentale appropriato a una scienza dellestetica.Vorrei convalidare con le parole di Bateson ci che ho fin qui detto sullinfedelt strutturale dellarte. In questo testo Bateson cita unaltra poesia: The man with a blue guitar di Wallace Stevens.Il poeta si vede separato dalle cose come sono. Infatti c un oggetto su cui lorganismo (in questo caso il poeta) non pu dir nulla e , nel suo poemetto, questoggetto chiamato le cose come sono. Forse questa cosa, questoggetto ineffabile, solo una finzione. Ma essi (il mondo degli ascoltatori, delle persone come sono) criticano il cantore (il poeta):
Essi dissero: Tu hai una chitarra azzurra,Tu non suoni le cose come sono
La creativit della mente esemplificata dallarte proprio laccettazione del filtro della chitarra azzurra che il creare poetico ed artistico conosce meglio di qualsiasi altro tipo di creazione.Lartista accetta linfedelt strutturale della nostra percezione: in questa accettazione non si muove con la pretenziosit di chi crede di poter tutto avvolgere con una rete finissima, ma
-
con lumilt e la grandezza di chi sa di poter cogliere solo contorni, e di poter giocare con essi.
Lopera darte come parte di un tutto strutturatoPrima che il nostro percorso si biforcasse avevamo detto che lopera darte sia internamente strutturata, sia parte di una struttura pi ampia che pu essere colta grazie alle caratteristiche stesse dellopera darte in quanto elementi che concernono la pi ampia struttura.Imbocchiamo ora la seconda tra le due strade che Bateson ci consiglia di frequentare per parlare di arte. Che lopera darte sia ridondante rispetto ad una pi ampia struttura di cui fa parte possibile percepirlo attraverso unanalisi che non verta tanto sul contenuto dellopera quanto sul tipo di codice utilizzato: stile, abilit tecnica, materiale, ritmo e composizione. Ossia dalle caratteristiche dellopera intesa come struttura.Torniamo ora nuovamente al saggio Stile grazia informazione nellarte primitiva. Sostiene Bateson che: Si ritiene che le caratteristiche delle opere darte di riferiscano ad altre caratteristiche dei sistemi culturali o psicologici, o parzialmente ne derivino, o ne siano determinate: il nostro problema potrebbe quindi essere rappresentato in modo molto schematico mediante il seguente diagramma:
[caratteristiche dellopera darte/Caratteristiche del resto della cultura]
ove le parentesi quadre racchiudono luniverso di pertinenza e la barra obliqua rappresenta la cesura attraverso la quale possibile qualche previsione, in una o in tutte le direzioni. Il problema allora quello di specificare quali tipi di relazioni, corrispondenza, ecc. attraversano o trascendono questa barra obliqua.Adoperando il suo consueto metodo abduttivo Bateson esemplifica questo problema proponendo un altro modello di relazione tra due universi strutturati, Dice: Supponiamo che io vi dica: Piove, e voi immaginate che, guardando fuori dalla finestra, vedrete piovere. Ci serviremo di un diagramma analogo:
[caratteristiche di piove/percezione della pioggia]
Interessante lintuizione batesoniana quando sostiene che poche persone in una simile circostanza si trattengono dallosservare fuori dalla finestra per controllare o verificare la correttezza dellopinione che abbiamo sulla nostra relazione con gli altriQuesto punto illustra oltre che la disposizione gerarchica dei sistemi di comunicazione, il fatto che la conformit tra le parti di un tutto strutturato pu contenere informazioni su un tutto ancor pi ampio di cui parte: in questo caso la relazione tu-io.
[(Piove/Pioggia)/relazione tu-io]
Trasponendo abduttivamente questo schema nellambito dellarte, allora unopera darte
-
potrebbe contenere informazioni interessanti sulla cultura in cui si genera e sulle relazioni tra il creatore dellopera e la societ di cui fa parte. Ma ci che trasmette questo messaggio come abbiamo visto non il contenuto bens il codice scelto. Per questo motivo Bateson incomincia a sondare lambito della relazione tra labilit tecnica e la struttura o ridondanza nellopera darte. Labilit tecnica concerne il codice e ci pu aiutare a rintracciare il rapporto tra il tutto pi ampio e lopera darte.Sulla base dellimpossibilit di scindere abilit tecnica da struttura mi sembra utile osservare alcune riflessioni che Bateson ha fatto nel 1968, in un saggio pubblicato in Una sacra unit: La struttura morale ed estetica delladattamento umano. Queste riflessioni ci riconducono ancora al tema della grazia. Bateson dice: Non sappiamo praticamente nulla dei processi con cui un lanciatore di baseball calcola il proprio lancio o un gatto valuta il balzo necessario a catturare un sorcio. Ma certo che questi calcoli non vengono fatti come li effettuerebbe un ingegnere: il gatto e il lanciatore non ricorrono al calcolo differenziale. Che cosa accade allora quando il gatto e il lanciatore esercitano la loro abilit? Bateson fa unipotesi: essi potrebbero conseguire i loro miracoli di precisione usando se stessi come metafora centrale.In una lettera di Bateson alla figlia Mary Catherine, Bateson approfondisce questo tema e ipotizza: E se fosse cheA)Ci che noi possiamo percepire del s la metafora che noi siamo; eB)Noi siamo la nostra epistemologiaC)Il nostro mondo interiore, il nostro microcosmo questa epistemologia; eD)Il nostro microcosmo una metafora appropriata del macrocosmo?[]Questi pensieri ci fanno regredire ad una sorta di totemismo: cominciamo a vederci come metafore della quercia e del coleottero e i nostri processi di pensiero (che sono necessariamente interazione) divengono la metafora dellevoluzione.In un capitolo di Dove gli angeli esitano la coautrice Mary Catherine fa coincidere il concetto di s come metafora centrale con il termine empatia. Anche il padre, in Mente e natura, propone uninterpretazione dellempatia allinterno, per, di alcune riflessioni sul totemismo. Con il termine totemismo gli antropologi designano una religione che si fonda sullanalogia tra individuo, sistema sociale e mondo naturale. Questa idea in parte esatta e in parte fantasiosa. Ma come Bateson ci ha ripetutamente insegnato, le idee sul nostro s tendono ad autoconvalidarsi, quindi questa fantasia totemica diviene morfogenetica. Presso molti popoli la gente rintraccia le leggi del loro agire individuale e sociale dalle leggi che regolano il mondo naturale e biologico. C quindi una sorta di empatia tra il s e il mondo naturale. Le regole dellagire vengono rintracciate a partire dallosservazione di leggi biologiche e naturali analoghe a quelle che regolano le parti componenti il s e gli elementi componenti la societ. Il totemismo una religione fondata su metafora e abduzione che non sono solo espedienti letterari, ma costituiscono la logica che regge landamento delluniverso secondo Bateson. Adeguarsi ad un agire che considera il s come metafora centrale e intuire in maniera abduttiva le regole del comportamento da questa metafora significa porci in una relazione con la pi grande struttura che connette.Abbiamo gi parlato di metafora e abbiamo visto che ci di cui si avvale la metafora la riproposizione di un certo tipo di relazione che fondante per due universi esplicativi. I
-
termini della relazione risultano cambiati ma la relazione ci che continua a rimanere valida. Quindi anche utilizzando il s come metafora centrale stiamo parlando di una relazione: non una relazione tra le altre, ma quella che Bateson considera fondante labilit in qualsiasi campo e in qualsiasi forma di vita. Il gatto pu balzare un salto perfetto azzannando il sorcio forse perch mette se stesso nei panni del sorcio in un calcolo che effettua a livelli troppo profondi per poter essere tradotti. Cos come Konrad Lorenz utilizzava lempatia per poter comprendere gli animali. Provava a fare le stesse cose che vedeva loro fare per poterli capire.Ma Bateson stato chiaro parlando di abilit: ha ricordato che qualcosa che non pu tradursi a parole. C una profonda corrispondenza tra abilit tecnica e abitudine. Entrambe sono programmate negli strati meno accessibili della mente. Il dilemma dellartista dice Bateson di un genere particolare: egli per esplicare le componenti tecniche del suo mestiere deve esercitarsi. Ma lesercizio ha sempre un duplice effetto: da una parte rende lartista pi abile nellesecuzione di ci che tenta di fare; e dallaltra parte, per il fenomeno della formazione dellabitudine, lo rende meno consapevole di come lo faccia.
Pu darsi che lapproccio estetico offra scorciatoie per valutare e criticare piani dazione, sostiene Bateson.Se per estetico si intende sensibile alla struttura che connette ora possiamo meglio parafrasare questa frase asserendo che i comportamenti determinati dalla bellezza, che sono quelli che siamo portati a definire come dipendenti dallarte, pur non riferendoci ad ambiti esclusivamente artistici come labilit di certi professori o giardinieri, o cuochi o addestratori di animali e cos via- dipendono dalla percezione di una intima analogia tra il s e ci con cui ci relazioniamo, tra il s e la pi ampia struttura.Ci che ipotizzo che la miopia sistemica, il riduzionismo, le forme pi grossolane di dicotomia mente/corpo, e cos via possono essere mitigati o evitati ricorrendo a processi mentali in cui tutto lorganismo (o gran parte di esso)sia usato come metafora. Probabilmente questi processi non seguono la lunga e tediosa strada di calcolare tutte le relazioni tra le variabili importanti, ma usano vari tipi di scorciatoie e congetture. Ma tengono comunque conto del fatto che lecosistema o la societ sono vivi.Usare se stessi come metafora centrale sottende una concezione del sistema di cui si parte come qualcosa di vivo. Quindi le loro azioni rispettano la flessibilit dei sistemi vivi, lasciando che non sia solo la coscienza lunico ago della bussola da usare per districarci nel corso della vita, ma anche livelli pi profondi. Il raggiungere un certo tipo di abilit tecnica comporta concedere spazio nelle nostre azioni anche a livelli di cui non possiamo essere consapevoli ma che, comunque, se lasciati liberi dalla volont della coscienza di esserne la capitana, dirigono la nostra andatura, lasciando libere queste componenti di seguire un moto senza rigide redini a trattenere il loro svolgimento. Un andamento che non essendo diretto dalla volont non pu che far scaturire la sua direzione da ci che ci circonda e che non siamo abituati a concepire come parti del nostro s. Ma se il s non rinchiuso nella nostra pelle, come ci ha insegnato Bateson, significa che esso pu percepire impulsi allagire in ci che la coscienza evita.
-
Mary Catherine BATESON, Dove gli angeli esitano, Adelphi, Milano.1989, cit.,p.289. Gregory BATESON, Mente e natura, Adelphi, Milano, 1984, cit.,p.17-18. Saggio contenuto in Verso unecologia della mente, Adelphi, Milano, 1976, pp.413-428. Ivi,p.416. Ivi,p.178. Ivi,p.178. Cfr. Verso unecologia della mente,p.174. Ivi,p.173. Ivi,p.176. Ivi,p.174. G.BATESON, Forma, sostanza e differenza, in Verso unecologia della mente, cit.p.504. G.BATESON, Stile, grazia e informazione nellarte primitiva, cit.,p.182. Ivi,p.182. Ivi,p.184. Ivi,p.167. Problemi relativi alla comunicazione tra i cetacei e altri mammiferi, in Verso unecologia della mente, cit.,pp.422-423. G.BATESON, Ridondanza e codificazione in Verso unecologia della mente,cit.,p.448. G.BATESON, Dove gli angeli esitano, cit., p.49. Ivi,p.49. G.BATESON, Mente e natura, cit.,p.192. G.BATESON, Stile, grazia ed informazione nellarte primitiva, in Verso unecologia della mente, cit., pp.167-168. Ivi,p.169. Ivi,p.169. G.BATESON, Dove gli angeli esitano, cit., p.229 Ivi,p.236. Ivi,p.294. Ivi,p.234. Ivi,p.246. Ivi,p.243. G.BATESON, La creatura e le sue creazioni in Una sacra unit, Adelphi, Milano, 1997, cit.p.397. Ivi,p.398. G.BATESON, Stile grazia ed informazione nellarte primitiva, in Verso unecologia della mente, cit.,p.170. G.Bateson, Dove gli angeli esitano, cit.p.170. Cfr. Ivi,p.170.
-
Ivi,p.171. G.BATESON, Una sacra unit,cit.,p.389. Ivi,p.389. G.BATESON, La metafora che noi siamo. Nove anni dopo, in Una sacra unit, cit.,pp.154-155. Cfr. MARY CATHERINE BATESON, Dove gli angeli esitano. cit., p.291. G.BATESON, Stile, grazia e informazione nellarte primitiva, in Verso unecologia della mente, cit.p.177. G.BATESON, La struttura morale ed estetica delladattamento umano, in Verso unecologia della mente, cit., p.385. Ivi,p.389.