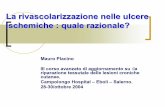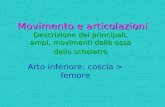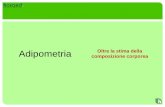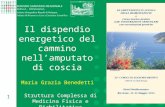Aristea Di Proconneso SPPEO Coscia
-
Upload
alessandro-coscia -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of Aristea Di Proconneso SPPEO Coscia

7/25/2019 Aristea Di Proconneso SPPEO Coscia
http://slidepdf.com/reader/full/aristea-di-proconneso-sppeo-coscia 1/8
IATROMANTI, SCIAMANI, UOMINI DIVINI?
ARISTEA DI PROCONNESO E LA TRADIZIONE PITAGORICA
Qualche nota sugli «sciamani» greci
Il dibattito sulla effettiva esistenza storica di figure sciamaniche nell’antica Grecia è ancora aperto,e forse fin troppo stratificato da interpretazioni dal segno più vario. 1
Storici, filosofi, commentatori antichi menzionano l’esistenza di personaggi come Abarisl’Iperboreo, pimenide di !reta, Aristea di "roconneso, veri e propri esempi di wundermann,uomini divini, spesso legati dalle fonti alle tradizioni sapienziali dell’gitto e dell’#riente, o allemisteriose plaghe iperboree, capaci di compiere viaggi uscendo dal corpo, di attuare guarigioni, divivere e rinascere, di purificare citt$. In una parola, gli iatromanti, secondo un termine di coniorecente, ma efficace.%
A partire dal contributo pionieristico di &arl 'euli e dal fondamentale studio di ric (odds ), glispecialisti si sono divisi sull’uso della categoria ermeneutica di *sciamanesimo+, in ambito greco. Atutt’oggi, la letteratura scientifica oscilla tra il possibilismo di ur-ert e lo scetticismo diremmer /. 0uesto tipo di discussione, peraltro, corre il rischio di impantanarsi in un ginepraio dicaratterere nominalistico e tecnico, più che di centrare la sostanza del fenomeno. !hi negalapplicazione del termine 2sciamano3 a figure del mondo ellenico ne enfatizza le differenze rispettoal prototipo dello sciamano siberiano o centroasiatico. 4el procedimento classificatorio, analogie ediversit$ vengono accentuate o sminuite per consentire ladattamento dei dati a una o allaltra grigliainterpretativa.5’altro polo di discussione, una volta ammessa l’esistenza di fenomeni di tipo sciamaniconell’occidente greco, è la possibile realt$ storica di contatti antichi tra la cultura greca e 6uellatracio7scitica, o iranica, dove tali fenomeni sembrano essere attestati8. 0uesto aspetto è ancora piùdelicato del primo, perch9 si scontra con archetipi :o paradigmi; ormai consolidati nelle strutture
mentali di molti specialisti< archetipi di segno opposto, che vanno da concezioni basate suldiffusionismo :contatti precoci tra mondo greco e mondo orientale; alla negazione di 6ualsiasiapporto derivato alla Grecia dalle culture extragreche.=
1 >ninteressante panoramica sulla storia degli studi :e, insieme, un acuto excursus di storia della cultura; è in .(ettori, Aristea di Proconneso “sciamano” e “corvo”: una presentazione (con qualche nota, 20uaderni di!lassiconorroena3, I, %??/, pp. @7%.
% "er unescussione critica delle fonti è ancora fondamentale I.". !ulianu, !atroi "ai manteis# $ulle strutturedell%estatismo greco, 2Studi storico religiosi3, I, 1@B?, pp. %BB7)?), con relativa bibliografia. Celativamente pococitato negli studi di settore, è uno dei più lucidi tentativi di in6uadramento della figura dell estatico nellanticaGrecia. Si veda anche I.". !ulianu, &sperienze dell%estasi dall%&llenismo al 'edioevo, 5aterza, Coma7ari 1@B8, pp.1@7)B. A !ulianu si deve anche il conio :e la fortuna moderna; del termine iatromantis :crasi dei termini iatros«guaritore3 e mantis, 2indovino3, gi$ attestati, in forma accostata, nelle fonti antiche;
) &. 'euli, $c)thica, 2Dermes3, =?, 1@)/, pp. 1%171=8E . (odds, *he +ree"s and the !rrational er-eleF 1@/1<trad. ! +reci e l%irrazionale, 5a 4uova Italia, irenze 1@=). 'a gi$ rHin Cohde aveva preparato il terreno alleinterpretazioni sciamanistiche, cfr. . Cohde, Ps)che, II, reiburg im r. 1B@B< trad. Ps)che, 5aterza ari, 1@18.
. ur-ert, ,ore and $cience in Ancient P)thagoreanism, !ambridge, 'ass. 1@=%./ J. remmer, *he &arl) +ree" -oncept o. the $oul , "rinceton 1@B), pp. %/7)B. 'a uno storico di formazione
classicista come Alfonso 'ele utilizza senza remore laggettivo 2sciamano3 per definire "itagora nella fasemetapontina della sua attivit$. edi A. 'ele, Pitagora .iloso.o e maestro di verit/, Scienze e 5ettere, Coma %?1), p.8@. !i pare comun6ue positivo che il dibattito sul cosiddetto sciamanesimo greco si stia incanalando in una
prospettiva interdisciplinare, come sembrerebbe risultare, ad esempio, dalle comunicazioni presentate al convegno2Sciamanesimo e sciamanesimi. >n problema storiografico3, tenuto a Coma il 1? maggio %?1?, i cui interventi nonho potuto consultare perch9 non ancora pubblicati :tra 6uesti, il contributo della studiosa 'arisa Kortorelli Ghidini, 0 esistito uno sciamanesimo greco1;.
8 &. 'euli, $c)thica, cit., p. 1/BE . (odds, ! +reci e l%irrazionale, cit., pp. 1=171=). Sui legami tra culti estatici
nelloccidente e sciamanesimo orientale si veda !. Ginzburg, $toria notturna# 2na deci.razione del sa33a, inaudi,Korino 1@B@.
= Si vedano le riflessioni di "eter &ingsleF in ". &ingsleF, +ree"s $hamans and 'agi, 2Studia Iranica3, %), 1@@, pp.1B=71@=.

7/25/2019 Aristea Di Proconneso SPPEO Coscia
http://slidepdf.com/reader/full/aristea-di-proconneso-sppeo-coscia 2/8
'a chi è propriamente lo sciamanoL Il grande sdoganatore del termine e del tema, negli studistorico religiosi in #ccidente, è stato 'ircea liadeB :anche se in uropa la parola era stata ac6uisitatramite la mediazione di espolratori ed etnografi ed entrM nel dibattito scineticio gi$ alla finedellB??;. "er comodit$ utilizziamo lefficace e sintetica definizione che ne d$ lo storico dellereligioni Gilberto 'azzoleni<
25o sciamano :dall’inglese shaman, adattamento del termine tunguso Naman; è un operatore rituale chegeneralmente agisce in stato di transe OPQ. Attraverso una progressiva attenuazione dello stato di veglia, losciamano perde il controllo del s9, consentendo alla propria *anima+ di staccarsi dal corpo e intraprendere unviaggio verso 6uella entit$ eRtraumana che gli possa rivelare le ragioni e i rimedi di una crisi, di un malessereo di una minaccia che incombono sulla comunit$3.@
5o sciamanesimo, inteso come fenomeno storico, ha una sua precisa connotazione geografica ereligiosa, che trova il suo fulcro nelle civilt$ subartiche dell’Asia e dell’America. 5’uso acritico edecontestualizzato di 6uesto termine per identificare realt$ differenti tra loro ha comportatosicuramente il rischio di interpretazioni fuorvianti. 'eglio sarebbe, dun6ue, parlare disciamanesimi, data la diffusione del fenomeno e per evitare il rischio di utilizzare impropriamente
un concetto che, provocatoriamente, e a differenza del termine 2sciamano3, si potrebbe definirecome 2il risultato di uninvenzione3.1? "er converso, una posizione ultrascettica sulla possibilit$ dicogliere tratti sciamanici, in alcune manifestazioni culturali dell’occidente, rischia di appiattire lospettro di possibilit$ di ricerca.
4on è 6uesta la sede per approfondire la 6uestione in termini generali, n9 per tentare di riformularenuove categorie interpretative.5a nostra prospettiva, nei limiti di 6uesto contributo e di chi scrive, vorrebbe essere 6uella dellascuola antropologica di !lifford Geertz11< lapproccio emico, che consiste nellanalizzare ifenomeni religiosi in 6uestione prendendo in esame le differenze, gli scarti rispetto alla nostra
.orma mentis, attraverso l’esame di figure liminari, eccentriche, rispetto a una generica visionemoderna della religione greca. Il punto di vista emico è 6uello dell osservato, non
dellosservatore. #vviamente, lanalisi deve muoversi tra i due poli, 6uello emico e 6uello etico :il punto di vista dellosservatore;, per giungere a uninterpretazione organica.1%
!hiarito, e assodato, che non esiste una religione greca :n9 una religione romana; intesa come blocco monolitico di riti, miti e credenze cristallizzate, si propone di ripartire a livello ermeneuticoscavando negli strati delle interpretazioni che si sono sovrapposte nel tempo, a cominciare daitermini con cui i Greci designavano i loro 2sciamani3. 0uesto non per preservare un concettocristallizzato di cultura greca da possibili contaminazioni esterne :tendenza che uno studiosocome "eter &ingsleF rileva ancora, sotto varie forme, negli studi classici; ma per collocare i
B '. liade, ,e chamanisme et les techniques archa4ques de l%extase, "aFot, "aris 1@/1 :"aFot, "aris 1@8B, II ed.condotta sulla scorta della traduzione inglese, 1@8;E trad. ,o sciamanismo e le tecniche arcaiche dell%estasi, occa,Coma 1@/) :I ed.;E ,o sciamanismo e le tecniche OsicQ dell%estasi, dizioni 'editerranee, Coma 1@= :II ed;,
consultata per il presente lavoro.@ G. 'azzoleni, 2Il viaggio dello sciamano3, in A. Saggioro :a cura di;, $ciamanesimo e sciamanesimi, !arocci,
Coma %?1?, p. %. Si veda in generale tutto il volume, che rappresenta una buona panoramica sullo statusquaestionis.
1? Angelo relich gi$ nel 1@88 notava che i termini sono impiegati in senso largo anche al di fuori dellarea culturaleindicata, in cui 6uelle caratteristiche hanno una precisa concomitanza e un rilievo particolare. Il dibattito sullavischiosit$ del termine 2sciamanesimo3 risale gi$ agli inizi del @??. an Gennep lo considerava una parola vaga,dal fascino esotico e spesso usata impropriamente e metteva in guardia sul rischio di considerare lo sciamanesimouna religione. >na disamina del dibattito è in A. Saggioro, 2Sciamani e sciamanesimi< invenzione o scopertaL3, inA. Saggioro, $ciamanesimo e sciamanesimi, cit., pp. @7%%.
11 !. Geertz, Antropologia interpretativa, Il 'ulino, ologna [email protected]% >tilizziamo in 6uesta sede le categorie ermeneutiche di !lifford Geertz< il punto di vista 2etico3 è 6uello
dellosservatore estraneo ad una cultura, in opposizione al punto di vista 2emico3, 6uello dellosservato. "er
lapplicazione di 6ueste categorie allo studio delle civilt$ greche e romane si vedano G. (e Sanctis, ,a religione a 5oma, !arocci, Coma %?1%, pp. @718E '. ettini, -omparare i 5omani# Per una antropologia del mondo antico ,2Studi Italiani di ilologia !lassica3, suppl. al vol. II, s., %??@, pp. 17= :tra gli iniziatori in Italia dellapproccioantropologico allo studio del mondo classico;.

7/25/2019 Aristea Di Proconneso SPPEO Coscia
http://slidepdf.com/reader/full/aristea-di-proconneso-sppeo-coscia 3/8
fenomeni in una serie morfologica storicamente contestualizzata.1)
+li iatromanti e le estasi5a difficolt$ nelladeguare categorie antropologiche desunte da altre civilt$ a una serie di fenomeniattestati in ambito greco, come 6uello dei culti estatici, emergono in maniera evidente, se ci si faimprigionare dalla tassonomia. Ioan '. 5eHis, nel suo &cstatic religion del 1@=11, individuava tre
tipi di possessione, fondati sul rapporto tra il soggetto e lentit$ che domina o da cui è dominato<1. culti estatici: il soggetto è involontariamente posseduto dagli spiritiE%. sciamanismo< il soggetto ha un controllo consapevole sugli spiritiE). stregoneria< loperatore che domina gli spiriti li dirige contro il soggetto passivo che sar$
posseduto contro la sua volont$.Il culto dionisiaco, secondo lo stesso 5eHis, rientra nel primo caso. 'a, come vedremo, non è certoche sia esclusivo del primo caso, in ambito greco. I fenomeni che invece occorrono agli iatromantigreci possono essere classificati come sciamanesimoL "roviamo a rispondere partendo da come6uesti fenomeni erano descritti dai Greci.Il termine iatromante deriva dalla combinazione di iatros :medicoTguaritore; e mantis :indovino;. Iltermine, o meglio i due termini accostati, sono attestati in schilo 1/, a proposito del dio Apollo, e, in
un altro contesto, a proposito di suo figlio Apis18. In entrambi i casi pare evidente il legame tramantica, capacit$ profetica e medicina. 5o stesso legame, nellambito culturale arcaico, ritorna nelfilosofo :in cui alcuni studiosi ravvisano tratti sciamanici o iatromantici; mpedocle, 6uandoafferma che gli uomini purificati dal tempo e dalla corporeit$ 2alla fine diventano m/nteis eh)mnop6loi :poeti; e medici e principi3.1= !ome aveva gi$ intuito 'ario egetti, ciM che accomuna6ueste figure è sia il controllo delle dimensioni temporali :lindovino e il poeta; sia la capacit$ dicondurre alla salvezza, alla guarigione. 'a possiamo spingerci oltre nellinterpretazione del passo.5a gradazione di ruoli o figure empedoclea, infatti, contiene le caratteristiche dello sciamano percome è stato definito da liade e dai moderni antropologi< un individuo in grado di controllare ladimensione temporale, con capacit$ guaritorie e mitopoietiche :è un narratore di storie;. 1B
4el secolo a.!. dun6ue un greco accosta 6uesti tratti in un percorso che potremmo definireiniziatico, ma soprattutto li mette in correlazione. U importante evidenziare 6uesto fatto, per lepocaarcaica, perch9 ridimensiona laffermazione che i presunti tratti sciamanici dei personaggi di cui cioccupiamo siano uninvenzione tarda. >n passo di !lemente Alessandrino, gi$ analizzato a suotempo da Ioan !ulianu1@ li riunisce in una presentazione collettiva<
2Il pronostico era praticato dal grande "itagora, da Abari lIperoboreo, da Aristea di "roconneso, da
1) "er il concetto di 2serie morfologica3 si veda ancora !. Ginzburg, $toria notturna, cit., pp. 1)?71/@. Sulla tendenzaconservatrice di alcuni studi classici si veda ". &ingsleF, +ree"s $hamans and 'agi, cit., pp. 1@?71@1.
1 I.'. 5eHis, &cstatic 5eligion# An Anthropological $tud) o. $pirit Possession and $hamanism, "enguin,DarmondsHorth 1@=1E trad. ,e religioni estatiche# $tudio antropologico sulla possessione spiritica e sullo sciamanismo, >baldini ditore, Coma 1@=%.
1/ &um. 8%18 $uppl . %8). >na terza ricorrenza è in Ag . 18%), con valore ironico, ma che ne conferma la valenza medica< in 6uesto
contesto si minaccia linervento dello iatr6mantis per curare con i lacci e la fame la malattia dei phr7nes di unvecchio impertinente. Si veda '. egetti, 2IatrMmantis. "revisione e memoria nella Grecia antica3, in '. ettini :acura di;, ! signori della memoria e dell%o3lio: .igure della comunicazione nella cultura antica, 5a 4uova Italia,irenze 1@@8, pp. 8/7B1.
1= 8atharmoi 18 O)B7)B8&., =7@ St.Q. 5intuizione primigenia sul nesso tra memoria, divinazione e sapienza èdi Jean7"ierre ernant, 2Aspetti mitici della memoria e del tempo3, in 'ito e pensiero presso i +reci# $tudi di psicologia storica, inaudi, Korino 1@=?, pp. @)71% :in particolare pp. 1?B711);
1B 5a connessione tra controllo del tempo, e dun6ue la memoria, è uno dei fondamenti della conservazione del passato.Su 6ueste premesse si basa 6uella 2immortalit$ sciamanica3 legata al culto pitagorico della 'emoria che consistenel riportare a consapevolezza la vicenda temporale del demone immortale di cui ogni esistenza individuale è soloun segmento. edi '. egetti, 2IatrMmantis3, cit., p. 88. Il problema esonda i limiti di 6uesto contributo, ma la
connessione tra il pitagorismo e il revivalTreinterpretazione di figure sapienziali e iatromantiche andrebbe indagato più a fondo. Si veda, ad esempio, !. rillante, !l sogno di &pimenide, 20uaderni >rbinati di !ultura !lassica3, n.s.,II, ==, %??, pp. 117)@.
1@ I.". !ulianu, !atroi "ai 'anteis, cit., p. %B@. "er la citazione si veda !lemente Alessandrino, $trom#, I, %1.

7/25/2019 Aristea Di Proconneso SPPEO Coscia
http://slidepdf.com/reader/full/aristea-di-proconneso-sppeo-coscia 4/8
pimenide il !retese, che andM a Sparta, da Voroastro il 'edo, da mepedocle di Acragas e da ormio loSpartanoE e certamente anche da "oliarato di Khasos, da empedotimo di Siracusa e specialmente da SocratelAteniese3.
4on ci occuperemo nel dettaglio di ciascuna di 6ueste figure. !ulianu ha passato al vaglio inmaniera convincente 6uesto elenco, concludendo che la presenza di Socrate e Voroastro è 2unafantasia ellenistica3, mentre mpedotimo è un personaggio creato da raclide "ontico. Alla lista!ulianu propone di aggiungere a-is :nome di un individuo, ma anche di una categoria diiatromanti;, !leonimo di Atene, rmotimo di !lazomene e 5eonimo di !rotone. %?
!lemente Alessandrino colloca 6ueste figure nella categoria dei cresmologi, individuando dun6ue lacapacit$ profetica come tratto comune.Abaris e Aristea sono chiaramente descritti, gi$ dalle fonti antiche, in stretto legame con ApolloIperboreo, ma 6uesto rapporto non è cosW evidente nel caso di pimenide, la cui iniziazione avvienesotto il segno di Veus.5a classificazione di !lemente non è stata certo condotta secondo criteri filologici, e la forzatura èevidente. 5influsso di uno sciamanesimo tracio7scitico potrebbe ancora essere contemplato :anchesolo come ipotesi di studio; nel caso di Abaris e Aristea, legati geograficamente a 6uellambito, ma
causa difficolt$ nel caso di pimenide !retese. U stato ipotizzato che 6uestre figure siano staterielaborate e adattate ad un paradigma comune in epoca più tarda :e vedremo come;. 'a è correttousare la definizione di sciamani per alcuni di 6uesti, e non per altri, solo perch9 non risulta attestatauna correlazione con il mondo scitico o nordico o perch9 non si puM ravvisare lo schema ermenutico
proposto dagli antropologi nel caso della possessione sciamanicaL Ancora una volta, cè un problema terminologico.Soffermiamoci su Abaris, vissuto al più tardi nel I secolo a.!. del 6uale, come abbiamo detto, lefonti mettono in evidenza proprio il legame con Apollo, oltre alle capacit$ iatromantiche. 5etestimonianze più antiche su Abaris 7 oltre ad una menzione da parte del poeta "indaro :fr. %=?Snell; 7 sono contenute nelle $torie di rodoto e in un frammento delloratore ateniese 5icurgo.
2ra scita, figlio di SeitoP e dicono che 6uando scoppiM una pestilenza su tutta la terra abitata, Apollo, aiGreci e ai barbari che consultavano l’oracolo, diede il responso che il popolo ateniese facesse un voto a nomedi tutti. poich9 molti popoli mandarono ambasciatori agli Ateniesi, dicono che dagli Iperborei giungesseambasciatore anche Abaris, durante la cin6uantreesima olimpiade O/8B7/8/Q3.%1
2Abaris, 6uando fu ispirato dal dio :9nthous ghenmenos;, andM in giro per la Grecia con una freccia, e pronunciM responsi oracolari e divinazioniE il retore 5icurgo poi dice, nell’orazione contro 'enesecmo, cheAbaris, 6uando si presentM una carestia fra gli Iperborei, partW e si pose al servizio di Apollo. dopo averimparato da lui i responsi oracolari, tenendo la freccia, simbolo di Apollo, andM in giro per la Grecia facendo profezie3.%%
24on racconto invero, riguardo ad Abari che si dice essere stato Iperboreo, il discorso secondo cui portM ingiro per tutta la terra la freccia, senza mangiare nulla3.%)
"orfirio, autore di una ;ita Pitagorica riporta una versione alernativa, parlando di Abarisleterobata, cosW detto 2perchè facendosi trasportare da una freccia donatagli da Apollo Iperboreo,superava fiumi, mari e passaggi inaccessibili, viaggiando in 6ualche modo nellaria3. "latone nomina con ironia Abaris, insieme a ValmoRis ricordandolo come un personaggio chefaceva incantesimi a fini terapeutici%.
%? I.". !ulianu, !atroi "ai 'anteis, cit., p. %B@E Id., &sperienze dell%estasi, cit., p. %%7%).
%1 Suda, s.v. XYZ[\] .̂%% 5icurgo, fr. /a lass7!onomis.%) rodoto, , )8 :trad. di Giorgio !olli;.% "latone, -armide 1/Bb.

7/25/2019 Aristea Di Proconneso SPPEO Coscia
http://slidepdf.com/reader/full/aristea-di-proconneso-sppeo-coscia 5/8
Korniamo alle fonti< Abaris è detto _`^%/, tradotto con posseduto dal dio. In seguito a 6uesta possessione, Abaris ottiene capacit$ profetiche e guaritorie. ppure le fonti greche parlano di2possessione3, ciM che striderebbe con il paradigma sciamanico che prevede che loperatorecontrolli consapevolmente gli spiriti. ppure altri elementi dell A3arisroman sono perfettamentein6uadrabili nello schema sciamanistico< la gi$ citata capacit$ di guarigione, le doti profetiche, ilvolo magico. 'a se si esce dalle gabbie classificatorie, lorizzonte potrebbe diventare più chiaro.
4ella terminologia greca antica non esiste un termine per indicare il fenomeno dellanima li3era,che si distacca consapevolmente dal corpo, nonostante ci sia una fenomenologia ben documentata.5o stesso termine di estasi non risulta attestato col senso di esperienza mistica fino allepoca tarda.5a prima applicazione della parola, con 6uesta valenza, è in "lotino, 6uando il filosofo descrivelultimo grado di contemplazione 2come un altro modo di vedere, un e"stasis»#<= Il significatooriginario di e"stasis :ex «fuori», stasis 2stabilit$3; significa 2uscita dal posto3, da cui2spiazzamento3, 2estraneazione3, 2smarrimento3. "er tutto il periodo classico il campo semanticodellestasi rester$ 6uello della pazzia, dei furori improvvisi, delle fughe dai comportamenticomuni.%= 4on risulta dun6ue esistere una dottina coerente delle manifestazioni estatiche, n9 untermine che indichi la separazione dellanima dal corpo come la intendeva dHin Cohde. 5a paroladesigna deviazioni mentali, ma non compare mai nei testi dove, se Cohde avesse ragione, ci si
aspetterebbe di incontrarla.%B dun6ue come uscire da 6uesto corto circuitoL >na soluzione possibile è 6uella di storicizzare la nascita del concetto e del termine ad esso associato. Il fenomenoesisteva, anche se non esisteva il lessico che ci aspetteremmo per definirlo. Se i Greci chiamavanoentheoi gli iatromanti che operavano sotto linflusso divino, non significa che 6uesti agisseroinconsapevoli, come dei posseduti nel senso moderno, in maniera diversa dagli sciamani
propriamente detti. 5a spiegazione va cercata, probabilmente, nella difficolt$ del lessico grecoarcaico :ma non solo; di rendere in termini propri il concetto di separazione dellanima dal corpo e,in generale, il binomio anima7corpo. 'a non solo< probabilmente nellutilizzo del termine entheoscè la consapevolezza di un estraniamento che non è alienazione, non è solo abbandono totale dellefacolt$. Abaris, posseduto da Apollo, è il soggetto di una rivelazione che crea una mutazione, unaccrescimento delle facolt$ che lo iatromante user$ poi con un controllo consapevole. 0uestoemerge dalle fonti se si leggono senza lenti deformanti.%@
"er tentare di rispondere ad alcune delle 6uestioni aperte, proveremo dun6ue a rileggere i datiestrapolati dal dossier relativo a una di 6ueste figure< Aristea di "roconneso.)?
5a scelta di prendere in esame 6uesto 2viaggiatore estatico3 come esempio paradigmatico ci permetter$ di valutare e, forse, proporre al dibattito 6ualche nuovo, ancorch9 limitato, elemento di
%/ 5icurgo, .r# /a lass7!onomisE G. !olli, ,a sapienza greca, I, Adelphi, 'ilano 1@==, p. )%@7))1.%8 "orph., ;ita di Plotino, %)%= Si veda la puntuale analisi di Giuliana Scalera 'c!lintoc-, 25eredit$ misterica nel lessico dellestasi3, in C.
!onforti, G. Scalera 'c!lintoc- :a cura di;, ,a mente e l%estasi, Cubbettino ditore, Soveria 'annelli :!V;, %??@, pp. 71%.
%B Si veda J. olton, Aristeas o. Proconnesus, !larendon "ress, #Rford 1@8%, p. 1)@.%@ Allevoluzione del concetto di e"stasis nella Grecia antica ha contribuito molto probabilmente la pratica dei cultimisterici, con la loro gradazione di svelamenti progressivi alliniziato, a partire da un iniziale destabilizzazione dellaconsapevolezza :enthousiasmos; per giungere alla visione finale, lepopteia. Andrebbe forse recuperato il concetto diestasi proposto da Giorgio !olli< e"stasis come 2uscita da s93 verso un superiore grado di conoscenza, un distaccoche libera una consapevolezza superiore. Si veda G. !olli, ,a sapienza greca, cit., pp. 1/7B. Si veda anche!.rillante, !l sogno di &pimenide, cit., pp. %B7%@. 5o studioso propone, con 6ualche riserva, di ipotizzare due formespeculari di esperienze sapienziali nellantica Grecia< nel primo lanima si separa dal corpo in totale autonomiaE nelsecondo accoglie la divinit$ che prende possesso del suo corpo. 'a, come si rende conto lo stesso studioso, un
personaggio come Aristea sembra sfuggire a 6uesta dicotomia, come vedremo.)? 5a bibliografia su Aristea è comun6ue corposa< fondamentale, anche se superata per certi aspetti, la monografia di J.
". (. olton, Aristeas o. Proconnesus, cit.E una puntuale analisi delle fonti è in . (ettori, Aristea di Proconneso«sciamano»e «corvo», cit.E Idem, Aristea «corvo» e «sciamano»1 (>erodot# ?#@, 2Seminari romani di cultura
greca3, I, 1, %??8, pp. B=71?)E sul poema composto da Aristea si veda S. 'ercier, ParBdel/ les $c)thes et au suddes >)per3or9ens# Arist9as de Proconn7se et les Arimasp9es entre m)the et r9alit9, 2olia lectronica !lassica3,11, %??8, pp. 17%? :lin-< http://bcs.fltr.ucl.ac.be/FE/11/TM11.html;E A. Ivantchic-, ,a datation du po7mel% Arimasp9e d%Arist9as de Proconn7se, 25anti6uit9 classi6ue3, 8%, 1@@), pp. )/78=. Si vedano le altre note in.ra#

7/25/2019 Aristea Di Proconneso SPPEO Coscia
http://slidepdf.com/reader/full/aristea-di-proconneso-sppeo-coscia 6/8
riflessione sugli interrogativi più fre6uenti<7 linflusso del mondo orientale sulla comparsa degli iatromanti greciE7 la stratificazione di rielaborazioni che si è prodotta gi$ in antico sulla narrazione delle loroimpreseE7 la circolazione di idee, pratiche religiose e 2uomini sapienti3 nel 'editerraneo antico.Aristea risponde a 6ueste caratteristiche< nasce ai margini del mondo greco :la colonia di
"roconneso, nel mar di 'armara; a contatto con le terre sciticheE vive esperienze di possessioneapollinea, in seguito alle 6uali compone unopera ispirataE è protagonista di episodi di sparizioni eapparizioni, ubi6uit$ e trance, e, infine, la sua vicenda ha un eccezionale riscontro nella storiamateriale e nellarcheologia< in una colonia delloccidente greco, 'etaponto, gli scavi hannorestituito le tracce di un luogo di culto a lui dedicato.
,a leggenda di Aristea: una stratigra.ia delle .onti5a fonte principale per la leggenda di Aristea è il noto passo di rodoto nel contesto del suo ^dedicato alle popolazioni scitiche :insediate nellattuale >craina meridionale;< )1
2Aristea di "roconneso, figlio di !aistrobio, affermM in un poema da lui composto di essere giunto presso gli
Issedoni, posseduto da eboE che al di l$ degli Issedoni abitano gli Arimaspi, uomini che hanno un occhiosoloE al di l$ degli Arimaspi i grifoni custodi dell’oroE al di l$ dei Grifoni gli perborei che si estendono finoa un mare. Kranne gli Iperborei tutti costoro, dice, 7 a partire dagli Arimaspi, attaccano di continuo i loroconfinanti< gli Issedoni furono cacciati dalle proprie terre a opera degli ArimaspiE gli Sciti dagli IssedoniE i!immeri che vivono sul mare meridionale, premuti dagli Sciti, lasciarono il loro paese. !osW, su 6uesta terra,neppure Aristea concorda con gli Sciti.(a dove venisse Aristea, l’autore di tutto ciM, l’ho gi$ dettoE ora narrerM invece il racconto che ho ascoltato sudi lui a "roconneso e a !izico. Aristea, dicono, che per nascita non era inferiore a nessuno dei concittadini, a"roconneso entrM in una bottega di scardassiere e morWE lo scardassiere allora chiuse la bottega e andM a darela notizia ai parenti del defunto. 0uando per la citt$ si era gi$ sparsa la voce che Aristea era morto, uno di!izico cominciM a disputare con 6uanti la diffondevano< egli veniva dalla citt$ di Artace e diceva di averincontrato Aristea che andava a !izico e di aver conversato con lui. mentre l’uomo discuteva con ardore, i
parenti del morto si presentarono alla bottega con 6uanto necessario per portarlo via. Kuttavia, aperta la bottega, Aristea non si trovM più, n9 vivo n9 morto. Cicomparso a "roconneso sette anni dopo, avrebbecomposto il poema che ora i Greci chiamano ArimaspeaE lo compose e scomparve per la seconda volta.:1/;. Se in 6ueste citt$ si raccontano tali episodi, so anche 6uanto accadde agli abitanti di 'etaponto, inItalia, duecento6uarant’anni dopo la seconda scomparsa di Aristea, come ho scoperto facendo calcoli a"roconneso e a 'etaponto. I 'etapontini raccontano che lo stesso Aristea, comparso loro nella regione,ordinM di innalzare un altare :3omos; ad Apollo e di collocarvi accanto una statua che recasse il nome diAristea di "roconnesoE affermava infatti che Apollo era giunto, tra i Greci d’Italia :italioti;, solo nella terradei 'etapontiniE e che lui era al suo seguito, lui che adesso era Aristea, ma che allora, 6uando seguiva il dio,era un corvo. !iM detto, scomparveE i 'etapontini raccontano che, inviati messi a (elfi, chiesero al dio cosavolesse dire l’apparizione di 6uell’uomo. 5a "izia ordinM di ubbidire all’apparizione< se avessero ubbidito,tutto a loro sarebbe andato meglio. I 'etapontini, accolto il responso, lo portarono a compimento. ora c’èuna statua che porta il nome di Aristea presso lo stesso monumento di Apollo e intorno alla statua ci sono piante di alloro. Il monumento sorge sulla piazza :agor/# 'a su Aristea basti 6uanto detto3.
5a collocazione cronologica degli eventi narrati da rodoto è stata definita in maniera convincenteda un recente saggio di Alfonso 'ele.)%Il complesso dei dati, storici, letterari e archeologici,
permette dun6ue di collocare nel tempo i due episodi o le due fasi narrate dallo storico< lAristea della "ropontide e 6uello della 'agna Grecia. 5a fondazione di !izico, colonia di 'ileto, cui"roconneso appartiene, era collocata dagli antichi allepoca di Gige )), tra gli anni =1BT= e 8@BT8=8.Sottraendo i duecento6uarantanni calcolati da rodoto, si arriva, per lapparizione metapontina, auna data compresa tra il =B e il 8B. I dati storici sembrano combinabili con 6uelli archeologici,
)1 rodoto, I, 1)718, trad. di Augusto raschetti:con adattamenti di chi scrive;, in A !orcella, S.'. 'edaglia :a curadi;, rodoto, ,e $torie, Arnoldo 'ondadori ditore, 'ilano 1@@), pp. %/, %/, %@.
)% A. 'ele, Pitagora .iloso.o e maestro di verit/, cit., pp. 8@7=%.)) Strabone, III, /@?.

7/25/2019 Aristea Di Proconneso SPPEO Coscia
http://slidepdf.com/reader/full/aristea-di-proconneso-sppeo-coscia 7/8
soprattutto dopo la recente datazione al @?TB? a.!. di un troncone della statua di Apollo :6uelladedicata dai 'etapontini su ispirazione di Aristea;.) Anche i dati archeologici relativi al complessocultuale del cosiddetto manteion sembrano aggirarsi attorno allo stesso arco cronologico.5e date trovano conferma anche analizzando ciM che si sa degli Arimaspeia, il poema composto daAristea< terminus post quem per datarlo è la menzione del popolo dei !immeri, alla cui invasioneera connessa la morte di Gige :8@B o 8=8 a.!.;E il terminus ante quem è costituito da un elemento
iconografico, la raffigurazione degli Arimaspi, le creature monocole, su uno specchio rinvenuto a&elermes e datato al /=/ circa.)/5a testimonianza più antica riguardo ad Aristea è in un frammentodi "indaro, citato da #rigene)8. 5a data di composizione del carme in cui il proconnesio venivacitato è sconosciuta, ma possiamo concludere che fosse compresa tra il @B a.! e il %T)B a.!. )=
Sembra probabile che il racconto di "indaro riferisse anche dellepisodio metapontino.)BIl dettaglio èimportante, perch9 conferma che la leggenda di Aristea circolava nelloccidente greco al più tardinel secolo a.!., probabilmente legata alla capacit$ del proconnesio di staccare lanima dal corpo,come dicono in maniera esplicita altre fonti più tarde, ma come afferma ancora "indaro, citato da"latone, dove si parla di una figura :nel dialogo platonico è il filosofo, ma nel testo di "indaro
probabilmente era un poeta; che 2vola dovun6ue ed ora si immerge nelle profondit$ della terra, orasi solleva nel cielo3, mente il suo corpo resta fermo e dimora in citt$. )@
ari tentativi *razionalizzanti+ sono stati fatti per interpretare il racconto erodoteo, che gi$ filtra glieventi con la sua sensibilit$ storica, e probabilmente, gi$ nel secolo a.!. non comprende il realesignificato di alcuni elementi della narrazione, da lui raccolti nella sua ricerca. Aristea avrebbesubito un fenomeno di morte apparente, o, meglio, ispirato da Apollo, lui, sacerdote del dio, sarebbe
partito improvvisamente verso le zone settentrionali del 'ar 4ero, di cui gli era giunta voce dagliesploratori greci suoi connazionaliE la sua sparizione sarebbe in realt$ la partenza per le terre degliSciti, travisata poi in leggenda.?Kutti 6uesti tentativi si scontrano, a mio avviso, con l’irriducibilit$di 6uesti racconti a resoconti storici. In essi c’è, magari travisato, rielaborato, parodizzato da fontisuccessive, un forte elemento simbolico. 5ungi dal considerarli favolistici nel senso deteriore deltermine, 6uesti elementi in realt$ ci *parlano+, sono come *fossili guida+ nella stratigrafia dei miti, e
) A. 'ele, Pitagora .iloso.o e maestro di verit/, cit., p. =1. 5attribuzione del frammento alla statua di Apollo è di'adeleine 'ertens Dorn, in una comunicazione dal titolo !onsiderazioni sull agalma e laltare di Apollo,allIncontro internazionale di studi 'etaponto ai tempi di Pitagora ('etaponto = giugno <CCD, di cui si attende la
pubblicazione. Su internet è reperibile un breve comunicato stampa riassuntivo dellintervento. In 6uesta sedecitiamo dal testo di Alfonso 'ele.
)/ "er lo specchio rinvenuto nel sito di &elermes, vicino al fiume &uban, nel !aucaso nord occidentale, si veda J.(.".olton, Aristeas o. Proconnesus, cit., pp. /7=E p. %/@, fig. I. 5oggetto è stato attribuito a maestranze sciticheinfluenzate dallarte dei coloni greci del 'ar 4ero.
)8 "indaro, fr. %=1 Snell< 2riguardo ad Aristea di "roconneso3. 0ueste le poche parole rimaste. "er la citazione di tuttele testimonianze letterarie relative ad Aristea, si veda A. ernab9 :ed.;, Poetarum epicorum graecorum# *estimoniaet .ragmenta, I, Keubner, 5eipzig 1@B=, pp. 171/.
)= 5a "itica, in cui "indaro narrava degli DFperborei è del @B a.!. 5a prima vittoria del poeta tebano in un agoneditirambico è del @=T8, mentre la sua morte, avvenuta allet$ di B? anni, cade 2a seconda che si scelga il /%% o il
/1B come anno pitico di nascita, nel % o nel )B3. 5a composizione del carme relativo ad Aristea si collocadun6ue allinterno di 6uesta forchetta cronologica, coerente con gli altri dati. Si veda A. 'ele, Pitagora .iloso.o emaestro di verit/, cit., p. =%.
)B Ivi, p. =?. Si veda anche G. !olli, 5a sapienza greca, cit., p. )1.)@ "indaro, fr. %@% Snell7'aehler. 5a citazione di "latone è nel *eeteto, 1=) , in "latone, *utte le opere, I, a cura di G.
"ugliese !arratelli, Sansoni ditore, irenze 1@=, pp. 1@/71@8. Il testo è una parafrasi libera di versi che "latonecita a memoria, ed è difficile stabilire 6uali siano state le reali parole di "indaro. 4el dialogo platonico il riferimentoè alla mente del filosofo, che si disinteressa delle cose terrene, e si stacca dal corpo vagando per indagare la naturadelle cose.
? J.".( olton, Aristeas o. Proconnesus, cit., p. 11. Altre interpretazioni vedono, nella storia di Aristea, elementisciamanici o favolistici mescolati a esperienze reali. Si vedano anche< .(. "hillips, *he legend o. Aristeas: Eactand Eanc) in &arl) +ree" Fotion o. &ast 5ussia $i3eria and !nner Asia, 2Artibus Asiae3, 1B, 1@//, pp. 1//71==E &.(oHden, Geux notes sur les $c)thes et les Arimaspes, 2Cevue des tudes Grec6ues3, @), 1@B?, pp. B87@%E J.'.
remmer, *he &arl) +ree" -oncept o. the $oul , cit., pp. %/7)B :remmer pensa che il racconto di Aristea sia unviaggio dellanima durante una trance ma rifiuta sia linterpretazione naturalistica che il paradigma sciamanico,riportando la vicenda a categorie culturali e mitiche prettamente greche;E . ur-ert, ,ore and $cience in Ancient P)thagoreanism, cit., pp.18%718 :posizione problematizzante;.

7/25/2019 Aristea Di Proconneso SPPEO Coscia
http://slidepdf.com/reader/full/aristea-di-proconneso-sppeo-coscia 8/8
dei culti.