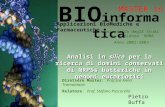Analisi in silico per la ricerca di domini conservati di NRPSs batteriche in genomi eucariotici
Appunti per una biografia del filosofo - ebraismi.it · ma soprattutto da lettere, foto e appunti...
-
Upload
nguyenmien -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
Transcript of Appunti per una biografia del filosofo - ebraismi.it · ma soprattutto da lettere, foto e appunti...
Sommario
Premessa
La statua d’argilla
1899-1919
1920-1930
1931-1937
1937-1952
Una presenza assente
1953-1971
Bibliografia degli scritti
Bibliografia critica
Premessa
Quanto scritto in questo libro trae origine dai miei pochi ricordi, dai racconti di alcune
delle persone che hanno conosciuto il protagonista in momenti diversi della sua vita,
ma soprattutto da lettere, foto e appunti da lui stesso disordinatamente conservati:
quasi niente, insomma.
Come si fa a scrivere di qualcuno che poco si è conosciuto e pochissimo ha raccontato di
sé e della sua famiglia?
La scoperta fortuita di due scatole di corrispondenza e documenti vari fatta nel 1999 è
stata un sasso nello stagno, il mio, nel quale per anni ho annegato dubbi, rancori e ri-
morsi nei confronti di due genitori per caso o per convenzione sociale.
Ricordo che la mia terapeuta stentava a capire perché per me la montagna – l’andare
in montagna – fosse così importante anche a livello psicologico: “La montagna le ricor-
da suo padre? Voglio dire, per lei suo padre era stabile e rassicurante come una mon-
tagna?”. L’avevo guardata un po’ perplessa e d’impulso le avevo risposto: “Mio padre
una montagna? Assolutamente no”. E la cosa era finita lì.
Negli anni, ripensandoci, mi veniva su un sorriso amaro, perché, al di là
dell’intermittente sentimento di affetto e di orgoglio che provo nei suoi confronti grazie
a un po’ di vecchie carte ingiallite, non è stato e non sarà la mia montagna, quanto
piuttosto un immenso puzzle che non potrò mai finire.
Le lettere che ho trovato sono ovviamente solo una piccolissima parte di quelle ricevu-
te nella sua vita adulta. Molte si saranno perse nei numerosi traslochi fatti o subiti per
quasi mezzo secolo su e giù per la penisola, diverse sono state riutilizzate per prender-
vi appunti e poi cestinate insieme ad altre nei rari momenti di voglia di riordinare se
stesso, la sua scrivania e la sua vita. Coprono un arco di tempo che va dal 1916 a pochi
mesi prima della morte, con un solo inspiegabile intervallo: la Seconda guerra mondia-
le.
E poi ci sono le foto. Sono tante, grazie alla sua passione per quest’arte nata già
nell’infanzia – i primi scatti sono ante 1910 – e morta con l’avvento delle prime se-
miautomatiche, che non lo divertivano più.
Ecco dunque il perché di un racconto così frammentario.
Ricordo qui le persone che mi hanno aiutato nel corso della stesura e sono purtroppo
scomparse nel frattempo: Enrico Biamonti, Mario Coloni, Domenico Maltese e Luigi
Stasi.
Grazie anche a Peter M. Ascoli, Annamaria Burlini, Girolamo De Liguori, Mariangela
Fantin, Lino Felician e Francesco Mercadante.
Errori e omissioni sono addebitabili esclusivamente a me.
Marilì Cammarata
1899-1919
Era nato a Catania il 27 giugno 1899, primogenito di una giovane coppia della medio-
piccola borghesia siciliana. All’anagrafe gli avevano messo tre nomi: il primo, Angelo,
ricordava il nonno paterno, il secondo, Filippo, il nonno materno, il terzo era quello del
giovane di studio di suo padre: Ermanno. Si firmava con due, lo chiamavano con uno, il
terzo. Mi disse che da bambino i nonni lo chiamavano Ninì.
Suo padre, Giuseppe (Peppino) Cammarata, pur provenendo da una famiglia regalbu-
tese non molto agiata (il padre, di origine contadina, era impiegato comunale), si era
laureato in giurisprudenza. Oltre a esercitare la professione di avvocato a Catania, in-
segnava diritto penale all’Università di Genova e aveva stretti legami con il mondo le-
gal-forense milanese: lo deduco non solo dal testo del necrologio pubblicato a stampa e
firmato da un suo confratello massone (lui era un gran maestro “30 con tre puntini”;
suo figlio Ermanno sarebbe stato uno dei più giovani massoni italiani), ma anche da
alcune lettere e foto. La commemorazione fatta da Luigi La Pergola (un “33 con tre
puntini”) a un mese dalla morte (3 maggio 1945) rievoca un uomo di profonda fede
massone, buono, generoso, tutto d’un pezzo, dotato di “ingegno pronto e versatile”, “vi-
gorosa eloquenza” e “autorità morale”. Aveva aderito nel 1895, a soli 22 anni, a una
Loggia in quel di Genova. Qui era avvocato di società genovesi e nello stesso tempo, a
Catania, il legale della società che gestiva la Ferrovia Circumetnea. A soli 25 anni
pubblicava, a Firenze, una monografia sulla responsabilità penale. Non fu il suo solo
scritto: un volume rilegato in nero, con sul dorso solo le iniziali dorate G. C. e dedica
all’omonimo nipotino milanese, contiene un altro studio (di cui oggi manca il titolo)
imperniato sulle “garenzie” legali, penali e processuali, e gli estratti di alcuni articoli
di medicina legale e giurisprudenza medica (allievo di P. Cogliolo, era, par di capire,
un antilombrosiano). Si è conservata poi una corposa commemorazione del poeta Ma-
rio Rapisardi, pubblicata dal fedele La Pergola pochi mesi prima della morte, unico in-
dizio che i suoi interessi erano rivolti, oltre che al mestiere, alla massoneria e alle
donne, anche alla letteratura locale. Sempre in veste di avvocato fu, sembra, uno dei
legali che si occuparono degli strascichi del famoso scandalo della Banca Romana.
Era un bell’uomo, a giudicare dalle foto: non alto, dotato fino all’età adulta di folti baffi
e folta barba, aveva gli occhi scuri, grandi e un po’ sporgenti, proprio come nei migliori
(o peggiori) stereotipi dell’uomo mediterraneo. Mio padre, che ne aveva ereditato le o-
recchie a sventola, gli assomigliava molto, sebbene nel suo volto si notassero anche al-
cuni tratti fisiognomici (la forma degli occhi e gli zigomi alti e larghi) di sua madre e
ne risultasse quindi più bello. Uno sguardo assassino, quello di Peppino: dopo pochi
anni di matrimonio, pur forse amando ancora sua moglie, cominciò a concedersi delle
distrazioni. Una di queste gli lasciò in ricordo un regalino venereo che — per nemesi —
si abbatté sul secondogenito. Manlio infatti era nato con la vista fortemente compro-
messa e dovette portare sempre spesse lenti da miope. Ma di questo mia nonna forse lo
perdonò: ciò che l’angustiava, dopo la separazione di fatto (lei era rimasta ad abitare
nel villino di via Etnea 700, lui viveva in via Landolina, e aveva lo studio in via Rapi-
sardi) era che queste avventure lo dissanguavano economicamente. Ecco che cosa scri-
veva in una lettera a Ermanno nel 1939: “[...] Tuo papà sta lavorando cosa rara in que-
sti tempi [...] Ti racconto una cosa: siccome con Jole litigò, se questa se ne va, vorrebbe
prendersi la vedova Cipriotti, che ha un figlio di 18 anni e se lo porterebbe in casa!!..
Quando me lo accennò, cercai persuaderlo del pericolo di mettere in casa un ragazzo
che non è uno stinco di santo, ma da bravo contadino tuo padre fa il conto senza Dio:
gli darebbe alloggio e mangiare e una piccola mesata... A parte la moralità che non è
pura di questa povera gente, tuo padre misura l’olio a Jole... a me lo ha detto lui stes-
so, le misura la pasta compra a etti carne, pesce, e se senti Jole non sai cosa dire!!
Dunque se dà 150 a Jole, serva cuoca dattilografa, cosa crede di risparmiare?!! met-
tendo due sconosciuti e pericolosi anche secondo me in casa! Perciò ti prego di avvertir-
lo [...] A me non mi sente [...]”.
Del resto, quanto a girotondi femminili, i suoi figli non furono da meno...
Come padre, comunque, era buono e comprensivo, prodigo di palanche anche quando i
suoi rampolli avevano da un pezzo superato l’età della ragione o, come si diceva allora,
quella dell’emancipazione. A questo proposito ecco il testo del telegramma inviato, a
mo’ di auguri, al primogenito, che abitava a Roma in via Campomarzio 69, per il venti-
cinquesimo compleanno: “Ricorrendo domani tua emancipazione definitiva malgrado
refrattario convenzionalismi accetta augurio mio profondo quantunque modesto drit-
tura vita sempre immacolata bacioti – Peppino”.
Come mia nonna si firmava “tua mamma Linda”, così anche il nonno firmava con il
nome proprio e non con la “carica” che aveva nei confronti del figlio. Evidentemente
questo era l’uso e nessuno se ne stupiva. Certo l’affetto non si misura da una firma,
anzi...
Nel 1905 nacque Manlio e infine, nel 1910, Anna Elide, che visse solo un giorno.
Della mia omonima nonna, Maria Linda Longo, sono rimaste relativamente poche
immagini, ma quelle che suo figlio le ha fatto fin da quando era un fotografo alle prime
macchine (parliamo degli anni 1908-1910: Ermanno è stato precoce anche in questa
disciplina) mostrano una donna piuttosto bella dal viso largo e la bocca grande aperta
al sorriso. Due particolari mi colpiscono: spesso ha un cane vicino o in grembo (ma
sempre bastardini dal muso vispo) e tiene sempre la testa reclinata da un lato. Guardo
le mie: a volte ho vicino un agnello, una mucca, un gatto, un pulcino, un coniglio e, da
più di trent’anni, cani bastardi dal muso tenero; e tengo la testa reclinata di lato. Oltre
al nome, sono queste le sole cose che ho in comune con lei. L’ho conosciuta nel 1961,
quando aveva più di ottant’anni, e non l’ho amata: il villino dove abitava con la donna
di servizio era buio, tetro, lei poco espansiva.
L’edificio aveva due ingressi: il cancello principale e, alla sinistra di questo, un usciolo
di servizio che dava su un ambiente privo di luce naturale e rischiarato solo dalle deci-
ne di lumini che ardevano davanti a numerose foto di morti a me sconosciuti poste su
un massiccio cassettone. In quei pochi giorni che mio padre e io siamo rimasti a Cata-
nia, è riuscita anche a darmi uno schiaffo perché, annoiandomi a morte e impaurita da
quei lumini (avevo solo 10 anni!), senza avvertire nessuno avevo attraversato la strada
per andare a giocare con i figli dei dirimpettai, certi Consoli che avevano un negozio di
lane.
Ermanno amava molto la madre, e ancor più i genitori di lei: se della prima ha conser-
vato solo poche lettere, dei secondi — Francesca Crimi e Filippo Longo — ce ne sono
relativamente di più e vanno dal 1920 dal 1930. Erano contadini, ma probabilmente di
diversa estrazione culturale: Filippo scriveva in un buon italiano ed era un accanito
lettore; Francesca, “Cesca” come si firmava, era appena alfabetizzata: “Ermanno mio,
ricevei il tuo cartolino ti scrivo poco per non farti stare all’ungo senza mie nuove, ti
scriverò più all’ungo, oggi mi fa un po male la testa [...]”. Ma quanto lo amavano! “Ca-
tania 12-1-1928 Mio Caro Ermanno – Dopo due mesi di pioggia e freddo, oggi si vede
un poco di sole, e così posso scarabocchiare due parole – Ho ricevuto la tua fotografia e
te ne ringrazio. L’ho già posta in un quadrettino, attaccata di fronte alla poltrona, e co-
sì stò in compagnia nelle lunghe ore di solitudine e di noja [...] Ho ricevuto, pure, la
cartolina da Napoli, firmata dagli avvocati 2° e 3°. Abbracci e baci dal tuo vecchio non-
no FLongo”. Anche Manlio, infatti, aveva seguito le orme del padre e del fratello, ma
esercitò soprattutto a Milano, dove conobbe la futura moglie Natalia (nipote, pare, del
famigerato Bava Beccaris) e dove nacque il figlio Giuseppe (poteva mio fratello, a que-
sto punto, non chiamarsi Manlio?).
La nonna Cesca morì nel 1924, e probabilmente anche il nonno Angelo Cammarata –
di cui non so nulla – dev’essere morto, probabilmente vedovo da parecchi anni, sul fini-
re degli anni ’20 o all’inizio del decennio successivo, perché le lettere di Peppino di
quegli anni sono listate a lutto. Di sicuro il nonno Filippo era ancora in vita, ultraot-
tantenne, nel fatidico 1930.
Del profondo legame esistente tra nonni e nipote è documento prezioso la dedica a
stampa che accompagna la pubblicazione nel 1925 del primo libro di Ermanno, quello
che lo consacrò alla fama di giurista, Contributi ad una critica gnoseologica della giu-
risprudenza: “Alla sacra memoria / della mia adorata Nonna materna / FRANCESCA
LONGO CRIMI”. Appare perciò quanto meno strano che dei tre nomi che gli erano stati
dati avesse da subito “soppresso” proprio quello del nonno preferito.
Da molti anni le loro foto mi fanno compagnia di fronte alla scrivania ed è sempre mo-
tivo di orgoglio e tenerezza osservare le loro facce tranquille e oneste, i loro abiti di-
messi, i baffoni bianchi di Filippo e... il solito bastardino dignitosamente in posa su
una similthonet.
Dei suoi primi anni non so quasi nulla. Di sicuro frequentò la quarta elementare nel
prestigioso collegio dei gesuiti “ A. Pennisi” di Acireale. (Da una scuola di gesuiti si e-
sce preti o mangiapreti: c’è da stupirsi del suo viscerale anticlericalismo?) Ne è rima-
sta una foto, scattata il 16 novembre 1906, che lo ritrae nella divisa di vago sapore mi-
litare dei convittori il cui cappello è vistosamente posticcio, essendo di un paio di taglie
più piccolo della testa.
L’originale era tra le sue carte, ma in famiglia la si era già vista perché alla fine del ‘66
tre suoi vecchi compagni di classe gliene avevano mandata un riproduzione: Gaetano
Modica, Giuseppe Castro Ferro e Stefano Torrisi ne approfittavano per mandargli gli
auguri per le feste.
Ci sono già alcune sue caratteristiche: lo sguardo dritto e un po’ scettico, un abbozzo di
sorrisolino ironico, la mano appoggiata di dorso sul fianco e i piedi un po’ piatti. Forse
era stato messo in collegio per cercare di moderarne l’esuberanza, per il prestigio
dell’istituzione e per non pesare sulle spalle di sua madre, alle prese con Manlio neo-
nato.
La sua vivacità fisica doveva infatti essere pari a quella intellettiva: non solo a 13 anni
era già in prima liceo classico (quella volta le elementari finivano a 9 anni se si passa-
va, alla fine del quarto anno, l’“esame di maturità”) ma, rimandato a settembre in tut-
te le materie per cattiva condotta – una ne pensava e cento ne faceva, ben spalleggiato
da alcuni compagni – non perse l’anno e finì la scuola a 16 anni. Raccontava ridendo
che il professore di matematica, appena entrava in classe, per prima cosa ordinava:
“Cammarata, De Luca e Russo: fuori!” ben sapendo che in caso contrario non gli sareb-
be stato possibile fare lezione in pace. Ermanno era infatti uno sfottitore per eccellen-
za, ricco d’inventiva nell’appioppare soprannomi, nel rifare il verso allo sbeffeggiato e
nell’ammutolirlo con una battuta al cianuro. Immaginiamoci poi quando aveva anche
una gang di supporto... e per di più, evidentemente, questo professore non riscuoteva
troppe simpatie. I tre discoli sono rimasti amici per tutta la vita.
Per non parlare poi degli scherzi domestici. Raccontava che più di una volta aveva
preso un uovo dal pollaio di casa e, dopo averlo accuratamente svuotato, l’aveva riem-
pito di acqua, sigillandone i fori con un po’ di cera.
Degli anni 1914-15 sono rimasti alcuni autoscatti in seppia dei quali particolarmente
interessanti sono quello con Manlio su un triciclo d’epoca e uno con tutta la famiglia.
Sono sotto un pergolato d’uva. Peppino è elegantissimo: ha la catena d’oro sul panciot-
to, i guanti di pelle in mano e l’immancabile sigaretta; Manlio veste alla marinara e
Linda ha un bellissimo cappellino sulle ventitré. Il nonno Angelo esibisce, chissà per-
ché, il suo orologio da panciotto, la nonna Cesca sembra la vecchina buona delle favole.
Il nonno Filippo, infine, tiene in mano la copia di una “Gazzetta”. La foto, piccola e con
gli spigoli arrotondati, sembra essere stata a lungo in una cornice. Ermanno se la por-
tava dietro nelle varie tappe di risalita della penisola?
Grazie a questi cartoncini, a volte poco più grandi di un francobollo, lo seguo nella cre-
scita da adolescente allampanato a giovanottino serio e composto per le foto ufficiali o
con la canna e la paglietta insieme agli amici. Nella raccolta di foto ci sono due scatti
fatti all’insegna dell’autoderisione: quelle, degli anni ’30, rispettivamente a cavallo e
alla guida di un’automobile, quasi a documentare l’antipatia per entrambi i mezzi di
locomozione. Tutte e due lo ritraggono nell’acconcio “costume” richiesto dalla circo-
stanza: insomma, una presa in giro seriamente architettata, com’era sua abitudine.
Gli anni della spensieratezza finiscono nel maggio del 1915: l’Italia entra in guerra, lui
termina il liceo e vede partire i suoi compagni di classe – che sono ovviamente più vec-
chi di due o tre anni – per il fronte.
Si è conservata intatta la sua pagella di maturando: ineccepibile nei voti di profitto
(tutti 7 e 8, tranne un meritato 6 in italiano scritto), discutibile in quello di condotta:
un infamante 8 per i primi due trimestri, ma un sonante 9 nel terzo, il che gli permette
di saltare la seduta degli esami di Stato e di venire automaticamente “licenziato”. Sul
retro di questo prezioso documento, nello spazio riservato alle “Osservazioni particola-
ri sulla condotta”, ha scritto di suo pugno: “Cesare taccio che per ogni piaggia / Fece
l’erbe sanguigne...”...
Si iscrive a Giurisprudenza all’università di Catania e si crea in breve altri amici (al-
cuni lo saranno per una vita, come Orazio e Luigi Condorelli). Tra questi ce n’è uno
molto caro che nel 1916 si arruola volontario. Si chiama Giuseppe Carnazza e ha due
fratelli minori, Federico e Luigi; con tutti e tre dev’essere molto affiatato. Il 1° agosto
1916 sotto una pioggia scrosciante vanno in bicicletta ad Acicastello per “ossequiare
l’Ill. prof. avv. Ermanno Cammarata”, ma lui non c’è e gli lasciano un divertente bi-
gliettino, scritto a matita e quindi quasi illeggibile. Quella che sembra un’azzeccata
profezia sulla futura carriera di Ermanno è invece, probabilmente, il malizioso ricordo
della risposta alla banale domanda “E tu, che cosa farai da grande?”. La precoce ma-
tricola avrà risposto: “Voglio fare il professore universitario e l’avvocato”. Quando si
dice avere le idee chiare... Molto probabilmente Giuseppe voleva salutarlo prima di
andare ad arruolarsi. Chissà che pena, per Ermanno, quando gli comunicano, 13 mesi
dopo, che non lo avrebbe mai più rivisto.
Questa incrollabilità d’intenti giovanili l’ho ritrovata ne Il gioco dei regni di Clara Se-
reni: “Fra 10 anni [siamo intorno al 1918, nda]: Tullio Ascarelli dice: sarò rappresen-
tante politico della nazione [...]. Enzo Sereni dice: sarò professore universitario ordina-
rio [...]. Emilio Sereni dice: sarò professore di agraria [...]” (pp. 137-138). In quel castel-
lo dei destini incrociati che è la vita, pochissimi anni dopo questi giovani coetanei lun-
gimiranti conosceranno Ermanno (che ne fequentava la casa) e uno, Tullio, gli divente-
rà molto amico; di Enzo riparlerò più avanti. Sono certa che a mio padre il libro della
Sereni sarebbe piaciuto immensamente e sarebbe stata l’occasione per dare la stura ai
ricordi dei suoi anni romani.
Ma torniamo a Giuseppe Carnazza che, non ancora diciottenne (era nato il 24 ottobre
1898), è andato a “difendere” la patria ai suoi estremi confini settentrionali (in Trenti-
no) e poi nordorientali, sull’Isonzo, forse anche per dimenticare una storia d’amore. Le
sue missive possono essere considerate emblematiche dei sentimenti della meglio gio-
ventù di allora.
La prima ha un tono quasi trionfalistico, seppur condito da qualche dubbio:
Cartolina postale italiana in franchigia / Corrispondenza del R. Esercito
Mittente Carnazza G. / soldato / 124 fant / Compagnia 2
28/10/916
Carissimo Ermanno, Solo oggi ho ricevuto la tua cara cartolina scritta dalle trincee
della Birreria; ma io ti rispondo da una vera trincea del Trentino, dove le palle nemi-
che ti fischiano sulla testa che è una bellezza, e dove la pioggia cade senza interruzioni
da 10 giorni. La Patria ci compenserà per quello che tu fai per lei? Se non altro ti resta
la soddisfazione di avere partecipato al gran conflitto (se resti vivo). Non mi pigliare
per pazzo. Porgi i miei ossequi ai tuoi e credimi tuo affmo
G. Carnazza
Nelle successive il tono di convinto interventista si smorza piano piano:
Cartolina postale italiana in franchigia / Corrispondenza del R. Esercito
Mittente Carnazza G. / soldato / 124 fant / Compagnia 2
7/11/916
Caro Ermanno,
Ho ricevuto ieri la tua cartolina dal campo dell'onore Minervale: veramente ho provato
un certo rincrescimento a non poter anch'io riprendere gli studi, ma poi ho pensato che
la Patria in questo momento ha bisogno di eroi del sangue e non di eroi del pensiero.
Quando la pace tornerà a stendere le sue ali sul mondo potremo dedicare di nuovo la
nostra attività a procurare alla nostra Italia il primato per la cultura, ora dobbiamo of-
frirle il nostro braccio, tutta la nostra vita, dobbiamo fare sacrificio di tutto ciò che ab-
biamo di più caro. Addio, anzi arrivederci a presto, in tempi migliori. Tuo aff. G Car-
nazza
Cartolina illustrata di Barghe (prov. di Brescia, vicino a Salò), senza data:
Dal campo dell'onore un saluto al mio caro amico
G. Carnazza
124 fant. 2 comp.
Zona di guerra
Lettera:
15/11/916
Carissimo Ermanno,
Ieri mentre mangiavo il rancio ricevetti la tua del 10/11 e mi affretto a risponderti det-
tagliatamente ad ogni tua frase.
Anzi tutto [illeggibile] anche il '98 non tarderà a venire sotto, anzi secondo tutte le pre-
visioni questo potrà succedere nel marzo entrante. Quindi tu ti trovi ad avere faticato
sei mesi senza ottenere niente dovendo a tale epoca sospendere ogni cosa. Io invece se fi-
no a marzo avrò la pelle salva, sarò già ufficiale, ottenendo così un nuovo vantaggio sui
miei colleghi. E poi ti assicuro che nessuno sarebbe stato più afflitto di me, se io non a-
vessi potuto partecipare a questo grave conflitto, se io avessi dovuto ripetere ai miei figli
i versi del Manzoni «Io non c'era». E queste non sono parole di tempi tramontati, non è
retorica. Ti persuadi?
Ti auguri poi che il freddo dei ghiacciai non riaccenda in me qualche fiamma spenta.
Tu sai bene che donne qua su non ne abbiamo, tu sai che quanto più difficile è avere
una cosa, tanto più la si desidera, tu sai che l'uomo non è fatto di legno, tu sai che
quando una fiamma sembra spenta gli è che langue sotto la cenere. Riunisci tutte que-
ste considerazioni e tu stesso potrai risponderti. Ma non temere che il riaccendersi di ta-
le fiamma non è la più orribile ricompensa ai miei sacrifici.
Cambiamo argomento. Tu dici che sopra ogni cosa c'è l'Università. Non è vero. Sopra
ogni cosa c'è la guerra. Cosa vuoi fartene di tanti giuristi, di tanti dottori sul suolo ita-
lico, se poi tutti questo dottori servono un'altro stato, faticano a ricercare il vero per uno
stato che non fa i loro interessi? Prima perciò bisogna combattere e assicurare col san-
gue la grandezza e la indipendenza della Patria; quando questa sarà raggiunta, sarà il
caso di coltivare le arti dette appunto della pace.
Queste sono in breve le mie opinioni e questo ho messo e metterò in pratica.
Mi piacerebbe adesso che tu mi confutassi questa teoria tanto per vedere un po' come la
pensi tu.
Scrivimi poi un po' a lungo quello che fai, come ti trovi e tante cosette che mi interessa-
no assai.
L'indirizzo di Ciccio qual'è?
Devi scusarmi se riceverai questa lettera senza francobollo, ma non me ne trovo qui e
non ho la possibilità di procurarne.
Nella speranza che questa missiva non ti paia telegrafica e col desiderio di poterti pre-
sto leggere ti abbraccio affettuosamente. Tuo Peppino
Cartolina postale italiana con timbro "Verificato per censura reggimentale":
Z. di guerra 5/2/917
Caro Ermanno
Come già ti scrissi allo scadere della mia licenza fui ricoverato al nostro Garibaldi per
catarro bronchiale e febbre reumatica. Dopo 10 giorni di quel magnifico (!) soggiorno
mi fecero uscire senza nemmeno un giorno di convalescenza. Ottenni solo di potere
viaggiare con treni diretti e in seconda classe: ecco perché non passai da Pisa e come
quindi non abbiamo potuto vederci.
Ora mi trovo di nuovo alla mia compagnia che si trova a riposo, ma ti assicuro che c'è
un freddo fenomenale. Chi sa quando potremo adesso rivederci!
Frattanto ti abbraccio caramente e credimi sempre tuo affmo
G. Carnazza
Lettera:
18/2/917
Caro Ermanno
Solo ieri sera ho ricevuto la tua del 6. Come vedi sono ritornato in zona di guerra [il-
leggibile] quell'annuncio che tu mi facevi poco si addiceva ad un volontario di guerra.
Ed eccomi quindi di nuovo al mio posto di combattimento. non sono ancora in trincea,
ma non tarderò ad andarvi e non so dove.
Adesso sono passato alla 15ª compagnia e quindi faccio parte del 4° battaglione, di
nuova formazione. Sarà meglio, sarà peggio? Chi può dirlo.
Del resto tra breve andrò a fare il corso per ufficiale e così potrò immolare la mia gio-
vane sì, ma ormai fradicia vita.
Quanto al terreno che tu mi chiedi se duro o molle, devo dirti di averlo trovato durissi-
mo e io non potei nemmeno accostarlo perché il portiere mi si mostrò ostile e diffidente
ed io non avevo che pochi biglietti da 10 £.
Speriamo di trovare un ambiente più favorevole alla mia prossima e ultima gita a Ca-
tania.
Forse tu non sai che uno dei miei zii materni, il minore, mi ha già preceduto nel viaggio
all'altro mondo. Ferito ad una gamba durante una lotta aerea, amputato poi della
gamba stessa, lasciò la vita poco dopo l'operazione, all'età di 27 anni.
Quando potrò raggiungerlo? Spero tra non molto e degnamente. Anche lo zio Carlo è
stato chiamato col '74 ma probabilmente avrà l'esonero. Non lo invidio.
Spero che puoi essere contento della lunghezza, se non del contenuto di questa lettera,
che però non sarà l'ultima che riceverai da me.
Saluti infiniti per i tuoi esami che credo prossimi dal tuo sempre affmo
G Carnazza
Lettera:
3-4-1917
Carissimo Ermanno,
Da qualche giorno ho ricevuto la tua cartolina, indirizzata ancora al 124°.
Ciò mi meraviglia assai, e più ancora mi meraviglia il fatto che tu non abbia ricevuto
ancora risposta a quella tua famosa lettera. Ad ogni modo ti faccio sapere che io non
sono ancora morto, e che per il momento non ho la occasione di andare incontro ad una
morte onorevole, perché come ti scrissi, da più di un mese mi trovo oramai a fare il plo-
tone allievi ufficiali. Ma lasciamo andare questi discorsi funerei, oggi specialmente che
ti devo fare i miei più cari augurii per la prossima Pasqua.
Non so veramente se riceverai in tempo utile queste poche righe, perché imagino, che
ora come per Natale, sarai andato a passare le feste in famiglia.
Il tuo studio intensissimo cosa dice? Gli esami quando saranno? e quali materie darai?
e il più che famoso tedesco cosa dice? Hai già pubblicato il tuo primo volume di diritto
penale, o c’hai perduto già la passione? Ricordi quelle movimentate discussioni in que-
sta materia che facevamo sotto gli archi del Siculorum Gymnasium? Quando ritorne-
ranno quei bei tempi!
Nei primi del mese entrante io dovrò recarmi a Milano e in quella occasione spero di
potere fare una scappata anche a Pisa, o se ciò non si possa fare, per mancanza di tem-
po, ci metteremo d'accordo per venire tu.
Intanto rinnovandoti i miei migliori, più cari, più affettuosi augurii, mi dico tuo affmo
Giuseppe Carnazza
Cartolina postale italiana in franchigia / Corrispondenza del R. Esercito:
Mittente Carnazza G. / sTenente / 22° regg. fant. / 7ª compagnia / Z di G.
Caro Ermanno, Ieri ho ricevuto la tua cara. Ti risponderò a lungo appena, tra qualche
giorno, avrò cacciata di corpo la poltronite [illeggibile] che mi affligge. Ti abbraccio ca-
ramente e sono tuo affmo
Giuseppe
Cartolina postale italiana in franchigia / Corrispondenza del R. Esercito:
Mittente Carnazza G. / allievo ufficiale / 42° regg. fant. / Z. di G.
7- 5- 917
Ermanno carissimo
da parecchio tempo non ho tue nuove, ma veramente anch'io è un pezzo che non ti scri-
vo, non per questo però non sei stato sempre presente nei miei pensieri. Hai già passato
la visita? E quando indosserai l'onorata divisa di terribile. Io attendo di giorno in
giorno la nomina e poi spero di andare qualche giorno in licenza per dare gli esami.
Nell'attesa di un tuo gradito rigo ti abbraccio caramente. Tuo affmo Giuseppe
Da nessuna di queste lettere, che rivelano grande intimità e affiatamento, traspare il
disagio che deve aver provato il figlio di un italiano e di una tedesca nel trovarsi a
combattere contro persone che parlano la lingua di sua madre e di sua nonna, che pro-
vengono dallo stesso loro Paese. Giuseppe muore da sottotenente, il 24 settembre
1917, durante una delle sanguinosissime battaglie sull’Isonzo e viene decorato con una
medaglia d’argento alla memoria.
Di suoi amici caduti nel corso della Prima guerra l’ho sentito parlare per la prima e ul-
tima volta nel 1966, quando aveva chiesto, a una mia amica che abitava a Crespano
del Grappa, di informarsi se nel locale cimitero ne fosse sepolto uno di cui oggi non ri-
cordo il nome, “un caro amico morto sul Grappa”.
Un ultimo accenno a quello che dev’essere stato, per lui poco più che adolescente, un
grande dolore lo ritrovo nel discorso di apertura del suo primo anno accademico da
Rettore dell’Università di Trieste: “[...] ed in questo momento al ricordo dei miei com-
pagni dell’Università di Catania, morti nell’altra guerra, si associa il ricordo [di] Mag-
gio Astori, Luigi Monti, Vinicio Lago [...]” (1° dic. 1946).
Per fortuna tornano, sia pure un po’ acciaccati, i complici di tante marachelle, Gioac-
chino de Luca e Giuseppe Russo.
A guerra finita si ritrova un po’ alla volta anche il tempo per gli svaghi: è datata a me-
no di due settimane prima della laurea un’istantanea di Ermanno con tre colleghi in
mezzo a un prato. Sul retro ha scritto: “In ricordo di un quadruplice assassinio fotogra-
fico... / Gullio (sconsolato) Ermanno (così-così) Federico (meditante sulle rovine di Car-
tagine) ‘Pullo’ (alla ricerca della prova civile...) / 21 Giugno 1919 Pisa”.
Alle spalle il laureando “così-così” ha un’altra dura prova superata per... miracolo. A
Catania si era fidanzato con una fanciulla sua coetanea, ma costei, ligia all’adagio
“lontano dagli occhi...”, una volta partito l’innamorato per il continente non aveva per-
so tempo a trovare un vero marito. Questo episodio mio padre me lo raccontò pochi
giorni prima di morire. Ricordo la chiusa fulminante: “Mi chiusi in camera per farla fi-
nita. Mi salvò la figlia dell’oste”, e lo sguardo che mi lanciò appena finì di parlare. Vo-
leva dire: “Hai capito che cosa intendo con ‘salvare’? O forse sarei più contento se tu
non avessi capito...”. Io avevo poco meno di vent’anni ed ero molto ingenua: più che ca-
pire, intuii.
Ma perché Ermanno era emigrato a Pisa, sulla terraferma? Probabilmente perché lì
insegnava un illustre conterraneo (e amico di loggia massonica di Peppino) del quale si
riconosceva discepolo, anche se criticamente, dal punto di vista filosofico. Ma Giovanni
Gentile era rimasto solo quell’anno, poi era stato chiamato a Roma e al suo posto si era
insediato Vincenzo Miceli. Con quest’ultimo si laurea il 7 luglio 1919 con una tesi su
“Il problema della coazione nella dottrina dei caratteri differenziali del diritto”. Se n’è
fortunosamente conservata una copia: sulla prima pagina ha scritto di suo pugno: 1°
marzo – 20 giugno 1919 (6° edizione...) / Ricordo documentato di un primo fallo di gio-
ventù... Pisa 3 luglio 1919. Nell’ultima c’è, sempre di suo pugno, l’elenco delle tre tesi-
ne presentate insieme: in diritto romano (prof. B. Brugi), in diritto civile (F. Ferrara) e
in diritto penale. E in fondo: Approvato con 100/100 e lode. La discussione è avvenuta
di primo mattino, perché alle 11,15 parte un telegramma alla volta di Milano, destina-
tario l’avvocato Giuseppe Cammarata: Laureatomi massimo voti lode partirò stanotte
spedisci 175 Navarra – Ermanno Cammarata. Navarra era probabilmente la persona
che gli aveva affittato la stanza in quei due anni di soggiorno pisano.
I legami con Pisa non si spezzano subito: a novembre ci sono le epulae epularum in o-
nore di un docente, tale prof. Alfredo Pozzolini, svoltesi al Grand Hotel con tanto di
menù a stampa. Sul retro il Pozzolini scrive: “a Ermanno Cammarata, cui l’ingegno è
pari al grande cuore, amico e compagno inseparabile della buona battaglia”, ove per
“buona battaglia” penso intendesse quella dei postriboli.
Nello stesso mese acquista, con un “sopraprezzo di guerra” del 20%, Malinconie Uni-
versitarie, scritto da uno dei suoi maestri di Diritto, Pietro Cogliolo. Nemmeno le tristi
considerazioni sullo sfascio (secondo l’autore!) dell’Università postunitaria esimeranno
però il filosofo in erba dall’aspirare a una cattedra d’ateneo. Nel libro un capitolo è de-
dicato perfino al Rector Magnificus…
Di Miceli e dei suoi anni pisani trovo un breve ritratto in una lettera all’amico Cesari-
ni Sforza del 1932: “Apprendo dalla tua cartolina la morte del povero Miceli e non puoi
immaginare il senso di tristezza che mi ha invaso. Mi tornano alla mente le lunghe di-
scussioni sul diritto e lo Stato, le esercitazioni, le conferenze che egli mi lasciava fare e
che furono per me preziosa esperienza didattica. Mi tornano alla mente gli anni di Pi-
sa, i miei entusiasmi per la filosofia del diritto, tutto un mondo che non è più e il cui
ricordo m’è caro e doloroso a un tempo”.
Trentasette anni dopo ricorda ancora con nostalgia il periodo pisano in un prezioso,
quasi unico, flash autobiografico. Nella presentazione di un volume di scritti di un al-
tro suo famoso docente degli anni pisani, Santi Romano scrive: “[…] dal secondo capi-
tolo di tale opera […] ho tratto, da principio inavvertitamente, l’ispirazione a formula-
re la tesi, che se non m’inganno, potrà ancora farsi strada, della ‘relatività’ della di-
stinzione tra ‘fatto’ e ‘valutazione giuridica’. […] Rileggendo questi saggi, sono venuti
affollandosi nitidamente alla memoria i ricordi dell’umanissima figura del Romano
professore: e prima di tutto le lezioni di diritto costituzionale […] Apparentemente
fredde, quasi distaccate […], le prime frasi […], Egli veniva via via accalorandosi […]
E poi, dopo la lezione, la pazienza […] nell’ascoltare le domande e le obiezioni dello
studente che non aveva perduto una sola parola del Suo discorso; la prontezza delle ri-
sposte, prive di ogni accademico sussiego, sì che l’interlocutore era subito posto a suo
agio […] E, ancora, l’affettuoso interesse con cui seguiva le vicende dei suoi allievi […]
E come potrei dimenticare di essere stato specialmente da Lui ricondotto nell’alveo
della carriera universitaria, dalla quale, trentasette anni or sono, avevo cercato di al-
lontanarmi?”.
La tessera d’iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Catania, fatta l’anno stesso della
laurea, è corredata da una foto scattata sul Lungarno pisano (sullo sfondo s’intravede
quel gioiellino gotico che è Santa Maria della Spina). Ermanno, magrissimo, ha i baf-
fetti e il pizzetto e un’imponente lobbia: ha lo stesso sguardo e l’identica posa della foto
di quando era allievo del “Pennisi” di Acireale.
1920-1931
Alla laurea segue un biennio di cui non so nulla, durante il quale forse viaggia su e giù
per l’Italia, da Milano a Roma a Catania, città dove inizia a fare esperienza legale nel-
lo studio di suo padre, in via Landolina 46: studia e scrive, in attesa di entrare in qual-
che maniera nel mondo universitario. E fuma. Un vizio che non smetterà mai più e che
fin da allora gli procura problemi polmonari, come le pleuriti di cui parla nella corri-
spondenza con il suo secondo “maestro”, Giorgio Del Vecchio, e che gli varranno la
“bocciatura” alla visita di leva, anche se in famiglia verrà diffusa un’altra versione, pe-
raltro non migliorativa: riformato per insufficienza toracica. Di sicuro nel 1921 pubbli-
ca un primo studio sul “Giornale critico della filosofia italiana” diretto da Gentile e
l’anno dopo un polemico intervento sulle “tendenze antifilosofiche della giurisprudenza
moderna in Italia” che gli vale non pochi attacchi e altrettanti consensi: glielo pubblica
Del Vecchio nella “Rivista internazionale di Filosofia del diritto”. Ancora ottant’anni
dopo gli addetti ai lavori sottolineeranno con un po’ di stupore che questo articolo ave-
va dato vita a un acceso dibattito dentro e fuori la “Rivista”, da lui in seguito ribattez-
zata “Rivista internazionale dell’insalata russa”. Ermanno ne regala un estratto agli
amici romani Peppino e Violetta Ederli con la dedica “... come sostituto del Veronal...”.
Nella loro casa ha conosciuto un bel ciociaro ventenne, allampanato e squattrinato, che
vuol fare del cinema: al perennemente affamato Vittorio De Sica Peppino e Violetta of-
frono molto spesso montagne di pastasciutta, ci racconterà mio padre ancora ridendo
quarant’anni dopo.
[L’amicizia di Ermanno con questa coppia di generosi mecenati durerà fino alla morte.
Ricordo (con scarso entusiasmo) le visite che si facevano reciprocamente tre o quattro
volte l’anno. Gli Ederli avevano un genero psichiatra – un medico dei matti, diceva di-
sgustata mia madre – e a costui fu chiesto, quando avevo circa dieci anni, di “darmi
un’occhiata” a causa delle ricorrenti crisi di sonnambulismo. Mi fece sedere, mi picchiò
gentilmente con le nocche tutt’intorno al cranio e sentenziò: “Non è niente. È l’età.
Passerà.”. Ma fino a oltre i cinquant’anni ho sofferto di sonnambulismo: negli anni
Sessanta, evidentemente, in Italia Freud non era ancora molto conosciuto, men che
mai in ambito psichiatrico. E anche l’endocrinologia, a quanto sembra, non era proprio
all’avanguardia]
Il 1922 è l’anno di Vienna e di Berlino, del cui soggiorno rimane però solo una foto
formato cartolina inviata ai genitori “perché si contemplino nella loro primogenita ri-
produzione”: ne ricava un po’ di tedesco e probabilmente anche la conoscenza di
quell’Hans Kelsen, filosofo del diritto, al quale è dedicato il suo ultimo scritto, uscito
postumo nel 1973, ma che definisce, un quarto di secolo più tardi, “quel gran pasticcio-
ne”.
L’anno dopo si trasferisce a Roma, assistente volontario di Gentile e avvocato alle pri-
me armi. Abita in via Campo Marzio 69, presso la numerosa famiglia dell’avv. Luigi
Biamonti, e ha uno studio, che condivide con il collega Gaetano Vigo, in via di Ripetta
70.
Luigi Biamonti è amico di suo padre e a lui Ermanno si lega di profondo affetto. Un af-
fetto ricambiato ma lucido, quello di Biamonti che, pur non nascondendo il piacere che
gli fa conversare con questo giovane di grande intelligenza e con idee (filosofiche e reli-
giose) opposte alle proprie, non manca di spronarlo a fare qualcosa di concreto nel
campo della filosofia del diritto. Infatti è solo dietro le sue tenaci insistenze – “quasi
legandolo alla sedia, soprattutto la notte!” ricordava divertito il figlio Enrico – che Er-
manno porta a compimento e dà alle stampe quello che è ancora oggi considerato il suo
lavoro più importante: i Contributi ad una critica gnoseologica della giurisprudenza.
L’autore ne dedica una copia al suo anfitrione “con affetto di figlio”.
Certo, a Roma di distrazioni ce ne sono molte, e non solo muliebri: quante ore, quante
serate, volano via discutendo e passeggiando con il nuovo, imponente, amico Max Asco-
li...
Chi era Max Ascoli, bellissima figura di ricco ebreo convertitosi, da giovane e in tempi
non sospetti, al cattolicesimo, antifascista della prima ora e senza ripensamenti, gene-
roso filantropo, acuto pensatore, giornalista e grandissimo cultore dell’amicizia?
Era nato il 25 giugno 1898 a Ferrara da una ricca famiglia ebrea e si era laureato in
filosofia nel 1920 con Alessandro Levi. L’anno seguente pubblicava il suo primo libro,
che usciva contemporaneamente in Italia e in Francia, incentrato sulla figura di Geor-
ges Sorel. Due anni più tardi, a Roma, gli ricorderà Ermanno, “Sandrino Levi ti con-
dusse all’Aragno dove io compivo il... tirocinio in maldicenza interuniversitaria. Ricor-
di? Siamo stati parecchie ore a discutere su Croce e Gentile, io messo un po’ in imba-
razzo dai tuoi solenni ‘fondamentalmente’, quanto tu dai miei ‘che significa’, dove le i
erano percepite dal tuo orecchio come e mute! E ricordo perfettamente che nel lasciar-
ci, credo dopo la mezzanotte, davanti il portone di Piazzale Flaminio 9, mi dicesti te-
stualmente: noi certamente diventeremo molto amici... La profezia si avverò prestis-
simo: e a quarant’anni di distanza considero (a parte le ragioni di profonda riconoscen-
za) come uno dei più fortunati della mia vita, quel 24 giugno 1923”.
Max fece conoscere a Ermanno molte persone, tra i quali i suoi carissimi amici Enrico,
Enzo ed Emilio Sereni, e Ada e Tullio Ascarelli, laureato in filosofia con Gentile, dei
quali è spesso ospite.
Nel 1924 usciva Le vie dalla Croce (sulla sua conversione, avvenuta ben prima delle
leggi razziali) e poi nel ‘28 e nel ‘30 due saggi di filosofia del diritto: La interpretazione
delle leggi, del quale regala una copia all’amico siciliano con la dedica “Al mio caro
Ermanno, con affetto fraterno, e con amicizia che voglio sempre più intima, pur nella
discussione e nel dissenso/ Max/ Roma – Estate del 1928/ (Ulrichs nobis haec otia de-
dit.)”, e La Giustizia, con dedica “Al mio caro Ermanno, bersaglio dei miei innocenti
strali, e oggetto della mia fraterna amicizia/ Max/ Roma IV-1930”. Il primo cita più
volte i tre saggi che Ermanno ha pubblicato tra il ‘21 e il ‘26 mettendoli a confronto con
quelli dei loro “maestri” – Gentile, Del Vecchio, Maggiore, A. Levi – e in una nota tro-
viamo questa curiosa affermazione: “[...] il Maggiore è un entusiasta ispirato, il Cam-
marata è un tormentato melanconico. Se la polemica tra loro avesse potuto superare la
fase gretta del dissenso di scuola, sarebbe stata interessantissima, come una sorta di
riproduzione della polemica fra Pascal e i Gesuiti. Ora, Pascal è, fra tutti i mistici, il
più caro agli atei: per la stessa ragione siamo portati a dare una notevolissima impor-
tanza all’opera del Cammarata...” (n. 2, pp. 44-45). Dunque, Ermanno si è già fatto tra
gli amici la fama di bel tenebroso, e si comprende anche come il “tormentato melanco-
nico” abbia pensato, men che ventenne, al suicidio alla prima delusione amorosa e
sprofondi poi in una pluriennale depressione al primo concorso importante andato ma-
le. E come, in fondo, da adulto si sarebbe trovato a suo agio in una Trieste dove uno
Slataper aveva scritto “grazie per l’anima in tormento che ci hai dato”.
Il secondo libro è tutto chiosato a matita da Ermanno che, se ne deduce, molto spesso
non è d’accordo con l’amico. Sui margini trovo annotazioni del tipo: “e la libertà dove se
ne va?”, “è assurdo! la storia non esiste più!”, “ma l’astratto presuppone il concreto: se
no da che cosa si astrae”, “e che diavolo è la normatività se non quella che è chiamata
‘legalità’”, “che diamine sono questi sistemi?”, “ha dimenticato che la legge etica è an-
che fine supremo, mentre la legge giuridica è solo legge e non fine” e addirittura, tutte
nella stessa pagina: “ma neanche per sogno!”, “fantasia”, “questo è giusnaturalismo!”.
Max si trovava a Roma da qualche anno, alla ricerca della sua strada. In una delle po-
che lettere conservate da Ermanno, del 1924, parla di un viaggio nell’“orrida Milano”
per un ipotetico “ufficio speciale presso la Comit [...] a Roma”. Quale fosse il grado di
amicizia tra lui ed Ermanno lo si capisce dall’incipit di sapore shakespeariano: “Vec-
chia e invereconda talpa, è sperabile che tu non abbia preso cilindri se per tanto non
t’ho scritto [...]” e dalla chiusa: “Non fare il fesso e scrivimi subito. [...] Ora non ci sarà
mica bisogna che ti ripeta anche qual’è l’affetto di cui ti onoro, animale. Ti abbraccio
fraternamente. Tuo Max”. Nella stessa lettera annuncia anche il suo matrimonio con
Anna Maria Cocchetti (una poetessa più conosciuta con il nom de plume di Anna Ma-
ria Armi, da cui divorzierà una decina d’anni dopo in America).
Nel 1926 è diventato associato di filosofia del diritto a Camerino e l’anno seguente con-
seguirà la libera docenza a Roma. Traggo queste notizie dalla benemerita Current Bio-
graphy 1954, pubblicata regolarmente in America ancora oggi. E cito testualmente: “Il
crescente potere del regime di Mussolini spinse Ascoli a scrivere le sue fortemente an-
tifasciste opinioni su giornali clandestini. Arrestato a Milano nel 1928, temette che
fossero stati scoperti quegli attacchi al governo ma scoprì che la polizia ignorava la sua
produzione letteraria clandestina e voleva semplicemente fare opera di intimidazione
a causa della sua reputazione di antifascista. Dopo tre settimane di prigione gli furono
inflitti due anni di ‘ammonizione’ (poi tramutati negli arresti domiciliari). L’arresto de-
terminò la fine della sua collaborazione con l’Università di Camerino e la messa al
bando dei suoi scritti in Italia e gli impedì di accettare la cattedra di filosofia a Roma
che aveva vinto per concorso.
Impossibilitato a insegnare nel continente, divenne associato di filosofia del diritto
nell’università di Cagliari in Sicilia [sic!] nel 1929. Qui si distinse per due motivi: era il
solo professore non iscritto all’Associazione dei professori universitari
(un’organizzazione fascista) e il solo membro della facoltà che avesse il suo poliziotto
personale. La presenza di questo funzionario non contribuì alla tranquillità accademi-
ca e ciò, insieme all’adamantino rifiuto di Ascoli di iscriversi al partito fascista o a
qualcuna delle sue appendici, lo costrinse alle dimissioni nel 1931.”
[Non mi risulta che il suo nome sia stato mai compreso in quella lista dei pochissimi
prof universitari che si dimisero per non prendere la tessera. Chissà perché.]
Riassumo il resto. A questo punto Max chiede e ottiene, grazie ai buoni uffici di Genti-
le, ormai ministro dell’Educazione nazionale, di riavere il passaporto per andare in
America, dove ha vinto una borsa di studio della Rockefeller Foundation. Ma proprio
al momento d’imbarcarsi, a Napoli, le competenti autorità lo bloccano perché il suo
nome è ancora tra quelli dei pericolosi che non possono andarsene. Con la parlantina
tipica del filosofo Ascoli racconta i suoi guai al vicecapo della locale polizia e finalmen-
te riceve il permesso per partire. “Presa la nave per l’ultima passerella” dice la C.B.,
“portando con sé un Gaugin, un Tintoretto e buona parte della cospicua fortuna di fa-
miglia”, arriva in America, da dove non se ne andrà più, facendo tra l’altro una brillan-
te carriera universitaria.
Quello che la C.B. non dice è che, durante la guerra, è uno dei fondatori e sostenitori
dell’“Emergency Rescue Committee” di Varian Fry: questa associazione, in mezzo a
immaginabili pericoli e inimmaginabili stratagemmi e difficoltà, riesce a portare in
salvo, tra il 1940 e il 1941, attraverso il porto di Marsiglia, la Spagna e il Portogallo,
migliaia di ebrei tedeschi, tra i quali anche Hannah Arendt e la di lei madre. Dal ‘41 al
‘43 è presidente e finanziatore della “Mazzini Society”, un’associazione di esuli antifa-
scisti di alto spessore culturale e politica (tra essi Sforza e Salvemini) che intendevano
suggerire agli americani che cosa fare dell’Italia e per l’Italia quando il fascismo fosse
caduto. Ascoli stila numerosi e acutissimi promemoria per l’amministrazione Roosevelt
ma, allora come oggi nei conflitti balcanici e mediorientali, gli yankees non si fidano di
nessuno se non di se stessi e snobbano tali proposte: per loro la soluzione dei problemi
deve venire sempre dalle armi...
La filantropia di Max Ascoli si esplica poi, a guerra finita e a fascismo sconfitto, anche
nei confronti dell’Italia: fonda e sostiene il CADMA (Committee for the Assistance and
Distribution of Materials to Artisans), un’organizzazione non-profit per contribuire al-
la rinascita delle nostre industrie artigiane distrutte dalla guerra. Il CADMA ha sede
a Firenze, a Palazzo Strozzi, ed è diretto dal critico d’arte Carlo Ludovico Ragghianti,
che organizza mostre dei nuovi artisti italiani in Italia e in America. Dona poi, nel
1950, 200.000 dollari (di allora!) all’ospedale ferrarese Sant’Anna per la costruzione
del padiglione di Oculistica, in memoria della madre, dalla quale ha ereditato quei
gravi problemi di vista che solo nel 1957 un’operazione in Germania riesce in parte ad
alleviare. Crea inoltre, stando alle cronache, una ricca fondazione per il restauro dei
monumenti italiani danneggiati dalla guerra. Nel 1952 apre un conto a nome del suo
amico Ermanno che sta per trasferirsi con tutta la famiglia, e definitivamente, da
Trieste a Roma. E guai a parlargli di restituzione!
Max è ormai famosissimo, in America. Nel 1949 ha fondato una rivista quindicinale,
inizialmente sul modello dell’inglese “Economist”, di idee liberali, che in pochissimo
tempo diventa leader nel campo delle pubblicazioni politiche “che contano” e fanno o-
pinione. Tra le firme più prestigiose di “The Reporter” troviamo quelle di Mary
McCarthy, James Baldwin, Isaac Deutscher, John Kenneth Galbraith, Henry Kissin-
ger, Boris Pasternak, Arthur Schlesinger Jr. e Edmund Wilson. Vi si analizzano sia la
politica americana che quella di buona parte del mondo. Max ne è il proprietario e il
finanziatore (ci ha investito 1.500.000 dollari!), avendo accanto come “limited – and si-
lent – partner” la seconda moglie, Marion Rosenwald, dalla quale nel 1942 ha avuto
un figlio, Peter Max. Marion, avvocato (1902-1990), figlia di un miliardario filantropo,
ha dedicato gran parte della sua vita a cause benefiche, molti delle quali per il benes-
sere dei bambini poveri.
Continua anche a scrivere saggi di politica. In uno, The Power of Freedom, scrive che
la libertà è “il potere propulsivo della civiltà — un potere che l’uomo può far scattare e
controllare [...] questo potere può guidare gli uomini del nostro tempo a fini così alti e
così buoni che possiamo a malapena intravederli”.
A volte trova anche il tempo per scrivere al grande amico siciliano, sicuramente meno
fortunato sul piano economico e su quello della visibilità culturale. Parlano di avveni-
menti mondiali, italiani e americani, ma anche di faccende personali, addirittura inti-
me. A proposito del problema di un comune amico, di non facile soluzione, scrive: “Ad
ogni modo non è il caso di fare delle disquisizioni di filosofia giuridica, come ai bei
tempi in cui te e io sedevamo da Rosati in Piazza di Spagna”. Ma i suoi contatti sono
sempre ad altissimo livello: “[...] prima di tornare a New York [da Londra] ho passato
anche qualche giorno a Parigi, dove ho avuto delle conversazioni molto interessanti
con Malraux e con Joxe, e ho fatto una corsa a Bonn per vedere Adenauer”.
“The Reporter”, che negli anni migliori è arrivato alle 200.000 copie (una cifra altissi-
ma, se si pensa che era una rivista per soli addetti ai lavori di politica nazionale e in-
ternazionale), chiude nel 1968: Max è scivolato sulla buccia di banana del Vietnam..., e
poi è stanco e pieno di acciacchi. Tuttavia quest’omone alto più di un metro e ottanta,
pure lui accanito fumatore, sopravviverà a Ermanno di ben 7 anni.
[Quando già disperavo di trovare fonti decisive su questa parte della vita di mio padre,
mi sono giunte dagli Archivi Max Ascoli di Boston le copie delle lettere (non tutte: solo
quelle che l’un po’ meno disordinato ferrarese aveva messo in salvo con l’aiuto della
sua segretaria) che i due amici si sono scambiati fra il 1954 e il 1970: essendo corri-
spondenza tra due coetanei, il tono di queste missive – soprattutto di quelle di mio pa-
dre, che lo considerava il suo migliore amico – è estremamente confidenziale, e mi ha
aiutato a comprendere meglio la vita interiormente travagliata e, in alcuni casi, anche
avulsa dalla realtà familiare, di Ermanno. Avrò modo di tornarci su più volte.]
E torniamo agli anni delle “disquisizioni da Rosati” (tra le lettere sopravvissute di
questo periodo, quelle di Michele Barillari). Provo a immaginare quante risate si sa-
ranno fatti nel ricevere questo breve messaggio del comune amico Enzo Sereni: “Roma
8 marzo; ore 10 ant. / Cari amici, ritenendomi offeso dal signor Giuseppe Maria Macry
per il suo contegno, tenuto, nei miei confronti, ieri all’Università vi prego di volermi
rappresentare presso la controparte allo scopo di ottenere spiegazione, e, se del caso,
una soddisfazione o una riparazione atta a tutelare il mio onore. Ringraziandovi, ab-
biatemi per vostro Enzo Sereni / Ai sig. avv. Ermanno Cammarata e o dott. Max Asco-
li”. La sibillinità di tale missiva si spiega, ancora una volta, grazie a Il gioco dei regni,
che ci rende edotti del probabile antefatto. Nel 1926 Enzo era fidanzato con Ada Asca-
relli (sorella di quel Tullio, grande amico e collega di Ermanno e di Max, di cui si è fat-
to cenno nel capitolo precedente). Il fatto che Ada fosse rimasta incinta prima del ma-
trimonio e la conseguente fretta di celebrare il rito onde legittimare il nascituro po-
trebbe essere stato il casus belli dell’offesa fatta dal Macry a Sereni. Di qui la richiesta
ai due amici di fargli da padrini nell’eventuale duello. Il duello, o la minaccia di esso,
doveva essere una costante di casa Sereni. Scrive infatti Clara Sereni: “[…] il matri-
monio di Enzo e Ada avvenne senza sfarzo, per non fornire esche ulteriori allo scanda-
lo: di mezzo c’era stato addirittura un rischio di duello, Lello [il padre di Enzo] e il tu-
tore di Ada erano stati lì lì per acquistare le pistole, ciascuno volendo stabilire con il
sangue chi, dei due giovani, fosse stato oggetto di seduzione. Il buon senso prevalse,
ma un gran gelo scese fra le famiglie, fino a quel momento assai legate fra di loro.” (p.
183).
L’anno prima di questo episodio Ermanno ha conseguito la libera docenza in Filosofia
del diritto. Ricordando il giorno fatidico in cui aveva fatto, di fronte alla commissione,
la lezione su un tema assegnatoli ventiquattro ore prima, mio padre rideva, con malce-
lato compiacimento, sul fatto che la sua imperturbabile logorrea siculo-filosofica aves-
se quasi ipnotizzato gli astanti, tutti peraltro grandi nomi del mondo accademico e
giuridico.
Le foto di questi anni ci mostrano un “uomo fatto”, non più filiforme, dotato di barba e
baffi, con vivacissimi occhi scuri: un vero “tipo mediterraneo”, anzi, il prototipo del me-
ridionale impiegato dello Stato... Ci raccontava che una volta, entrato in un bar dalle
parti di Campo Marzio roteando disinvoltamente il bastone (del quale tutti i giovanotti
un po’ snob erano in quegli anni dotati), vide il locale, in quel momento pieno soprat-
tutto di belle fanciulle, vuotarsi improvvisamente al suo avanzare. Avvicinatosi al
banco per ordinare, si sentì dire dal barista: “Ma le lasci in pace, poverette!...”. Allo
sguardo stupito e interrogativo di lui, che da distratto pensatore qual era già allora
non aveva capito nulla della scena, l’uomo gli chiese: “Ma come, non è della Buonco-
stume, lei?”. Aspetto mediterraneo-semita a tal punto che, durante l’occupazione an-
gloamericana di Trieste, fermo in strada in attesa della fidanzata e ormai definitiva-
mente senza barba, si era sentito chiedere da un giovane soldato americano con in fac-
cia l’espressione di gioia di uno che ha trovato finalmente la persona giusta: “Excuse
me, where is the synagogue?”.
Con la libera docenza arriva finalmente anche il primo incarico di filosofia del diritto a
Messina. Ermanno torna nella sua isola e può stare a lungo con i genitori e i vecchi
nonni.
Nella città siciliana prepara anche il suo primo concorso, quello per professore non
stabile alla cattedra di diritto e procedura penale della Regia Università di Bari. Pro-
babilmente vuole solo saggiare le sue forze, perché quelle non sono le “sue” materie. Vi
partecipano, tra gli altri, due amici: Orazio Condorelli e Giacomo Perticone. In com-
missione ci sono Del Vecchio, Alfredo Bartolomei, Gioele Solari, Barillari e Maggiore.
Il risultato è deludente: la sua vivacità speculativa, rilevano gli augusti commissari,
non è sempre accompagnata da vigile senso critico. Il carattere del suo pensiero, poi, lo
porta spesso a eludere invece che a risolvere i problemi, e il giovane viene perciò invi-
tato a sottoporre il suo pensiero “più corrivo a presumere che abile a dimostrare, a una
maggiore disciplina”. Una sconfitta che non pesa affatto: Ermanno sa (o pensa) di ave-
re ben altre frecce al suo arco. Quanto al sottolineare il problema dell’eludere invece
che affrontare, questo è un difetto che si porterà sempre dietro anche nella vita quoti-
diana.
Dopo un solo anno in Sicilia rieccolo a Roma, dove Gentile, direttore della nascente
Enciclopedia Treccani, gli ha affidato, tramite Ugo Spirito e poi Santi Romano, diret-
tori della sezione “Diritto, Folosofia e Pedagogia”, l’incarico di redigere alcune voci
(contrattualismo, autocrazia, autorità, demagogia, dispotismo, plutocrazia). In questa
occasione rivela uno dei suoi difetti principali e imperituri: il correggere e ricorreggere
ciò che scrive, a scapito della puntualità della consegna del lavoro. Un anno dopo rice-
ve questo ultimatum: “Mi stupisce il Suo Silenzio: poichè alle nostre lettere sollecitato-
rie del 25/II/28 e 9/III/28 non è mai giunta alcuna risposta, sono costretto ad insistere
vivamente, perchè Ella ci faccia pervenire con la maggiore possibile sollecitudine i
manoscritti delle voci a Lei assegnate. In attesa, Le invio distinti saluti. Gentile”. Ma
sotto, a penna, il senatore del Regno ha scritto: “Ora che ti do del Lei, ti degnerai di ri-
spondere!”. Ed Ermanno finalmente risponde, inviando solo le prime due voci. Quelle
inevase verranno poi affidate ad altri più puntuali collaboratori. E pensare che ha po-
tuto scrivere e firmare le voci anche senza essere iscritto al Partito fascista, perché è
noto che Gentile non chiede, ai suoi collaboratori, alcun tipo di tessera. Ma i lemmi so-
no incompleti, tanto che Spirito gli sollecita l’invio della bibliografia relativa a “Autori-
tà”. La risposta del giovane filosofo è puntuta e falsamente seria: in realtà sta dando al
suo collega e coetaneo una buona lezione di storia del pensiero occidentale, da Platone
a Gentile. La fine della collaborazione con l’Enciclopedia potrebbe essere stata, al di là
della nota pigrizia, un modo per scrollarsi di dosso il sospetto di una sua simpatia per
il fascismo?
E sempre a proposito del suo rapporto, da lui mai disconosciuto, con Gentile, un suo al-
lievo ricorderà, ben ottant’anni dopo: “[Nel] 1925 Giovanni Gentile stilò il manifesto in
appoggio al fascismo. E Cammarata, allora giovanissimo allievo del filosofo siciliano, si
precipitò da lui e gli disse: Maestro, ma non è stato lei a educarci al culto della libertà? E i
rapporti con Gentile si raffreddarono, quando Cammarata era ancora giovane docente e
ancora attendeva la definitiva consacrazione della cattedra universitaria. E non fosse
stato per Santi Romano, che lo appoggiò nelle evenienze concorsuali, egli avrebbe subito
forse ben dure conseguenze di quel suo atto di coraggio e di lealtà: allora i grandi mae-
stri credevano tanto in se stessi da non ammettere critiche, soprattutto da giovincelli an-
cora imberbi!”. Credo che il riferimento a Romano sia inesatto, in quanto mai gli abbiamo
sentito fare quel nome. Dalle lettere a Max e da quelle alla famiglia si deduce invece che i
suoi padrini concorsuali erano stati altri: Cesarini Sforza, Biamonti, Maggiore…
Nello stesso anno viene chiamato a insegnare sia la sua materia che Diritto interna-
zionale a Macerata. Gentile, che nonostante tutto gli vuole molto bene e lo stima, vigi-
la su di lui e lo raccomanda al podestà della tranquilla cittadina marchigiana. Ma
quella raccomandazione non viene spesa e la lettera resta nelle tasche – e poi nei cas-
setti – di un giustamente orgoglioso Ermanno.
Che i rapporti con Gentile e con la sua famiglia siano rimasti immutati anche dopo la
tragica scomparsa di quest’ultimo me lo conferma il fatto che ancora negli anni Ses-
santa a volte veniva a trovarlo la figlia Teresa, detta Teresita: ricordo una donna piut-
tosto imponente con i capelli brizzolati, molto somigliante al padre, che conversava
familiarmente con i miei genitori.
A Macerata si trova bene (vi resta fino al 1932) e si fa molti amici sia tra gli studenti
che tra i colleghi, perché è uno che, fuori dall’aula, è assolutamente informale, dedito
anche, se capita, alla più sfrenata goliardia. È del ‘30 una foto che lo immortala davan-
ti a un leggio da musica mentre si esibisce in un concerto per “chirofono”, come dice
lui, ossia in una musica prodotta unendo i palmi delle mani e manovrandoli in modo
da far uscire ed entrare l’aria con la tecnica degli strumenti a fiato. (Una volta gli ho
sentito dire che fra i suoi sogni c’erano quello di navigare come capitano “di lungo sor-
so” e quello di diventare direttore d’orchestra. Peccato che soffrisse di vertigini e mal
di mare...). Non c’è da stupirsi se quando lascia Macerata i “laureati partenti” (per il
servizio militare?) inviano un telegramma di saluti al “professore amatissimo”.
Come al solito molte di queste foto sono autoscatti: la passione per la macchina foto-
grafica è al suo apice, ma ciò non obnubila l’abituale autoironia: si fa addirittura ri-
trarre con tre amici, anch’essi dotati di binocolo o macchina fotografica, tutti a caval-
cioni di una sedia e con lo sguardo da malfattori. Sotto ciascuno di loro ha scritto:
“Sacco – Vanzetti – Pollastri?” e di sé: “Cannella o Bruneri?”.
Ma il goliarda professore si prepara in silenzio al concorso a cattedra di filosofia del di-
ritto, che viene finalmente bandito nel 1930.
Non so esattamente quali importanti e determinanti fatti siano accaduti in Italia e nel
mondo nel 1930; so però di sicuro, adesso, che annus horribilis è stato per Ermanno, il
quale probabilmente sentiva di avere già la cattedra in tasca – e nella sua città natale!
– e invece...
Dunque, all’inizio del 1930 viene bandito il concorso per la cattedra di filosofia del di-
ritto nella Regia Università di Catania. La commissione è formata da illustri perso-
naggi che conoscono a fondo Ermanno e, a voce, non fanno che tesserne le lodi – Genti-
le, Del Vecchio, Maggiore, Barillari – e dall’ormai anziano storico del diritto Federico
Ciccaglione. I retroscena sulla formazione di tale commissione (nella quale avrebbe
dovuto esserci pure Tullio Ascarelli) li scrive a Ermanno il catanese prof. Biondo Bion-
di, il cui resoconto sembra stilato pochi giorni fa: davvero il vezzo del baratto e del voto
di scambio è usanza senza età! Anche i concorrenti sono, in buona parte, amici o buoni
conoscenti: Max Ascoli, Giuseppe Capograssi, Widar Cesarini Sforza, Orazio Condorel-
li, Alessandro Passerin d’Entrèves, Giacomo Perticone ecc., oltre ad alcune vecchie glo-
rie, tanto che Max, da Cagliari, gli scrive divertito che a leggerne l’elenco “sembra
l’inno di Garibaldi. Quali altre tombe si scoperchieranno?”. Max lancia accidenti a Del
Vecchio, si ritiene certo della vittoria del suo amico e gli consiglia di lavorare e scrivere
“perché credi che la sola difesa possibile è lì: nel lavorare”.
Certo, trovarsi come rivali il concittadino e amico di gioventù Orazio Condorelli (un al-
tro ex allievo di Sandrino Levi) e il “fratello” Max Ascoli, non dev’essere molto piacevo-
le dal punto di vista emotivo ma... à la guerre comme à la guerre: la posta in gioco è al-
tissima.
Si noti poi che Gentile, Del Vecchio e Maggiore (già giudici del concorso del ‘27, oltre
tutto) sono buoni amici (anche di loggia) di Peppino Cammarata.
E arriva il 29 ottobre 1930, il giorno della sconfitta: Ermanno è sì “idoneo”, ma non
rientra nella terna dei vincitori (tra i quali c’è invece Condorelli, che si aggiudica la
cattedra catanese): i commissari gli rimproverano di aver aver scritto poco negli ultimi
quattro anni; quel che è peggio, i suoi scritti “lasciano insoluti i problemi trattati ovve-
ro non apportano un contributo positivo alla loro soluzione”. Quanto allo scrivere poco
(se cinque saggi per oltre 200 pagine complessive sembran poco), c’è da dire che, dopo
il ‘30, nel suo campo scriverà ancora di meno e inciderà molto di più. Oltretutto, la
pubblicazione dei saggi la pagherà sempre di tasca sua, fin quasi alla fine della carrie-
ra: pur essendo a contatto di gomito con fior di intellettuali, tra cui Croce e Gentile,
non troverà mai un editore nazionale interessato ai suoi scritti. Forse perché lo si ri-
tiene un po’ troppo astratto, se non addirittura astruso?
In lui lo schianto dev’essere stato spaventoso: non solo per l’alto tasso di ambizione che
si porta dietro fin dagli anni giovanili, grazie all’incessante incoraggiamento che gli è
venuto da tutta la famiglia, nonni compresi, e dagli amici; non solo perché l’idoneità
non dà alcuna garanzia di lavoro universitario (e Dio sa quanto ne ha bisogno: come
avvocato guadagna poco ed è ancora il padre a foraggiarlo in parte); non solo perché il
lavoro di ricerca gli piace veramente – molto più che fare l’azzeccagarbugli – e solo con
uno stipendio fisso potrebbe dedicarvisi quasi a tempo pieno; non solo perché uno dei
vincitori è un grande amico e non può ufficialmente mandarlo a quel paese; ma soprat-
tutto perché è stato tradito, per la seconda volta!, da persone che stima moltissimo e
che gli si rivelano in tutta la loro piccineria.
Di sicuro è andato a rileggersi la lettera che Orazio, per gli amici Ciccio, gli ha scritto
nell’ormai lontano 1925. L’amico gli confida che avrebbe voluto chiedere l’incarico
all’università di Messina ma siccome vi aspira anche lui ci rinuncia: “Penso del resto
che, poiché tu hai deciso di darti completamente alla carriera accademica, sarebbe da
parte mia poco fraterno attraversarti la strada, tanto più che io ancora mi barcameno
tra scienza e professione.”. Passa poi a esaminare “obiettivamente” la questione, ac-
cennando a Barillari. Gli dice quali sono i problemi per le cattedre di Messina e Cata-
nia e lo esorta a sbrigare “subito l’affare della [...] libera docenza, che ormai è divenuto
lungo oltre ogni limite di sopportazione”. Ribadisce infine che non gli costa molto sacri-
ficarsi per lui, anche perché Ermanno avrebbe fatto (o farà) lo stesso per lui.
Tempora mutantur et nos mutamur in illis avrà pensato, cinque anni dopo,
l’amareggiato Ermanno, che però non gli porta rancore. Ecco infatti come lo ricorderà
quasi quarant’anni dopo: “[...] il mio sodalizio con Orazio Condorelli cominciò negli ul-
timi mesi del 1915. Egli era già ‘anziano’, ossia studente del terzo anno della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Catania, io ‘matricola’: la simpatia fu immediata, di-
rei quasi istintiva, e si convertì rapidamente in una profonda, fraterna amicizia, che
affrontò indenne il collaudo di non facili prove, e rimase saldissima anche negli anni
dell’inevitabile antagonismo nel noviziato accademico. [...] un uomo che fu [...] gran ga-
lantuomo e gran cuore.”.
La settimana successiva al verdetto è tutto uno scrivere lettere disperate e un ricevere
trepide voci di conforto: entro la prima quindicina di novembre ha già ricevuto le lette-
re colme di affetto di Sandrino Levi (due nel giro di una settimana!), Max Ascoli, Gio-
acchino Scaduto, Peppino Cammarata.
Sono, queste, le lettere più importanti dell’esiguo epistolario fortunosamente ritrovato.
Sono certa che le ha volute conservare, a ogni costo, per il grande calore umano che
trasmettono. A me sembrano altrettanto importanti per il ritratto di lui che me ne
hanno conservato.
Sandrino: “[...] Comprendo, e giustifico pienamente, il tuo rincrescimento; ma bada a
me, che ti voglio bene, che ho tanta stima di te, che ho... l’esperienza del mio quasi –
mezzo – secolo: non offuscare la rettitudine della tua linea morale con miseri, e ad ogni
modo, inutili pettegolezzi o critiche a carico di un giovane [Condorelli] del quale sei
sempre stato amico. Hai, invece, piena ragione di dolerti (secondo quanto mi riferisci)
del tiro, che ti ha giocato chi dovevi considerare come il più fervido tuo sostenitore [Del
Vecchio]. Ma anche nei riguardi del tuo Maestro, bada a me, non ti conviene di esage-
rare o, per dire più esattamente, di spifferare a chicchesia le tue lagnanze. Di me, lo
sai, ti puoi fidare... più che di te stesso. Ma, se vuoi presto la piena rivincita che meriti,
non... irritare un Nume di quella forza! È inutile, amico mio: o si è prepotenti... fino in
fondo, o si è fessi, come sei tu e come... mi vanto di essere io! Tu sei, come lo sono io,
troppo galantuomo per assumere la posa del prepotente. Abbi fiducia in te stesso: ne
puoi avere. Ed abbi fiducia anche nella giustizia [...] Tu meriti sicuro rispetto per il tuo
carattere, per il tuo ingegno fervidissimo, per il tuo lavoro [...] Porta ben alta la testa
e... cerca di tenere più chiusa che puoi la bocca!! [...]”. Ermanno gli risponde riportando
le untuose espressioni di dispiacere che Del Vecchio ha scritto a Peppino all’indomani
dei risultati. E Sandro: “[...] Ti ringrazio di avermi ricopiato le sue righe a tuo Padre: lo
stile è l’uomo. Gli si potrebbe chiedere perché, con tutte quelle buone disposizioni che
dimostra verso di te, ha lasciato che il voto te lo desse soltanto – con una lealtà e indi-
pendenza, che, per una volta, l’onorano – il prof. Maggiore; [...] Ho piacere di sentire
che hai già ripreso a lavorare. Anche se non farai molto di qui al nuovo concorso, io
amo credere che ti dovrà essere resa giustizia. Ma il lavoro è la nostra vita; come si
può farne a meno?”.
Gli scrive subito un altro dei suoi maestri, Widar Cesarini Sforza, che è uno dei terna-
ti: gli esprime solidarietà per il concorso andato a male e lo incoraggia a continuare gli
studi “perché hai delle idee e in un modo o nell’altro esse vorranno venir fuori.”. “Sta di
buon animo e pensa all’Esperienza giuridica, che sarà il tuo capolavoro”. Cesarini
Sforza è stato davvero un gentiluomo: alla notizia del concorso gli aveva scritto senza
dirgli che vi avrebbe partecipato ma dandogli delle speranze. Nomina Battaglia, Perti-
cone, Passerin d’Entrevès, che concorreranno anch’essi. E ora il vincitore scrive
all’escluso: “[...] A Pisa parlai con Volp.[icelli], e in complesso ho l’impressione che si
siano resi conto della porcheria fatta. Per Volp. la colpa di tutto è Del Vecchio: sarebbe
stato per difendersi contro di questi, che non si sarebbe badato ai mezzi... Da Ascoli ho
saputo che Gentile ha parlato di te. Ti consiglierei a non insistere nelle reazioni verba-
li: cui bono? [...] Ad ogni modo conta su di me per un’eventuale proposta alla teoria
gen.[erale]. [Cesarini era stato appena trasferito a Pisa] [...] Condorelli mi tempestò di
lettere e telegrammi supplicandomi... di non guastargli le uova nel paniere! [...]” .
Com’è difficile, per Orazio, il mestiere di amico...
Max, altro idoneo non vincitore, va giù ancora più duro: “[...] la lettera del Maestro che
tu fedelmente mi copi, mi pare una delle cose più sporche fra le molte porcherie che ho
visto compiere al porchissimo uomo. Lui che aveva in pectore la sua terna, lui che di-
chiarava a persona che ho ragione di ritenere sicura essere te fra quelli che non avreb-
be in alcun modo appoggiato, ora ha l’impudenza di unirsi al rammarico tuo e della tua
famiglia. Dovrebbe, se avesse un po’ di sale in zucca, benedire Gentile che con la sua
grossa zampa ha levato la castagna (o meglio la castagnola) dal fuoco: che altrimenti
questa sarebbe esplosa contro di lui, Del Vecchio. Ma rinfocolare il vostro risentimen-
to, parlare anche lui di baratto, piangere coi tuoi perché non gli è stato permesso di
fregarti [...], tutto questo è schifoso, turpe; [...] Ripenso poi alle lacrime di coccodrillo
che ha versato nel seno del povero Giacomino [Perticone] [...] e ho l’impressione precisa
che fra le due forme di porcheria quella di Gentile, per la sua stessa enormità grosso-
lana, sia onesta. Da Gentile domani potresti anche avere un aiuto; da Del Vecchio,
mai. Poichè non ti credo del tutto rincoglionito, voglio sperare che non abboccherai
all’amo del tuo nuovo Maestro, che non spererai sia uomo da metterti nel prossimo
concorso in terna saltando la triade dei diletti del suo cuore. Per mio conto, la lettura
di quella lettera mi ha dato tanto l’impressione schifosa della sua ignobile doppiezza
che, contrariamente a quanto gli avevo annunciato, parto martedì per Cagliari senza
neanche andargli a dir crepa.”. Niente male, per uno che era spiato giorno e notte da
un segugio della polizia fascista... (Ricordo che Gentile era, oltre che senatore, ministro
dell’Educazione).
E suo padre: “[...] Se non sapessi di farti male, ti direi che ne ho piacere, per il solo fat-
to che ti pone a tu per tu con quella realtà della vita, che gl’illusionisti come me – e da
me tu hai ereditato! – non riescono a intravedere per bontà d’animo, soprattutto. [...]
Del camorrista principale non ebbi a farmi soverchie intenzioni; verrà il suo turno. Per
quel di Palermo avevo fatto parlare a [illeggibile] dell’Arenella, e questi mi assicurò di
averne interessato la signora. Ero incerto, ma speranzoso. Non ho dubitato, nonostan-
te il tuo [illeggibile] in contrario, di Del V. Con me fu limitato, ma sincero. Lo vedrò ed
avrò maggiori dettagli prima di colpire il monarchico d’Abbruzzo, divenuto liberale a
Napoli, assessore socialista in Catania, e poi maestro segreto (4°) in massoneria, per
scivolare dal fascismo al più smaccato clericalismo. [...] Ma... tirando le somme, io vedo
altra ragione di compiacimento, meno le botte al tuo sistema nervoso: quello di fare
quel che io feci [quando fu trombato al concorso a titolare di diritto penale, nel 1899],
almeno in parte: mandare la scienza alle ortiche, salvo a sfruttare la situazione, conti-
nuando a scrivere grossi volumi e indirizzare la tua attività nello esercizio professiona-
le che rende parimenti la gioia dei trionfi e soldi a profusione. [...] Ti abbraccio e stra-
fottitene!”.
Gli scrive Enrico Biamonti riferendo l’esito del ricorso che è stato immediatamente fat-
to al Consiglio Superiore dell’Istruzione. Dice che in quella sede il giudizio della com-
missione d’esame ha fatto un’impressione “non soltanto sfavorevole ma severamente
contraria” ma che a livello legale non si può annullarlo. Gli consiglia di tranquillizzarsi
e di dimenticare, perché sicuramente ce la farà al prossimo concorso.
Gioacchino Scaduto (un amico di Ermanno e di Peppino): “[...] Habent sua sidera non
le liti ma i concorsi! Purtroppo il male non è rimediabile, perché il Consiglio Superiore
ha già provveduto approvando [...]”.
Giuseppe Maggiore scrive invece a Peppino per comunicargli che lui ha votato per Er-
manno. Ribadisce che non deve perdersi d’animo, anche se la via dell’università “è, per
i più, aspra di triboli e di amarezze”. Illuminante la chiusa: “Quanto a me, desidero di
non fare più parte di commissioni esaminatrici, per non smarrire quel po’ di fede che
ho ancora nella giustizia”.
Il fiasco di Peppino nel concorso a titolare di diritto penale all’Università di Padova lo
racconta, in tono quasi da leggenda, un suo amico e collega catanese, Alberto Scabello-
ni, 42 anni dopo:
“Presiede la Commissione il Prof. Alessandro Stoppato e sono membri, Lucchini, Im-
pallomeni, Nocito e Napodano.
A un certo punto della discussione, il candidato batte il tasto con un verso di Giosuè
Carducci:
« Quando si dan la man, Cesare e Piero... »
e, rosso in viso, pieno di fervore, convinto più che mai di quanto afferma, così prosegue:
«La libertà è stata sempre compromessa dai frequenti baci e litigi fra Chiesa e Stato»...
E il Professore Stoppato, calmo e padrone dei suoi nervi, ma contrariato nell’intimo
della sua fede cattolica, con un sorrisetto ironico, chiede: – Dove ha letto queste prezio-
se teorie?
Candidato: – Nell’opera di un grande Autore.
Professore: – Ma di grazia, il nome di questo autore?…
Candidato: – La Storia!
L’epilogo s’intuisce facilmente; solo per l’autorevole e coraggioso intervento del Prof.
Nocito, Peppino Cammarata risultò il dodicesimo in graduatoria.”
Ah, se Ermanno avesse davvero ereditato il carattere di suo padre!…1
Prima di abbandonare la lacunosa cronistoria di questo decennio devo fare un excursus
su un altro personaggio qui citato e molto importante per mio padre non solo in quegli
anni ma per tutto il resto della sua vita, come vedremo più avanti.
Alessandro (chiamato Sandro o, dai più intimi, Sandrino) Levi, nato a Venezia nel
1881, si era laureato in filosofia del diritto nel 1902. Suo compagno di università era il
veneziano Oddone Ravenna, del quale frequentava tutta la famiglia, composta da un
fratello maggiore studente di medicina, Arrigo, e dalla madre, vedova, Giuseppina Le-
vi Ravenna. Arrigo e Oddone si erano laureati nel 1903, negli stessi giorni, e una sera
erano andati insieme a festeggiare l’avvenimento in un locale pubblico. Qui uno dei
partecipanti alla festa aveva avuto la balzana idea di rivelare ai due fratelli che il loro
padre si era suicidato per problemi economici. Oddone non aveva detto nulla. Tornato
a casa (abitavano al piano nobile delle Procuratie Vecchie), aveva aperto una finestra
che dava sulla calle del Capel nero e si era buttato. Un’altra versione raccontava di un
colpo di pistola. Da allora, comunque, quella finestra era rimasta sempre chiusa e resa
cieca da una vetrofania. Sandro si legò ancor di più d’affetto ai due superstiti. L’anno
dopo curerà un volume di scritti giuridici vari intitolato proprio In memoria di Oddone
Ravenna.
Tra le tante università in cui Levi aveva insegnato c’era quella di Catania. Qui aveva
avuto come allievo Ermanno il quale, evidentemente, aveva avuto fin da giovane un
particolare feeling nei confronti degli ebrei, in particolare di quelli che, caso non raro,
si occupavano di filosofia e/o di diritto, e per di più antifascisti. Scrive a Max in occa-
sione della morte di un cognato, Gaddo Glass: “la saggezza, l’equilibrio, la generosità
di Gaddo mi hanno fatto pensare tante volte alla enorme difficoltà di trovare uomini
del medesimo stampo tra i c.d. ariani”. Con l’eccezione dell’ebreo Del Vecchio, natu-
ralmente...
All’inizio degli anni Venti Ermanno è a Venezia e Sandrino lo porta a passeggiare sul-
la spiaggia del Lido. Qui incontrano la famiglia dell’amico Arrigo: la moglie e cinque
figli, l’ultima dei quali, Lea, ha quattro o cinque anni. Di sicuro il giovane filosofo non
la degna di uno sguardo. Se avesse saputo…!
Quanto sia grande questa amicizia lo si comprende da una lettera al comune collega
Renato Treves del 1946, nel quale lo informa che è stato più volte invitato
dall’Università Statale di Milano, ma che vi ha rinunciato “sia perché non venisse
commessa un’ingiustizia verso Sandro Levi, sia perché mi era sembrato che lasciare
Trieste sarebbe stata una diserzione”. Il fatto che si sia appena sposato non è, eviden-
temente, un fattore da prendere in benché minima considerazione…
[In una delle lettere di conforto Sandro Levi cita un comune amico, Rodolfo De Mattei,
anch’egli siciliano. È un personaggio che ho sentito spesso nominare in famiglia, ma
non credo di averlo mai visto. A lui, comunque, come a tutti i più cari amici, mio padre
aveva affibbiato un soprannome e con questo era quasi sempre chiamato. Pure De
1 Nel volumetto di A. Scabelloni, 5 avvocati … e 4 racconti, Catania 1941, vi è un intero capitolo dedicato
a Giuseppe Cammarata. Scrive tra l’altro l’autore: “Aneddotica su di lui? Ma occorrerebbero centinaia di
pagine.” E in questo sì che padre e figlio si assomigliano!
Mattei aveva partecipato, da lontano, alla dolorosa conclusione del concorso e conosce-
va benissimo l’astio che da quella volta Ermanno nutre per Del Vecchio, il “maestro
dalla brutta ghigna”, come lo ha ribattezzato. Così, ancora trent’anni dopo, ogni volta
che gli telefonava, le prime battute, dette con voce contraffatta imitante quella dell’ex
idolo (che morirà ultranovantenne pochi mesi prima di Ermanno), erano: “Parla il pro-
fessor Del Vecchio...”. Immancabilmente sentivo la voce – non proprio un sussurro – di
mia madre: “Ermanno, c’è quell’idiota di De Mattei...” e poi quella di mio padre che,
avviandosi verso il telefono, bofonchiava tra l’irritato, l’ironico e l’affettuoso: “Il solito
paneperso!”: questo era infatti il nomignolo, di pretta origine sicula, di cui lo omaggia-
va fin dalla giovinezza per sottolinearne forse la sbadataggine o la (apparente) superfi-
cialità.]
Del Vecchio, peraltro, non sembrò (o non volle) mai rendersi conto della “porcheria” nei
confronti di Ermanno e dev’essersi molto stupito della freddezza di quest’ultimo nei
suoi confronti. Un’autentica faccia di bronzo se, tre anni dopo, gli invia una raccolta di
suoi (orribili) versi con la dedica: “a un discepolo immemore”.
Ermanno ha invece la memoria lunghissima: trovatosi per la prima volta dopo molti
anni – nel 1951! – faccia a faccia con il suo ex maestro che gli porge la mano per salu-
tarlo, gli oppone “un brusco rifiuto”, come gli rimprovera incredulo, pochi giorni dopo,
l’amico Giuseppe Capograssi. Questi lo invita, invano, a scusarsi per il “disgraziatis-
simo incidente”, ma l’ormai affermato filosofo del diritto non ha mai dimenticato a chi
deve la più importante stroncatura della sua carriera. E, del resto, lo aveva scritto a
Cesarini Sforza più di trent’anni prima: “Con individui del calibro di Del Vecchio non
intendo più avere il benché minimo rapporto”.
1931-1937
Ermanno, che ha ormai 31 anni, sprofonda in una depressione che, col senno di poi,
può sembrare eccessiva. Per tutto l’anno seguente, l’ultimo dell’insegnamento a Mace-
rata, è un continuo arrovellarsi e, novello Orfeo, chiedersi: “Che farò? Dove andrò?”.
Medita di abbandonare la carriera universitaria e di tornare a Catania per seppellirsi
nello studio legale paterno. Ed ecco il consiglio amichevole di Cesarini Sforza: “[...] mi
dispiace quanto mi dici delle tue intenzioni rinunciatarie. Hai mille ragioni di essere
disgustato dei concorsi e di aspirare a un lavoro più redditizio di quello universitario,
ma perché decidere oggi, senz’altro, di abbandonare la strada che hai scelto e percorso
finora non per un capriccio? [...] Le facoltà sono sempre in movimento e le occasioni fa-
vorevoli si presentano quando uno meno se le aspetta. Sta di buon animo e pensa
all’Esperienza giuridica, che sarà il tuo capolavoro [...]”. E, come abbiamo visto, anche
il suo maestro degli anni pisani, Santi Romano, non manca di fargli sentire la sua sti-
ma e il suo incoraggiamento.
Di ciò viene a conoscenza l’ipocrita e maldicente Del Vecchio, che scrive all’“illustre e
caro amico” Peppino: “[...] Comprendo, certamente, il rammarico del Suo Ermanno;
rammarico che dev’essere tanto maggiore, in quanto che, se è esatto ciò che ho appreso
testè, la famigerata Commissione sarebbe stata composta da lui medesimo, in accordo
col prof. Gentile! È proprio vero che ‘on n’est jamais trahi que par les siens’! Ma, se il
rammarico e anche l’indignazione sono pienamente giustificati, mi sembrano a dirittu-
ra eccessive e fuori luogo le conclusioni che egli vuol trarre dall’accaduto: cioè niente-
meno che il definitivo addio alla carriera scientifica! [...] avrei desiderato di rileggere la
relazione dello scandaloso concorso, nella parte relativa al Suo Ermanno (la quale ve-
ramente, per quanto rammento, non parmi a lui così sfavorevole). Ma non ho potuto
averla in lettura [...] Comunque, è proprio il caso di dar tanto peso a quella relazione,
dato ciò che sappiamo? [...].”.
Ci mancava pure l’insinuazione di una ipotetica manovra di stampo mafioso: proprio
quello che ci vuole per rasserenarlo...
Ci prova Peppino, con una lunga lettera che sono costretta a riassumere. Ermanno e
Manlio si sono lamentati con lui per il reciproco silenzio epistolare, e quindi gli consi-
glia di chiarire con il diretto interessato. Nota che l’accoramento del suo primogenito si
sta trasformando in scoramento e ne segue una serie di saggi consigli su come affron-
tare la vita, sul fatto di pubblicare articoli scientifici che ricordino “la tua esistenza nel
mondo scientifico”. Ermanno si preoccupa troppo di Manlio: “Lascia che il mondo
cammini! La perpetuità amorosa è una fola, e nulla più”. Pare che ci sia un problema
di convivenza con una donna, ma l’importante è che Manlio superi l’esame per avvoca-
to. Per quanto riguarda i problemi economici di entrambi, assicura che li aiuterà “a co-
sto di qualunque sacrificio [...] finché vivrò ed avrò salute sono per voi, con voi, capi-
to?”.
Gli scrive perfino il vecchio nonno Filippo, che ha ricevuto una fotografia del nipote e
nota “l’ottimo stato di tua salute. Coraggio non te ne manca, perciò ‘SEMPRE AVANTI
CAMMARATA’”.
Ermanno decide di trasferirsi a Milano, un po’ per tenere sotto controllo il fratello “far-
fallone” (ma da che pulpito…), un po’ perché, appunto, pensa di farla finita con la car-
riera universitaria. Gli scrive Maggiore, che approva la decisione ma non è d’accordo
che abbandoni l’insegnamento perché pensa che dovrebbe ritentare il concorso.
Non c’è da sperare però che Milano, con il suo freddo, le sue nebbie e la sua bruttezza
architettonica, possa risollevare il morale di Ermanno, il quale come avvocato convive
nello studio del fratello. Del resto, con l’università poco può avere a che fare, perché si
ostina a non volere la tessera del partito fascista. Per di più, con la partenza di Max
Ascoli per l’America, è rimasto privo di un importantissimo punto di riferimento filoso-
fico e affettivo; Sandrino Levi insegna a Parma, Orazio Condorelli si tiene un po’ alla
larga, gli altri amici stanno mettendo su famiglia. E nel giro di poco tempo è morto an-
che l’amatissimo e ormai vecchissimo nonno... insomma, probabilmente è in piena crisi
esistenziale. Gli ci vorrà più di un anno per incominciare a intascare le prime parcelle
e a rendersi finalmente autonomo.
Tra i nuovi amici del periodo milanese va ricordato Antonello Gerbi, che non solo è
molto amico di Max Ascoli, ma per di più è nipote di Sandrino Levi. Hanno pochi anni
di differenza (Ermanno ne ha 5 di più), e due fondamentali interessi in comune: la filo-
sofia del diritto e la fotografia. Infatti la dedica di un saggio di Ermanno è proprio
“all’amico Antonello”.
Non ci sono molte testimonianze scritte o fotografiche di questo periodo – a parte pic-
cole e preziose istantanee dei navigli in fase di ricoprimento e un interessante episto-
lario con l’amico, collega e “avversario” filosofico Widar Cesarini Sforza – forse perché
Ermanno nel 1932 si sta preparando al concorso per la nomina a professore straordi-
nario alla cattedra di Filosofia del diritto a Siena. Lo vince come secondo della terna,
nonostante due dei commissari, Giorgio del Vecchio – che ha addirittura cercato di in-
validare il risultato! – e Benvenuto Donati, facciano mettere agli atti la loro contrarie-
tà a tale promozione, e grazie anche ai buoni uffici di Luigi Biamonti, che, sembra, gli
ha costruito una commissione d’esame “su misura”. Il fatto non serve a restituirgli un
po’ di spensieratezza, anzi. Questo è un concorso di “serie B” e non garantisce nulla,
soprattutto perché manca quella benedetta tesserina... Ed è anche l’ultimo, sembre-
rebbe. Assegnato all’Università di Messina, vi resta, prima come straordinario e poi
come ordinario, fino al 1937, insegnandovi filosofia del diritto e, come incaricato, dirit-
to costituzionale. Qui, nel ‘34 lo raggiunge una breve lettera di Maggiore, che lo sprona
a lavorare e a non lasciarsi “spadroneggiare” dal clima. Il vecchio maestro gli dà poi
suggerimenti su come scrivere un libro “un’ora al giorno”, lo esorta a lavorare, studia-
re, a fare qualche viaggio, e conclude con un saggio ma inascoltato consiglio: “viva e
prenda gusto a vivere”.
Frequenta, quando possibile, il cenacolo che si raccoglie a casa di Gentile, a Roma, do-
ve convengono adulatori e contestatori. Così scriverà all’allievo napoletano Luigi Ca-
pozzi un quarto di secolo dopo, nella copia di una lettera purtroppo rimasta a metà
proprio nella parte più importante: “Chi ha vissuto intensamente il ‘ventennio’ ricorda
perfettamente che, a parte Croce e Gentile, crociani e gentiliani militavano sia nel
campo del fascismo, come in quello dell’antifascismo: non tutti, ma certamente molti,
in perfetta buona fede, e senza secondi fini. Gentile – quante discussioni, talvolta viva-
cissime al punto che una sera Casati e Nicolini, senza parlare, ma col solo modo di
guardarmi, mi diedero del maleducato! – aveva ragione su un punto: che tutti eravamo
in certo modo responsabili di quel che accadeva [...] E su questo neanche Croce gli po-
teva dare torto [...]”.
Per via epistolare si fa un nuovo amico, anch’egli docente di filosofia del diritto, Flavio
Lopez de Oñate, e lo presenta a Sandro Levi e a Cesarini Sforza. A sua volta Lopez,
verso la fine del decennio, gli presenta Vezio Crisafulli, che da semplice estimatore di-
venterà poi molto amico di Ermanno. È del 1942 l’ultima lettera, nella quale gli comu-
nica che sta per uscire il suo libro su “la certezza del diritto”, libro che, dice, deve an-
che all’incoraggiamento di Ermanno: gliene manderà al più presto una copia, “la prima
di esse, che ti spetta di diritto”.
Ma ecco che cosa scrive di sé in un curriculum scritto una ventina d’anni dopo: “So-
pravvenuta la famosa ‘legge Starace’ che obbligava i dipendenti statali alla iscrizione
al partito unico, sotto pena di impromovibilità, il prof. Cammarata, essendo ancora
straordinario si è trovato di fronte al dilemma: o chiedere la tessera o abbandonare
l’insegnamento, perché lo straordinario impromovibile, per qualsiasi ragione, al grado
di ordinario, non poteva essere mantenuto in servizio. Ho dovuto perciò chiedere nel
1934 la tessera ‘Per Necessità Familiari’”. In un successivo curriculum, chiestogli dal
Governo Militare Alleato di Trieste durante il periodo delle epurazioni accademiche,
afferma di essere stato “uno dei non molti professori universitari che nel periodo tra il
1922 e il 1945 abbia ignorato nei suoi scritti l’esistenza del partito fascista, celiandone
con gli studenti, ed esponendosi perciò a denunzie, fortunatamente andate a vuoto”.
Sicuramente è l’unico che abbia ribattezzato Mussolini “il Truce”. (Del “Truce” e del
suo “vate” D’Annunzio Ermanno sa imitare la scrittura alla perfezione ma, onesto
com’è, non ne approfitterà mai.)
Ancora una volta due lettere di Peppino ci illuminano sulla situazione. La prima è del
gennaio 1932: vi affronta i problemi relativi al prossimo concorso, cioè fare una buona
e utile preparazione, entrare nella terna, scegliere una sede. Gli fa presente i problemi
iniziali della carriera avvocatesca. Parla poi di un “quartierino” che gli ha messo a di-
sposizione a Milano e che dovrebbe rimanere a lui “per ricevere in qualunque ora o in
qualunque tempo”, senza abbandonare “nelle ore solite, lo studio di via Bossi” [...]. E
prosegue: “Tu hai 32 anni, ma per me sei sempre il mio piccolo Ermanno, pieno di
buon cuore ma di altrettanta inesperienza e spensieratezza, se non addirittura noncu-
ranza”. Dice di aver aderito al progetto di una “stanza aggregata [allo studio legale di
Manlio] perché stimavo averti dato così quella libertà necessaria alla tua vita di stu-
dioso – disordinato [...]. Con tuo fratello, che amo come te e quanto te, dev’esserci stato
un malinteso” perché gli aveva promesso di liberarsi “senza scosse morali ed economi-
che” di tale stanza. Né d’altra parte, “il tuo sacrificio di amministratore quotidiano si
adatta al tuo temperamento e allo stato delle cose”. Peppino potrà sovvenzionare Man-
lio ancora per qualche mese, poi dovrà “emanciparsi economicamente”. Se non ce la fa-
rà, dovrà tornare a Catania: “Troverà tutto: casa, letto e studio”.
[Di questa lunga, e per alcuni versi oscura, missiva mi colpisce l’accenno al fatto che il
nonno non ritenga suo figlio un buon “amministratore quotidiano” a causa del suo ca-
rattere. Ciò è comprensibile solo in parte: è vero che Ermanno non ha mai dato ecces-
sivo peso al denaro (si definirà, qualche decennio dopo, “strafottente in materia di sol-
di”) ed era fondamentalmente un generoso, ma di sicuro non era uno scialacquatore o
uno sprovveduto: tutt’altro! Da buon mediterraneo di chiara ascendenza araba amava
la contrattazione e non si lasciava abbindolare da nessuno. Proverbiale il rituale in-
scenato quando uno dei suoi figli andava a batter cassa. Apriva il cassetto della scri-
vania – disordinatissima! – dove teneva il portafoglio e sospirava con aria rassegnata:
“Finché ci sono...”. Non ho mai capito se quel “ci sono” si riferisse a se stesso o ai soldi.
Del resto, per tutta la vita ha dovuto tenere sotto controllo le entrate (che erano esclu-
sivamente quelle di impiegato dello Stato, allora non laute nemmeno all’Università),
non solo perché aveva una moglie casalinga e due figli piccoli, ma perché, dopo la mor-
te del fratello e del padre, si era fatto carico del mantenimento di sua madre e a volte
sovvenzionava anche il nipote. Ogni mese partiva per Catania un vaglia con circa un
terzo dello stipendio.]
Sei mesi dopo la situazione non è molto diversa. Ermanno a Siena è stato “ternato”,
ma non ha vinto la cattedra. E Peppino riprende la penna: “Mio caro Ermanno, il tuo
accoramento ed il tuo scoramento non mi erano sfuggiti. Mi consenti che, malgrado i
tuoi 33 anni, io ti dia un po’ dei miei 59? Nessun consulente, medico o psicologo po-
trebbe o saprebbe farlo, in quanto io rilevo che tu rivivi sin dalla nascita la mia vita in-
teriore, costituita appunto dai malanni intimi che te pure affliggono. Essi dipendono
da un eccesso, che, per quanto non morboso, portano seco il germe dell’accoramento – e
dello scoramento. Difatti, possediamo entrambi un temperamento a sfondo sentimenta-
le, irrazionalissimo, in quanto viene acuito d’autosuggestività a... rovescio. Anziché
temperare e temprare, noi si tende ad esagerarlo. Se l’obbietto fallisce... l’accoramento
è maggiore.
Possediamo un carattere – il mio, nervoso alla superficie, il tuo, nervoso fisiorganica-
mente – con uno sfondo di bontà, talvolta iperbolicamente spinta sino all’ingenuità.
Anziché mitigarla, noi si eccede, e, smascherata la vernice, lo scoramento ci assale. Tu
sei un filosofo, ma io ritengo di essere un psicologo. Siamo sulla stessa strada: tu mi
comprendi e io ti sento. A segno che, per fenomeno sicuramente telepatico, avverto
bruschi richiami alla realtà del viver tuo. E non mi sono mai sbagliato.
Tale il tuo, tale il mio, tali i nostri difetti. Tu puoi ancora correggerli, io no, anche per
un eccesso di ipersensibilità sul tuo.
Ed allora?... Per quanto si voglia o ci si riprometta esser crudeli o cattivi col prossimo
di ambo i sessi, tanto cattivo in nostro confronto, non ci si può riuscire del tutto. Così
essendo, non rimane che attingere energie di richiamo, di volta in volta. Mi sono spie-
gato? Mi hai compreso? Ed allora strafottitene un po’ di tutto e di tutti. Se ci riuscirai,
sarai meno infelice di quanto il tuo organismo può consentirti. Ai supplementi di bi-
lancio, provvederò io! Ti abbraccio Peppino”.
E Manlio gli regala una sua foto con dedica: “Ad Angelo mio, mio angelo protettore...”.
Dell’Ermanno di questi anni ci sono poche foto: in qualcuna ha i baffi, in altre baffoni e
barbone, in altre nulla. In alcune rivela la passione per il papillon. La sua fisionomia è
quasi quella definitiva, l’adulto serio e posato gran tombeur de femmes. Molto belle so-
no due foto-ritratto in posa da egregio-prof. Una è addirittura con la pelliccia e la fa-
scia accademica: probabilmente se l’è fatta fare quando è diventato ordinario. È davve-
ro un bell’uomo e non si capisce perché non trovi l’anima gemella. Dall’amico e collega
Bruno Leoni, trasferito a Bari, riceve una lettera in cui costui dichiara di avere nostal-
gia di Messina e dice: “E facciamo giuramento di prendere moglie tutti e tre - Paolo, te
ed io - entro il 1937”. Chissà com’è andata per lo scrivente e per il non meglio identifi-
cato Paolo. Quanto a Ermanno, aspetterà ancora qualche anno. Deve però sentirsi già
molto vecchio e molto saggio, tanto da scrivere come prefazione di un suo scritto (al
pari di quasi tutti gli altri pubblicato a sue spese) questa specie di manifesto pro-
grammatico della sua vita di studioso parco di parole scritte: “Le presenti indagini
[...]vogliono essere una revisione [...] delle idee già accolte in un libro che posso ormai
considerare giovanile (Contributi ad una critica [...], 1925). Confesso di aver nutrito
una certa invidia per tutti gli scrittori di cose filosofiche ai quali riesce facile esporre i
risultati delle proprie meditazioni facendo assistere il lettore al travaglio interiore nel
quale si sono svolte: io riesco appena ad esprimere le conclusioni delle mie fatiche, la-
sciando me solo testimone di quanto esse siano state penose.
Né con ciò, intendiamoci, penso che siano da biasimare coloro che non vogliono o non
possono nascondere tutto il pathos di un’ansiosa ricerca: che è sempre, in fondo, ricer-
ca di se stessi. Quest’avvertenza [...] varrà, spero, a giustificare la magrezza scheletri-
ca dell’esposizione: che [...] aspira semplicemente a far pensare: il che non è certo mo-
desta aspirazione, né io oserei nutrirla ed esprimerla, se non avessi tranquilla la co-
scienza su un punto: quello, cioè, di non essermi affidato alla improvvisazione. Per il
resto, habent sua fata...”.
Risale a questi anni la love story con una “Rosaria”, probabilmente siciliana, di cui re-
sta un’unica, drammatica testimonianza nella lettera, scritta ma non inviata, a tale
avvocato Camillo Raboni di Parma, ritrovata settant’anni dopo in uno dei suoi libri.
Qui il giovane filosofo rivela di essersi innamorato perdutamente di una fanciulla mol-
to giovane e non del tutto convinta dei suoi e dei propri sentimenti. Ermanno chiede a
Raboni di intercedere per lui presso la ragazza, giurando di essere pronto ad aspettar-
ne il consenso anche dieci anni. Ma dieci anni dopo questa lettera nella sua vita sarà
già entrata la futura moglie…
Tra i nuovi amici conquistati a Messina tanto a suon di lazzi che di dotte disquisizioni
giuridiche ce n’è uno che diventerà, a dispetto della statura, un “pezzo grosso”, anzi
grossissimo. In quegli anni però la sua fama si deve a ben altro, come si deduce da
questa poesiola sopravvissuta nella sua prima redazione e scritta a due mani.
Con gran voglia di coire
il Leon venne a Messina
e sì baldo era l’aire
che da sera alla mattina
Ei volea prodigarsi
in assalti furibondi
(e voleva dimagrarsi)
prosciugando tutti i fondi.
Ma il vilissimo destino
le fanciulle desiate
gli soffiava e nel lettino
ei sognava le chiavate.
E zompava giù dal letto
attentissimo al rumore
ammirava il bell’aspetto
d’una coppia in pieno amore
che incurante d’ogni spia
di Leone o colleone
insegnava l’armonia
d’ogni balda posizione.
E il Leon coi piedi a terra
soffocando lo sternuto
la pistola in mano serra
senza metterci lo sputo.
E scotendo la criniera
per la prossima serata
promettevasi una fiera
solennissima chiavata.
Ma il destino ahimè! bislacco
a le belle del tRoiale
sempre alzar faceva il tacco,
verso un letto più ospitale.
E alla sera il buon Leone,
in pigiama e piediaterra,
risentiva la lezione
e giurava nuova guerra.
Passa un giorno, passa l’altro,
non coita il buon Leone,
ed essendo molto scaltro
affidavasi al segone.
finché il tren del continente
lo sottrasse a quelle pene
e portò l’incontinente
a cercar miglior [illeggibile]
“Giovannino” Leone, futuro presidente della Repubblica, non è il solo bersaglio della
goliardia professorale messinese. Ce n’è anche per un altro illustre collega, evidente-
mente tutto l’opposto del precedente. (Le strofe sono opera di ben quattro diversi “poe-
ti”.)
Mastro Allorio è quella cosa
che assomiglia a un damerino
col vestito a quadrettino
è lord Brummel redivivo.
Mastro Allorio è quella cosa
che somiglia a un prefettino
se gli chiedi un sol quattrino
se lo coglie un accident.
Mastro Allorio ha della donna
un terror davvero sacro
che lo rende santo e macro
e lo affoga nello sgob. [?]
Mastro Allorio è quella cosa
che ad un chierico assomiglia
disgraziata chi lo piglia
per legittimo marit.
Mastro Allorio è quella cosa
che la donna ha in nessun conto
ma a concedersi è poi pronto
se la dote à di un milion.
Mastro Allorio è sempre intento
a ponzar su libri e tomi
concorrenza ai grandi Nomi
ei vuol fare ad ogni cost.
Mastro Allorio in procedura
ti studiò l’impugnazione
ma se vede una “guagliona”
non sa il brando poi impugnar.
Mai contenti, questi dottissimi e virilissimi cattedratici!
A Ermanno – abituato a città come Roma, Milano, Berlino – Messina, nonostante tut-
to, sta stretta. E si dà da fare per essere trasferito.
Nell’autunno del 1937, infatti, gli arriva – grazie all’intervento di Cesarini Sforza sul
ministro dell’Educazione nazionale – il trasferimento alla Regia Università di Trieste.
Immediate gli arrivano le felicitazioni di due più giovani colleghi filosofi: Renato Tre-
ves e Norberto Bobbio. Il primo, che ha conosciuto a Milano nella cerchia di Antonello
Gerbi, gli sarà fedele e affezionato amico per tutta la vita: ci sarà anche lui a comme-
morarlo, con non poca fatica (è molto anziano, morirà di lì a un paio d’anni) nella stri-
minzita mezza giornata di chiacchiere che l’Università di Trieste gli dedica nel 1991.
Nelle stesse ore, in un’altra aula, l’intera giornata è dedicata a Vezio Crisafulli.
Norberto Bobbio, che in quel periodo insegna a Camerino, costituisce un vero enigma:
se di lui Ermanno ha conservato un numero relativamente cospicuo di lettere (dieci)
che vanno dal 1937 al 1970, è pur vero che era nota la sua antipatia nei confronti di
questo studioso, giovane e presuntuoso, che si faceva accademicamente largo, a volte, a
suon di gomiti. Le lettere di questi testimoniano invece un rapporto apparentemente
molto amichevole, con scambi di opinioni filosofiche ma perfino personali, dove non
mancano né la critica (soprattutto per la voce “Formalismo giuridico” dell’Enciclopedia
del diritto Giuffrè, l’ultimo lavoro di Ermanno, definito poco meno che incomprensibile.
E forse non a torto!) né espressioni di stima. È un fatto, però, che nella ben pubbliciz-
zata autobiografia bobbiana il nome di Cammarata non compare mai, fatto tanto più
strano in quanto non ha esitato, all’occorrenza, a chiedergli aiuto per la sua carriera.
Bobbio scrive inoltre di aver molto frequentato Piero Calamandrei, Guido Calogero,
Renato Treves, Luigi Cosattini (friulano, laureato nell’ateneo giuliano) e Benedetto
Croce. Le stesse frequentazioni, e negli stessi anni, di Ermanno. Che improba fatica
dev’essere stato “dimenticarsi” di lui, “rimuoverlo” al pari del suo passato di giovane
universitario fascista!
Del resto, pur essendo entrambi di formazione liberale, erano diversissimi: il più gio-
vane scriveva in modo chiaro e comprensibile, l’altro era oscuro, involuto, fin troppo
essenziale. L’uno amava Kelsen, l’altro, come abbiamo visto, dopo averlo amato, arrivò
a disprezzarlo. L’uno era fascista per convinzione, l’altro antifascista viscerale. Nor-
berto aveva un po’ sgomitato per trovare il suo posto al sole universitario, Ermanno
era ricorso soprattutto alla sua intelligenza, alla sua preparazione e alla fama di one-
stissimo.
Insomma, si detestavano. O meglio: Ermanno detestava Norberto. Eppure… eppure si
scrivevano, anche se non risulta che nell’archivio del secondo vi siano lettere del pri-
mo. E, infatti, chi parla di Bobbio non parla mai di Cammarata. E viceversa.
1937-1952
“[...] egli venne tra noi che ancora l’Università di Trieste non era Università degli
Studi ma soltanto di studi commerciali. Era il tardo autunno del 1937. Egli non era
ancora quarantenne. I suoi documenti recavano ancora il volto incorniciato da folta
barba. Accadde che io fossi lì nell’atrio della vecchia sede ad incontrarlo e ad accom-
pagnarlo al Rettorato. Per tanti anni e da allora ci legò consuetudine fraterna. [...]”
Carlo (Carletto) Amigoni ricorda così, un anno dopo la morte di Ermanno, l’impatto
dell’amico siciliano con lo scheletrico ateneo triestino.
Persone più diverse non potevano incontrarsi e amarsi. Tanto quanto, a quei tempi,
era alto, “visibile”, ciarliero, socievole Ermanno, tanto piccolo, profondamente pessi-
mista – e anche un po’ lamentoso e brontolone, com’è tipico dei suoi concittadini – era
Carletto. L’uno antifascista viscerale, l’altro addirittura assurto ad alte cariche del
Fascio locale! È proprio vero che gli opposti si attraggono... soprattutto quando hanno
in comune un’intelligenza e una generosità superiori alla norma, nonché un’abilità
oratoria che li renderanno, in quel torno d’anni, due temibilissimi “principi” del Foro
triestino.
Dunque, Ermanno si trova catapultato nel profondo Nordest, lontanissimo dai genito-
ri ma più vicino all’amato fratello. La città, unita all’Italia da meno di vent’anni ma
che si proclama a voce fin troppo stentorea “italianissima”, non ha ancora trovato una
sua identità: da unico porto dell’Impero asburgico è diventata uno dei molti porti ita-
liani e le sono stati sottratti molti degli antichi privilegi. Stenta perciò a costruirsi
una sua personalità e un suo ruolo nella nuova patria e nel mondo. Città diventata di
confine, vede crescere il problema della minoranza slava, che rappresenta invece una
buona percentuale del mondo del lavoro, soprattutto di quello agricolo, cantieristico e
portuale, senza trovare (o forse senza voler davvero cercare) una soluzione per una ci-
vile convivenza. Mussolini (che la visiterà di lì a pochi mesi) ha già messo in azione il
“piccone demolitore”: la città vecchia, luogo di osterie, postriboli, malattie veneree e
tubercolosi, sporcizia e miseria, sta sparendo. Al suo posto si innalzano pochi ma orri-
bili edifici piacentiniani che ancora oggi convivono guardando in cagnesco quelli anti-
chi.
Per prima cosa il nuovo immigrato compera una pianta della città e la percorre –
impugnando come al solito almeno una macchina fotografica – da solo o in compagnia
di colleghi e amici di colleghi che ben presto ha conquistato per quel parlare lento, de-
cisamente nasale, che è il massimo degli stereotipi dell’uomo del Sud ma che veicola
tutta la sua intelligente e umana bonomia. Camminare per ore a grandi passi – fuori
o dentro casa, chiacchierando o meditando di filosofia – è un tratto tipico di Ermanno,
e tale esercizio sarà per tutta la vita l’unica forma di sport praticata.
In fondo, Trieste deve piacergli molto, se l’anno dopo rinuncia a candidarsi alla catte-
dra di Filosofia del diritto di Padova, occupata poi da Bobbio.
Un altro aspetto positivo è il più frequente incontrarsi con Sandrino Levi, che a Trie-
ste viene spesso a trovare l’amico Arrigo Ravenna, pediatra affermato e padre di cin-
que figli ormai adulti. Sandro, a sua volta, gli fa conoscere gente che orbita in campi
assai diversi da quello universitario.
Sembra proprio che la vita finalmente cominci a sorridergli. Tra l’altro, le donne trie-
stine hanno fama di esseri libere e indipendenti anche in campo sessuale e lui non si
tira certo indietro, tanto che in breve si fa una notevole fama di “cotolèr” (donnaiolo o
meglio, alla lettera, “gonnaiolo”). E a Trieste il beffeggiante di Messina diventa bef-
feggiato, anche se, a onor del vero, con molta più classe e molto più affetto (la locuzio-
ne “amico prima Angelo che Ermanno” la dice lunga sui sentimenti che ha suscitato in
molti).
È infatti del 1939, anno primo della nuova facoltà di Giurisprudenza nella quale inse-
gna anche lui, questo ritratto in versi a rima baciata.
La Facoltà giuridica triestina
nell’anno accademico 1938-39/XVIII
Dedicato all’amico prima Angelo che Ermanno
(con divieto di riproduzione)
Nella nuova Facoltà
Molto bene non si sta:
Quasi sono più i docenti
Che gli alunni diligenti.
Le lezioni in tre aulette,
Pochi libri in due stanzette,
Nelle quali tu non fai
Che assistere al via vai.
Nella nostra Facoltà
Molto bene non si sta:
Tanto è ver che la metà
Spesso a Roma se ne va.
Viaggia sempre il piè veloce,
Scappa via il Consigliere,
E lo stesso “effe effe”
Se ne ride e si fa beffe.
Nella nostra Facoltà
Molto bene non si sta.
C’è la barba del Rettore
Che a qualcuno fa terrore.
C’è il Guiscardo che presiede
Stando sempre fuori sede,
E fa spesso a padre Dante
Fremer l’ossa tutte quante.
Nella nostra Facoltà
Molto bene non si sta.
Ma ci sono degli amici
Con cui passi dì felici.
C’è l’Achille gaio e nano,
C’è il Carnera goriziano,
Lo ieratico Piolone
E Peppino il distrattone.
C’è l’olimpico Virgilio
Con quel fiero suo cipiglio;
C’è il Renato amico bello
e il serissimo Lionello.
C’è il Barbero piemontese,
Mario Viora ognor cortese,
Dongiovanni Cammarata,
direttore e camerata.
Poi ci son gl’incaricati,
Che non van dimenticati,
Col Battaglia della razza
E un timone di gran stazza.
C’è un Amleto sano e baldo,
C’è il gerarca Teobaldo,
il tascabile Barbieri
Ed un conte dei più fieri.
Nella nostra Facoltà
Molto bene non si sta;
Ma d’accordo coi colleghi
Te ne ridi e te ne freghi.
Poi verrà il trasferimento,
Che ti porta via col vento,
Che lontano ti fa andare
Da Trieste e dal suo mare.
Ed allora tu vedrai
Che dovunque vi son guai;
Che la vita è una tragedia
E più spesso una commedia.
L’autore, che “vuole, per ragioni evidenti, mantenere l’incognito”, si firma “Uno dei
dodici”, dal momento che tanti erano gli... apostoli che avevano composto il primo
Consiglio della Facoltà.
Vediamo di ricostruirne i nomi, ove possibile: il rettore barbuto è Manlio Udina, il
primo dei nemici che Ermanno si farà anni dopo per la questione dell’italianità di
Trieste, nonché per il fatto di avergli ribattezzato la villa che si è fatto costruire a
Barcola con proventi extrauniversitari “villa Propina”. “Achille” è Donato Giannini;
“Effe Effe” è il “facente funzione di rettore”, mentre il preside “Guiscardo” è Roberto
Scheggi; “Carnera” dovrebbe essere Giuseppe Bettiol, “Piolone” è Andrea Piola, “Pep-
pino” Giuseppe Branca, “Virgilio” Andrioli, “Renato” Balzarini, “Lionello” Rossi, Do-
menico “Barbero”, Mario Viora futuro preside della facoltà, futuro rettore e fraterno
amico del “Dongiovanni” (“camerata” nel senso etimologico, non in quello politico!); e
poi gli incaricati “Amleto” Loro, “Teobaldo” Zennaro e il “conte” Mario De Dominicis.
Del ‘38 è una grande fotografia che vede un gruppo di quasi coetanei con il calice alza-
to in un brindisi all’interno della “Locanda Cimetta” (in seguito, pomposamente, “Ba-
gutta triestino” e attualmente ristorante cinese), la cui pubblicità recita: “Si mangia
bene – si spende poco”. Ermanno è proprio lì al centro e con il viso privo di barba e
baffi sembra addirittura più giovane.
Non se li farà più ricrescere, quasi presago che la futura moglie dichiarerà sempre:
“Se lo avessi conosciuto con la barba e i baffi non avrei mai potuto innamorarmi di
lui”.
Quanto al “divieto di riproduzione”, il tempo che è trascorso da quella volta – più dei
canonici settant’anni – giustifica ad abundantiam la mia disobbedienza.
[Quante volte, negli ultimi due anni della sua vita, seduta di fronte a lui nel fumosis-
simo studio, gli chiedevo: “Papà, perché non ti fai ricrescere la barba?”. E lui, sorri-
dendo, rispondeva: “Adesso no, ché è ancora pepe-e-sale e non è bella. Quando sarà
tutta bianca...”.]
La foto da Cimetta è preziosa per datarne un’altra che, in autoscatto, mostra Erman-
no, dotato di imprescindibile grembiule da colf, alle prese con fornelli e pignatte. Non
è un falso storico. In cucina ci sa fare, glielo riconoscono tutti, ma dal giorno del ma-
trimonio si ritira a vita privata: la concorrenza con la moglie, a sua volta ottima cuo-
ca, lo distrarrebbe dai suoi diletti strologamenti filosofici. Il particolare curioso è che
una foto praticamente identica (invece dei fornelli c’è il lavandino) è stata pubblicata
in un’autobiografia del filosofo Paul K. Feyerabend. “Il Sole 24 ore” la ripropone con la
didascalia “Il ‘filosofo al lavoro’, la sua foto preferita”. Evidentemente la cucina è il ri-
poso del guerriero dei pensatori.
Tra le prime conquiste triestine c’è una bella donna di agiata famiglia, sua coetanea,
sposata e con un figlio, la quale, tra le altre cose, lo usa come fotografo quando decide
di fare la modella indossando, nel giardino della sua villa di Opicina, gli abiti di Anita
Pittoni, allora all’apice della sua fama di artista-artigiana. Bella la modella, belli i ve-
stiti, bellissime le foto (alcune approdate fin nel Nuovo Mondo)…
Il 1939 scorre via così, tranquillamente. La città è, ai suoi livelli più alti della cultura
e dell’industria, praticamente judenrein: a partire dall’autunno dell’anno precedente,
via gli ebrei dalle scuole, dalle università, dai ministeri, dagli impieghi più umili e da
quelli dirigenziali, dalle banche, dalle assicurazioni, dagli ospedali. Del resto, così è
accaduto in tutta Italia, dalle Alpi a Capo Passero.
Sandro Levi, a Parma, è una delle migliaia di vittime di quest’assurdità. Scrive a Er-
manno: “[...] Sono calmo e sereno; la mia coscienza (tutt’altro che elastica) non mi
rimprovera nulla. Aspetto con tranquillità gli eventi, rammentando le grandi parole
platoniche che val meglio patire, che non fare, ingiustizia. Alle amarezze [...] ho due
grandi conforti: le prove di amicizia, che mi giungono da molti (noto, a titolo di onore,
perché nelle ore difficili si saggia la tempra del metallo, due siciliani: tu, mio carissi-
mo Ermanno, ed il mio vecchio Mormino; ma parecchi altri si sono fatti vivi, come
l’ottimo Calamandrei, e perfino S. E. Benini, che non vedo da trent’anni!); altro con-
forto, il lavoro scientifico, che – pare impossibile – riesce ad appassionarmi. [...] ‘Non
ridere, non lugere, sed intelligere’. E – passando dal latino di Spinoza al... meneghino
– tiremm innanz...“.
Il suo amico Ravenna, in quanto combattente decorato della Prima guerra mondiale, è
invece un “discriminato”: può infatti continuare a esercitare (ma solo a favore dei cor-
religionari). Lea, la figlia più piccola, deve sbrigarsi a dare gli ultimi esami e la tesi,
se vuole laurearsi, altrimenti... E infatti si laurea in prima sessione in economia e
commercio con uno studio sui consumi della famiglia media europea, avendo per rela-
tore quel Luzzatto Fegiz che qualche anno dopo a Milano fonderà la Doxa.
Poiché l’insegnamento universitario gli lascia molto tempo libero, Ermanno vorrebbe
trovare un altro lavoro che gli consenta di raggranellare qualche soldo da mandare al-
la madre che ormai, persa la speranza di far ragionare il marito (da cui è ufficiosa-
mente separata da anni), dipende in buona parte dai figli. Prova, con una presenta-
zione di Luigi Biamonti, a proporsi come consulente della Confederazione degli indu-
striali triestini, ma per ben due volte gliene viene risposta negativa. Comunque sta
già lavorando nello studio di Carlo Amigoni.
Durante l’estate, di sera, va spesso sul lungomare di Barcola a prendere un po’ di fre-
sco e a... lustrarsi gli occhi: nei bar e lungo il nuovissimo viale Miramare la meglio
gioventù locale ama fare lo struscio e mettere in mostra l’abbronzatura. Una sera, nel
déhors della gelateria Pipolo scorge, tra due coppie di una certa età, una ragazza poco
più che ventenne, compostamente seduta ma con l’aria un po’ annoiata. È proprio il
suo tipo: occhi e capelli neri, ben vestita, formosetta, lo sguardo sveglio. Ma chi sarà?
Quando la fanciulla se ne va, in compagnia di quelli che ne sono evidentemente i geni-
tori, decide di seguirla. Sale sullo stesso tram, scende con loro e guarda in quale por-
tone di via San Lazzaro s’infilano. Poi va a vedere i nomi sui campanelli: dott. prof.
Arrigo Ravenna. L’amico veneziano di Sandrino Levi! Quando si dice la combinazione.
Chissà se in quel momento si ricorda della passeggiata di quasi vent’anni prima sulla
spiaggia del Lido di Venezia …
Alla prima occasione s’informa discretamente presso l’amico il quale, ben conoscendo-
ne le abitudini non proprio monacali, gli dà sì i ragguagli richiesti – la fanciulla, che si
è appena laureata, ha un’ottima reputazione – ma probabilmente lo mette anche in
guardia: attenzione, Lea ha avuto un’educazione puritana e severissima, non le si co-
noscono flirt di sorta, è guardata a vista... insomma il genere opposto delle signorine
che è uso frequentare il focoso Ermanno. Che non fa una piega: se è così, pazienza.
Non ha nessuna voglia di impegnarsi in un legame serio, lui. E poi, forse, c’è ancora in
ballo la famosa Rosaria…
E riprende la solita vita: l’università, lo studio legale, le serate con gli amici ecc. ecc.
L’autunno del ‘39 porta una buona nuova da Milano: Manlio, che si è sposato con una
donna un po’ più anziana di lui ma di ottima famiglia, affettuosa e di polso, annuncia
al fratello che sta per diventare padre. È una delle pochissime lettere del fratello che
Ermanno ha conservato, ed è scritta a due mani. “Mio caro Ermanno, pare accertato
che Natalia sia incinta, quindi mi affretto a dartene notizia. La principala ne è con-
tenta, io... speriamo bene. Tanti bacioni Manlio. Ci sono novità?”, e sotto: “Caro Er-
manno, confermo la notizia di Manlio e speriamo sia un piccolo Cammarata. Ti ab-
braccio con affetto Natalia”.
La domanda di Manlio non è retorica: tutti si chiedono quando Ermanno si deciderà a
fare il grande passo. Qualche mese prima l’amico e collega Nino Levi, che evidente-
mente lo conosce bene, gli ha scritto da Cambridge: “Sta bene che tu sfoghi i tuoi ar-
dori con le triestine – questo prova che le mie notizie non erano così infondate come
credevi i primi giorni. Ma prima di andare all’altro mondo, ti dissi, ti volevo vedere
accasato. Ora ci sono andato (o venuto) e più che mai ti vedo come perfetto marito.”
Addirittura, quando era in Italia, gli ha presentato una certa signora DF e non capi-
sce perché non gli piaccia, “a meno che tu non sia come de Filippo della commedia”.
Pare che costei sia la figlia di un generale che vedrebbe molto di buon occhio un gene-
ro siciliano. Torna alla carica, il caro Nino: il generale, scrive, “sta nella villa deserta –
novello Re Lear – invoca un Ermanno che si è lasciato riprendere dalla sua vocazione
postribolare”. Spera che tale ritorno di fiamma sia soltanto “il congedo dalla vita ga-
lante e che sarai lo sposo modello che ho vagheggiato. Prima di andare all’altro mondo
(o nel nuovo mondo) voglio vederti accasato, te l’ho detto mille volte!”. Lui invece vive
benissimo senza donne (che nell’austera Cambridge, peraltro, non ci sono). Emigrato
a New York a causa delle leggi razziali, che lo hanno privato della sua cattedra a Ge-
nova, morirà lì nel 1942.
Nel 1940 scoppia la guerra, ma buona parte dell’Italia pare non esserne consapevole e
tutto sembra procedere nel solito modo. Ermanno, antifascista e anticomunista di-
chiarato, continua a vedersi – e a farsi fotografare – con gli amici, anche quando o-
stentano fiammanti divise da gerarchetti di provincia. Tutti sanno che ha ribattezzato
il Duce “il Truce”. Per molto meno altri sono stati sbattuti a Ventotene! Molti si sono
sposati e lui inizia a diventare lo “zio” dei loro figli (chiamare “zio, zia” gli amici dei
genitori è una vecchia e immortale abitudine dei triestini). Forse incominciano a scar-
seggiare le occasioni, forse incomincia a intuire che la guerra durerà a lungo, al con-
trario dei genitori, i quali chiedono anche a lui di dar loro un nipote; Linda gli scrive:
“[...] che [io] possa prima di morire saperti con una buona compagna, possa provare
per te il riposo che provo quando sento che Manlio è voluto bene dalla moglie!”. Ormai
ha passato i 40 e la solitudine comincia a pesargli. Chissà che fine ha fatto la piccola
Ravenna, che non ha più visto da quella sera sul lungomare di Barcola... bah, meglio
non pensarci...
Il ‘41 comincia con le prime restrizioni imposte dal conflitto e la partenza dei soldati
per il fronte russo. L’Italia è stata sconfitta in Africa, l’Inghilterra e la Francia solleci-
tano l’intervento degli Stati Uniti contro la Germania. Ermanno, che è arrivato a
Trieste con una mentalità da liberale europeista ma ha scoperto il conflitto etnico (e
culturale) tra slavi e triestini, va in crisi, anche se continua a tenersi fuori dall’agone
politico, sia quello ufficiale sia quello clandestino e antifascista. È da cinque anni che
non pubblica nessun lavoro scientifico e non sembra averne alcuna voglia.
Un mattino di mezza estate sale sul tram che va dal centro a Barcola e tra la folla
scorge la piccola Ravenna che, armi e bagagli, con le amiche sta andando a fare il ba-
gno sulla scogliera.
“Permette, signorina? Sono Ermanno Cammarata, un amico di Sandrino Levi. Mi ha
detto di chiederle di portare i suoi saluti a suo padre...”. Che marpione! Sa che il nome
del grande amico del padre, che anche lei conosce benissimo, è l’unica arma a sua di-
sposizione per vincere la diffidenza della ragazza e lo usa senza scrupoli. Infatti a quel
nome Lea abbassa le difese e... inizia la conversazione. La prima di una lunga serie,
perché da quella volta s’incontrano spesso “per caso”. Sandrino decide di far conoscere
l’amico siciliano ad Arrigo: i due s’incontreranno subito sul terreno delle sigarette,
perché entrambi sono fumatori accaniti, e su quello della massoneria. Ma non succede
nulla. Ermanno e Lea “si parlano”, ma non debordano mai da un rigorosissimo e for-
male “Signorina?” “Professore...”. I sentimenti sono duri a nascere quanto a morire, a
volte. Del resto, come si fa a capire se si piace all’uomo che ci piace quando costui se
ne esce con frasi del tipo: “La mia prima moglie è la macchina fotografica”?
Un giorno Lea torna a casa un po’ in ritardo e per giustificarsi davanti allo sguardo
interrogativo della madre e delle di lei cugine – Maria e Virginia Ascoli, nubili ma non
ingenue – sbuffa: “Ho incontrato il professor Cammarata, che mi ha attaccato uno di
quei bottoni...”. E Maria, poetessa delicata e ricca di humour: “Ah! Te vedarà che tra
qualche tempo non te dirà più ch’el te gà ‘tacà un botòn...”. Non sono state tramandate
né la reazione di Lea né quella di sua madre. Anche perché, se è vero che il professore
è un gran chiacchierone, è altrettanto vero che la signorina non è quel che si dice una
povera muta.
Nel frattempo, di amico in amico, Ermanno ha conosciuto il fratello di Lea, Ezio, sbat-
tuto fuori dall’esercito dalle leggi razziali, e Gaddo Glass, il marito della sorella Elsa,
proprietario di un’industria di legname. Ha così modo di farsi apprezzare e benvolere
da quelli che un giorno potranno essere i suoi alleati nei confronti del professor Ra-
venna, e nello stesso tempo si fa un’idea chiara della famiglia nel suo insieme.
La sua vita ha assunto ritmi da vero anonimo impiegato dello Stato. Di questi primi
due anni di guerra non si è conservato nulla, né foto, né lettere né documenti. Anzi,
foto di guerra non ne scatterà mai. Il ‘43 è invece un anno ben più caotico. Ermanno è
stato eletto preside della facoltà di Giurisprudenza, nella quale insegna Filosofia del
diritto e Dottrina dello Stato. Dai registri delle lezioni si deduce che ha pochi studenti,
un po’ per il fatto che molti sono stati richiamati o sono latitanti, un po’ perché evi-
dentemente le sue lezioni richiedono un Q.I. leggermente superiore alla media. Tanto
che a volte è costretto a scrivere: “Lezione non tenuta per assenza di studenti”, “As-
senza totale di studenti”, e la cosa non sembra turbarlo affatto: l’importante è avere
uno stipendio sicuro e il tempo per continuare a elucubrare. Non turba neppure il ret-
tore Mario Viora, che controfirma i registri ed è diventato uno dei grandi amici di Er-
manno.
Appare pertanto preziosa questa solitaria testimonianza di un suo ex allievo e suo
conterraneo (anzi, come diceva con una buona dose di autoironia, “conterroneo”), Do-
menico Maltese, uomo di straordinaria finezza e bontà: “Alla chiarezza del docente era
pari la cordiale apertura dell’uomo. Mi riceveva talvolta, di sera, con la semplicità di
un amico, nel suo studio, sito in una delle minuscole e gelide stanze della vecchia sede
dell’Ateneo triestino dov’era il suo studio. Stavamo seduti con i cappotti indosso... Gli
rivolgevo domande per avere chiarimenti sul fondamento ultimo della sua dottrina,
con particolare riguardo al pensiero di Benedetto Croce. Ne avevo sempre esaurienti
risposte. ‘Che cosa sono le sciagure terrestri e le tempeste solari, la velocità della luce
e l’infinito delle galassie, di fronte al sorgere di una coscienza?’, mi chiese a un tratto,
durante uno dei nostri colloqui. Nello stesso tempo si arrotolava, con rapidità straor-
dinaria, una sigaretta... Non credeva nel nozionismo. Seduto in cattedra, con la sciar-
pa al collo e le mani inguantate per il gran freddo, sollevava l’indice all’altezza
dell’orecchio, e ripeteva dalla parte opposta il medesimo gesto, per spiegare come le
nozioni entrassero e, con la stessa facilità, uscissero dal patrimonio intellettuale dello
studente. Perciò, all’esame, dopo avermi chiesto su quali libri avessi studiato, mi pose
la più semplice delle domande: ‘Che cosa ne ha ricavato?’. ‘Acqua fresca’ usava ripete-
re di molte, inconcludenti definizioni del diritto rimaste famose nei secoli.
Era l’inverno 1941. Quando uscivo, nel buio della città oscurata, scorgevo soltanto le
luci remote nel cielo notturno della tragedia. E quando da questa fui direttamente co-
involto, portai con me alcuni libri, indicatimi durante i nostri colloqui. Li avevo ancora
con me nell’avventuroso ritorno. Per quarantacinque anni, nella mia vita di giudice,
non me ne sono mai separato. Di ciò, pure, sono debitore al Maestro.”.
L’8 settembre del ‘43 pone fine a molti sogni e speranze degli italiani. Anche a quelli
di Lea che, emula del pius Aeneas, scappa da Trieste con gli anziani genitori stravolti
dalla paura: dal loro appartamento all’ultimo piano di piazza Dalmazia 2 hanno visto
arrivare le truppe tedesche e hanno capito (finalmente) che la “discriminazione” elar-
gita dal regime fascista è meno che carta straccia. Saranno quasi due anni di fuga, di
paura, di delatori e di benefattori, di fame... solo ogni tanto sarà possibile scriversi:
“Gentile signorina...”, “Caro professore...”
Anche all’università regna il caos, ma i filosofi e i giuristi non perdono la testa: che co-
sa opporre ai tedeschi che hanno inglobato Trieste nel Küstenland e ne vogliono fare
una colonia tedesca, per di più germanofona? Niente meno che una facoltà di Lettere,
creata a metà novembre (su idea di Viora), ma il cui atto costitutivo viene retrodatato
al 13 settembre, cioè nei giorni del “regno di nessuno” tra la fuga del Re e della sua
corte da Roma e la nascita della Repubblica Sociale. Alla prima occasione tale docu-
mento viene esibito al generale (tedesco) della piazza, che fa buon viso a cattivo gioco.
Ma tra i firmatari dell’atto c’è anche il nome di Ermanno. Il buon Carletto gli dice:
“Ormai neanch’io posso più aiutarti: vattene al più presto”. E l’amico obbedisce. Senza
neanche poter prendere le sue carte dalla “gelida stanza” di via dell’Università 7, sale
sul treno che va a Milano e si rifugia dal fratello. In una città così grande gli è più fa-
cile mimetizzarsi e, soprattutto, può continuare l’attività di avvocato nello studio di
Manlio. La tranquillità dura poco. Pochi mesi dopo sfollano tutti a Brienno, sull’altro
ramo del lago di Como, dove la famiglia di Natalia ha una bellissima villa proprio sul-
la riva.
[Negli anni ‘50 siamo stati un paio di volte, d’estate, tutti insieme ospiti di questa bel-
la costruzione a picco sulle acque lacustri, scure e gelide. Ricordo i giochi (e le baruffe)
con mio fratello e con il cugino Peppinello, un enorme “Ercolino-sempre-in-piedi” di
plastica gonfiabile e un altrettanto gigantesco pallone di plastica colorata, l’albero di
fichi che arrivava fino al balcone del secondo piano e Manlio junior che aspettava di
sotto, con aria non proprio furba – aggravata da un paio di orrendi occhiali da astig-
matico – che un’anima pia gliene facesse cadere uno in mano.]
Ma anche Viora non se la passa bene: prevedendo di dover a sua volta scappare, no-
mina a fine novembre un sostituto: il prorettore Giorgio Roletto, e poi, nel maggio suc-
cessivo, se la dà a gambe (ufficialmente: si dimette dalla carica).
Il biennio ‘43-45 è sicuramente il peggiore vissuto dalla città nel corso della sua storia.
I rastrellamenti degli ebrei si sovrappongono a quelli degli antifascisti, dei partigiani
e degli slavocomunisti.
Ermanno si guarda bene dal rimettervi piede. Anzi, per coprirsi le spalle a livello
amministrativo, fa in modo di ottenere un certificato ufficiale del Ministero
dell’educazione nazionale (dove conta numerosi amici e conoscenti) con il quale “tenu-
te presenti le precarie condizioni di salute del Professore Angelo Ermanno Cammara-
ta dell’Università di Trieste, condizioni che non gli consentono di affrontare un viag-
gio di fortuna, si consente che il medesimo sia aggregato” all’Università statale di Mi-
lano, dove “potrà svolgere, in caso di necessità, un corso parallelo presso codesto Ate-
neo”.
Ma a Trieste la sua è un’assenza presente, come testimonia una lettera tanto affet-
tuosa quanto sgrammaticata inviatagli da Piero Cimetta, il proprietario dell’omonima
locanda, del quale evidentemente era diventato consueto e amichevole avventore:
“Trieste 15 agosto 1944. Egregio signor prof. Ermano Camerata. Anzitutto Vi debbo le
mie scuse, per non aver risposto mai alle vostre gentili notizie, aspettando sempre un
Vostro ritorno, ma purtroppo la Vostra salute non lo permise. Ora l’amico Zampagni ci
informa che Vi siete ristabilito ed in più che avete finalmente potuto avere notizie dei
Vostri genitori, tutto questo ci fà molto piacere. Nella speranza che questo stato di co-
se passi molto presto e ci dia la possibilità di vivere questi pochi anni che ci rimane in
pace e con più soddisfazione. Quì da noi abbastanza calmo. Novità nel nostro eserci-
zio, abbiamo abolito la cucina fino a tempi migliori. Nella speranza di presto abbra-
ciarvi Vi salutiamo caramente unitamente alla famiglia di Vostro fratello. Resta af-
fmo Piero”. Il resto del foglio è riempito da frasi di saluto di vari amici-avventori dalle
firme incomprensibili. Non è difficile immaginare il retroscena: una sera di ferragosto
in una città ammutolita e affamata dall’occupazione nazista. Per ingannare l’attesa e
la fame si fa la conta degli assenti e qualcuno propone: “Perché non scriviamo a Er-
manno?”...
Il mese prima gli è arrivato addirittura un invito in versi, firmato da un certo “Pepi” –
probabilmente Giuseppe Branca, l’autore del già ricordato ritratto della nuova facoltà
di Giurisprudenza – che lo esorta a tornare:
Se pur suonano le trombe
qui non piovono le bombe
e nell’aria tanto aprica
non si vide ala nemica.
Tutto è triste e tutto è muto
nel giuridico istituto
poi che il nostro buon Ermanno
scappò via pieno d’affanno!
I maligni voglion dire
che temea del serbo l’ire
mentre tutti invece sanno
che non teme bombe Ermanno!
Torna dunque ai patri lari
tra i giuristi tanto cari
che si storcono pe’ mali
in quei lor vecchi scaffali…
Tal richiamo non capisci?
Forse invece preferisci
passar ora più gioconda
con la dama tutta bionda!
Qual che sia la tua brama
quando inver Trieste s’ama
s’abbandona anche Milano
ove pace cerchi invano!
Colognati qui presente
(uomo saggio che non mente)
sottoscrive quanto scrivo
ad Erman non più giulivo!
Meno di due mesi dopo, il 10 giugno, Trieste conoscerà il primo, vero e sanguinoso
bombardamento che spazzerà via quella sua “aria tanto aprica”…
A questi guai di ordine politico-logistico si aggiungono, ai primi di aprile del 1945, la
notizia della morte del padre al termine di una breve ma grave malattia e il dolore di
non averlo potuto salutare un’ultima volta. Gliene resta solo una foto abbastanza re-
cente scattata nel suo “predio ogninese” (l’orto di Ognina, in riva al mare, dove Peppi-
no trascorre il tempo libero coltivando soprattutto le rose). Sul muro che circonda la
proprietà c’è una targa che recita: “Rose e spine: così la vita”. Ermanno si affretta,
compatibilmente con lo stato delle ferrovie italiane di quel momento, a tornare a Ca-
tania per stare vicino alla madre.
Sopraggiunge poi il ciclone dei quaranta giorni dell’occupazione slava e la successiva
consegna della città agli angloamericani. Finalmente anche la famiglia Ravenna può
tornare a Trieste. Ma l’appartamento è stato completamente ripulito dai tedeschi e in
quel momento è occupato dai soldati neozelandesi. Fatti valere i suoi diritti e sfrattati
i gentili ospiti, Lea, che vi è arrivata prima dei genitori, procede a una sommaria ripu-
litura: tra l’altro scopre che uno dei pochi mobili non trasformati in legna da ardere è
riempito fino all’inverosimile di... rotoli di carta igienica. Una benedizione, anche se in
quei giorni è più facile morire di fame che di indigestione.
A luglio a Ermanno arriva una lettera (che pare quasi un bollettino di guerra) da par-
te di un fido bidello dell’università, Bruno Walderstein. La trascrivo integralmente
con in nota alcune precisazioni:
“Trieste 26-VII-1945 / Egregio Signor professore, per prima cosa vi faccio le mie più
sentite condoglianze per il grave lutto che ha colpito la Vostra famiglia. Ho sentito la
triste nottizia dal prof. Luzzatto,2 che è rittornato da Roma.
Noi qui eravamo molto in pensiero per Voi, perché per radio si sentiva che a Como e-
rano dei combattimenti piutosti forti, e dato che anche qui da noi, si aveva delle gior-
2 Si tratta di Pierpaolo Luzzatto Fegiz..
nate infernali, combattimenti per tutte le vie, e a Como che è più piccola, si pensava
che sara stato peggio di qui, cosi la venuta del prof. Luzzatto, ci ha tranquillizzatto.
Qui all’Università e stato una baraonda, le truppe inglesi, hanno fatto caserma, noi
non si poteva venire per diverso tempo, nella Vostra stanza dormivano dieci soldati,
rimanevano qui 5 o 10 giorni e poi venivano altri, cosi che hànno rovinato tutta
l’Università, delle vostre cose hanno portato via quel scattolone, e gettato a terra una
parte di ciò che era dentro, della vostra scrivania hanno rotto la serratura per vedere
cosa era dentro, io non so se avete lasciato qualcosa di valore, ma se c’era ora non sara
più di certo, nei vostri cassetti, è delle vostre carte, e cartucce di rivoltella, e di mo-
schetto,3 insomma hanno fatto un desio,4 e portato via diversi testi, dell’Istituto di
Medicina legale hanno preso metà dei testi, e poi altre cose che Vi racconteremo
quando verrete qui. Ora dopo tanto siamo liberi, però a qualcuno dispiace, pensa non
stava mai cosi bene come in questo tempo.5
In questo mese si aveva di fare gli esami, ma poi un articolo del giornale, diceva che
gli studenti veranno esaminati dai prof. fascisti, cosi e stato rimandato tutto a tempo
da destinarsi, poi hanno fatto le ellezioni per un comissario al posto del Rettore, che
ha dato le dimissioni, i due elettori6 erano il prof. Fegiz, e il prof. Satta, quest ultimo
ha vinto con 6 voti in più, cosi la parte avversaria, cioe tutti quelli della facoltà di E-
conomia, erano molto arrabiati, chi diceva che era meglio Luzzatto, e chi che hanno
fatto bene a ellegere il prof. Satta,7 e ancora ora non si sa nulla di certo perché do-
vrebbero avere il consenso dalle autorita alleate. Intanto noi siamo con lo stesso sti-
pendio di prima, con le tessere non danno più nulla, e si deve vivere tutto a borsa ne-
ra, che ora e libera,8 cosi pure le calzatture, ma un paio di scarpe in pelle e cuoio co-
stano settemilla lire, e i viveri sono tanto cari, che mai ancora si stava cosi male come
ora.
Il povero coll[ega], Blotta, e stato preso dai partigiani, e credono che sia in un campo
di concentramento a Lubiana, però fino ad ora non so ancora nulla di lui, anzi biso-
gnera che telefoni per sapere se hanno nottizie, di qui dell’Università si sa che il dott.
Zenaro9 e stato arrestato, e non si sa altro di lui, gli altri si trovano tutti bene.
Vi ho scritto questa lettera perché il nostro studente Reggio, mi ha detto che va prop-
prio a Catania, è la porterà lui stesso a Voi.
Noi vi ricordiamo sempre, e speriamo che rittornerete in breve, cosi potremo raccon-
tarvi qualcosa di più. Ricevete tanti saluti da Achile, Rosina, Amelia, e da tutti gli al-
tri conoscenti,10 nonchè da me i più cari saluti per Voi, e Vostra madre. Distintamente
/ Bruno”
3 Mi pare strano che mio padre in tempi così pericolosi tenesse proiettili (senza la relativa arma) in un
cassetto dell’università. 4 Parola veneta che indica caos, disordine. Un romano avrebbe scritto: “un gran casino”. 5 Dal che si dimostra che anche il peggio a volte sembra il paradiso. 6 Bruno intendeva dire “candidati”. 7 Lo scrittore Salvatore Satta resterà in carica pochi mesi, poi, insalutato ospite, se ne andrà da Trieste
per non più ritornarvi. 8 Bella, questa immagine della borsa nera che è diventata praticamente legale! 9 Si tratta dell’avv. T. Zennaro, che abbiamo visto essere uno dei protagonisti della nuova facoltà di Giu-
risprudenza. Fascista convinto, è stato poi processato, e assolto, dalla Corte d’Assise straordinaria di
Trieste. 10 Si noti che il “personale ausiliario” è citato familiarmente per nome, proprio come si fa con i buoni co-
noscenti: tale è sempre stato il rapporto di mio padre con i subordinati.
Perché Ermanno è sempre così amato dagli studenti, dai colleghi e da tutti coloro che
a vario titolo lavorano nelle università dove ha insegnato? Perché è così intelligente e
onesto da saper tener distinti il “dentro” e il “fuori” dell’istituzione (non a caso è stato
docente anche di Dottrina dello Stato). Giurista laico e rigoroso, democratico senza
mai scadere nel populismo, ha per lo Stato un sacro rispetto, anche quando non ne
condivide i dettami, e pretende che tutti, dagli uscieri ai dirigenti, si conformino
all’impegno che la loro “divisa” (reale o virtuale che sia) richiede. Quanto succede fuori
dal sacro recinto accademico, invece, è assolutamente personale e il fattore umano re-
gna sovrano: lo scherzo, la battuta, la presa in giro, la solidarietà e l’amicizia non de-
vono avere supervisori morali o materiali, se rientrano nel “comune senso del pudore”.
Ecco il ricordo di un altro ex allievo, poi collaboratore e amico, Luigi Stasi: “Le sue le-
zioni erano seguite con stupito interesse per l’arte d’insegnare i concetti, anche i più
difficili da seguire, con metafore, divagazioni apparenti, sempre con ironico distacco
dal rapporto effettuale, che spesso si concludevano con animate discussioni sul diritto
che si celebra nella coscienza degli individui. Definiva la filosofia del diritto la ‘cene-
rentola’ della facoltà di Giurisprudenza, ma, al di là dei dogmi giuridici, da lui abbia-
mo imparato un modo di capire quello che nella vita del diritto bisogna fare”.
Lo prova pure il seguente aneddoto, che mi è stato raccontato dal protagonista, Lino
Felician. “Diplomato ragioniere al ‘Da Vinci’ e reduce da un anno di guerra tra i parti-
giani, mi ero iscritto a Economia e Commercio. L’ultimo dei tre soli esami che ho so-
stenuto non lo dimenticherò mai. Era il maggio 1946 e faceva un caldo da morire.
All’epoca ero agli inizi della mia carriera presso l’INAM locale e avevo chiesto un bre-
ve permesso per sostenere l’esame di Diritto pubblico. Recatomi in via dell’Università,
chiesi ai miei compagni il favore di lasciarmi sostenere subito la prova, data l’urgenza
di tornare in ufficio. Avuta risposta favorevole, mi aggiustai la giacca sulle spalle –
che con quel caldo era già un gran sacrificio – e aspettai il mio turno. Non feci in
tempo a sedermi che venni chiamato dentro. Entrai di corsa e mi accingevo a sedermi
di fronte al mio esaminatore, il prof. Cammarata, quando questi mi fulminò con un
‘Indossi la giacca, per favore’. Arrossii per l’imbarazzo e mi confusi a tal punto che non
riuscii a rispondere a tono alla sua prima domanda. Resosi conto della situazione, con
molta calma pronunciò alcune parole atte a restituirmi le facoltà mentali e riuscii a
portare a termine il colloquio. Però la mia avventura universitaria finì lì.”
[Ripenso a questo episodio ogni volta che, passando nei pressi di un’università, ne ve-
do entrare e uscire ragazzotti in jeans e orecchino al naso, e fanciulle truccatissime
(s)coperte da un risicatissimo top e da un’altrettanto invisibile minigonna. E mi chie-
do quale sarebbe il suo commento (e il suo tormento morale) davanti a un simile spet-
tacolo. Ricordo che un giorno, pochi mesi prima della sua morte, tornando a casa con
la macchina di mio fratello, ci fermammo a un semaforo. Davanti a noi una giovanis-
sima coppietta inscatolata in una Cinquecento ne approfittò per darsi un rapido bacio.
L’esplosione d’ira e di disgusto di mio padre ci fece sobbalzare: “Che vadano a farle in
un casino, queste cose”, urlò. Manlio e io ci guardammo tra il divertito e
l’imbarazzato: mai avremmo immaginato una simile pruderie da parte del nostro ge-
nitore!]
In autunno Ermanno torna finalmente a Trieste, ormai diventata zona occupata dagli
alleati e in attesa di ulteriori decisioni internazionali (deve diventare “territorio libe-
ro” e autonomo? deve essere riunita all’Italia? deve diventare una città jugoslava? No-
ve anni dura l’incertezza...) e chiede a Lea di sposarlo, anche se per rispettare il lutto
dovranno attendere alcuni mesi.
In casa Ravenna c’è un po’ di subbuglio: dimentichi che Ezio si è convertito per sposa-
re la fidanzata cattolica, desta preoccupazione la decisione di Lea di unirsi a un ex al-
lievo dei gesuiti (anche se dichiaratamente agnostico), molto più vecchio di lei e per di
più meridionale. Ma la corrente di simpatia e di stima che si è creata tra Ermanno, il
futuro suocero, il fratello e il cognato di Lea dà i suoi frutti. Del resto, Lea non è più
una ragazzina, i due si vogliono bene, e in fondo Ermanno è pur sempre un docente
universitario... Per di più è, come il professor Ravenna, un accanito fumatore e un
“convinto miscredente”.
Nel frattempo l’Università ricomincia il suo ciclo. Nella foto che il “Giornale alleato”
pubblica in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico, tra i prof in toga c’è
anche lui, smagrito e un po’ invecchiato. Mi viene da dire: finalmente adulto, final-
mente uomo.
Quello sarà l’ultimo inverno “tranquillo” per molti anni. Nel marzo del 1946 Manlio
muore di polmonite (in Italia ci sono gli americani ma la penicillina è ancora pratica-
mente introvabile, e per di più ha prezzi proibitivi). Il matrimonio viene ritardato an-
cora di un mese, fino al 10 aprile.
La cerimonia è quanto di più sommesso si possa immaginare. Ne sono al corrente solo
gli amici di Ermanno e la famiglia di Lea; non si fanno inviti, non si fanno bombonie-
re; i testimoni vengono raccattati all’ultimo minuto davanti alla Sala Rossa del Muni-
cipio. La sposa è già in abito da viaggio, lo sposo ha una fascia nera sul braccio in se-
gno di lutto. Una sola fotografia. Se dal mattino si dovesse sempre vedere il buon
giorno, questo matrimonio sarebbe dovuto diventare ben presto un funerale. Per for-
tuna anche i vecchi adagi qualche volta sbagliano.
Gli altri sapranno tutto a cose fatte. Anche l’Istituto per i Ciechi Rittmeyer, al quale
gli sposi devolvono l’equivalente di quanto avrebbero speso per i confetti. Questa elar-
gizione viene fatta probabilmente anche pensando a Max Ascoli e alla sua quasi ceci-
tà.
E piovono regali e auguri (più dei secondi che dei primi: a Trieste e in Italia è l’anno
primo della pace). Tra i secondi, l’unico conservato è quello dei goliardi triestini: “Al
più gentile dei professori / al più caro tra gli amici / Noi Petrus Tribunus auguriamo a
nome degli studenti tutti una lunga e serena felicità. /Petrus (e timbro di ceralacca)”.
Gli sposi partono per Venezia, fanno tappa a Padova dalla sorella della rispettiva ma-
dre e suocera, e da lì vanno a Roma, dove Ermanno presenta la novella sposa ai suoi
amici di gioventù: gli Ederli, gli Aiello e altri ancora, che l’accolgono con un calore al
quale la riservata Lea non è sicuramente preparata ma che ricambia volentieri. Poi di
nuovo in viaggio verso la Sicilia. Ma l’impatto della giovane nordica con una Sicilia
decisamente arcaica non è dei più felici: sebbene nei mesi precedenti futura nuora e
futura suocera si siano scambiate lettere di rara affettuosità, Lea, figlia di medico, i-
norridisce per la scarsa igiene che regna in casa Cammarata. Per esempio,
all’immancabile bastardino vengono fatti ripulire i piatti dove si è appena finito di
mangiare, e la doccia si fa con l’acqua piovana raccolta nelle vasche sopra il tetto delle
case, fredda di sera e foriera di ustioni durante il giorno. Amor omnia vincit, è vero,
ma i rapporti tra le due donne non saranno mai più gli stessi.
Curiosamente, anche se non si conobbero mai di persona, fra le due consuocere vi fu
uno scambio di lettere piuttosto fitto, come deduco da una lettera della nonna Itala a
mia madre in viaggio di nozze. Penso che tale abitudine sia proseguita negli anni a
venire.
Ritornare a Trieste significa affrontare altre difficoltà: gli sposi non hanno fissa dimo-
ra e vivono un po’ in casa Ravenna, un po’ in stanze in subaffitto, un po’ ospiti di ami-
ci. Non dimentichiamo che la guerra ha inflitto gravi danni al tessuto urbanistico cit-
tadino ed è iniziato l’esodo degli istriani. Lea ed Ermanno non possono vantare né pu-
lizie etniche né case distrutte dai bombardamenti. Che Lea sia stata una perseguitata
razziale per le istituzioni pubbliche non conta nulla (e non conterà mai). Nei sei anni
che la coppia resterà ancora a Trieste nessuno dei loro amici – alcuni potenti come il
sindaco Bartoli e l’arcivescovo Santin – avrà voglia di esporsi con le onnipresenti e
onnipotenti autorità occupanti tanto da procurar loro quel tetto cui hanno diritto al
pari di tutti gli altri residenti.
[La storia di Trieste dal 1945 al 1954 è già stata raccontata così tante volte e così tan-
to in mala fede che mi sento esonerata dal farlo anch’io. A confrontare le varie istorie
tra di loro, si scoprono tante di quelle menzogne che nel corso del millennio suderà
sangue chi vorrà studiare la storia (e la storiografia) triestina della seconda metà del
Novecento: tra acrobazie linguistiche e “amnesie”, scambi di persone e di ruoli, insulti
e peana (spesso entrambi a sproposito) avrà di che combattere per infiniti anni. Di
questo tragico periodo ricorderò solo quanto ha a che fare direttamente con la vicenda
umana di mio padre.]
Nel frattempo l’Università si rende conto di essere priva di un vero e proprio rettore.
La nuova legislazione italiana prevede che questi non sia più di nomina ministeriale
ma venga eletto dal Corpo accademico. L’ateneo triestino è minuscolo (tre sole facoltà:
Giurisprudenza, Lettere e Ingegneria) e i superstiti docenti sono per la maggior parte
sotto accusa per conclamato e acclamato fascismo, tanto che la scelta si riduce a pochi
nomi.
Il giorno della riunione del Corpo accademico vede riuniti professori, assistenti (veri e
volontari senza distinzione) e altra manovalanza universitaria. L’ordine del giorno ha
un solo punto: l’elezione del nuovo rettore. Nessuno dei presenti, naturalmente, osa
autocandidarsi. Uno dei più ambiziosi, Pierpaolo Luzzatto Fegiz, manda in avansco-
perta un “tirapiedi”, il quale appunto si alza e, nel silenzio più totale, fa il nome del
suo patrono. L’assemblea annuisce (sempre nel massimo silenzio) mostrando di pren-
dere atto della proposta, ma nessuno si sbilancia apertis verbis e l’atmosfera si fa im-
provvisamente un po’ tesa. Ne approfitta un giovane assistente volontario di Storia,
Mario Coloni, che scatta in piedi inviperito e senza perifrasi apostrofa i presenti:
“Mentre noi difendevamo l’Università dai fascisti, dai tedeschi, dai titini e dagli ingle-
si, il signore che osa candidarsi in virtù del suo antifascismo faceva la resistenza
tranquillamente seduto a leggere, a pescare e a fare i bagni nella sua diletta isola
dalmata. E adesso pretenderebbe di rappresentarci? Propongo invece una persona che
davvero ha difeso l’autonomia e l’italianità del nostro Ateneo esponendosi in prima
persona: il professor Angelo Ermanno Cammarata.”. Di nuovo quell’insulso annuire
dei presenti, i quali, messi poi alle strette dalla necessità di esprimere un voto, ne da-
ranno 11 a Ermanno e 9 a Luzzatto Fegiz.
[Mario Coloni ha poi, per sua e nostra fortuna, lasciato il mondo accademico e ha pre-
so altre strade, diventando anche scrittore e giornalista di razza. A lui, l’unico dei pre-
senti a quella storica riunione dell’estate 1946 ancora vivo e lucido quando ho comin-
ciato a stendere queste note – una ventina di anni fa –, devo la preziosa testimonian-
za.]
La prima decisione del neorettore è quella di non reiscriversi alla massoneria, che era
stata ufficialmente abolita dal regime di Mussolini ed era risorta appena caduto il fa-
scismo. Poi, rimboccatosi le maniche, affronta l’intricata situazione. “Con olimpica
calma – ricordava Stasi – ha saputo infondere nei suoi collaboratori, che ascoltava
sempre, entusiasmo e dedizione.”
Bisogna ricostruire il corpo docente, portare avanti la costruzione della nuova univer-
sità, iniziata nel 1938, interrotta durante il conflitto e in quel momento, come buona
parte degli edifici pubblici, castello di Miramare compreso, occupata dagli angloame-
ricani e da vari uffici del Governo militare alleato; bisogna, soprattutto, mantenere i
legami con il resto di quell’Italia che, per volontà alleata, deve fissare il proprio confi-
ne orientale all’altezza di Duino, a soli 20 chilometri dalla città giuliana, affinché Tito
non approfitti del distacco per convincere gli alleati che Trst je naš (Trieste è nostra);
bisogna contenere le esuberanze dei comunisti filoslavi e antioccidentali, che creano
incidenti a ripetizione; bisogna, infine, mantenere buoni rapporti con gli alleati mede-
simi i quali, va detto, non hanno una gran simpatia per gli italiani (con un’eccezione
per le giovani triestine, che sono richiestissime anche come mogli).
Quello che degli occupanti Ermanno proprio non sopporta (oltre alla gomma da masti-
care e ai “diseducativi” fumetti) è la loro mania di voler cacciare il naso anche negli af-
fari che non li riguardano, come per esempio nello svolgimento delle attività accade-
miche più importanti. Non hanno ancora capito che un rettore che per 365 giorni
all’anno espone il tricolore sugli edifici universitari risponde del suo operato solo al
Ministero (italiano) della Pubblica Istruzione?
Il dissidio, abilmente nascosto da diplomatici sorrisi e strette di mano di circostanza,
risale probabilmente al giorno in cui Ermanno è stato eletto rettore. Così ricorda Ste-
lio Crise: “[...] un certo capo dell’ufficio educazione del Governo militare alleato aveva
avuto la debolezza di rinfacciare al prof. Cammarata di non essere stato invitato a
presenziare alla seduta del Corpo Accademico che aveva determinato l’elezione del
nuovo Rettore. [...] Con pacatezza finemente umorosa il prof. Cammarata si era senti-
to in obbligo di obiettare che, se per ipotesi non concessa, il presidente della Repubbli-
ca Italiana avesse avuto la velleità di chiedere di partecipare ai lavori del Corpo Ac-
cademico, sarebbe stato fermamente invitato ad attendere in anticamera”.
Pur di mantenere i contatti con l’Italia non esita ad allearsi con i nazionalisti locali
per far rinascere l’antica Lega Nazionale, e con essi ne firma il nuovo statuto. Una
delle prime azioni della Lega è un referendum – organizzato all’indomani del Trattato
di Parigi che istituiva il Territorio Libero di Trieste – fra triestini e istriani su quale
sorte debba avere Trieste. È quasi un (illegale) plebiscito a favore dell’Italia.
“Nella preparazione degli atti del Trattato di pace – ricorda ancora Stasi – Cammara-
ta fu espressione della volontà non solo accademica di fornire al Governo la documen-
tazione probatoria delle ragioni di sostegno della permanente sovranità italiana nel
territorio della Venezia Giulia occupato dalle truppe angloamericane e nella zona i-
striana da quelle jugoslave. Il Rettore mi affidò personalmente una grossa borsa con-
tenente studi e relazioni giuridiche, dati statistici, politici, diplomatici e sociali e mi
accompagnò al treno che partiva per Roma, dove li avrei consegnati al conte Sforza, il
quale li mise poi a disposizione della delegazione governativa.”
Gli alleati (che sull’argomento Trieste hanno sempre dato prova di grande parzialità)
non apprezzano queste interferenze e fanno di Ermanno, che pare sia stato l’ideatore
del referendum, il capro espiatorio delle loro ire. Decidono, in un impulso di cui do-
vranno ben presto pentirsi, e con una scusa che più stupida non si può – alcuni disat-
tendimenti burocratici – di deporlo dalla poltrona di rettore. Ma hanno fatto i conti
senza i triestini.
Sette anni dopo Ermanno raccontava il fatto ai “sodali” della Società di Minerva, che
così la riassumerà nei suoi verbali: “Cammarata ha voluto subito sottolineare che di
quelle vicende egli fu soltanto apparentemente il protagonista, giacché gli autentici
protagonisti furono il Senato accademico e gli studenti e, quindi, tutta la cittadinanza,
che compatta si strinse intorno a loro. La decisione di eliminare il Magnifico Rettore
venne presa, come sostiene l’oratore, in alto loco [...]. Al prof. Cammarata, invitato a
presentarsi il 13 aprile 1947 ‘ad audiendum verbum’, venivano imposte le dimissioni.
Ma egli, anziché sottomettersi a tale richiesta, preferì accendersi una sigaretta e ri-
spondere che, veramente, non ne vedeva il motivo. Una settimana dopo gli perveniva
una lettera da parte dell’ufficiale superiore per gli affari civili con cui il Rettore veniva
licenziato, così come si farebbe ‘con un fattorino colto in fallo’”. Contemporaneamente,
l’Ufficio informazioni del G.M.A., scrive il “Giornale di Trieste”, “ha emesso in data 21
aprile il seguente comunicato: ‘La Sezione Educazione del G.M.A. annuncia che il
prof. Angelo Ermanno Cammarata, Rettore dell’Università di Trieste, è stato sostitui-
to dal prof. Pierpaolo Luzzatto Fegiz, che è stato nominato prorettore da oggi 21 aprile
1947’.”.
Per la cronaca, l’esatta risposta di Ermanno all’ingiunzione del colonnello Bowman
“Lei mi deve presentare le sue dimissioni”, è: “Ma neanche per sogno: non ne vedo il
motivo”.
Come si evince dai verbali delle riunioni del Corpo accademico, il vero motivo
dell’ostilità degli americani (e in particolare di Bowman) nei confronti del legittimo
rettore non è mai saltato fuori; si capisce invece come per tutta la vita questi sia ri-
masto ostile a qualunque cosa “sapesse” di America... Si può ipotizzare che agli alleati
non piacesse il viscerale e mai nascosto anticomunismo/antislavismo di Ermanno,
laddove era manifesto che essi, pur di farla finita e di tornare presto a casa, avrebbero
volentieri consegnato Trieste a Tito. Del resto, nel chiedere un nuovo rettore al Corpo
accademico, Bowman pretende che esso sia “politicamente ineccepibile nei riguardi
degli Alleati”!
Nelle sue memorie il colonnello spende ben tre pagine per parlare del rettore Camma-
rata. Nel testo le critiche, anche feroci, si alternano a espressioni di stima. Ermanno è
sì una “nice person” ma non capisce niente di politica, del momento cruciale in cui la
città si trova e questo – secondo Bowman – lo rende inviso prima di tutto agli jugoslavi
e poi anche ai leader italiani. Questa la sua versione dei fatti: “Ho sempre cavalcato ed
anche nei quasi due anni permanenza a Trieste, cavalcando per circa due ore giorna-
liere non mi era mai capitato un incidente, ma un pomeriggio di inizio aprile il mio
cavallo è scivolato per uno smottamento del terreno ed io cadendo ho sbattuto la testa
su una pietra.
Questo fatto mi ha messo k.o. per alcuni giorni, incluso l’inizio della pratica del succes-
sivo licenziamento del Rettore dell’università di Trieste.
Forse, se non avessi ricevuto quel colpo in testa che mi ha destabilizzato per alcuni
giorni, avrei capito per tempo che licenziare per incompetenza amministrativa un Ret-
tore non era una ragione valida. Il mio funzionario addetto alla pubblica istruzione mi
aveva informato di fatti incontestabili ed io li avevo controllati settimane e mesi pri-
ma.
Angelo E.Cammarata era una persona amabile, uno studioso rinomato e un convinto
super irredentista politico ed etnico. Ma i fatti dimostravano che egli era completa-
mente incapace di capire le basi amministrative, senza parlare poi di applicarle prati-
camente per risolvere i problemi che giornalmente si presentavano all’Università.
C’era da fare una sola cosa, e senza consultare i miei superiori l’ho licenziato; poi in
una breve dichiarazione alla stampa ho detto che avevo fatto così solo per ragioni pu-
ramente amministrative che in nessun modo ledevano la sua reputazione di studioso e
di docente.
Nei giorni seguenti sono stato subissato da telegrammi e lettere di protesta e da aspre
critiche da parte di Atenei e universitari in generale, alcuni anche dalla Jugoslavia,
dove Cammarata era molto conosciuto come irriducibile calvinista e irredentista.
I messaggi ricevuti direttamente erano nulla in confronto a quelli inviati
all’ambasciatore italiano, al Dipartimento di Stato e al Presidente degli Stati Uniti
d’America. Dopo le lettere sono arrivati i corrispondenti, che mi hanno chiesto se avevo
deciso di soffocare la libertà accademica della Venezia Giulia.
Per la stampa locale furono giornate campali, particolarmente per il giornale satirico
“Caleidoscopio” che uscì su una intera pagina con un racconto di fantasia in cui io nar-
ravo in una intervista di come avessi licenziato il Papa per ragioni puramente ammi-
nistrative!
Ed è in questa occasione che ho ricevuto il più bel regalo che un subordinato possa ri-
cevere da un superiore. Come ho già menzionato in altra parte di questo racconto, il
gen. Harding informò le alte sfere di essere stato informato a suo tempo delle mie in-
tenzioni che lui approvava incondizionatamente. Questo fatto scongiurò il peggio, dato
che questo proveniva dal mio diretto superiore militare che avrebbe potuto rendere la
vita militare peggiore di quanto già non fosse.
Alla fine, dopo vari incontri (con Cammarata) e dietro mio suggerimento che, se avesse
continuato ad apporre la sua firma su documenti universitari, il GMA avrebbe smesso
di erogare aiuti finanziari ,Cammarata se ne andò pacificamente.
Ho letto in seguito degli articoli che menzionavano il fatto che Cammarata nel 1949
era Rettore. Penso lo abbiano rieletto dopo la mia partenza.
Il 1° Maggio festa del lavoro comunista fu seguito dalle solite manifestazioni pro-
Jugoslavia in piazza dell’Unità, ma questa volta senza tumulti anche grazie alla buona
organizzazione delle forze dell’ordine della Venezia Giulia, più responsabili, delle quali
ero molto fiero e che provocarono derisione da parte degli amici della stampa.
Il resto del mese fu dedicato più al caso Cammarata che ad altro”.
Mi chiedo se il suo finto stupore nell’apprendere che il Rettore era tornato al suo posto
(e per di più dopo che lui stesso gli aveva chiesto pubblicamente scusa) faccia parte
della solita ipocrisia americana. Quella volta, per di più, il rettore di un’università ita-
liana non doveva occuparsi dei conti, ma di gestire le facoltà, i docenti ecc. Poi sì, Er-
manno si è occupato anche di soldi, e in maniera egregia, a dispetto dei pregiudizi bo-
wmaniani. Per non parlare dell’incoerenza di tutto il racconto. e della bugia finale: il
rettore in carica non se n’era mai andato, pacificamente o no, era solo rimasto dietro le
quinte senza apporre firme sui documenti ufficiali.
Ma c’è di più, come racconta lo storico triestino Alfio Morelli. “Intorno a questo episo-
dio, che alcuni commentatori definiscono «oscuro», si muovono le più diverse interpre-
tazioni. C’è chi sostiene che l’ordine di destituzione fosse una risposta al rifiuto da par-
te del Rettore di avallare le disposizioni del capitano italo-americano Simoni, capo
dell’Ufficio Educazione, sull’uso della lingua slovena nelle scuole (con l’immissione di
docenti provenienti da Lubiana). Altri ritengono che il provvedimento punì Ermanno
Cammarata perché troppo «italiano», e quindi suscitatore della fiamma dell’italianità
nell’Ateneo. Ma chi lo ha conosciuto bene, afferma che le motivazioni erano più com-
plesse e riguardavano il carattere del personaggio, educato a fermi principi. Frequen-
tando Cammarata si restava colpiti dalla sua cultura e dal suo senso del «diritto». Tal-
volta poteva apparire anche freddo e distaccato, quasi un «aristocratico» del pensiero;
spesso era incline al sarcasmo nei confronti di certi funzionari del G.M.A., che dimo-
stravano evidenti carenze e grossolanità in materia giuridica. Che avesse gran cuore
di italiano è indiscutibile; non difettava di coraggio e di umanità. Seppe dimostrare
queste doti in due particolari circostanze.[…] L’altro episodio fu ad una conferenza che
Cammarata tenne alla fine degli anni '50 al ridotto del Verdi, per il Circolo della Cul-
tura e delle Arti, sul tema: «II dissidio Croce-Gentile». Egli espose le «strade parallele»
percorse dai due uomini di pensiero. Strade, disse, che «portarono al loro incontro,
all’amicizia e infine al dissidio e allo scontro». E tutto questo, commentò, «lo rileviamo
in un momento in cui la cultura sta subendo i più profondi capovolgimenti, imbarbari-
ta dalla moda, dalle finzioni e dall’opportunismo, che inducono a stravolgere l’impegno
culturale, asservendolo alla parte politica». Cammarata, pur in anni difficili, evidenziò
anche in quella circostanza il carattere universale del pensiero. Non dimenticò di esse-
re «gentiliano», e in quella conferenza, con l’affetto del discepolo, non ignorò la tragica
fine del suo maestro. Chiuse il suo discorso con una frase di grande coraggio: «di
quell’assassinio ci fu un partito che si gloriò».
Altrettanto vigoroso era il credo giuridico di Cammarata. Ritengo perciò che non con-
dividesse affatto la condotta politica del colonnello Bowman e di Simoni in materia di
istruzione: aveva sempre difeso tenacemente l’autonomia della scuola italiana. E la di-
fendeva non soltanto negli aspetti culturali, ma anche negli istituti e sugli strumenti
legislativi che presiedevano al suo sviluppo: erano ancora le leggi italiane che regola-
vano la scuola, e pertanto i rapporti con il competente Ministero dell’Istruzione dove-
vano essere mantenuti. E ciò ovviamente non andava a genio al colonnello Bowman,
né all’italo-americano capitano Simoni, a proposito del quale negli ambienti universi-
tari correva una simpatica storiella. Si raccontava che questi, nel corso di una visita al
Magnifico Rettore, si fosse prodotto in una sorta di lezioncina democratica, spiegando
che la scuola, ma specialmente l’Università, avrebbero dovuto assumere caratteri me-
no autoritari. Bisognava seguire il modello delle Università americane, in cui – affer-
mava Simoni – i professori passeggiavano confidenzialmente con gli studenti sotto i co-
lonnati, o lungo i viali dei giardini prospicenti gli atenei, e così erano soliti tener lezio-
ne. Si dice che Cammarata, finito il discorsetto, guardandolo con la sua aria apparen-
temente dimessa e bonaria e con quel sommesso tono di voce, avesse detto: «Non mi
sorprende molto. Mi par di ricordare che i greci lo praticassero prima che Cristoforo
Colombo scoprisse l’America»”.
Da notare che Alfred C. Bowman non era uno sprovveduto: prima di indossare la divi-
sa era stato un giurista laureato all’Università del Michigan ed era stato sostituto pro-
curatore a Los Angeles, quindi di istituzioni universitarie aveva esperienza. Peccato
che non avesse messo in conto che l’istruzione in Italia era molto, molto diversa da
quella statunitense.
Chi ha frequentato l’Università in quegli anni ricorda che la porta della stanza di Er-
manno, in Rettorato, era sempre aperta, per tutti, studenti compresi. Un po’ meno, pa-
re, per quelli sloveni. Quanto alle lezioni “peripatetiche”, da quando venne trasferito
all’Università di Napoli, esse divennero una caratteristica costante del suo insegna-
mento.
Ed ecco un’altra occasione di scontro con il capitano John Simoni, che insegna Psicolo-
gia dei colori in un’università del suo Paese: ottimo per la scelta della cravatta, com-
menta nell’accogliere la notizia il poco diplomatico Rettore. In realtà l’italoamericano
Simoni, addetto al “riordino” delle istituzioni scolastiche di Trieste e della Venezia
Giulia, non è un idiota: direttore di musei, critico d’arte, professore universitario, scrit-
tore e lui stesso pittore, prima di tornare in America acquista numerose opere di arti-
sti sloveni come Music e Cernigoi. Forse è quel suo interesse per il mondo slavo a riu-
scire indigesto all’“irredentista” rettore.
Lasciamo stare il pandemonio che il comunicato della rimozione, trasmesso anche per
radio, provoca in quasi tutti i triestini. Pensiamo invece a quale sconquasso psicologi-
co ed emotivo dev’essersi verificato in Lea, incinta di cinque mesi, tacitamente messa
sotto accusa dalla famiglia per aver sposato uno che finisce sulla prima pagina dei
giornali locali (di destra e di sinistra, ma con motivazioni opposte) e poi perfino su
quelli nazionali e internazionali. Dove andrà a finire l’onorato nome dei Ravenna?
Ermanno non fa una piega. È una sua caratteristica, quella di rimanere calmo nel
mezzo della tempesta, salvo poi farne scontare le conseguenze al suo organismo. E an-
che le sue ire, quando esplodono, sono tanto furibonde quanto brevi. Della persona che
è riuscito a scuoterlo dalla sua proverbiale pigrizia esistenziale si scrolla subito via il
ricordo con una sola, apparentemente innocua, parola: “Poveraccio”.
Per di più, da Milano dove la sua Doxa si sta facendo un’ottima fama, Fegiz risponde
(due giorni dopo) alla decisione di Bowman: “No, grazie, non farei mai un torto del ge-
nere a un amico”. Questa è la versione ufficiale che dà nelle sue memorie. In realtà, se
appena ci fosse una reale possibilità di fargli le scarpe, direbbe di sì, non foss’altro che
per vendicarsi della mancata elezione dell’anno precedente. E poi, perché tornare in
una città di provincia così... border-line quando può vivere ammirato e ossequiato in
una Milano che sta meravigliosamente rinascendo dalle proprie ceneri e offre sviluppi
inimmaginabili alla sua attività (la Doxa, nata sul modello della Gallup americana, è
la prima società italiana specializzata in sondaggi d’opinione)? E inoltre, grazie alla
nuova legge italiana, il posto di rettore non dipende più da un ministero o da una vo-
lontà politica, e quindi la rimozione del titolare legale, così come la sua stessa nomina,
non ha alcun valore giuridico. Il gioco non vale davvero la candela. Meglio acconten-
tarsi della cattedra che continua a tenere presso la facoltà di Economia e Commercio.
Questo suo gentile ma non particolarmente sollecito declinare l’offerta non placa né le
ire degli alleati né quelle degli studenti universitari che, come si è visto, vogliono mol-
to bene al loro rettore e che il giorno dopo il comunicato si sono, come recita un titolo a
sette colonne della “Voce libera”, asserragliati all’Università pronti a respingere un
attacco della polizia. È l’inizio di quello che viene subito ribattezzato “il ballo degli as-
sediati”. Questo il resoconto dello stesso quotidiano: “[...] All’ora di andare in macchi-
na apprendiamo che fatti gravi si stanno svolgendo nella sede universitaria. Alle 12
gli studenti, come deciso, avevano occupato l’Università, tenendo socchiuso il portone.
Mezz’ora più tardi arrivò sul luogo una camionetta con agenti di Polizia che, forzato
l’ingresso, invasero l’atrio. Tra gli studenti e gli agenti si venne a violenti tafferugli,
gli studenti opponendosi a seggiolate agli uomini della forza pubblica che usavano i
bastoni. Dopo un breve, violentissimo scontro [...] gli studenti riuscivano a ricacciare
gli agenti e a chiudere il portone.”.
Ermanno è con loro dietro il grande portone di ferro che cerca di calmarli. “Fermate-
vi!”, dice. “Così vi mettete dalla parte del torto!”. Ma impugna una pistola…
“Verso il tocco sono arrivati i rinforzi di P.M. [Police Men, la polizia del G.M.A.]. Al lo-
ro arrivo gli studenti hanno issato il tricolore sopra il portone dell’Ateneo cantando
l’inno di Mameli. Essi sono un’ottantina, rinchiusi tuttora nell’interno dell’edificio. [...]
Il Rettore cerca di far opera di persuasione tra gli studenti e la Polizia. [...] La richie-
sta di revoca del provvedimento entro le ore 12 è stata rifiutata dal col. Robertson, e
comunicata agli studenti al tocco. Alle 13 in via Cavana un gruppo di studenti è stato
aggredito da agenti al comando dell’ispettore Cesare [...].”. Gli studenti delle scuole
superiori cittadine dichiarano lo sciopero.
L’indomani il “Messaggero Veneto” titola: “Solidarietà piena di tutti gli Atenei italia-
ni.”. E solidarietà viene dal governo di Roma e dal Ministero dell’Istruzione. Il caso si
complica vieppiù, tra docenti che, come Roletto, rifiutano di sostituire il rettore, stu-
denti che annaffiano con gli idranti i poliziotti e Senato accademico in assemblea qua-
si permanente.
Ed ecco che, dall’America, dove la vicenda triestina ha una certa eco perfino sui quoti-
diani più importanti, si fa vivo Max Ascoli: dopo essersi recato personalmente a Wa-
shington a protestare e a cercare di far ragionare i suoi concittadini, manda un tele-
gramma al vecchio amico in cui dice tra l’altro: “La misura presa contro di te offende
la libertà accademica in ogni paese ed in particolare negli Stati Uniti, la cui funzione
è oggi di garantire il rispetto di ogni libertà. Ti abbraccio fraternamente. Tuo Max”.
Vuoi grazie all’azione perentoria di Max, vuoi grazie a quella della stragrande mag-
gioranza della popolazione (solo i comunisti hanno esultato, sperando di liberarsi di
un avversario così scomodo), vuoi perché a nessuna delle parti in causa conviene pro-
seguire in uno sterile braccio di ferro, nel giro di qualche settimana, con le scuse a
Ermanno da parte del colonnello Bowman, tutto rientra nella normalità. Tutto? Non
proprio. Otto mesi dopo un suo acerrimo nemico politico e accademico, lo storico Fabio
Cusin, dalle pagine del filoslavo “Corriere di Trieste” si stupisce che Cammarata si
presenti ancora in pubblico nelle vesti di rettore: “Lieta sorpresa per noi e per gli altri
ingenui che lo credevamo destituito come da una mai smentita notizia ufficiale!”. In
perfetta malafede, perché il dietrofront americano è contenuto perfino in una lettera
del 2 novembre indirizzata al Corpo accademico e firmata dal colonnello Airey (che ha
sostituito Bowman). Questo, sembra, è stato finora l’unico esempio di occupazione di
un’università italiana cui abbia partecipato il rettore in persona.
Sta di fatto che per tutti gli anni dell’occupazione alleata il solo edificio pubblico dove
quotidianamente continui a sventolare il tricolore è proprio l’Università.
Ma la carica di rettore oltre agli oneri porta anche qualche vantaggio: Ermanno è uno
dei primi in Italia a usare le diapositive a colori. Che la cosa sia un’assoluta novità lo
dimostra il fatto che i rullini devono essere mandati in America per lo sviluppo. Il suo
tramite è un occupante evidentemente “non ostile”, anzi forse un appassionato come
lui, il direttore di Radio Trieste H. L. Jacobson, che gliele fa inviare e rispedire a suo
nome. Jacobson, già ufficiale della V Armata statunitense, andrà via da Trieste nel
1952 portandosi dietro una moglie triestina, Fiora Ravasini.
Nel 1950, con raro senso dell’opportunismo, qualcuno torna alla carica, ricordando
questo episodio, addirittura dalle pagine di “Epoca”... Peggio ancora, un altro vi torna
nientemeno che trentasette anni dopo dalle pagine del “Meridiano di Trieste”, con con-
torno di insulti razzisti all’indirizzo del defunto Ermanno. Per fortuna è proprio uno
degli studenti protagonisti dei fatti di aprile, Oberdan Pierandrei, a rintuzzare
l’attacco e a mettere a tacere l’immarcescibile e anonimo insolente.
Comunque i rapporti tra Ermanno e gli americani tornano in breve tempo (cioè dopo
la partenza di Bowman) a essere normali. O quasi. Un giorno il responsabile della
propaganda invia per conoscenza al rettore un opuscolo (in inglese ma destinato ai
triestini) dove vengono spiegati, in inglese e con l’ausilio di vignette more americano
quali sono i diritti del cittadino di un Paese democratico. Ermanno risponde plauden-
do all’iniziativa, ma facendo presente al suo interlocutore che non gli pare opportuno
educare il popolo italiano a suon di cartoons.
[L’unico giornale per bambini ammesso in casa era il “Corriere dei piccoli”, che rac-
contava le avventure del Sor Pampurio, di Bonaventura e di Pier Lambicchi con le ri-
me e non con i fumetti. Nel 1960 me ne venne regalato l’abbonamento annuale.
Quando arrivava (piegato in due e chiuso da una fascetta gialla) tra me e Manlio si
scatenava la lite per chi dovesse leggerlo per primo. Un giorno, non essendo riusciti a
trovare l’accordo, andammo a far dirimere la questione da papà. Lo trovammo como-
damente seduto in poltrona, talmente immerso nella lettura del Corrierino da non ac-
corgersi che tra i suoi figli, a pochi metri da lui, si stava svolgendo l’ennesima baruf-
fa.]
Gli avvenimenti primaverili lasciano una profonda cicatrice nell’animo (e nella mente)
di Ermanno. Solo la nascita del primogenito, il 4 settembre, riesce a rasserenarlo. I
goliardi sono in festa: oltre a regalargli un disegno che lo ritrae capelli, naso e orec-
chie al vento mentre porta a spasso una carrozzella, sormontato dalla scritta Viva il
Magnifico Papà!, sul “Giornale di Trieste” esce questo spiritosissimo carmen tergesti-
num: “Gaudium Gaudium Gaudium / Goliardi tergestini nuntiant / Pulchris puellis
patronisque bettolarum universarum / Et quoque populo tucto istae civitatis / Vultis
scire ultimam? / Nactus est unum cocculum piccium, / Et postea? Et postea bonum! /
Debetis scire hunc magnificum putelinum / Alter non est quod heredes masculus /
Formidabilis Rectoris Magnifici / Optatissimae tergestinae Universitatis / Famosus et
celeberrimus professor / Angelus Ermannus Cammaratus. / Eamus, pueri, eamus,
puellae! / Nunc est bibendum et gavazzandum / Pagabit tuctum Rector Magnificus”.
Il poema è anonimo, ma si vocifera che sia opera del direttore della Biblioteca univer-
sitaria, Stelio Crise.
Ermanno non si occupa solo della “sua” Università, anzi, anche se volesse... Dopo i
fatti testè ricordati la sua popolarità cresce a dismisura. Perfino alcuni avversari poli-
tici non si fanno scrupoli di chiedergli favori, per sé o per i loro protetti. E non basta:
per esempio, alla fine degli anni ‘40 nella nuova zona di espansione residenziale di
Valmaura, proprio dietro il nuovo stadio, è stato costruito un brutto ma utilissimo edi-
ficio: sul lato prospiciente via Flavia vi trovano posto le Cooperative Operaie; di fian-
co, un nuovo cinema. Come chiamarlo? I proprietari, tali Dannecker, non hanno dub-
bi: il problema lo risolverà il Magnifico. E infatti il cinema si chiamerà “Lumière” “su
suggerimento – recita una foto dell’epoca che immortala nel retro, a penna, lo storico
avvenimento – del Magnifico Rettore prof. Angelo Ermanno Cammarata”.
A Trieste c’è una folta colonia di siciliani, e non solo all’Università. Fuori da questa,
ma ben dentro l’unico quotidiano cittadino, c’è un catanese tutt’altro che estraneo alla
vita di Ermanno: Santi Corvaja. “Santino” è figlio di un ex spasimante (e lontano pa-
rente) di Linda Longo, giornalista a sua volta: non si sono potuti sposare perché Filip-
po è inorridito all’idea di dare la sua unica figlia in sposa a uno “senza arte né parte”:
tali, nel XIX secolo, erano considerati i giornalisti... Strano destino, per i due mancati
fratelli, ritrovarsi, e diventare buoni conoscenti, proprio a Trieste!
Il più giovane rettore d’Italia continua a rimuginare sui fatti occorsigli. Era legale,
sulla base dell’art. 21 del Trattato di Pace del ‘47, l’intervento del G.M.A.? Nasce an-
che da qui la sua tesi della mai cessata sovranità italiana sul Territorio Libero di
Trieste. Con argomenti squisitamente giuridici spiega, in qualsiasi sede e con qualsia-
si mezzo gliene venga data facoltà – articoli sui giornali, su riviste giuridiche, confe-
renze, convegni – che nella città giuliana, nonostante l’occupazione (che è certamente
a tempo determinato, perché prima o poi le Grandi Potenze dovranno pur prendere
una decisione), viene prima la legge italiana e poi quella del Governo alleato, almeno
fino a quando non sarà stato reso funzionante il governo dell’ipotetico TLT. Che in re-
altà non è mai nato, perché gli alleati non sono mai riusciti ad accordarsi nemmeno
sul nome del governatore!
Questa tesi, universalmente nota come “tesi Cammarata”, presa al balzo e opportu-
namente strumentalizzata dai nazionalisti italiani, in realtà è stata da lui elaborata
grazie a uno spunto offerto dal giurista Tomaso Perassi, che a quel tempo gravita
nell’orbita del Ministero degli Esteri. L’elaborazione della tesi sui fondamenti proposti
da Perassi e da Ermanno e corredati da cavilli e cavalli (di Troia) squisitamente giu-
ridici passa probabilmente al vaglio, oltre che dello stesso Perassi, anche di Carlo A-
migoni e di altri giuristi.
[Perassi aveva proibito a Ermanno di fare il suo nome: in quanto consulente del Mini-
stero degli esteri, non solo avrebbe rischiato il posto ma avrebbe rivelato la genesi di
tale tesi, politica prima ancora che giuridica. Sospetto inoltre che Perassi, sapendo
che la sua tesi mostrava il fianco a critiche da entrambi i punti di vista, abbia delibe-
ratamente strumentalizzato il giovane rettore secondo la prassi tutta italiana del “vai
avanti tu ché a me mi vien da ridere”. Il nome di Perassi, ormai defunto, verrà uffi-
cialmente fatto solo nel 1963. Con l’inaffondabile onestà che lo contraddistingueva
mio padre scrisse nel “Foro italiano” di quell’anno: “[...] la tesi [...] non era tutta farina
del mio sacco, ma del compianto prof. Perassi; [lo avrei detto prima] se l’Autore mi a-
vesse autorizzato a farlo”.
In conclusione, gli oneri (molti) e gli onori (pochi) di questa operazione graveranno
sulle sue spalle. Fino a che punto, prima di iniziare la battaglia, ne era stato consape-
vole?]
Nel 1949 viene rieletto per il triennio ‘49-’52 alla carica di rettore con 24 voti su 35.
Non insegna più, non scrive altro che per ribadire la “sua” tesi, non fa più l’avvocato (o
meglio, fa l’avvocato difensore di Trieste...). Come una delle massime autorità rappre-
sentanti l’Italia davanti agli Alleati insieme al sindaco e all’arcivescovo, è costretto a
presenziare a tutte le cerimonie pubbliche, di qualunque ordine e grado esse siano.
L’Università assorbe tutte le sue energie. In una lettera a Pierluigi Zampetti scrive:
“[...] senza il pomeriggio della domenica non riuscirei più a tenermi al corrente o, per
essere più esatti, a ricordare a me stesso che non sono un semplice burocrate, e che ho
fatto qualche altro mestiere... “.
Se va a Roma, è per batter cassa per la sua Università. Il nuovo direttore amministra-
tivo, Luigi Stasi, ricorda che al ritorno da una di tali questue può annunciare agli im-
piegati: “Vi ho portato un regalo di Pasqua!”. E i bidelli, quando ne parlano tra loro, lo
chiamano affettuosamente “el zio”.
Nel 1950 gli tocca in sorte di inaugurare la nuova sede dell’Università, alta sulle pen-
dici del Carso a dominare tutto il golfo. Non è solo una questione formale e burocrati-
ca: le stanze devono essere arredate, i ruoli amministrativi e didattici devono essere al
completo, e ci sono da sistemare le nuove facoltà di Scienze politiche, Scienze naturali,
Ingegneria, Chimica, Fisica e Matematica. Durante la cerimonia che apre l’anno ac-
cademico e insieme inaugura il brutto edificio iniziato a costruire nel ‘38 accade
l’incidente che gli costa il terzo rinnovo della carica e il suo definitivo allontanamento
da Trieste. È presente il ministro Guido Gonella, buon conoscente di Ermanno. Ma nel
bel mezzo della benedizione della nuova sede, officiata da monsignor Santin, i goliardi
si mettono a sghignazzare e a fare gesti rumorosi più consoni a un’osteria che a
un’aula magna. La chiassata continua, secondo un copione tipico della goliardia ita-
liana di quegli anni, anche durante il discorso di Gonella.
La cerimonia finisce dopo che studenti e professori sono venuti alle mani: che Erman-
no non riesca a imporre la calma viene interpretato come un segno di debolezza, inde-
gna di chi ricopre la carica di rettore. È la fine del suo prestigio accademico e della sua
permanenza all’Ateneo triestino. Lui lo capisce benissimo e incomincia a darsi da fare
per trovare un’altra università dove insegnare. Non prima, però, di aver punito i re-
sponsabili della gazzarra: tra i quattro individuati come caporioni c’è anche Fulvio
Anzellotti, nipote di Italo Svevo e futuro dirigente dell’importante industria di fami-
glia in cui era impiegato il suo ben più illustre ed educato parente. Rileggendo i verba-
li degli interrogatori (svolti dal Senato Accademico), sembra di capire che Anzellotti
sia il meno colpevole, ma ciononostante viene punito come gli altri: il divieto di pre-
sentarsi agli esami per un anno è un eufemismo che significa l’espulsione dall’ateneo.
Il vero responsabile, Tullio Boglich, paga comunque il prezzo più pesante perché il
giorno dopo la cerimonia avrebbe dovuto laurearsi (potrà farlo appena un anno dopo,
dopo essere emigrato in un’altra università). (L’anno seguente, a tre dei cinque impu-
tati la pena verrà cancellata, mentre ai due succitati viene confermata l’espulsione
dall’ateneo con una lettera indirizzata a tutte le università italiane.)
Lea, che accetta in silenzio tutto questo putiferio e il fatto di avere un marito part-
part-time, si dedica a crescere il figlio, che ha tutta l’aria di essere un enfant prodige.
Nei ritagli di tempo, la sera soprattutto, la coppia si ritrova con gli amici (alcuni veri,
alcuni tali solo per bieca convenienza) al Caffè San Marco. Il distratto filosofo ha avu-
to fiuto: la moglie, donna piacente ed elegante, vivace conversatrice, recita a meravi-
glia il ruolo di rappresentanza che le viene richiesto dalle circostanze (“Ma che noia,
quando attaccavano a parlare di politica o di filosofia!...”).
Le foto di questo periodo, che non sono (e non saranno mai più) degli autoscatti, mo-
strano un Ermanno invecchiato ben oltre l’età che ha, con lo sguardo ora stanco ora
ironico ma sempre fermo, come se si fosse imposto di portare una maschera consona al
suo rango. “Nella sua fisionomia”, ricorda Maltese, “la linea di una fronte quadrata ri-
velava il matematico del diritto. Ma egli di sé diceva: ‘Faccia da passaporto: bocca re-
golare, naso regolare...’”. Sul fatto che il suo naso fosse davvero “regolare” tutti quelli
che lo hanno conosciuto avrebbero qualcosa da obiettare. Più onestamente bisogna ri-
conoscere che era quanto meno degno dell’importanza del suo proprietario, e altret-
tanto visibile... Come del resto anche le orecchie.
A casa di un giovane docente universitario, Fabio Todeschini, il poeta Virgilio Giotti e
il direttore della Biblioteca generale dell’Università, Stelio Crise, gli hanno presentato
Anita Pittoni, che ha appena fondato le Edizioni dello Zibaldone ed è la compagna uf-
ficiale dello scrittore Giani Stuparich. Nessuno dei presenti sa, evidentemente, che i
due si erano conosciuti già prima della guerra, in occasione delle foto a Paola Costan-
tini che indossava le ultime creazioni della già famosa artista-artigiana. Anita non è
ricca di famiglia: è sempre vissuta del suo lavoro di artigiana della moda e
dell’arredamento e ora, per nutrire la sua creatura letteraria, non esista a vendere i
pezzi più belli e premiati della sua pregressa attività. Ermanno non è un grande e-
stimatore dell’arte moderna e per di più, nonostante la sua amicizia con l’arcivescovo,
è un anticlericale. La nuova sede, realizzata fedelmente su un progetto approvato da
Mussolini in persona, non gli piace. Tuttavia non esita ad acquistare il grande arazzo
della Pittoni con le “Storie di san Francesco” per decorare il grande e squallido salone
che ospita l’Aula Magna; così come acquista (ma probabilmente con ancor minore con-
vinzione, perché l’autore è stato notoriamente fascista) il bassorilievo di Marcello Ma-
scherini, anch’esso tuttora visibile nella stessa Aula, nonché la statua della Minerva,
posta sull’angolo della facciata principale.
Nella damnatio memoriae di cui lo fa segno la città dopo la sua morte incappa anche
l’arazzo della Pittoni che, in una pubblicazione commissionata e pagata dal Comune
in onore di Anita, risulta essere stato acquistato dal rettore... Domenico Costa (che ta-
le non è mai stato)!
Il 10 marzo 1951 vengo al mondo io, seconda e ultima erede. Sul nome da darmi si ac-
cende l’unica vera discussione che i coniugi Cammarata abbiano avuto in ventiquattro
anni di matrimonio. La spunta la lontana ma imperiosa nonna catanese, e io risulto
all’anagrafe Maria Linda. Ma per tutti, da subito, è pronto il compromesso: Marilì,
come una delle figlie di Luigi Biamonti.
Nel momento in cui vedo la luce, vicino a mia madre, oltre all’ostetrica, c’è solo la
nonna Itala. Papà è impegnato, imprigionato tra le più alte cariche della città – im-
maginiamoci con quale spirito – nella cerimonia dell’inumazione dei resti dei poveri
marinai della corvetta “Berenice”, una nave affondata a poche miglia dalla costa giu-
liana il 9 settembre 1943, finalmente ripescati. Chissà se ricorda che la sorellina An-
na Elide era nata e morta nello stesso giorno dello stesso mese, 41 anni prima. E se se
lo ricorda anche sua madre.
Tempora mutantur... Niente più peana sui giornali locali per la mia urlante venuta al
mondo. Anzi: nel laconico trafiletto del “Giornale di Trieste” che mi annuncia, divento
“Marilli”.
Col senno di poi si può ben dire che per mio padre la mia nascita è l’avvenimento più
importante e faticoso dell’anno. Non solo i miei genitori continuano a essere privi di
domicilio stabile (nel frattempo per ospitare i docenti dell’Università non residenti
mio padre ha fatto costruire un intero palazzo, di cui non usufruirà mai), ma io mi
prendo la briga di scambiare il giorno con la notte, col risultato che per trentanove
notti consecutive l’imperativo è: “Nessun dorma!”. Curvo sulla culla da dove lo guardo
con grandi occhi spalancati e disperati, papà mormora sconsolato ma profetico: “Indi-
pendente di sinistra...”. Ne ho ben donde di protestare: allergica al latte materno, ri-
schio, a quattro mesi, di lasciarci la pelle. In estate la famiglia si mette in viaggio per
Catania. Al ritorno, di passaggio a Roma, vengo visitata da un pediatra amico degli
Aiello, il dottor Cammarella, che subito azzecca diagnosi e cura. Sono salva.
Il 1952 è l’ultimo anno del lungo soggiorno triestino di Ermanno. Ricevuta la chiama-
ta dall’Università di Napoli per la cattedra di Filosofia del diritto, scatta la ricerca
della nuova sistemazione. Non la città partenopea, come sembrerebbe ovvio, perché
Ermanno sa che ancora troppo profonde sono lì le ferite belliche e il livello delle sue
istituzioni scolastiche lascia molto a desiderare, ma Roma, che è poi il sogno segreto di
sua moglie. Lea vi è già stata, in divisa da Giovane Italiana, nel 1933, con un gruppo
di coetanee capitanate da Livia Veneziani vedova di Italo Svevo e da una cugina di I-
talo, che è anche sua zia. Bianca Luzzatto Fano (ha sposato l’ingegner Angelo Fano,
fratello di Itala) in famiglia è già una leggenda, sia per il carattere estremamente de-
ciso, sia perché è stata una delle prime donne triestine a prendere la patente e a gui-
dare (piuttosto spericolatamente, pare) una lussuosa Fiat per le vie ancora tranquille
della città appena “redenta”.
Grazie a uno degli innumerevoli amici siciliani di Ermanno, il proverbiale “uomo giu-
sto al posto giusto”, la casa viene in breve tempo trovata: è quella dove mia madre ha
vissuto per oltre mezzo secolo e dove io ho abitato fino ai 25 anni.
Nel frattempo Ermanno cerca un successore alla cattedra triestina di Filosofia del di-
ritto. Il suo interesse si appunta su un collega giovane ma che già si è fatto conoscere
nell’ambiente, Pietro Piovani. Gli scrive, sic et simpliciter: “Vuol venire Lei?”. Piovani,
che è in trattative con l’Università di Modena, non esita. Da Napoli il 23 maggio scri-
ve: “Le rispondo senz’altro: sì. [...] Perché, avendo avuto, occasionalmente, la fortuna
di essere, qui a Napoli, pro tempore, Suo ‘predecessore’, non posso, certamente, rinun-
ciare all’onore di essere, sia pure immeritatamente, Suo ‘successore’ a Trieste.”. E in
chiusura aggiunge: “Stia tranquillo per quanto riguarda il Suo messaggio [sulla que-
stione di Trieste]. Esso è stato letto per intero, in pubblico teatro, dal Suo illustre ami-
co On. Lamalfa: nessuna possibilità di interpretazione non chiara. Fu inteso benissi-
mo, applaudito dalla folla in piedi, riprodotto dalla stampa: il Partito Repubblicano ne
ha anche fatto affliggere frasi su manifesti che si leggono nelle strade (in questi giorni
di baraonda elettorale divenute, come certamente anche a Trieste, ‘sale di lettura’)”.
Nasce da qui uno degli inesorabili e fantasiosi soprannomi riservati ai più intimi,
“Don Pedro”. Il quale, peraltro, dimenticherà ben presto stima e riconoscenza nei con-
fronti del più anziano collega, che invece ha conservato immutata la simpatia per lui.
Dunque, non resta altro che espletare le ultime formalità, passare da un banchetto
d’addio a un altro, promettere che dalla capitale Ermanno farà di tutto perché la
“questione Trieste” si concluda a favore dell’Italia e poi via, armadi e bagagli, si tra-
sloca a Roma. Un trasloco comprensivo di mobili, figli, moglie e libri non è certo a por-
tata del suo stipendio di professore. Ed ecco che da New York arriva il dono del gran-
de amico Max, un conto aperto in una banca italiana a suo nome.
Bisogna dire che molto probabilmente, non fosse stato per l’increscioso incidente del
1950, non solo Ermanno sarebbe stato rieletto per la terza volta ma anche, allo scade-
re di quel mandato, sarebbe volentieri rimasto a insegnare a Trieste. La città gli ri-
corda, posta com’è sul mare, Catania e, confesserà lui stesso, arrivato qui con una
mentalità improntata al cosmopolitismo, si è fatto contagiare dal nazionalismo irre-
dentista che ancora vi spira, e ha riscoperto di essere prima di tutto cittadino italiano
e di voler sottrarre il mai nato Territorio Libero alle sgrinfie di Tito.
“Il Rettore Cammarata dovette abbandonare Trieste”, scrive Crise, “nel novembre del
1952. Egli che era stato disinteressato campione della civiltà italiana di Trieste partì
povero, dopo aver amministrato centinaia e centinaia di milioni, lasciando dietro di sé
un’alta eredità morale che la borghesia triestina era intrinsecamente negata a inten-
dere”.
Tornerà molto spesso, soprattutto nei primi anni romani. Le sole foto a colori del “ri-
torno” di Trieste all’Italia dell’ottobre-novembre 1954 sono le sue: neppure i grandi fo-
tografi e fotoreporter locali, accreditati o no, possono permettersi, a causa dei costi
proibitivi, di scattarne qualcuna. Per di più il punto di ripresa dell’arrivo delle navi e
della folla assiepata sulle Rive è privilegiatissimo: il balcone del Palazzo della Prefet-
tura, in piazza Unità.
La partenza di Ermanno fa felici molti: dagli americani ai comunisti filoslavi ai capo-
rioni della Democrazia Cristiana, che lui fin da allora chiama “merdocratici” e che non
possono sopportare le sue mani pulite.
1953-1971
Oggi un rettore, al pari di un politico, molto spesso aspetta che lo si vada a omaggiare,
presenzia il presenziabile e spende parte del suo tempo a costruirsi la carica di presiden-
te di qualche importante ente locale o nazionale, carica di cui verrà insignito il giorno
stesso della sua non-rielezione. Ermanno, smessi i panni rettorali, torna semplicemente
al suo mestiere, quello di professore universitario.
La tradizione di famiglia non accoglie nessuna leggenda sul trasloco di una famiglia di
quattro persone più mobili, libri, regali dell’ultimo minuto, baci, abbracci e, sicuramente,
molte lacrime della nonna Itala, per la quale ogni arrivo e ogni partenza erano fonte di
intensa commozione, dettata da un cuore che, con l’avanzare dell’età, si faceva sempre
più tenero. Manlio, poi, a detta degli altri cugini, era il suo preferito.
Ma esaminiamo più da vicino il materiale traslocato con pugno di ferro da Lea: oltre a
due figli piccoli (io ho appena un anno e mezzo), ci sono i mobili. Di famiglia, direte voi.
Neanche per idea: sono stati quasi tutti comprati di seconda mano dai rigattieri triestini
(a parte qualche pezzo comprato in seguito da quelli romani), scuri, robusti, rigorosa-
mente anni ‘40 e altrettanto rigorosamente privi di fronzoli. Un incubo di razionalismo.
Lea ed Ermanno hanno fatto a gara per spendere il più oculatamente possibile il denaro
di Max. E a questo proposito c’è, sì, una leggenda familiare. Un giorno – siamo ancora
nel cosiddetto Territorio Libero di Trieste – Lea torna a casa trionfante con un portace-
nere (in fatto di sigarette si è fatta contagiare dal marito appena sposata) dicendo:
“Guarda. Il negoziante voleva 100 lire, ma io sono riuscita a portarglielo via per 60!”.
Ermanno fissa brevemente l’oggetto e la prende in giro: “Ah, sì? Secondo me l’hai pagato
troppo...”. S’infila la giacca ed esce. Torna dopo mezzora con un altro portacenere, identi-
co al primo e proveniente dal medesimo negozio. Butta lì con finta indifferenza: “L’ho
pagato 50”. Il gioco del tirare sul prezzo è e rimarrà sempre il loro preferito.
I regali che Ermanno ha ricevuto quando ha lasciato l’Università sono molti. Oltre alle
inevitabili medaglie (dell’Università stessa e del Comune), ci sono utili oggetti da scriva-
nia, tra i quali un bell’orologio di vetro e una lampada da tavolo snodabile. Entrambi re-
cano l’etichetta che ricorda i donatori. Dietro uno di questi si cela un giallo, o meglio
l’ennesima dimostrazione che i triestini non riescono ad mettersi d’accordo nemmeno
quando si tratta di fare un regalo.
C’è infatti la lettera di tale Nestore Brunisek che si ritiene obbligato a sottolineare che il
dono della lampada è stato fatto da tutto lo staff dei tecnici dell’università “assieme ad
amministrativi e subalterni”, e non solo (mi pare di capire) da quelli di un certo sindaca-
to. La lettera è del 29 ottobre, quando ormai Ermanno non è più rettore, ma ugualmente
lo scrivente lo chiama con il titolo accademico. Non è il solo. Stelio Crise, il direttore del-
la Biblioteca Generale, continuerà per tutta la vita a scrivere “Mio carissimo Rettore”!
I goliardi gli hanno fatto dono del loro stemma, un collare con appesa una “medaglia” di
legno colorato: si tratta di un cerchio, sopra il quale è scritto “Noi”, che racchiude una
chiave e un remo incrociati. Un innocuo e plateale rebus di chiara impronta sessuale…
Nel giro di pochi mesi il trasloco è ormai dimenticato e la famiglia Cammarata inizia un
tran tran esistenziale che durerà circa una ventina d’anni e che mi è possibile seguire
grazie alle molte lettere scritte al grande amico Max, ormai completamente americaniz-
zato.
Lontano dai problemi tergestini e coccolato da una moglie innamoratissima, Ermanno
ormai può rilassarsi, nella misura in cui glielo permettono il suo sistema nervoso e la si-
tuazione politica italiana. Da un lato comincia a ingrassare, o meglio a mettere su una
vistosa pancetta “da commendatore” – oltremodo buffa, per noi bambini, in quanto pog-
gia su lunghe ed esili gambe dalla pelle bianchissima – dall’altra il clima della capitale,
più umido rispetto a quello di Trieste, comincia a fargli scricchiolare le ossa.
Le rare foto di questi ultimi lustri conservano l’immagine di un uomo invecchiato anzi
tempo, che solo nello sguardo ha lampi di vivace ironia e filosofico distacco dalle cose del
mondo.
Per di più i travagliati anni del rettorato gli hanno messo a cronico subbuglio il sistema
digestivo. Da queste e altre piccole magagne nasce il primo rito: quello di “passare le ac-
que” e i fanghi a Porretta Terme, ogni estate. Ci va con la moglie, dopo aver scaricato la
prole in altro luogo, si tratti delle terme di Salsomaggiore o della pensione per bambini
in Valtellina. Né a uno dei due sorge il dubbio che, essendo il pater familias costretto a
fare il pendolare con Napoli per tutto l’anno, l’estate sarebbe il solo periodo nel quale
rinsaldare i legami pratici e affettivi tra lui e i figli. Anche il soggiorno triestino, in casa
della suocera, non viene sfruttato: mentre il resto della famiglia si abbrustolisce sulle ri-
ve sassose del golfo, lui se ne va a chiacchierare beatamente con i vecchi amici. E la sera,
come una volta, i coniugi, affidati i bambini alla nonna, tengono salotto al Caffè San
Marco.
Quanto è lontano dal pensare che tale assenza fisica ed emotiva nei confronti dei figli sia
deleteria per tutta la famiglia lo dimostra questo suo sfogo epistolare al solito Max: “La
prole cresce, e con essa le preoccupazioni per il suo futuro [...] ti assicuro che vi sono
momenti in cui rimpiango di aver messo su famiglia, caricandomi di responsabilità e di
preoccupazioni a non finire”.
Eppure, questa prole è tutt’altro che pessima: nel fatidico (e per lui poco comprensibile)
‘68 confessa a Max, quasi con un sospiro di sollievo, che “Manlio [...] non è ‘capellone’,
non ‘protesta’ né ‘contesta’, ma è preso dalla smania di guadagnare [...] [Marilì] studia in
collegio per l’ultimo anno del Liceo classico [...] a diciotto anni è alta e robusta come sua
madre e minaccia, purtroppo, di andar oltre [...]”.
Non è dunque un caso che di mio padre io abbia così pochi e così vaghi ricordi legati al
tempo dell’infanzia. Non ne rammento la fisionomia ma ho la sfumata percezione di un
uomo anziano, che non gioca e non esce mai con me perché, rinchiuso nel suo studio pe-
rennemente saturo di fumo, deve “lavorare” e che, quando proprio si sente di dirmi qual-
cosa di affettuoso, srotola un rosario di aggettivi quali “carogna”, “faccia da schiaffi” e
amenità varie.
Su una cosa non transige: il divieto di chiamarlo, sia pure per scherzo, “babbo”. E come
dargli torto? “Babbo” in siciliano significa “scemo”…
Sobillato dalla mamma, ricicla, a favore della prole altrui, i regali di un certo valore che
alcuni suoi amici fanno a me o a Manlio: “Non ve li meritate” o “Per voi è troppo” è
l’unica spiegazione che ci viene data mentre sopra le nostre teste passano rapidi piccoli
gioielli, portafogli di vera pelle o altri oggetti di pari valore. Solo una volta punto i piedi e
vinco: quando Carletto Amigoni mi regala una tracolla di Gucci. La protesta è per la
forma, molto pratica, non certo per la griffe di cui non so e non m’interessa nulla.
E Trieste (o meglio, i triestini)? Accortisi troppo tardi di quanto hanno perso, per anni lo
perseguitano perché si faccia portavoce nella capitale delle loro miserie politiche ed eco-
nomiche. Le loro lettere grondano affetto e nostalgia: ma perfino amici carissimi come
Carletto Amigoni e Stelio Crise non sanno scrivere altro che per comunicargli le depresse
visioni della (loro) vita e del mondo. Di queste due menti finissime resta un cospicuo
numero di missive che mettono tristezza perfino a rileggerle a distanza di mezzo secolo.
Proprio quello che ci vuole per uno incline alla malinconia come Ermanno...
In una delle lettere di Crise, uomo di vastissima cultura e di penna felice pur se a volte
incline alla retorica, si legge: “[...] so, per esperienza, lo dico sans amertume, ch’Ella non
gradisce mai d’esser fatto oggetto di confessioni”. Immaginiamoci se lo fosse stato! Del
resto, non è triestino il carissimo amico che si è offerto di farmi da padrino, suicida di lì a
pochi anni? Come pure si suiciderà la buona e brava levatrice che mi ha aiutato a nasce-
re...
Anche Ermanno, però, ha nostalgia di Trieste, e con la scusa di una conferenza o di un
congresso, o semplicemente per accompagnare moglie e figli ospiti della suocera durante
l’estate, vi torna ogni anno a farsi tiranneggiare.
Ricorda Luigi Stasi: “Ci scriviamo spesso quando non ci ritroviamo in visita a Trieste con
gli amici più stretti: Crise, Amigoni, Arduino Agnelli, Pio Montesi, Giulio Cervani e
qualche altro suo collega di vecchia data. Si parla di tutto, di varia cultura, dell’attività
accademica, della politica locale e nazionale, di formalismo giuridico... Ma la sua atten-
zione e il suo interessamento si rivolgono anche ai fatti personali di ciascuno degli amici.
Personalmente coinvolto e in certo modo vittima della politica restauratrice del conser-
vatore Agostino Origone, che gli è subentrato quale rettore, Cammarata segue da vicino
le mie vicende di dirigente amministrativo dell’Università determinato a lasciare Trieste
e ogni altro pubblico incarico per altro ateneo. Interviene personalmente presso il Mini-
stero per sostenermi nell’azione di supporto alla creazione del Centro internazionale di
fisica teorica voluto da Paolo Budinich, e con lo scritto e con la parola mi convince a ‘non
mollare’, a resistere al mio posto di lavoro e nella altre attività pubbliche locali”.
Non che a Roma gli manchino gli amici, anzi: ha ritrovato antichi colleghi d’università e
vecchi amici della giovinezza, come il cardiologo Luigi Condorelli, fratello di Orazio, i
Biamonti, gli Ederli, gli Aiello, e se n’è fatti altri. I coniugi vanno spesso fuori la sera,
dopo aver affidato i figli alle mercenarie mani di una colf o, se è il periodo giusto, in quel-
le più fidate, ma ben più severe, dell’anziana ex-governante di casa Ravenna. Per Mad-
dalena Lea nutre un affetto e una fiducia sconfinati: non la sfiora nemmeno il dubbio che
i metodi che costei adottava negli anni ‘20 per i figli del professor Ravenna non siano più
così giusti per quelli del professor Cammarata. E così, alla sua severità e alla sua pro-
pensione a quotidiane e robuste punizioni corporali si aggiungono quelle della terribile
vecchietta...
A causa del suo carattere e dei bisettimanali viaggi a Napoli, papà non è dunque mai
stato molto presente nella mia vita: direi piuttosto che la sua è stata, quando c’è stata,
una presenza assente, fatta di una delega in bianco alla moglie per la conduzione della
casa e la nostra educazione. Questa delega è stata usata fino in fondo, e oltre. In più, la
mamma non ha mai smesso di alimentare in noi il mito del padre Magnifico Rettore,
Grande Filosofo e Migliore degli Uomini Possibili: un pericolosissimo e rischiosissimo la-
vaggio del cervello del quale il protagonista principale non si è probabilmente mai reso
conto, per distrazione o per quieto vivere. Che solo su di lei si regga la famiglia lo dimo-
stra il fatto che, quando viene messa ko da una forma non grave di epatite virale, un
uomo molto spaventato confessa a Max che “lo scombussolamento della vita familiare
non è stato di poco conto”.
Ma il suo comportamento a volte davvero eccessivamente duro e nevrotico non doveva
piacergli del tutto. Una volta sbottò in una critica, forse l’unica di fronte ai figli, tanto
azzeccata quanto feroce ed asciutta. Eravamo a tavola, nell’unico momento di tutta la
giornata in cui lui usciva dallo studio per unirsi a noi. E mia madre iniziò con una delle
sue solite geremiadi sul fatto che, in quanto femmina, non le dessi il minimo aiuto in ca-
sa (cosa peraltro solo in parte vera). Io tacevo, come sempre, e alla fine, non sapendo più
cosa aggiungere al rimprovero, finì col rinfacciarmi: “Io alla tua età, mentre studiavo,
spazzavo e pulivo casa…”. E lui, secco e inappellabile: “È così che ti sei rovinata i nervi.”.
Un silenzio di tomba scese sulla tavola. Perfino lei ammutolì. Lo guardò imbarazzata e
con un lampo di odio negli occhi: probabilmente non si aspettava di vedersi sminuita
proprio da chi, evidentemente, non l’aveva mai criticata così duramente.
Direi una bugia se affermassi di essere certa che ci amava, perché per farlo dovrei prima
di tutto essere certa che, oltre alla sua filosofia e alla sua famiglia d’origine, era in grado
di amare la vita. Lui, almeno, non mi ha mai picchiato. Solo una volta, esaurita tutta la
scarsa pazienza di cui era provvisto nei confronti dei bambini, mi sbatté fuori dallo stu-
dio con un calcio: ma era inverno e le sue pantofole erano di morbido feltro.
Distratto, mio padre: al punto di non accorgersi, per esempio, che quella che aveva in
mano non era la bottiglia dell’acqua ma quella dell’olio. Accortosi dello sbaglio quando
ormai il bicchiere era ormai pieno a metà, sussultava ed esclamava: “Ossanpantaleoaba-
teeprotomartire! Che gran distratto!...”, mentre io e mio fratello scoppiavamo in una to-
nante e poco rispettosa risata, per il fatto in sé e per quell’invocazione – a un santo a noi
sconosciuto e sicuramente non protomartire – così in disaccordo con il suo proclamato
anticlericalismo.
E pigro: una volta, avuto l’incarico di far parte di una commissione d’esami universita-
ria, dopo aver sopportato per un po’ quella passerella d’ignoranti, si appoggiò con aria
teatrale alla sedia esclamando: “Questo non è un incarico, è un lavoro…”.
Nel mangiare era molto parco, per indole e per una lieve forma di ipocondria gastrica:
col senno di poi, però, ho scoperto che certi abbinamenti di cibi che rifiutava affermando
che gli facevano “l’ascensore” o “conflitto” nello stomaco sono proibiti dalla cucina macro-
biotica (come il formaggio con il pomodoro). Ma doveva privarsi anche di cose delle quali
era ghiotto. Capitava per esempio che, quando arrivava in tavola l’uva, la guardasse so-
spettosamente da sopra gli occhiali, poi allungasse timido la mano, ne staccasse due o
tre acini dicendo: “A quanto vedo...”, e si accingesse pazientemente a mondarli di semi e
buccia. In caso contrario gli avrebbero fatto “l’ascensore”...
Credo di poterlo definire un uomo in fuga: di fronte a qualsiasi difficoltà, superato a fati-
ca l’iniziale stato depressivo, si rifugiava nella filosofia, boeziana consolazione di tutta la
sua esistenza.
Conservo ancora la sola lettera che mi ha scritto in tutta la sua vita: è dell’estate del
1967. Poche righe, scritte con una calligrafia al limite della linea retta, tutta giocata sui
toni dell’ironia e che comincia con un distaccato “Cara la mia secondogenita...”.
C’’è da dire che, sempre per quel vizio di giocare con i nomi o di appioppare soprannomi,
ancora oggi alcuni suoi amici vengono ricordati più per questi ultimi che per il nome vero
(chi era “Mezzo spicchio di mandorla amara”?): “Faccia di merluzzo bollito” è l’insigne
professor Edoardo Volterra, “Faccia da pitale antico” l’ancor più insigne Giuliano Vassal-
li... Il più fortunato (se così si può dire) è forse l’amico e collega siciliano Ernesto
D’Albergo, tanto generoso quanto vanitoso e donnaiolo – e, durante il fascismo, un tanti-
no razzista – cui spetta un apparentemente banale “Ernesticchio”: ma “sticchio”, in sici-
liano, è una parola molto volgare, l’equivalente della “mona” dei veneti... E che dire di
uno dei suoi successori, il rettore Origone? Per il suo fare sempre impettito gli spetta il
titolo di “nobile-solenne-e-crepuscolare Agostino”. Non era raro, al contrario, che a tavola
qualcuno dicesse: “Mi passi l’origone (l’origano) per favore?”. L’amico filosofo Giacomo
Perticone è, dal canto suo, il “sagg-e-prode Giacumine”. Verso la fine degli anni ‘60 gli
arriva in omaggio la rivista “Il Cavour”, fondata da Umberto Allioni di Brondello. La ri-
vista, spiccatamente destrorsa, non gli piace. Ed ecco che il poveretto diventa Coglioni di
Bordello... Per uno strano destino le loro tombe si guardano da un lato all’altro dello
stesso viale del cimitero del Verano a Roma.
Ma la ferocia del soprannome è, quasi sempre, direttamente proporzionale all’affetto che
nutre per i malcapitati destinatari, come dimostra la dedica che Paneperso/De Mattei gli
indirizza nel 1934 inviandogli una sua pubblicazione, Studi campanelliani: “Al caro Er-
manno, questo pane speriamo non perso del suo Rodolfo”. Ed è “Ernesticchio” a donare il
marmo delle sue cave carraresi per la tomba dell’amico scomparso e a pronunciarne
l’orazione funebre; è “Ernesticchio” l’unico dei suoi amici a farmi da padre al momento
della laurea donandomi una somma tale da consentirmi, l’anno dopo, viaggio e perma-
nenza di 10 giorni in Inghilterra.
Il fatto che questo tipo di famiglia non fosse del tutto uguale a quelle dei nostri compa-
gni di scuola non sembrava (apparentemente) turbarci più di tanto: nostra madre era ri-
uscita a fare dell’eccezione la regola e come tale ce l’ammaniva. Del resto, si contano sul-
la punta di due dita le case altrui che noi bambini (e poi adolescenti) avevamo il permes-
so di frequentare: come avremmo potuto fare confronti?
Siamo stati i primi, negli anni Cinquanta, ad avere i libri di scuola foderati con la plasti-
ca trasparente, che lei cuciva a macchina, su misura, numerando a mano perfino le pa-
gine di tutti i nostri quaderni: guai se ne strappavamo una!
L’unica nota positiva era data dal fatto che le sere in cui papà era a Napoli, in Sicilia o
comunque fuori casa, cenavamo in una rosticceria di corso Trieste oppure – trasgressione
delle trasgressioni! – portavamo calzoni e supplì a casa e li mangiavamo direttamente
sulla carta del negozio, senza piatti e senza posate: insomma, come si diceva nel latineg-
giante lessico famigliare, “alla porci maniera”. Ci sembrava di consumare il massimo del
proibito possibile.
Aveva una grande passione per le radio a transistor. La prima, una Toshiba grande co-
me un pacchetto di sigarette, fece la sua comparsa alla fine degli anni ‘50. Gli era caris-
sima e non voleva che nessuno la toccasse: per molti anni fu l’unica radio e l’unica fonte
di musica e notizie esistente in casa. Poi, negli anni ‘60 ne comprò di sempre più piccole.
L’ultima che mi regalò misurava sì e no 5-6 centimetri per lato. Il giradischi dovette re-
galarcelo la nonna Itala, nel 1960: era una delle famose offerte di Selezione dal Reader’s
Digest e ci fece toccare con mano i primi ellepì della nostra vita. Manlio e io scoprimmo
così i grandi dell’Ottocento, il tango, il valzer. Alla chetichella, qualche anno dopo, arri-
varono Endrigo, Paoli, Nini Rosso....
Altre sue passioni erano gli orologi (ne ricordo tre, uno più bello dell’altro: uno Zenith,
un Tissot e un Rolex. A perdere sbadatamente il primo sono stata proprio io, e ancora
non me lo perdono) e le penne. Prima le stilografiche poi, perché più comode e leggere, le
biro. Negli ultimi tempi, quando faticava a tenerne una in mano, si era affezionato a un
tipo sottile e bruttino, la Lyretta. Lo avevo fatto felice, un giorno, regalandogliene una
mezza dozzina.
La televisione, in quanto invenzione americana, per lui era esecrabile: cedette, di fronte
alla prospettiva di un’estate senza vacanze extramoenia, appena nel 1968: arrivò il gior-
no dell’invasione della Cecoslovacchia. L’unico programma che gli piaceva era la serie di
telefilm di Padre Brown, con Renato Rascel.
Tra le altre diavolerie moderne che detestava c’era l’aria condizionata.
Se voleva discutere di politica gli bastava andare a trovare Augusto Guerriero, il famoso
Ricciardetto che fustigava gli italiani dalle pagine di “Epoca” (proprio come ha fatto poi
Montanelli dalle pagine del “Corriere della sera”), che abitava poco lontano, in viale XXI
Aprile. “Don Augusto” e papà discorrevano per ore. Ricordo che una volta mi portò con
sé: immobilizzato in una poltrona vidi un anziano e magro signore dagli acquosi occhi
azzurri che parlava un italiano fortemente venato di napoletano, ma ero troppo giovane
e troppo ignorante per coglierne il fascino intellettuale. Ricciardetto aveva nominato mio
padre, che gli dava sempre rispettosamente del voi, suo esecutore testamentario: fato
volle che, pur essendo più anziano e più malandato di lui, gli sopravvivesse ancora di ben
dieci anni.
Di certo, anche quando era a casa, passava più ore a parlare con gli studenti e con gli as-
sistenti del suo corso che con noi. Venivano spesso a trovarlo, nel tardo pomeriggio: io o
Manlio li accompagnavamo nel suo studio e poi dovevamo sparire, facendo ben attenzio-
ne a non disturbarli con i nostri giochi o, più spesso, con le nostre baruffe. Anzi, per me-
glio salvaguardare la pace domestica, mia madre ci spediva fin quasi a ora di cena a casa
della maestra di mio fratello, che teneva, a pagamento, una specie di doposcuola a metà
strada tra il metodo Don Milani (i grandi che sentivano la lezione ai piccoli) e il corso di
recupero. Per tutte le elementari siamo stati da lei costretti a fare almeno un tema in
più al giorno. Ma anch’io, come papà, ero (e sono) molto pigra: così, per riempire le tre
facciate obbligatorie di frasi in buon italiano e senza errori di ortografia – altrimenti vo-
lavano urli, scappellotti e tirate d’orecchie – avevo inventato un metodo molto efficace:
scrittura larghissima, una riga sì e una no...
Tra i giovani che spesso con aria deferente si affacciavano alla porta di casa c’erano nomi
oggi piuttosto noti: dal futuro maître à penser del Pci Biagio De Giovanni al suo futuro
successore alla cattedra romana, Francesco Mercadante. Venivano, come ho detto, a me-
tà pomeriggio e se ne andavano, i vestiti impregnati dal fumo delle sigarette del loro
“maestro”, a ora di cena. Sarà mai passato per la mente di costoro che il tempo che dedi-
cava a loro era sottratto ai figli?
De Giovanni è stato sicuramente uno degli allievi prediletti di mio padre e gli causò un
grande dolore quando approdò nel porto dei suoi acerrimi nemici politici. Le porte della
carriera universitaria gliele aveva spalancate proprio lui, qualche anno dopo la laurea.
Una laurea con il massimo dei voti: quella volta, come del resto oggi, si poteva dare la
lode a chi scriveva di essersi dovuto operare di “tonzille”. Non c’è da stupirsi se paterna-
mente gli suggerisce di rimandare la pubblicazione di un lavoro perché scritto in manie-
ra poco chiara!
Per Mercadante aveva grande stima e affetto, tant’è vero che quando qualcuno di noi fa-
ceva notare che, sì, sarà stato anche bravo, ma con quel cappottone e quel cappello pe-
rennemente calato sugli occhi aveva più l’aria di un commissario di polizia che di un filo-
sofo, papà ridacchiando lo difendeva: “Mercadante? ‘Contadino, scarpe grosse e cervello
fino!’”.
Sta di fatto che il primo, dopo la sua morte, a rendersi conto delle difficoltà finanziarie
della famiglia (quella volta la pensione di reversibilità arrivava molti anni dopo il deces-
so del titolare) è stato proprio Mercadante, il quale mi offrì un posto di correttore di boz-
ze presso la Giuffrè, del cui fondatore aveva sposato un’erede. Ed è stata mia madre –
forse con scarsa lungimiranza – a farmi rifiutare l’offerta, con il pretesto che dovevo fini-
re l’università. Correttrice di bozze lo sarei diventata comunque, ma quindici anni dopo.
Stimato com’è, Ermanno crede che gli sia possibile fare il grande salto: essere nominato
giudice della Corte Costituzionale. Ma allora, come oggi, ciò richiede molto tatto, molta
diplomazia, molti amici influenti e... avere la tessera di un partito che conta. Lui non
possiede niente di tutto questo, e la nomina, che insegue ancora per una dozzina d’anni,
non arriverà mai.
Mi chiedo perché ci tenesse tanto: per lo stipendio? per il prestigio? per avere una mac-
china con autista, come confessa a Max? perché pensa di poter meglio servire lo Stato?
per non sentirsi inferiore ad altri suoi amici o colleghi che lo sono diventati con minori
meriti accademici di lui? Domande che non avranno mai una risposta.
Magra consolazione, è stato insignito, nel 1955, della medaglia d’oro ai Benemeriti della
scuola, della cultura e dell’arte. L’anno dopo arriva qualcosa di più consistente: la nomi-
na a componente effettivo del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione sici-
liana: è un incarico di notevole prestigio, poca fatica, e per di più gli dà la possibilità di
andare spesso a Catania a trovare sua madre, ormai ottantenne. Lui stesso, parlandone
con Max Ascoli, la definisce una “pacchia”. E bisogna dire che la maggior parte dei mes-
saggi di rallegramenti e auguri gli vengono proprio dai suoi vecchi amici catanesi. Quelli
da Trieste si contano sulle dita di una mano.
Per la maggior parte di origine sicula sono le decine di regali che riceve a Natale e a Pa-
squa. Ricordo che in certi anni, fin quasi la metà degli anni ’60, la stanza guardaroba si
riempiva all’inverosimile di panettoni, dolci di mandorle, cassette di aranci e mandarini
(questi ultimi “Acireale doc”, dalle tenute dell’amico Cristoforo Cosentini), per non parla-
re dei fichi secchi e delle cotognate fatti e inviati dalla nonna Linda. Spesso questi pacchi
nel risalire la penisola “perdono” parte del contenuto. E papà, ironicamente rassegnato:
“Ringraziamo di ciò i compagni ferrovieri...”. Nessuno degli altri componenti della fami-
glia ha però mai capito perché si sottomettesse senza fiatare all’umiliazione di vedersi
regalare da Luigi Condorelli un uovo di Pasqua (uno delle molte dozzine che costui rice-
veva) già aperto e privo di sorpresa. Ultimi, dopo un viaggio durato inspiegabilmente pa-
recchie settimane, arrivavano dalla Svizzera grandi scatole di cioccolatini spedite su in-
dicazione di Max Ascoli.
Tale abbondanza scompare negli ultimi anni, segno non solo della prima crisi economica
nazionale dalla fine della guerra, ma anche della consapevolezza, da parte dei mancati
donatori, che papà, ormai alla fine della carriera, non ha quasi più “potere” accademico.
In compenso viene sommerso di bigliettini augurali, ai quali risponde con tanta fatica,
un po’ di rabbia e molto ritardo. Il panettone dei nostri ultimi due natali lo compra di ta-
sca sua.
Gli anni di Napoli sono abbastanza tranquilli, anche se neppure quell’università è esen-
te da tresche baronali e, da accenni che fa in alcune lettere, lui stesso ritiene quella sede
qualcosa di molto simile a un immeritato castigo accademico. Non è tanto il fare il pen-
dolare che gli pesa, quanto il fatto che, essendo la sua una materia obbligatoria per gli
studenti di Giurisprudenza, si ritrova sommerso, a ogni sessione, da decine e decine di
studenti, fino a cinquecento: “una marea urlante di cialtroni che cercano di farti fesso”,
come scrive al fido Max, che gli provocano un “continuo e sempre più veloce affievolirsi
della passione per l’insegnamento”. Non è un caso se in facoltà gira e girerà ancora a
lungo la “leggenda” che “Cammarata non tiene lezioni”. Tant’è vero che si dà da fare (in-
vano) per vedere se può riprendere a fare l’avvocato a Roma. Si rivolge perfino a un vec-
chio amico diventato senatore (Giovannino Leone?), ma: “ho avuto una gelidissima acco-
glienza, dopo di che mi sono fatto un dovere di non disturbarlo ulteriormente”. Sono gli
stessi anni e lo stesso ambiente così ben descritti nel film “Morte di un matematico napo-
letano”, nel quale sono stati inseriti o nominati vari suoi colleghi.
Crea poi mugugni il fatto che, in occasione di un concorso di cui è commissario due dei
suoi allievi, uno dei quali è il “valentissimo” Biagio Di Giovanni, risultino vincitori. “Mi
sono fatto la fama di mattatore” scrive a un amico. Ha ripreso a scrivere, oltre ad alcuni
articoli sulla posizione giuridica di Trieste città occupata e dallo status ancora incerto, di
filosofia del diritto. Poche pagine, ma in compenso prima l’Università di Trieste poi Cap-
pelli (le cui lettere che sollecitano l’invio delle bozze corrette fanno parte dell’aneddotica
famigliare: il vecchio vizio di correggere e ricorreggere... e non mettere mai la parola fi-
ne! “[...] da buon romagnolo, chissà quante volte mi avrà mandato al diavolo”, confessa a
Max) pubblicano una raccolta dei suoi saggi più importanti in un volume intitolato For-
malismo e sapere giuridico. L’ultimo saggio, scritto per l’occasione, serve a “metterne in
rilievo le manchevolezze. Non volendo dir male di alcuno, dirò male di me stesso!”, gli
scrive. Insomma, continua a lavorare “ossia a scrivere e a cancellare con ugual frenesia”,
quando non si dibatte “nelle spire dell’autocritica”.
Degli anni napoletani appena mezzo secolo dopo De Giovanni e Luigi Capozzi ricorde-
ranno il suo allora inconsueto metodo didattico. Racconta il secondo: “Era sparuto il nu-
mero dei discenti […] a raccogliersi intorno a Cammarata, in luoghi inusuali, quali un’Aula
universitaria o il Bar di Mezzocannone nell’appartata sala interna o anche in riservati locali
pubblici all’aperto nella zona di Posillipo, specie nelle giornate calde di primavera, allora
piene di sentori marini e profumi di fiori. Era una scolaresca nomade che si muoveva col
suo Docente, con un’efficienza inversamente proporzionale alla localizzazione talora ecce-
zionale dell’“Aula” dell’insegnamento, il quale si svolgeva su nodi difficoltosi di problemi,
che venivano sottilmente argomentati e felicemente sciolti, nello stimolo di animati dibatti-
ti”. E De Giovanni: “Cammarata aveva un governo del tempo assai più blando [di Piovani,
il surricordato Don Pedro], conversevole, gli studi intensi appartenevano ormai al passato,
ed egli preferiva, a quel punto della sua vita, le lunghe passeggiate periparetiche con noi
giovanissimi allievi (Gino Capozzi, il sottoscritto e qualche altro che talvolta si aggiun-
geva, e, da un certo momento in poi, Enzo Oliveri: i sodali costanti erano questi) ai quali
partecipava le sue riflessioni sempre più sottili, sempre più sofisticate e filiformi, sui temi
che erano stati costantemente i suoi: formalismo giuridico e dintorni. E poi, naturalmen-
te, si parlava anche di varia umanità. […] il suo incubo (ma “in idea”, perché vi partecipa-
va assai poco, affidandosi a noi che allora ne facemmo scorpacciata) erano gli esami, e
l’impressione, già presaga, che l’università stesse diventando un esamificio. Non amava
molto la didattica, rispetto alla quale era abbastanza avaro di contributi, sempre per
quel suo privilegiare la conversazione ristretta che ho prima menzionato, né amava im-
mergersi nella lettura di quella che chiamava "titolografia", ovvero i libri scritti per i
concorsi universitari, sui quali egli aveva una battuta rimasta celebre fra i cultori del
suo lessico: quei libri, diceva, “sono un ostacolo alla conoscenza dei candidati”, che egli
immaginava costretti fra scadenze burocratiche e imposizioni accademiche e mode cui ci
si doveva piegare. Molto più proficuo, aggiungeva, può essere un colloquio di mezz’ora
con il docente in pectore per capire chi veramente ci si trova di fronte”.
La versione dell’interessato è alquanto diversa. Scrive a Max: “Nulla meglio che le gran-
di Università è in grado di farti passar la voglia di tenere lezioni «a modo», visto che
l’uditorio cambia continuamente”; “a Napoli gli esami durano due mesi ogni sessione e
durante gli esami gli studenti del quarto anno si squagliano, liberandomi automatica-
mente dal viaggio di andata e ritorno”. Più esplicito di così…
Nel 1968 esce – e quanta fatica gli è costato consegnare il testo definitivo! – la summa
del suo pensiero filosofico-giuridico nella voce “Formalismo giuridico” dell’Enciclopedia
del Diritto edita da Giuffrè. Avrebbe dovuto scrivere altre voci, forse, ma alcune scorret-
tezze firmate dal direttore della sezione, un suo ex allievo “saputello” e “scortesissimo”
pongono fine alla collaborazione.
Non mancano poi, tra la corrispondenza di questi anni – secondo una consuetudine nata
a metà degli anni ‘40 e conclusasi solo con la morte – le lettere degli amici (nord e sud in
questo si equivalgono) con richieste di raccomandazioni. Ce ne sono tantissime, e per i
motivi più svariati: dalla pratica al Ministero dell’istruzione all’incarico come commissa-
rio agli esami di maturità c’è davvero di tutto. Una versione generosa e disinteressata, si
potrebbe dire, di quello che era il potere mafioso nella sua Sicilia.
[Un giorno, davanti al giornale pieno della solita cronaca nera se ne uscì con una consi-
derazione che solo molti anni dopo ho compreso in tutta la sua gravità: “Ai miei tempi
Catania era una città tranquilla e sicura, dove la sera si usciva senza particolari preoc-
cupazioni. Ci pensava la mafia a mantenere l’ordine. Se qualcuno sgarrava – un furto,
uno scippo, un imbroglio... – il mattino dopo non c’era più e nessuno chiedeva notizie o se
ne preoccupava...”.
Una simile percezione della mafia non era tipica di poche persone come mio padre, ma
era una realtà presente trasversalmente nella società siciliana. Così infatti la si ritrova
nel film di P. Germi In nome della legge, del 1949, che, come ha scritto un giornalista più
di sessant’anni dopo, “dipingeva una mafia vecchio stile, garante dell’ordine, che alla fine
accetta perfino le istituzioni”.]
L’incarico siciliano, che dura cinque anni, non gli viene rinnovato. Per fortuna, si po-
trebbe dire. Non solo la salute comincia a vacillare, ma proprio in quegli anni si abbatte
su mio padre una serie di dolori e preoccupazioni da ammazzare un individuo ben più
robusto (anche psicologicamente) di lui.
Il nipote Peppino pare non sia quel “piccolo Cammarata” che sognava sua madre. Anzi,
dal poco che trapela in casa sembra che sia un elemento più da riformatorio che da stu-
dio legale. E lui invia soldi pure alla cognata...
Nel 1963 muore la suocera e tra Lea e i suoi fratelli si scatena una battaglia all’arma
bianca che tra querele e insulti si trascina per diversi anni.
Due anni dopo è la volta di sua madre. Per papà è uno schianto, perché non può condivi-
dere il dolore né con la moglie, per i motivi appena ricordati, né con i figli: uno è in piena
crisi adolescenziale e passa da una bocciatura all’altra; l’altra è confinata in collegio. C’è
una sola foto di quel periodo: complice la mancanza della dentiera (un oggetto che non
accetterà mai e che in casa porta solo per mangiare), mostra almeno dieci anni di più.
Non se ne rende conto, ovviamente, e scrive a Max: “il tuo vecchio amico [...] somiglia
sempre più ad un antico palazzo ben conservato nella facciata, ma pieno di crepe
all’interno”. Non è dunque solo a causa delle sigarette che di lì a pochissimi anni si sca-
tenerà il cancro che gli sarà fatale.
Ma perché io ero in collegio? In quel fatidico 1963 papà era stato finalmente chiamato a
Roma, a ricoprire la cattedra di filosofia del diritto a Scienze Politiche. Ciò significava da
una parte la fine della sua attività di pendolare, dall’altra ritrovarsi in mezzo ai proble-
mi causati da due figli piuttosto litigiosi e da una moglie non particolarmente equanime
ed equilibrata (e i due fattori si alimentavano a vicenda...). Che non sempre approvi il
pugno di ferro della mamma è una confessione che fa soltanto a Max: “I bambini cresco-
no [...] anche in discoleria, sebbene non grave, ma sempre meno conciliabile con la non
lieve pedanteria, tutta triestina, di mia moglie”. Non solo: pochi anni dopo, adolescenti,
per lui siamo diventati “anarcoidi e, nello stesso tempo, abulici”.
Non riesco proprio a intravedere, in questo triste, e in buona parte ingiusto, giudizio su
noi ragazzi qualcosa che assomigli a un domandarsi perché siamo così, né se, in qualche
modo, sia anche lui responsabile di questa situazione. Ancora una volta, di fronte a pre-
cise responsabilità o difficoltà della vita, si rifugia nell’irrealtà dell’astrattezza filosofica.
Quasi dicesse: “Fate di me quello che volete, ma non chiedetemi di vivere”.
Io – e non è un caso – non andavo molto bene a scuola: l’insegnante di lettere (una sici-
liana) arrivò a dire a mia madre: “Lo sa che sua figlia è una reproba?”. E neanche a casa
ero un modello di bambina tranquilla.
Si poneva dunque il problema di dividere i fratelli e creare quella tranquillità cenobitica
che era la conditio sine qua non papà potesse continuare la sua attività di pensatore.
Che fosse Manlio ad andare in collegio (era questa, allora, l’unica psicoterapia contem-
plata per i bambini “difficili”) era escluso: il genio primogenito? Non fia mai! Al grande
amico d’America confessa: “[...] Aggiungi a ciò i dispiaceri per i figli, o troppo riottosi (la
bambina l’ho dovuta mettere in collegio e sembra che ciò le abbia fatto bene) o troppo
svogliati – Manlio ha perduto un altro anno – e qualche preoccupazione per i malanni
della vecchiaia [...]”.
E così toccò a me: per la quiete della famiglia mi sono stati rubati sei anni di vita. I sei
anni più importanti, ma che a nessuno evidentemente importavano.
Di sicuro importavano poco a lui, che mise piede in via Cicerone, dove allora si trovava il
Convitto Santa Chiara, solo due o tre volte, costrettovi dalle circostanze: mia madre era
a letto con l’epatite virale. Sembrava infatti non chiedere, in cambio della sua personale
tranquillità, altro che il ruolo di ufficiale pagatore di tutte le spese per il mantenimento
della famiglia.
Una volta, avevo circa 15 anni, gli feci vedere che sul giornalino del collegio avevano
pubblicato una mia poesiola. La lesse rapidamente, poi senza dire nulla aprì il portafo-
glio e mi diede mille lire. Non gli ho fatto mai più vedere niente e ho continuato a scrive-
re versi di nascosto.
Con quei soldi corsi a comprarmi un ellepì molto economico con i valzer di Chopin, la
mia passione. Glielo mostrai e gli chiesi: “Indovina quanto l’ho pagato?”. Rispose, con un
sorrisetto ironico: “Figlia di tua madre... sicuramente molto poco.”.
Dunque, ho vissuto fuori della famiglia proprio negli anni in cui si sarebbe potuto creare
un legame psicologico e affettivo tra me e lui. Con inoltre il risultato (possibile che nes-
suno l’avesse messo in conto?) che io e mio fratello siamo cresciuti estranei l’uno all’altra:
due figli unici, in un certo senso, ma, né in quegli anni né poi, dei lati positivi di questa
“unicità” ho mai potuto minimamente godere.
Pare impossibile, ma neppure il trasferimento a Roma è avvenuto in maniera tranquilla,
come si deduce dalla copia di una lettera scritta all’amico Piovani: “Roma, 26 maggio
1962. Caro il mio Don Pedro, grazie del biglietto ricevuto ier sera: se il diavolo, come suol
dirsi, non vi metterà la coda, in ottobre (grazie agli sciaguratissimi esami di maturità,
sarà assai difficile che la Facoltà possa procedere alla chiamata entro luglio) il problema
sarà risolto. Già uno tra quei colleghi che mi avrebbero tranquillamente lasciato, per al-
tri sette anni, a Napoli, si è affrettato a... volare in mio soccorso, ignorando evidentemen-
te che io conoscevo la qualifica di ‘peso morto’ appioppatami discutendo con un altro col-
lega... Rimane il mistero della improvvisa resipiscenza di Volpicelli: vi è chi l’attribuisce
ad un momento di... lucido intervallo tra due di alcoolica ebbrezza; vi è chi ritiene che, ti-
rate le somme, Volpicelli abbia pensato che una persona per bene come il sottoscritto non
gli avrebbe arrecato alcuna noia (e qui non ha certamente sbagliato!); e può anche darsi
ch’egli si sia divertito a mandare per aria tutte le previsioni e le congetture, probabil-
mente irritato dalle manovre di Ago, Tosato e soci che avrebbero voluto non solo Crisa-
fulli, ma anche il tascabile quanto ‘massimamente’ ambiguo Giannini, affidando le mie
sorti alla ipotetica concessione di un nuovo posto di ruolo, per la quale non avrebbero
mosso un dito. Secondo notizie avute da Guarino poche ore fa, tutti coloro che certamen-
te non avrebbero votato la proposta di Volpicelli, si accingono a volare in soccorso dei
vincitori, caldeggiando la chiamata del sottoscritto. Staremo a vedere. [...]”.
Arrivano le prime congratulazioni, ma Ermanno non è tipo da lasciarsi adulare impu-
nemente. L’Ateneo romano, poi, non è certo un campus inglese... come si deduce da que-
sta brutta copia, dallo stile appuntistico, di lettera ad Agostino Origone, suo successore
nella carica di rettore a Trieste: “Maestoso (per cagion della pancia) Gustin, quel ‘caro
vecchio amico’ è di una crepuscolarità commovente (penso a Scheggi e a Monsieur Le-
normand); quello ‘spero che le mie doti letterarie mi aiuteranno’ è di una solennità im-
pressionante. Ma poiché in bellissima forma si possono anche scrivere cose che non
stanno né in cielo né in terra (come ti è accaduto il 24 maggio 1961) ti sarei grato se mi
telefonassi la prima volta che avrai occasione di... romanizzarti.
[retro; manca evidentemente un altro foglio] Così mi ha assicurato, sbadigliando, il mi-
tizzato futuro neo-preside, detto anche [illeggibile]. Per la storia, t’informo che alla Fa-
coltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma non esiste alcuna toga. Forse perché,
all’epoca dell’istituzione eran tutti ‘pezzi grossi’ anche la quasi totalità dei membri attua-
li ne sono [sprovvisti], ma il sottoscritto non appartiene all’élite, essendo un povero filoso-
fo sprovvisto perfino della più scalcinata ‘utilitaria’. Non si è chiamato alcun pittore o
cromosofo ad ‘oggettivare’ il color del cane che fugge [della mia stanza]. Col quale, crepu-
scolarmente non men che [illeggibile] ti saluto.”.
È vero: la sua stanzetta (una dozzina di metri quadri) ha le pareti di un colore-noncolore
che mette tristezza, né lui l’abbellisce in alcun modo. Ci sono una scrivania, un armadio,
due sedie e, appesa al muro, una foto di Gentile. Nient’altro.
Di questo suo primo anno dice a Max: “ho ritrovato finalmente un uditorio costante (do-
dici studenti, di cui solo due maschi [...]), anche se non eccessivamente perspicace, men-
tre a Napoli nessuno veniva più ad ascoltarmi per più di una o due lezioni”. A Scienze
Politiche filosofia del diritto è materia facoltativa, e quindi quelli che lo vanno a sentire
sono “automaticamente selezionati”, cosa che gli dà non poca soddisfazione.
Alla cella da eremita accademica corrisponde quella domestica: una grande scrivania ri-
nascimental-biedermayer con annesso armadio a vetri e un’intera parete a libreria. Il
poco che rimane delle pareti assumerà negli anni un colore da lui stesso affettuosamente
definito “giallino oro antico”, dovuto alle migliaia di sigarette che non smetterà mai di
fumare.
Non è certo uomo amante della mondanità, eppure ad alcune cerimonie ufficiali deve
partecipare, come per esempio a quella del 2 giugno nei giardini del Quirinale (negli an-
ni in cui erano presidenti della Repubblica due suoi ex colleghi e amici, Antonio Segni e
Giovanni Leone) o all’ennesimo omaggio al Milite Ignoto (sempre nella zona riservata al-
le “autorità”). Proprio in piazza Venezia accade il fattaccio che rischia di segnarlo per
sempre come individuo non rispettoso della Patria: ha infatti, come d’abitudine, una
macchina fotografica in ciascuna tasca dei pantaloni, che usa tenere su non con la cintu-
ra ma con le bretelle. Queste, del tipo a pinze invece che a bottoni, a un certo punto si
stancano di sopportare il peso di quegli attrezzi infernali e... mollano la presa. Per tenere
su quei benedetti pantaloni, che rischiano di scivolargli fino alle scarpe, a Ermanno non
resta altro che infilare entrambe le mani nelle tasche e aggrapparvisi, in un atteggia-
mento che a quei tempi era ritenuto sommamente disdicevole e che deve conservare per
tutta la cerimonia. Da allora le bretelle saranno sempre e rigorosamente quelle con i bot-
toni. E, d’altra parte, la macchina fotografica la usa sempre meno.
Non perde però la memoria di quelle possedute e delle foto fatte. A venti, trenta, qua-
rant’anni di distanza ricorda ancora, e senza sforzo, non solo il dove e il quando
dell’immagine, ma perfino l’apparecchio, l’obiettivo, la pellicola, i tempi e i diaframmi. È
rimasta un mito quella “rubata” alle Fonti del Clitunno, negli anni ‘30, che immortala un
giovane frate francescano intento al suo breviario sotto un albero. Poiché costui aveva
chiesto di non essere fotografato, Ermanno aveva fatto finta di obbedire, si era allonta-
nato di qualche passo volgendogli la schiena, poi aveva appoggiato la macchina sulla
spalla e con mira impeccabile, quasi avesse occhi anche sulla nuca, aveva scattato. Una
foto perfetta, per tecnica, inquadratura e atmosfera.
I sette anni che gli restano prima di andare fuori ruolo non sono neppur essi rose e fiori:
per quanto l’attività didattica non debba pesargli molto – nessuno oserà mai chiedergli
una tesi – sono gli intrallazzi politico-istituzionali a infastidirlo sempre più. Ne rimane a
testimonianza questa lettera che, nella sua parte finale, oggi può ben essere definita
“profetica”.
“Roma 23 marzo 1963. Carissimo Di Nardi, Ti prego vivamente di voler consegnare al
Preside della Facoltà l’acclusa lettera, con la quale dichiaro di rinunziare alla domanda
per la chiamata alla cattedra di ‘Istituzioni di diritto e procedura penale’.
Quasi alle ore quindici sono tornato dal mio duro lavoro del Palazzo di Giustizia e ho ap-
preso che aveva telefonato Moro. Mi è bastato questo. Mi contento di poco? Non fa nien-
te, mi è bastato sapere che il Collega Moro si è ricordato della mia esistenza. Inviai la
domanda sia per ritorsione a quello che la più diretta creatura di Moro mi ha fatto, sia
perché ho voluto in tal modo rispondere a coloro (Petrocelli primo) che dimenticano come
vi siano altre persone che meritano, che soffrono, che fanno il loro dovere da più di
trent’anni, percorrendo strade irte di ostacoli e di difficoltà. Prima di andare a Napoli, io
sono stato quindici anni al confino (Camerino) e sette anni all’estero (a Trieste tra le fu-
cilate). Non mi sono mai lamentato. Ma perché gli altri devono credere che il mondo, al-
meno quello accademico, è fatto solo per loro? Ma lasciamo andare. Adesso sono riuscito
a parlare con Moro, e gli ho detto che sto inviando la presente. Io mi auguro solo che il
Signore mi faccia fare questi sforzi e questa vita per moltissimi anni ancora. Ho sentito
dalla Tua voce il disagio nel quale mettevo Te e i cari Colleghi, ai quali Ti prego di dire
che fanno bene a chiamare Moro, veramente giurista valoroso. Fatevi dare l’impegno che
si rimetta a studiare. Che possa la ripresa dei contatti con la scienza allontanarlo dalla
triste strada politica in cui si è messo? Chi sa. Ogni tanto si verifica pure qualche mira-
colo. Tante cordialità”.
Che diplomazia! Solo a Max, infatti, può scrivere che cosa pensa davvero di Moro: “[...]
l’ineffabile Moro, campione della mediocrità degli ex aspiranti al titolo di littore”, “fasci-
stissimo”... e rivelargli il soprannome (questa volta davvero perfido) che gli ha appioppa-
to: “l’anguillone pugliese”.
Se gli accade di trovarsi in un gruppo di colleghi, gli scrive, il loro vociare “mi ricorda
quello delle lavandaie catanesi, una trentina di anni fa”.
[Moro riapparve altre due volte nella nostra vita. Durante l’estate del ‘64 eravamo stati
invitati a Terracina da un’amica di mia madre la cui villetta dava sul lungo stradone che
costeggiava la spiaggia libera. Stesi ad arrostirci sotto un rovente sole agostano, ogni
mattino vedevamo passare, sempre alla stessa ora, un Moro impeccabilmente incravat-
tato e in completo blu che, due guardie del corpo davanti e due dietro – anch’esse vestite
di tutto punto –, faceva la rituale passeggiata di buon passo sul lungomare. Lo seguiva-
mo con gli occhi per un bel pezzo e lo compiangevamo: non avremmo voluto essere al suo
posto per tutto l’oro del mondo. Era lo stesso uomo che con la stessa compunzione verrà,
insieme a Giovanni Leone, a farci le condoglianze al funerale di papà.]
Ma neanche gli studenti sono proprio degli stinchi di santo. Uno di questi, tale Antonino
Soave casertano, si procura addirittura un “libretto” falso e poi lo manda a Ermanno
perché con la sua firma lo avalli. Buono sì, il professor Cammarata, ma non tre volte. Lo
rispedisce al mittente, il quale torna alla carica. A questo punto il corpo del reato finisce
dritto dritto nelle mani del preside della Facoltà accompagnato da poche ma esplicite ri-
ghe: “19 agosto 1963. Mio caro Preside, ritengo strettamente doveroso inviare senza in-
dugio a Te l’accluso libretto e la lettera di accompagnamento in cui la confessione del fal-
so non potrebbe essere più esplicita. Di tale falso avevo già avuto il sospetto fin dalla
prima volta che mi era stato inviato il libretto: ho pensato bene di restituirlo con un sec-
co rifiuto, ma come vedi, lo sciagurato insiste. Scusami se ti do questa seccatura, ma
francamente, non vedo altra via d’uscita, perché il falso sarebbe stato scoperto ugual-
mente a Palermo. [...]”.
Per quanto riguarda invece la sua vita universitaria, scrive a Max, “[...] nessuno si occu-
pa di me, io non mi occupo degli altri, e così non ho mai beghe né diatribe”.
Il 1969 è stato un anno molto importante nell’almanacco della famiglia: io mi preparavo
agli esami di maturità – e quindi alla definitiva uscita dal collegio – e papà andava fuori
ruolo, come dire nel limbo prepensione caratteristico dei docenti universitari italiani.
È stato l’anno delle occasioni perdute, perché nemmeno con il mio definitivo rientro a ca-
sa le cose cambiarono: papà era sempre distante dai miei problemi anche se a volte, in
maniera distratta, quando la mia testa gli capitava a tiro vi posava delicatamente una
mano per una timida carezza. Incredula, restavo immobile per paura che si stufasse e ri-
tirasse la mano. C’erano poi dei giorni in cui il filosofare camminando su e giù per il cor-
ridoio gli veniva a noia. Allora mi proponeva una partita a dama o a filetto. Era bravis-
simo e velocissimo. Non mi lasciava mai vincere. Alla fine, con la scusa che dovevo stu-
diare, rinunciai ad assecondarlo: dal fatto di non essere, per carattere, né ambiziosa né
competitiva non derivava comunque che fossi sempre felice di perdere.
Sebbene la filosofia che ci veniva propinata a scuola fosse davvero all’acqua di rose,
spesso avevo difficoltà a capirla (e oggi come allora). Allora andavo nel suo studio: “Papà,
mi spieghi?...”. E lui, scuotendo la testa sconfortato: “Figlia degenere...”.
Solo in un caso lo sapevo dalla mia parte: quando mia madre pretendeva che, per uscire
con lei, io mi mettessi un po’ di gioielli (quasi tutti della sua famiglia d’origine: spille, col-
lane, braccialetti), onde non sembrare, diceva, “la figlia di nessuno”. Detestando fin da
allora l’apparire – e in particolare il mio apparire – protestavo, sbuffavo e alla fine an-
davo da lui, che sapevo altrettanto nemico delle ostentazioni. E infatti, “ma lascia perde-
re, Lea” era la sua mite ma convinta perorazione. Solo a quel punto lei cedeva bronto-
lando.
Per il mio diciottesimo compleanno mi regalò una racchetta da tennis e per la maturità
un microscopio. Non me ne sono mai separata, anche se da oltre quarant’anni non li uso
più.
Era presente quando mia madre mi comunicò che, dal momento che sarei andata
all’università, aveva deciso di concedermi un mensile di ben 5000 lire (40-50 euro, oggi).
Non ho mai conosciuto nessun altro così bravo nel far cadere le cose, perfino le più mise-
re, dall’alto. Naturalmente non era previsto che io protestassi per l’esiguità della cifra,
destinata a tutte le mie necessità extrascolastiche, e infatti tacqui. Anche lui: anzi, sem-
brava che non fosse nemmeno stato ad ascoltare. Ma il giorno dopo mi chiamò e mi disse:
“Mi rendo conto che i soldi che ti passerà tua madre non ti basteranno. Perciò aggiunge-
rò io ogni mese altre diecimila lire. Le preferisci tutte insieme o in due volte?”. Presa alla
sprovvista e pensando di sembrargli più virtuosa, risposi che mi andava bene la seconda
soluzione. E così, per un anno e mezzo, trescammo alle spalle della mamma. (Un’altra
cosa che non era contemplata dalle vigenti leggi di casa era sapere quanto nel contempo
veniva dato a mio fratello.) Dunque, quando voleva, sapeva essere coi piedi per terra!
Non sempre si ricordava le scadenze e a me costava gran fatica chiederglieli. Adottai la
tecnica meno dolorosa. Quando arrivava il giorno della riscossione andavo nel suo studio
e mi sedevo in silenzio davanti a lui che scriveva a macchina o rimuginava, indifferente
al mondo che lo circondava. Poi, dopo un tempo variabile ma che a me sembrava infinito,
si accorgeva della mia presenza. Guardandomi al di sopra degli occhiali chiedeva in tono
sollecito e affettuoso: “Ti servono soldi?”. Estraeva dal cassetto il portafoglio con il rituale
“Finché ci sono...” e mi allungava il denaro. Ringraziavo e sparivo.
Lui stesso capiva di non avere figli molto esigenti, eppure scriveva a Max: “Con le esi-
genze di due figli ancora all’università, anche se ridotte al minimo, comincio a constatare
che lo stipendio non basta più e bisognerà intaccare le non cospicue riserve”.
Si era mai posto il problema che una non piccola parte dello stipendio finiva nel fumo
delle sue sigarette?
Avrei voluto fare medicina ma fui costretta a ripiegare su biologia. I problemi iniziarono
poche settimane dopo, quando un compagno di corso con cui avevo fatto subito amicizia
mi chiamò per darmi un appuntamento. Enrico Lambiase, ragazzo buono, generoso e o-
nesto come pochi, faceva attività di volontariato pro baraccati del famigerato “fosso di
Sant’Agnese” presso la parrocchia di Santa Francesca Cabrini, in piazza Massa Carrara,
e io gli avevo dato con entusiasmo la mia disponibilità. Telefonò all’ora di cena. Rispose
mio padre, che di malavoglia mi passò il ricevitore. Non lo avevo ancora posato che mi
investì con una raffica di domande inquisitorie e con un tono più adatto a una figlia sco-
stumata che alla bambina sprovveduta che ero a quei tempi: il collegio aveva arrestato la
mia crescita psicologica, affettiva ed esistenziale al giorno in cui vi ero entrata. Di-
ciott’anni li avevo solo per l’anagrafe. Sconcertata dall’imprevista reazione, gli risposi
come potei, farfugliando. Non giunse a impedirmi di andare all’appuntamento, ma da
quel giorno mi sentii perennemente sotto controllo e giudicata male.
Un paio di settimane prima di Natale, dovendo trovarmi con Enrico e gli altri amici poco
dopo il pranzo, quando sia lui che la mamma andavano a fare il solito riposino, bussai al-
la loro porta annunciando la mia uscita. “Dove devi andare?” “Vado in parrocchia a pre-
parare i pacchi di Natale per i baraccati...” “Lascialo fare agli altri!” fu la risposta secca e
seccata che mi giunse da dietro la porta chiusa. Restai di sale. “Ma sono io gli altri”,
mormorai incapace di comprendere. Non mi sentirono, non insistettero e io uscii, chiu-
dendomi la porta di casa alle spalle con un respiro di sollievo. Né allora né mai in circo-
stanze analoghe mi passò per la testa di dire la bugia che per gli anni a venire avrebbe
potuto evitarmi tante critiche e tante ironie: un’inderogabile lezione all’università.
Le mie (vaghe, e comunque diverse dalle sue) idee politiche e la mia assidua frequenta-
zione dell’ambiente cattolico gli avevano dato l’occasione di affibbiarmi un altro dei suoi
soliti epiteti: mi chiamava “criptocomunista”, dove il “cripto” si riferiva alla parte della
chiesa che si trova sotto l’altare,“comunista” era chiunque non la pensasse come lui...
(Tra gli amici del “magazzino” di piazza Massa Carrara c’era un altro dolcissimo ragazzo:
Domenico Di Biase, detto Mimmo. Incapace di fare del male a una mosca, generoso e for-
se un po’ ingenuo, è stato facile, venticinque anni dopo, incastrarlo nell’affare Di Pietro-
Guardia di Finanza. Sono sicura che anche in quell’occasione il suo comportamento è
stato più che corretto.)
Per Natale l’allora ministro della Pubblica istruzione ci regalò la liberalizzazione dei
piani di studio. Esonerata dunque dall’obbligo di dover sostenere esami di greco (che non
avevo mai né amato né imparato) e di latino (che adoravo, ma sarei dovuta passare per
le forche caudine di Paratore), decisi di cambiare facoltà e iscrivermi a Lettere. Il solo e
poco incoraggiante commento di mia madre fu: “Te l’avevo detto io che non eri fatta per
le materie scientifiche...”.
Mio padre non disse niente, perché niente aveva capito del mio travaglio interiore, dal
momento che a Max scrisse: “[...] la sua rassegnazione preventiva alla carriera
dell’insegnamento medio suscita in me una profonda malinconia: spero che trovi prima
un buon marito...”. Premesso che non avevo mai pensato seriamente all’insegnamento
come mia futura professione (anzi, non avevo nessuna idea concreta su cosa avrei fatto
da grande, dal momento che non avrei potuto fare il medico), perché non mi ha mai chie-
sto che cosa davvero pensavo o sentivo?
Del resto, non è chiaro nemmeno che cosa realmente sperasse per me: è probabile che,
da buon siciliano nato nell’Ottocento, rifuggisse dall’idea di una figlia lavoratrice. Lo a-
veva chiaramente mostrato quell’estate, quando avevo espresso il desiderio di andare a
lavorare temporaneamente in una delle librerie Maraldi, che vendevano libri scolastici
usati, per raggranellare qualche soldo, come già facevano alcune mie compagne di scuo-
la. Sbalordito e un tantino indignato mi chiese: “A che ti servono quei soldi?”. “Vorrei
comprarmi una macchina da scrivere...”. Il giorno dopo tornò a casa con una simil-
Remington portatile nuova fiammante. A prova di rottura, lo aveva rassicurato il nego-
ziante: faceva parte dei pregiudizi familiari nei miei confronti il fatto che non potessi fa-
re a meno di rompere tutto quanto mi veniva tra le mani, talché i primi venticinque anni
della mia vita hanno avuto un solo, ineluttabile, ritornello: “Lascia stare, non toccare,
ché lo rompi”.
Proprio in quei mesi cominciava ad accusare vaghi quanto insistenti dolori alla schiena e
alle braccia. Condorelli gli fece fare varie lastre, tra cui quelle ai polmoni, ma disse che
non c’era nulla di preoccupante. Era una bugia pietosa o non si era accorto del cancro che
si era annidato appunto a livello polmonare? Non lo sapremo mai. Quella volta in Italia
le cure oncologiche erano poche e approssimative, e comunque Condorelli non ne propose
nessuna.
All’inizio dell’estate incominciò a sentire un fastidioso e insistente dolore sotto l’orecchio
sinistro: gli dissero che forse era a causa dell’unico dente che gli era rimasto e se lo fece
togliere, ma il dolore non passava.
All’inizio di ottobre Condorelli prescrisse una biopsia. Io, immersa nella preparazione
dell’esame di Letteratura italiana, facevo poco caso all’aria strana che c’era in casa. E, a
dire il vero, a casa ci stavo il meno possibile: nel magazzino di piazza Massa Carrara a-
vevo trovato tutto quello che fino ad allora mi era stato negato: amici, calore, solidarietà,
pazienza, allegria... e le lezioni che frequentavo all’università mi piacevano realmente.
Due giorni dopo aver dato l’esame (in cui presentavo una ricerca sul catanese, amatissi-
mo, Giovanni Verga), mi trovavo in cucina con la mamma. Lui era già andato a riposare.
Mi disse, con la voce strozzata dal pianto, qual era la natura dei disturbi di papà. “Con-
dorelli dice sei mesi, al massimo un anno... Papà non sa e non deve sapere”. Non dissi
nulla e guardai fuori dalla finestra: era una di quelle mitiche giornate romane
d’autunno, ma tutto mi parve improvvisamente senza colore e senza senso.
Si sottopose senza protestare a un ciclo di cobaltoterapia che gli spacciarono per raggi X
perché non avesse sospetti, ma il male era troppo avanzato e non ne trasse alcun benefi-
cio. Anzi, cominciò a stare peggio.
Il tono delle sue lettere a Max è sempre più triste e lamentoso: “[...] non ho avuto il ben-
ché minimo estro per la lettura dei ‘titoli’ di sei o sette ‘candidati’ in un concorso di filoso-
fia del diritto: avrei una gran voglia di rinunziare, ma non posso farlo per non lasciar so-
lo il mio valentissimo allievo De Giovanni.”. E ancora, nell’ultima, del 23 dicembre: “Na-
turalmente, il mio tentativo di offrire, alla tenera età di settantadue anni, un approfon-
dimento dell’attualismo è stato messo in quarantena: chissà se avrò la forza di riprende-
re.” Fuggire nella filosofia, ancora una volta, e per l’ultima.
Già dall’estate non usciva più da solo per quella che chiamava la “passeggiata igienica”
del dopocena. Io o la mamma lo accompagnavamo nel giro che faceva attraverso il quar-
tiere Coppedè, non prima però di essere passati in rosticceria ad acquistare un paio d’etti
di pesce per i gatti del rione. Era forse il suo modo di farsi perdonare il poco innocente
hobby che aveva da ragazzo, sparare con il flobert a tutti i randagi che gli venivano a ti-
ro. Sono convinta che non un colpo sia andato sprecato: ancora l’anno prima, al tiro a se-
gno di Seiano, dove eravamo in villeggiatura, aveva mostrato di avere una mira infallibi-
le. In via Tirso non c’erano solo i gatti, ma anche una giovane, scheletrica lupa costretta
a vivere in un terrazzino di pochi metri quadrati, con la quale papà faceva lunghi discor-
si a distanza. Quando la bestiola lo vedeva chinarsi ad accarezzare un gatto, esplodeva
in grandi abbaiate di gelosia.
Una sera, durante la passeggiata, gli chiesi: “Ma perché non siamo rimasti a Trieste?”.
(La città era già la meta dei miei sogni di fuga dalla città e dalla famiglia.) Rispose: “L’ho
fatto per voi ragazzi. Qui avreste avuto più possibilità”. Aveva ragione.
Di un’altra passeggiata, stavolta diurna e con la mamma, ho un ricordo fotografico. Era-
vamo andati a passeggiare in centro e, giunti in piazza di Spagna, papà e io ci mettemmo
a scattare (anzi, a “sparare”, come diceva lui) alcune foto. L’unica macchina che ancora
usava volentieri – delle altre, più moderne, non sapeva che farsene – era, oltre alla vec-
chia Leica, una Voigtlaender a soffietto. E mentre inquadrava la “barcaccia” io inquadrai
lui.
Oggi guardo questa foto, vecchia ormai di quasi mezzo secolo, e chiedo ancora una volta
alla sua ombra: “Ma chi eri veramente?”.
E arrivò Natale. Una festa odiatissima perché, fino a qualche anno prima, mio padre la
passava (come del resto il Capodanno) a casa dei Condorelli, lasciando noi tre soli, a
guardarci in faccia e ad aspettarlo. Tornava regolarmente pochi minuti dopo la mezza-
notte. Gli ultimi due anni erano stati, per me, ancora più infernali perché, pur di non
scontentare né l’amico né la moglie, ci aveva costretti ad andarci, come si diceva nel les-
sico famigliare, “in corpo e deputazione”, naturalmente vestiti di tutto punto. La casa dei
Condorelli, un villino a più piani, era internamente rivestita di marmi pregiati, ragion
per cui per scaldarla ci sarebbero volute cifre da petroliere arabo. Così, era sempre geli-
da: neppure per quelle due feste, a cui partecipavano i molti figli del patriarca con rela-
tivi coniugi e alcuni sceltissimi amici, i padroni di casa si premuravano di rialzarne la
temperatura pressoché polare, talché le lunghe, pantagrueliche (e per me e Manlio, i soli
ragazzi presenti, noiosissime) libagioni restavano poi tutta la notte sullo stomaco.
Come Dio volle la serata passò. E stava passando in maniera analoga quella di Capo-
danno, quando, nell’atrio della villa, mentre ci accingevamo a tornare a casa, papà si
sentì male e cominciò a tremare come una foglia. Evidentemente non era stato in grado
di digerire, oltre alla cena, anche il freddo imperante nell’inospitale appartamento.
Arrivato a casa, si mise a letto, e da quel momento non si alzò più. Il giorno seguente si
ricordò che doveva darmi la mezza mesata ma, aperto il portafoglio, mi porse una banco-
nota da 10.000 lire. Tra noi corse una rapidissima occhiata: in quel momento entrambi ci
eravamo resi conto, seppure inconsciamente, che non ci sarebbe stato tempo per la se-
conda rata.
Nei giorni successivi mi divisi, e con non poca fatica emotiva, tra l’università e il suo let-
to, presso il quale mi sedevo facendo finta di studiare. Fortunatamente non aveva grandi
dolori ed era lucidissimo, anche se parlava poco. Mi raccontava qualche episodio della
sua giovinezza, di quando due palline di gelato costavano un soldo (e per sottolinearne
l’esiguità alzava il mignolo della mano sinistra appoggiandovi l’unghia del pollice) e poco
di più il “Corriere dei Piccoli”.
Il 13 si assopì e poi andò in coma. Probabilmente non sentì nemmeno la voce del vecchio
amico Carletto, che era venuto appositamente da Trieste sperando di salutarlo ancora
una volta. Morì, senza più aver aperto gli occhi, la notte tra il 15 e il 16 gennaio 1971.
Io non avevo ancora vent’anni.
BIBLIOGRAFIA DEGLI SCRITTI
Recensione a B. Donati, II rispetto della legge dinanzi al principio d’autorità, in “Giorna-
le Critico della filosofia italiana”, 1920/3, pp. 322-324
Recensione a A. Levi, Filosofia del diritto e tecnicismo giuridico, in “Giornale Critico del-
la filosofia italiana”, 1920/3, pp. 352-354
La razionalità del diritto e il giusnaturalismo nella filosofìa dell’immanenza assoluta, in
“Giornale Critico della filosofia italiana”, 1922/2, pp. 163-172
Recensione a C. Caristia, Contributo alla dottrina intorno alla natura e al fondamento
del Governo parlamentare (estratto da “Rivista internazionale di Filosofia del Diritto”,
II/1922, pp. 1-5)
Recensione al Festgabe für Dr. Jur. H. c. Otto Liebmann, (estratto da “Rivista interna-
zionale di Filosofia del Diritto”, II/1922, pp. 5-7)
Su le tendenze antifìlosofiche della Giurisprudenza moderna in Italia, in “Rivista inter-
nazionale di filosofia del diritto”, 1922/3, pp. 234-258
Recensione a G. Del Vecchio, Il concetto di natura e il principio del diritto, in “Giornale
Critico della filosofia italiana”, 1923/2, pp. 188-198
Diritto e Stato. Relazione tra i due concetti, Roma 1924, pp. 174 (bozze di stampa di Con-
tributi ad una critica gnoseologica della giurisprudenza)
Contributi ad una critica gnoseologica della giurisprudenza, Roma 1925, pp. 175
Qualificazione giuridica e scienza del diritto, Catania 1926, pp. 28
Il concetto del diritto e la “pluralità degli ordinamenti giuridici”, Catania 1926, pp. 40
Immanentismo e Filosofia del diritto, in “Rivista internazionale di filosofia del diritto”,
1926/1, pp. 234-258
Sul fondamento del principio “ignorantia juris non excusat”, in “Rivista internazionale di
filosofia del diritto” 1928/3, pp. 327-338
Il significato e la funzione del “fatto” nell’esperienza giuridica, in “Annali della R. Uni-
versità di Macerata” 1929, pp. 393-431
La positività del diritto e il valore pratico della norma di condotta, in “Studi filosofico-
giuridici dedicati a G. Del Vecchio nel XXV anno di insegnamento (1904-1929)”, I, Mode-
na 1930, pp. 43-53
Sulla c.d. coattività delle norme giuridiche, Milano 1932, pp. 20. Ripubblicato in “Archi-
vio Penale”, I-II/1953, pp. 3-16
Studi sul problema del diritto naturale, Catania 1936, pp. 16
Sul fondamento delle “valutazioni pratiche” dell’intelletto, Catania 1936, pp. 32
Limiti tra formalismo e dommatica nelle figure di qualificazione giuridica, Catania
1936, pp. 107
Giusnaturalismo e “critica delle leggi” in rapporto alla distinzione tra giustizia ed equità,
in “Boll. dell’Istituto di Filosofia del Diritto della Regia Università di Roma”, Roma 1941,
pp. 1-17
All’Italia la sovranità su Trieste, in “II Foro Italiano”, n. 73/1-2,1950, pp. 3-12
La sovranità italiana sul territorio di Trieste, in “II Foro Padano”, n. 4/1951, pp. 3-8
Le sentenze triestine in corte di Cassazione, in “II Foro Italiano”, n. 74/5-6,1951, pp. 3-8
La sovranità italiana su Trieste, in “Rassegna Italiana” n. 315/1951, pp. 3-11
La posizione giuridico-politica della Venezia Giulia occupata a sei anni dall’entrata in
vigore del Trattato di pace, Trieste 1953 (in fascicolo due articoli scritti per il “Giornale
di Trieste” del 16 e 18 settembre 1953)
Aspetti di diritto internazionale e problemi di diritto interno nella situazione attuale di
Trieste, in “Temi” n. 5/1955, pp. 3-12
Gli istriani rimasti nella zona B sono sempre cittadini italiani, in “Accademia di studi
economici e sociali ‘Cenacolo triestino’“, s.d.
Aspetti di diritto internazionale e problemi di diritto interno nella situazione attuale di
Trieste, in “Temi” n. 5/1955, pp. 3-12
Legislazione e giurisdizione nell’ex Zona “A”, estratto da “Atti del III Congresso Naziona-
le giuridico forense”, Trieste 1955, pp. 5-17. Ripubblicato in “II Foro Italiano” 78/1955,
pp. 3-14
Ai cittadini italiani di Trieste non si addice neppure la Corte costituzionale, in “II Foro
Italiano” 79/1956, pp. 3-5
Giuseppe Capograssi (necrologio), in “Temi”, 2/1956
Intervento alla “Tavola Rotonda sul positivismo giuridico”, in “Il politico”, Pavia,
XXXI/1966, pp.2
Ricordo di Remo Pannain (necrologio), in “Temi”, 2/1967
Sulla concepibilità di un nesso logico tra “illecito” e “sanzione”, in Scritti in memoria di
Antonino Giuffrè, Milano 1967, vol. 1, pp. 101-109
Formalismo giuridico, in “Enciclopedia del Diritto”, Giuffrè, Milano 1968
Ricordo di Orazio Condorelli (necrologio), in “Rivista int. le di filosofia del diritto”, Mila-
no, 1969, pp. 2
[“Presentazione”], in S. Romano, Lo Stato moderno e la sua crisi – Saggi di diritto costi-
tuzionale, Giuffrè, Milano 1969, 2 pp. n.n.
Presentazione, in O. Condorelli, Scritti sul diritto e sullo Stato, Giuffrè, Milano 1970, pp.
V-X
Annotazioni su Kelsen, in “Storia e politica”, 4/1973, pp. 493-506 (postumo)
Fra la teoria del diritto e la questione di Trieste – Scritti inediti e rari, EUT, Trieste 2010
BIBLIOGRAFIA CRITICA
GORETTI, CESARE, recensione a A.E. Cammarata, Sulla c.d. coattività delle norme
giuridiche, in “Rivista di filosofia”, XXIV/4 1933, pp. 364-365
PIOVANI, PIETRO, Momenti della filosofia giuridico-politica italiana, Milano, Giuffrè
1951, pp. 51 ss.
MALTESE, DOMENICO, Attualità del pensiero di Cammarata, in “Umana”, ott.-dic.
1971, p. 18
SERRA, TERESA, “La Via e A.E. Cammarata di fronte all’attualismo”, in Studi in
memoria di V. La Via, Messina 1984
SERRA, TERESA, A.E. Cammarata – La critica gnoseologica della giurisprudenza,
ESI, Napoli 1988
SERRA, TERESA, “A.E. Cammarata e G. Capograssi di fronte al formalismo”, in F.
Mercadante (a c. di), Due convegni su Giuseppe Capograssi (Roma-Sulmona 1986),
Giuffrè 1990, pp. 677 ss.
MALTESE, DOMENICO, “Cammarata, il filosofo del diritto”, in L’Università di Trie-
ste, settant’anni di Storia 1924-1994, Trieste 1994, pp. 221-227
LAMI, GIAN FRANCO, Forme logiche e scienza del diritto in A.E. Cammarata, Pelli-
cani, Roma 2000
FRANCHI, GIOVANNI, “Identità nelle regole. Modelli di comunità a partire dalla filo-
sofia delle regole di A.E. Cammarata e L. Wittgenstein”, in T. Serra (a c. di), L’identità
e le identità, Giappichelli, Torino 2003, pp. 93-109
FRANCHI, GIOVANNI, “Personalità e rapporto interpersonale in Angelo Ermanno
Cammarata”, in G. Sorgi (a c. di) Vocabulum juris. Omaggio a Francesco Mercadante,
Giappichelli, Torino 2005 pp. 211-224
CAPOZZI, LUIGI, “Angelo Ermanno Cammarata”, in Aa.Vv., Rileggere i maestri (a c.
di M. Tedeschi), Pellegrini, Cosenza 2011, pp. 187- 196
DE GIOVANNI, BIAGIO, “Angelo Ermanno Cammarata”, in Aa.Vv., Rileggere i mae-
stri (a c. di M. Tedeschi), Pellegrini, Cosenza 2011, pp. 197-205
SERRA, TERESA, “Un gentiliano ‘confesso’: Cammarata”, in La filosofia italiana del
ventesimo secolo (a c. di T. Serra), Atti del convegno di Montecompatri 2009, Nuova
Cultura, Roma 2012, pp. 217-240
PALUMBO, CIRO, Sul pensiero filosofico-giuridico di A.E. Cammarata Dalla legalità
alla giustizia nel ‘formalismo’ giuridico, Giappichelli, Torino 2017
In Internet (GOOGLE) ho trovato
GENTILE, FRANCESCO, Enrico Opocher
MODUGNO, FRANCO, Esposito, Crisafulli, Paladin – Tre costituzionalisti nella cat-
tedra padovana
dove si cita e si commenta Cammarata.