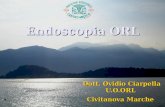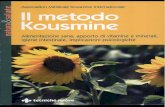Apporto delle tecniche di medicina nucleare nella gestione delle patologie della sfera...
Transcript of Apporto delle tecniche di medicina nucleare nella gestione delle patologie della sfera...

Apporto delle tecniche di medicinanucleare nella gestione delle patologiedella sfera otorinolaringoiatrica
G. Bonardel, E. Gontier, M. Soret, H. Foehrenbach
Gli esami di medicina nucleare, in quanto tecniche di imaging funzionale e metabolico, hanno un ruolosempre più grande nell’arsenale diagnostico a disposizione del medico otorinolaringoiatra (ORL). Latomografia a emissione di positroni (PET), ormai sistematicamente accoppiata alla TCX, confluorodesossiglucosio (FDG) rivoluziona il trattamento dei pazienti portatori di affezioni neoplastiche,specialmente in ORL, dove la percentuale dei carcinomi epidermoidi è predominante. Molto efficace nelbilancio di estensione linfonodale regionale o a distanza, come per la diagnosi delle neoplasie sincrone, ilsuo ruolo è destinato a divenire fondamentale per la ricerca di lesioni residue e per l’individuazioneprecoce delle recidive. Anche la valutazione della risposta dei tumori ai trattamenti chemioterapici el’ottimizzazione dei campi e della dosimetria nella radioterapia risultano essere applicazioni con molteprospettive, tanto più che la tecnica mediante PET è in costante evoluzione. Riguardo alla medicinanucleare monofotonica, la tecnica del linfonodo sentinella è in pieno sviluppo, in particolare per lagestione delle lesioni della cavità orale senza alcun interessamento linfonodale clinico o radiologico.Permette di evitare uno svuotamento linfonodale selettivo nei tre quarti dei pazienti, riducendo così lamorbilità, la durata e il costo del trattamento con la stessa sicurezza oncologica. Infine, altre tecniche piùclassiche sono tuttora di attualità, che si tratti della tomoscintigrafia ossea con difosfonati al tecnezio edella scintigrafia al gallio 67 per la valutazione dell’efficacia del trattamento dell’otite maligna esterna,della scintigrafia delle paratiroidi per la ricerca degli adenomi paratiroidei nella valutazione preoperatoriao, ancora, della sialoscintigrafia per la valutazione funzionale delle ghiandole salivari.© 2009 Elsevier Masson SAS. Tutti i diritti riservati.
Parole chiave: Tomografia a emissione di positroni; Fluorodesossiglucosio; Linfonodo sentinella; Cancro ORL;Otite maligna esterna; Adenoma paratiroideo; Sindrome secca
Struttura dell’articolo
¶ Introduzione 1
¶ Tomografia a emissione di positroni 2Principi 2Esecuzione pratica 2Applicazioni cliniche 3
¶Medicina nucleare monofotonica 7Tecnica del linfonodo sentinella 7Otite maligna esterna 8Scintigrafia delle paratiroidi 9Scintigrafia delle ghiandole salivari 9
¶ Conclusioni 9
■ IntroduzioneLa medicina nucleare è una specialità di imaging medica,
dedicata al carattere funzionale e molecolare degli organi e delleloro patologie. Essa permette di trasformare in immagini imetabolismi biologici per mezzo dello studio cinetico di vettorimolecolari marcati da traccianti radioattivi.
I rapporti tra medici nucleari e clinici ORL sono stati a lungoconfinati al campo della patologia tiroidea. Questa non saràtrattata in questo articolo, essendo oggetto di un capitolospecifico. Il ricorso alle tecniche di medicina nucleare per lagestione delle patologie benigne della sfera ORL si limita adalcuni esami relativamente poco praticati: la scintigrafia osseaaccoppiata alla scintigrafia al gallio 67 nella gestione delle otitimaligne esterne, la scintigrafia delle ghiandole paratiroidi perl’identificazione degli adenomi paratiroidei e la sialoscintigrafiaper la caratterizzazione delle sindromi secche cliniche. Questetecniche sono illustrate brevemente nell’ambito della patologiabenigna. Per la patologia maligna, la scintigrafia ossea condifosfonati alla ricerca delle lesioni ossee secondarie nel bilanciodell’estensione dei tumori localmente avanzati e sintomaticicostituiva, fino a poco tempo fa, il solo legame tra le duespecialità.
L’avvento della PET e, più recentemente, l’introduzione dellatecnica del linfonodo sentinella nel campo della cancerologiaORL hanno rivoluzionato il ruolo della medicina nuclearenell’arsenale diagnostico a disposizione del medico ORL.
Questa breve presentazione permette di strutturare questotesto in due parti, la prima dedicata all’imaging con emettitoridi positroni e la seconda a quella degli emettitori monofotonicigamma.
¶ I – 20-902-A-01
1Otorinolaringoiatria

■ Tomografia a emissionedi positroni
Con 20 000 nuovi casi ogni anno, responsabili di 7 000decessi ogni anno, i cancri della sfera ORL rappresentano l’8%dei tumori che si verificano in Francia [1]. Tra questi, l’istologiapredominante è quella dei carcinomi epidermoidi in più del95% dei casi [2].
Mentre l’80% circa degli stadi precoci è curabile, la metà deipazienti viene purtroppo scoperta in uno stadio avanzato almomento della diagnosi. Il trattamento di queste patologiemaligne richiede una collaborazione multidisciplinare trachirurghi, medici oncologi e radioterapeuti (riunione diconcerto pluridisciplinare o RCP). Questa collaborazione siestende anche agli specialisti dell’imaging perché svolge unruolo importante in tutte le fasi della gestione, che si tratti delbilancio iniziale o della sorveglianza con l’identificazione e ilbilancio di estensione delle recidive. Le tecniche radiologiche, inparticolare la tomodensitometria (TC) e la risonanza magnetica(RMN), sono divenute molto efficaci per la descrizione dellastruttura anatomica delle lesioni neoplastiche primitive e deiloro rapporti con le strutture limitrofe. Questi dati sonofondamentali per un approccio chirurgico carcinologicamentesoddisfacente, perché danno indicazioni sulle condizioniottimali di exeresi della lesione. Lo sono anche in vista di untrattamento con radioterapia, in quanto consentono di definireil volume bersaglio e di effettuare i calcoli dosimetrici perprevedere e minimizzare gli effetti sulle strutture normalicircostanti.
Tuttavia, qualunque sia la risoluzione anatomica raggiunta,queste tecniche radiologiche puramente morfologiche trovano ilproprio limite massimo nella caratterizzazione della natura dellelesioni messe in evidenza. Infatti, le lesioni maligne nonpresentano densità particolari in TC o segnali specifici in RMN,anche con l’iniezione di mezzi di contrasto per via endovenosa.Per questo la malignità di una lesione può essere affermata soloper il suo aumento di volume nel tempo. Inoltre, al momentodel bilancio dell’estensione solo l’aumento delle dimensioni diun linfonodo permette di indicare la sua invasione da parte delprocesso maligno.
Esiste, dunque, un posto per una tecnica di imaging alterna-tiva basata sul riconoscimento dei caratteri biochimici omolecolari delle cellule che compongono i tumori. Questocampo è quello della PET al 18F-fluorodesossiglucosio(18F-FDG).
PrincipiLa PET è una tecnica di imaging scintigrafica. Consiste
nell’iniettare a un paziente un tracciante radioattivo e nel farel’immagine della sua ripartizione in vivo mediante il rileva-mento dall’esterno, dopo un intervallo di attesa che dipendedalla fisiologia del tracciante.
La sua particolarità è legata al rilevamento in coincidenza didue fotoni gamma derivati dell’annichilazione del positroneemesso dal marcatore radioattivo utilizzato con un elettrone diriposo. Questa modalità di rilevamento dei positroni permettedi mettere in opera molteplici correzioni fisiche destinate a faredell’immagine realizzata la riproduzione più esatta possibiledella distribuzione reale del tracciante nel paziente, e questocon una buona risoluzione spaziale.
Anche se l’analisi delle immagini PET è soprattutto visivaqualitativa, è possibile calcolare diversi indici numerici cheesprimono la quantità di tracciante fissato o accumulato in unastruttura anatomica o in una lesione. L’indice più frequente-mente utilizzato è il standardized uptake value (SUV), ottenutosemplicemente rapportando la fissazione tumorale all’attivitàtotale iniettata e al peso del paziente.
Le camere PET (PETscan in inglese) permettono, dopo l’acqui-sizione dei dati in una scansione longitudinale del paziente, diricostruire delle immagini nei tre piani dello spazio e sottoforma di proiezioni volumetriche.
L’ultima generazione di tomografi è ormai abbinata a untomodensitometro nello stesso apparecchio, per realizzare i duetipi di immagini metaboliche e anatomiche quasi simultanea-mente con il paziente nella stessa posizione. Oltre al fatto che
un tale dispositivo consente di ridurre considerevolmente iltempo di esame, esso permette di localizzare esattamente ifocolai osservati alla PET. Il termine di PET, utilizzato perconcisione, sottintende da adesso in poi, un apparato ibrido(morfo-PET, PET-TC oppure PET-scanner).
La risoluzione intrinseca di questi equipaggiamenti PET sisitua vicino ai 4 mm. Tuttavia, a causa del fenomeno di volumeparziale, legato alla risoluzione intrinseca e al cosiddettocampionamento spaziale delle immagini, la grandezza minimadelle lesioni valutabili in vivo è dell’ordine di 8 mm.
Il tracciante emettitore di positroni più utilizzato attualmentenell’imaging clinico è il 18F-FDG. Questo è captato a livellodelle cellule dallo stesso trasportatore di membrana del gluco-sio [3]. Il suo impiego in oncologia è giustificato dalla nozioneormai vecchia dell’aumento del consumo di glucosio nellecellule neoplastiche [4]. Il criterio diagnostico di malignità èquindi la presenza di un’iperfissazione, che testimonia lecaratteristiche metaboliche delle lesioni. Tuttavia, il 18F-FDG èun tracciante del trasporto intracellulare del glucosio e dellaglicolisi. Ora, anche se l’aumento del metabolismo glucidico èuna caratteristica di numerosi tipi di cellule maligne, questacaratteristica non è di per sé specifica. Così, alcune lesioniinfiammatorie o granulomatose sono formate da cellule, inparticolare macrofagi e polimorfonucleati neutrofili, chepresentano anche un’iperattività metabolica. In questo tipo dilesioni si possono manifestare fissazioni importanti che possonoessere all’origine di falsi positivi per la diagnosi delle lesionimaligne (esempio della diagnosi differenziale difficile tra lelesioni della tubercolosi polmonare e quelle del carcinomabroncopolmonare). Inoltre, per minimizzare questo rischio difalsi positivi, l’esame PET deve essere eseguito a distanza da unintervento chirurgico (2 mesi di intervallo) e dalla radioterapia(3-4 mesi di intervallo), generatori di fenomeni infiammatori.
Al contrario, certe lesioni autenticamente maligne presentanoun aumento della glicolisi insufficiente per poter essere all’ori-gine di una fissazione significativa identificabile alle immaginiPET. In oncologia ORL, le lesioni epidermoidi, le più frequenti,presentano un ipermetabolismo intenso, ma non nel caso dicerte lesioni delle ghiandole salivari o dei linfomi di bassogrado, per esempio.
Esecuzione praticaLa procedura della realizzazione di un esame di buona qualità
è di lunga durata, dell’ordine di 2-3 ore. A eccezione delposizionamento di una via venosa periferica per l’iniezione delradiotracciante, si tratta di un esame non invasivo. Nessuneffetto collaterale del 18F-FDG, né alcun fenomeno allergicosono mai stati riportati in più di 20 anni di utilizzazione.L’esame è effettuato in un paziente a digiuno da più di 6 ore eben idratato, a causa dell’eliminazione urinaria del tracciante.
La fissazione fisiologica del tracciante nei muscoli e nel grassobruno è una potenziale sorgente di artefatti. Oltre al riposo aletto o in poltrona sotto una coperta, durante la prima ora cheprecede l’iniezione del tracciante e durante l’attesa dell’esame,ovvero 1-2 ore, può essere proposta una premedicazionemiorilassante e ansiolitica come il diazepam (5-10 mg per viaorale, secondo il peso).
Dopo questo periodo di attesa e di riposo, il paziente vieneposizionato sul lettino d’esame in decubito dorsale, con lebraccia in abduzione sopra la testa o lungo il corpo. L’acquisi-zione delle immagini a «corpo intero» (campo dedicato dellasfera ORL completato da una scansione a corpo intero) dureràcirca 30 minuti per un’apparecchiatura ibrida PET-TC di ultimagenerazione: questa cifra può essere ulteriormente ridotta a unaventina di minuti con gli ultimissimi apparecchi che utilizzanola tecnologia di tempo di volo, per esempio.
L’irradiazione del paziente durante un esame PET-TC è ugualea quella rilasciata nel corso di una TCX a scopo diagnostico,con una dose efficace di 15-20 mSv in media per le attivitàiniettate di solito (circa 5 MBq/kg) [5].
L’uso della PET nella donna in gravidanza rappresenta unacontroindicazione relativa ed è da discutere, come per gli esamidi imaging che utilizzano raggi ionizzanti, in funzione delcontesto clinico. Se la paziente allatta, l’allattamento deve essereinterrotto per diverse ore.
I – 20-902-A-01 ¶ Apporto delle tecniche di medicina nucleare nella gestione delle patologie della sfera otorinolaringoiatrica
2 Otorinolaringoiatria

L’unico vero limite dell’esame al 18F-FDG è il diabete nonequilibrato, perché l’iperglicemia, durante l’iniezione deltracciante, riduce notevolmente la sua fissazione nelle lesionimaligne e riduce la sensibilità della tecnica. L’uso di insulina almomento dell’iniezione non è consigliato perché comporta unaccumulo del tracciante nei muscoli scheletrici, provocandoimportanti artefatti e riducendo la disponibilità del traccianteper una fissazione lesionale.
Applicazioni cliniche (Tabella 1) [6]
Diagnosi di malignitàIn ORL, dove il tumore è di solito accessibile all’esame diretto
e alla biopsia, la diagnosi di malignità è effettuata dal medico
ORL e la conferma istologica dal patologo nelle biopsie. Latomografia a emissione di positroni al fluorodesossiglucosio(PET-FDG) non è quindi indicata per la diagnosi positiva deitumori ORL. Tuttavia, in caso di lesione clinicamente o radio-logicamente sospetta, ma in cui le biopsie restano negative,oltre alla diagnosi di malignità il metodo può orientare un attobioptico e aumentare così le sue possibilità di successo. Siricorda inoltre che, anche se il 18F-FDG non offre indicazioniriguardo alla natura istologica della lesione, l’intensità della suafissazione è correlata all’attività proliferativa delle cellulemaligne che compongono la lesione. Questa correlazione puòspiegare il ruolo prognostico dell’intensità della fissazioneiniziale, che è stato riportato. Così, per Kim et al. [7] nei cancridell’orofaringe, e per Roh et al. [8] nei cancri della laringe edell’ipofaringe, il valore del SUVmax della lesione primitiva nelbilancio dell’estensione iniziale rappresenta un fattore prognos-tico indipendente e incoraggia a ipertrattare le lesioni piùipermetaboliche (SUVmax superiore a 6 o 8). Secondo gliStandard, le Opzioni e le Raccomandazioni del 2003 per l’usodella PET al 18F-FDG (PET-FDG) in oncologia, lo studio quanti-tativo della fissazione del 18F-FDG da parte di un tumore dellevie aerodigestive superiori (VADS), la cui malignità è conosciuta,ha un valore prognostico, o per la probabilità di sopravvivenzao per la probabilità di recidiva dopo il trattamento. Questacaptazione può essere quantificata durante il bilancio iniziale odurante il follow-up, al fine di disporre di un fattore prognos-tico di sopravvivenza o di probabilità di recidiva dopo iltrattamento [9].
Bilancio d’estensione (Figg. 1 e 2)
Anche se molti studi hanno mostrato valori di sensibilitàmolto buoni per l’identificazione del tumore primitivo, parago-nabili a quelli della RMN o della TC [10-13], la PET e la PET-TC(senza iniezione di contrasto iodato) non forniscono informa-zioni altrettanto valide per stabilire i suoi esatti limiti. Così, essehanno un ruolo limitato nella determinazione dell’estensionelocale (T) al momento del bilancio dell’estensione iniziale.Questo ruolo resta pertinente all’imaging morfologico.
Tabella 1.Indicazioni e vantaggi della tomografia a emissione di positroni alfluorodesossiglucosio (PET-FDG) in oncologia otorinolaringoiatrica(ORL) [6].
Indicazioni Vantaggi
Bilancio di estensioneiniziale
Migliore valutazione dell’estensionelinfonodale locoregionale (con impatto suicampi di radioterapia e svuotamentochirurgico)
Migliore diagnosi delle metastasi a distanza
Localizzazione dei cancri sincroni
Identificazione della lesione primitiva incaso di adenopatia prevalente di carcinomaepidermoide di primitivo ignoto
Valutazione terapeutica Migliore valutazione della risposta al tratta-mento differenziando più precocementeresponder e non-responder
Sorveglianza Migliore differenziazione tra rimaneggia-menti post-terapeutici e recidiva maligna
Migliore diagnosi di metastasi a distanza
Diagnosi di un secondo cancro
Figura 1. Paziente di 67 anni. Bilancio di estensione iniziale di un carcinoma epidermoide della base della lingua destra. Esame con tomografia a emissionedi positroni al fluorodesossiglucosio (PET-FDG) presentato in prospettiva 3D (a) e immagini di fusione tomografia a emissione di positroni-tomodensitometria(PET-TC) in sezioni assiali trasverse (1), sagittali (2) e frontali (3). Messa in evidenza del carattere ipermetabolico della lesione primitiva della base della linguadestra associata a un’adenopatia necrotica del gruppo IIB omolaterale (b) e scoperta di una seconda localizzazione della radice dell’epiglottide sinistra (c), cosìcome di un terzo carcinoma sincrono del colon destro (d).
Apporto delle tecniche di medicina nucleare nella gestione delle patologie della sfera otorinolaringoiatrica ¶ I – 20-902-A-01
3Otorinolaringoiatria

Come per il tumore primitivo, la lesione metastatica linfono-dale è caratterizzata da ipermetabolismo, indipendentementedalla grandezza del linfonodo interessato. Ciò costituisceun’importante differenza con le tecniche di imaging anatomi-che che si basano solo su caratteri geometrici, come la gran-dezza del linfonodo come criterio di lesione neoplastica. Ora, auno stadio precoce il linfonodo metastatico non presentaimmediatamente un aumento di diametro e, d’altra parte, unlinfonodo può essere aumentato di volume per un processoinfettivo o infiammatorio di vicinanza. Questa differenza delcriterio di malignità è all’origine delle differenze di rendimentoriscontrate in letteratura tra PET e imaging radiologico. Così, perla valutazione dell’estensione linfonodale numerosi studi hannodimostrato la superiorità della PET-FDG rispetto all’imagingmorfologico nel bilancio di estensione iniziale [14-17]. Questasuperiorità è tanto più evidente con i dispositivi ibridi PET-TC.In una revisione della letteratura condotta da Schöder eYeung [18], la sensibilità della PET-FDG è compresa tra l’87% e il90% per una specificità compresa tra l’80% e il 93%, mentre laRMN e la TC presentano una sensibilità compresa tra il 61% eil 97% e una specificità variabile tra il 21% e il 100%. La tecnicanon è tuttavia perfetta e i suoi falsi negativi sono dovuti a unagrandezza delle lesioni troppo scarsa rispetto alla risoluzionespaziale della PET. Quindi, le lesioni linfonodali microscopichenon possono essere riconosciute [10, 19] e, nonostante le buoneprestazioni nella valutazione dell’estensione linfonodale, anchein caso di risultato negativo (N0), lo svuotamento selettivo nonpuò essere evitato ad oggi, lasciando così un ruolo certo allatecnica del linfonodo sentinella, sviluppata più avanti nelparagrafo «Tecnica del linfonodo sentinella». Allo stesso modo,la necrosi dei linfonodi tumorali riduce la possibilità di metterliin evidenza con la PET a causa del fenomeno di volume parzialeche degrada la misurazione della fissazione reale del tessutomaligno vitale nel contesto dell’adenopatia. In ogni modo, laPET-FDG svolge un ruolo importante, identificando delleadenopatie aggiuntive in territori meno tipici o misconosciuticon l’imaging radiologico (gruppo retrofaringeo, mediastinicosuperiore o ascellare).
Oltre il bilancio di estensione linfonodale locoregionale, ilcarattere a corpo intero del metodo permette di esplorare lecatene linfonodali distanti e i parenchimi frequentementecoinvolti dalle metastasi come polmoni, scheletro e fegato, con
una grande capacità di differenziare tra lesioni benigne esecondarie, con la riserva che le lesioni studiate presentino unvolume sufficiente. Così, alcune metastasi a distanza, misconos-ciute con i mezzi di imaging abituali, sono scoperte alla PET-FDG nel 10% circa dei pazienti che presentano uno stadioavanzato [13, 14, 16, 18, 20, 21]. Come per altri tumori ipermetabo-lici, in caso di sospetto di metastasi ossee la PET-FDG dovrebbesostituire la scintigrafia ossea con difosfonati al tecnezio. Aquesto proposito è da notare che la PET-TC con 18F-fluoruro disodio è ormai la tecnica scintigrafica a più alto rendimento perl’individuazione delle metastasi ossee.
Infine, la tecnica presenta un interesse certo per la ricerca,allo stesso tempo, di una seconda lesione maligna associata,polmonare, esofagea e via dicendo, caso frequentementeriscontrato, nel 15%-20% dei casi [2], per effetto della riparti-zione degli stessi fattori di rischio [22-24].
Questa superiorità della PET-TC rispetto alla PET singola e alletecniche di imaging morfologico al momento del bilancio diestensione iniziale si traduce, in particolare, in termini diimpatto clinico. Così, in uno studio di Fleming et al. [25] la PETha un impatto valutato al 31% nell’identificazione di 16 lesioniprimitive tra le 22 adenopatie prevalenti della sua serie, all’8%per i cancri sincroni o, ancora, al 15% per le metastasi adistanza. In uno studio prospettico di Gordin et al. [26] l’impattoè stato valutato al 56% (51/90) ed è dettagliato nel modoseguente: sei casi di biopsia guidata dalla PET, 24 disdette dibiopsie inizialmente previste per l’assenza di fissazione del 18F-FDG e 21 cambiamenti di strategia terapeutica.
È interessante notare che questa superiorità della PET-FDGrispetto alle tecniche morfologiche nel bilancio di estensione,ma anche in termini di impatto terapeutico, è stata osservataanche nei tumori maligni delle ghiandole salivari, benché i tipiistologici di queste lesioni siano molto vari con carcinomiepidermoidi, ma anche adenocarcinomi, carcinomi mucoepi-dermoidi, carcinomi adenoidocistici o, ancora, linfomiMALT [27-29].
Linfoadenopatia cervicale metastatica senzaporta d’entrata (Figg. 3 e 4)
Le adenopatie senza porta d’entrata rappresentano il 2%-9%dei tumori ORL. Questa modalità d’entrata nella malattianeoplastica è una situazione difficile, perché corrisponde a una
Carcinoma epidermoide ORL
Nc+ certo
PET raccomandataa PET opzionaleb
Nc+ dubbio
Agoaspirato(se modificazione
strategia terapeutica)
Nc 0
Trattamento definitivo
Esame clinicoEndoscopiaTC e/o RMN
−
±
Figura 2. Algoritmo decisionale. Ruolo della tomografia a emissione di positroni al fluorodesossiglucosio (PET-FDG) nel bilancio di estensione iniziale deicarcinomi epidermoidi della sfera otorinolaringoiatrica (ORL). RMN: risonanza magnetica; TC: tomodensitometria. aPET raccomandata: negli stadi avanzatiprima della decisione terapeutica essenzialmente per il miglioramento della determinazione dello status e dell’estensione linfonodale e prima della scoperta dimetastasi o di un secondo carcinoma misconosciuti dal bilancio convenzionale. bPET opzionale: in caso di trattamento non chirurgico per la valutazione dellarisposta alla terapia [9].
I – 20-902-A-01 ¶ Apporto delle tecniche di medicina nucleare nella gestione delle patologie della sfera otorinolaringoiatrica
4 Otorinolaringoiatria

malattia sin da subito metastatica per la quale le possibilitàterapeutiche e la prognosi vitale dipendono direttamentedall’identificazione della lesione primitiva. In una recente meta-analisi [30], che include studi specialmente dedicati a unasottopopolazione che ha beneficiato di un bilancio inizialecompleto infruttuoso, sia clinico sia di imaging morfologico,la PET-FDG permetteva di trovare il cancro primario nel 27%dei casi.
Praticata dopo le altre tecniche più convenzionali (TC, RMN,panendoscopia), la PET-FDG permette di identificare il tumoreprimitivo nel 30% dei casi in media (8-54%), costituendo, così,un’indicazione maggiore della tecnica [28, 29].
Diagnosi di malattia residua e di recidiva (Fig. 5)
Dopo un trattamento chirurgico o radioterapico la persistenzadi una formazione tissutale residua pone un problema diagnos-tico importante. Una tale lesione può corrispondere a unafibrosi cicatriziale inattiva, ma può anche rappresentare unfocolaio di persistenza della malattia che impone un tratta-mento complementare per evitare una recidiva precoce [31].
Inoltre, in caso di remissione completa dopo il trattamentoiniziale è necessario poter diagnosticare una recidiva nellamaniera più precoce possibile.
Questa indicazione costituisce un limite delle tecniche diimaging radiologico, che non possono differenziare in modoaffidabile una formazione fibrosa stabile residua e una lesioneresidua o una recidiva autentica. Il solo criterio differenziale èl’aumento delle dimensioni su due esami praticati a qualchesettimana o mese di distanza. Questa applicazione è uno degliapporti più importanti della tecnica PET, con una convergenzadei lavori pubblicati sia nello stabilire le prestazioni dellatecnica, con valori di sensibilità e di specificità superioriall’80%, che nel confermare la sua superiorità nei confrontidelle tecniche radiologiche per il riconoscimento delle lesionimaligne evolutive [32-39]. Quindi, trascorso un intervallo di12 settimane dopo la fine dei trattamenti e con l’aiuto degliapparecchi ibridi PET-TC, i valori di sensibilità riportati oscillanotra il 93% e il 100% per l’individuazione delle recidive sia alivello del sito primitivo sia a livello delle catene linfonodalilocoregionali o delle metastasi a distanza [40-50]. Tutti questi
Figura 3. Paziente di 62 anni. Ricerca di una lesione primitiva nel quadro di un’adenopatia cervicale sinistra di 4 cm, metastasi epidermoide di primitivoignoto. Esame con la tomografia a emissione di positroni al fluorodesossiglucosio (PET-FDG) presentato in immagini di prospettiva 3D (a), TC (b) e di fusionetomografia a emissione di positroni-tomodensitometria (PET-TC, c) in sezioni assiali trasverse (1) e frontali (2). Individuazione dell’adenopatia cervicale sinistraconosciuta e messa in evidenza della lesione primitiva della base della lingua sinistra.
Linfoadenopatia cervicale metastatica senza porta d'entrata
PanendoscopiaBiopsie guidate
PanendoscopiaBiopsie stadiate
Terapia adattata Trattamento primitivo ignoto
PETopzionaleb
PETraccomandataa
Esame clinicoEndoscopiaTC e/o RMN
−
+
+
+
−
Primitivo ignotoPrimitivo sospettato
Figura 4. Algoritmo decisionale. Ruolo della tomografia a emissione di positroni al fluorodesossiglucosio (PET-FDG) nel bilancio dei carcinomi epidermoididi primitivo ignoto rivelati da un’adenopatia prevalente. RMN: risonanza magnetica; TC: tomodensitometria. aPET raccomandata: per screening della lesioneprimitiva. bPET opzionale: nel quadro del bilancio di estensione iniziale [9].
Apporto delle tecniche di medicina nucleare nella gestione delle patologie della sfera otorinolaringoiatrica ¶ I – 20-902-A-01
5Otorinolaringoiatria

studi sottolineano la superiorità della PET-FDG rispetto al soloimaging morfologico. Questa ottima sensibilità si traduceessenzialmente con un valore predittivo negativo molto elevatoin questa indicazione, superiore al 90% nella PET singola [34] etra il 95% e il 100% nella PET-TC [38-40].
La messa in evidenza delle lesioni residue e delle recidive èdunque un’applicazione importante del metodo in oncologiaORL. Essa riscontra, tuttavia, lo stesso problema di specificitàdelle sue altre indicazioni, quest’ultima compresa tra il 63% e il94%. Così, la reazione infiammatoria postattinica è una fonteimportante di falsi positivi che possono persistere per parecchimesi dopo la fine dell’irradiazione. In pratica, è necessarioprevedere un intervallo di 3-4 mesi dopo la fine della radiote-rapia per effettuare il controllo PET, al fine di minimizzare ilrischio di falsi positivi infiammatori, restando compatibili conla gestione della malattia [34, 38, 39]. Un’altra difficoltà è rappre-sentata dalla radionecrosi, che può anche essere all’origine difalsi positivi. Essa impone una correlazione precisa con i daticlinici e con quelli delle altre tecniche di imaging.
Studio della risposta al trattamentoLa combinazione della chemioradioterapia sotto forma della
triade 5-fluorouracile (5FU)-cisplatino-docetaxel, da una parte, edella radioterapia con modulazione di intensità dall’altra,costituisce frequentemente la terapia iniziale dei tumori ORL.Questo trattamento di primo approccio non chirurgico puòessere scelto per due motivi principali: o nel quadro di unprotocollo di conservazione di organo nei cancri della laringeper evitare una chirurgia troppo mutilante nell’immediato o nelcaso in cui la terapia medica abbia dato prova della sua supe-riorità nei confronti del trattamento chirurgico. In questi casi laPET-FDG può essere particolarmente utile per valutare l’efficaciadella risposta al trattamento [51, 52]. In effetti, l’importanza dellafissazione del 18F-FDG è proporzionale all’attività proliferativadei tumori e alla vitalità delle cellule che li costituiscono. Lamodalità abituale di valutazione della risposta di una lesionemaligna alla chemioterapia è la riduzione di volume dellelesioni su immagini scanner consecutive. Questa riduzione divolume è la conseguenza dell’eliminazione delle cellule dis-trutte. Ora, questa distruzione cellulare è necessariamenteconseguente alle alterazioni metaboliche indotte dai prodottidella chemioterapia che porteranno alla morte cellulare. Per
questo fatto, una tecnica di imaging metabolico fornisceun’informazione più precoce quanto agli effetti della chemiote-rapia di una tecnica anatomica. Questo carattere precoce dellarisposta metabolica è all’origine dei lavori riguardanti lapossibilità di predire la risposta del tumore a una chemioterapiafin dal primo ciclo, per poter evitare la ripetizione di cicliinefficaci e costosi, ma che comportano gli stessi effetti secon-dari. Un limite di questo uso è la possibilità di persistenza diqualche cellula non evidenziabile nel contesto di una lesioneche non è più scintigraficamente percettibile. Questo limite èsimile a quello delle tecniche radiologiche, per le quali untumore che regredisce oltre la soglia di identificabilità non è piùvisibile senza che si possa formalmente dichiarare una steriliz-zazione completa.
Viceversa, la riduzione di volume di una lesione neoplasticanon significa necessariamente una sensibilità omogenea deltumore alla chemioterapia utilizzata. In effetti, in caso dieterogeneità clonali la chemioterapia porta all’eliminazione diun clone sensibile e alla selezione di un clone resistente.Quest’ultimo è all’origine di una recidiva tumorale precoce. Inquesta situazione, la riduzione del volume tumorale corrispondesolo all’eliminazione del clone sensibile. L’interesse della PET al18F-FDG è allora quello di evidenziare la persistenza di unafissazione di intensità costante o aumentata in seno a unalesione di volume minore.
Inoltre, l’effetto di una chemioterapia sulle lesioni malignepuò provocare un fenomeno di siderazione cellulare transitorioche impone di rispettare un intervallo di 2-3 settimane dopo lafine di una cura prima di un esame PET, per evitare di sottova-lutare la fissazione reale delle lesioni tumorali [51].
Ottimizzazione dei campi di radioterapia (Fig. 6)
Con lo sviluppo degli apparecchi ibridi PET-TC è diventatopossibile integrare le informazioni metaboliche fornite dalla PETnei campi della radioterapia conformazionale. Anche se questaindicazione molto promettente è in corso di valutazione, è natoun nuovo concetto di gross tumor volume-PET (GTV-PET), ovolume tumorale macroscopico delimitato dalla PET, ancorachiamato biological target volume o BTV. Quindi, il secondovantaggio della tecnica risiede nella modificazione dei volumi
ChemioradioterapiaRadioterapia da sola
AgoaspiratoBiopsia 3-4 mesi post-trattamento
PET raccomandataa
Chirurgia, se necessarioTrattamento di seconda linea
9 e 15 mesi post-trattamentoPET opzionaleb
2 mesi post-trattamentoRMN ± TC
2 mesi post-trattamentoEsame clinicoEndoscopia
−
−
++
+ +
−
Risposta completaapparente
Malattia residuaProgressione tumorale
Figura 5. Algoritmo decisionale. Ruolo della tomografia a emissione di positroni al fluorodesossiglucosio (PET-FDG) nella sorveglianza e nello screening dellerecidive precoci dei carcinomi epidermoidi della sfera otorinolaringoiatrica (ORL). aPET raccomandata: negli stadi avanzati che presentano un consistenterischio di recidiva. bPET opzionale: in funzione dei dati della clinica, dell’imaging morfologico e del rischio valutato di recidiva [9]. RMN: risonanza magnetica;TC: tomodensitometria.
I – 20-902-A-01 ¶ Apporto delle tecniche di medicina nucleare nella gestione delle patologie della sfera otorinolaringoiatrica
6 Otorinolaringoiatria

bersaglio modificando la definizione del GTV e, quindi, delplanning target volume o PTV e, infine, del volume di tessutosano irradiato. Schematicamente, i risultati possono esserepresentati così:• gli incrementi importanti della GTV-PET-TC in rapporto alla
GTV-TC sono in generale dovuti all’integrazione nel volumebersaglio di adenopatie misconosciute nel bilancio standard oal riconoscimento del tumore primitivo in caso di carcinomaprimitivo ignoto;
• le modificazioni della sagomatura del tumore stesso sonomeno evidenti, e quindi meno valide, in quanto ci si scontracon problemi tecnici di sagomatura dell’informazione meta-bolica non ancora completamente risolti. Tuttavia, moltiautori sembrano trovare una migliore riproducibilità dellasagomatura tumorale e, dunque, una minore variabilitàinteroperatore quando sono presi in considerazione i datidella PET [53].Così, molte pubblicazioni hanno riportato modificazioni dei
piani di trattamento nel 20% circa dei casi, tenendo conto deidati della PET-FDG. Questi cambiamenti interessano di più ilpiano dell’area linfonodale (nella maggior parte dei casiaumentando più che riducendo la grandezza del campo inizial-mente previsto) che quello del tumore stesso [54, 55]. Tuttavia,questo uso della tecnica è ancora di dominio della ricercaclinica e sono necessari altri studi per precisare la sagomaturaesatta dell’informazione metabolica [56, 57].
■ Medicina nucleare monofotonica
Tecnica del linfonodo sentinella (Fig. 7)
PrincipiIl coinvolgimento linfonodale è uno dei principali fattori
prognostici nei tumori delle VADS [58]. La tecnica del linfonodosentinella è interessante nelle localizzazioni in cui il tasso diinvasione linfonodale subclinica è inferiore al 15-25%. Essa èoggi ben provata per alcune localizzazioni tumorali, tra le qualii melanomi cutanei e i tumori del seno [59]. È utilizzata piùrecentemente nei carcinomi epidermoidi della sfera ORL e, piùin particolare, nei tumori della cavità orale. Il suo principio sibasa sulla localizzazione intraoperatoria del primo relè linfono-dale del drenaggio linfatico del tumore, permettendo così dinotare un’eventuale invasione linfonodale nei pazienti affetti daun piccolo tumore classificato T1 o T2, N0, cioè senza alcuninteressamento linfonodale clinico né radiologico. La tecnicapermette di evitare uno svuotamento linfonodale selettivo che,da solo, potrebbe affermare con certezza la presenza o meno diuna metastasi linfonodale.
La sua giustificazione si basa sul fatto che, qualunque sia lamodalità del trattamento (chirurgia o radioterapia) del tumoreprimitivo, si pone sempre il problema dell’atteggiamentoterapeutico da adottare nei confronti delle aree linfonodali inun paziente per il quale non è stata scoperta un’invasionelinfonodale clinica e radiologica. Tutte le tecniche di imagingmoderne TC, RMN, ecografia e PET [60] permettono di visualiz-zare le adenopatie centimetriche o infracentimetriche, ma senza
Figura 6. Tomografia a emissione di positroni (PET) e radioterapia.Acquisizione dell’esame PET in posizione di trattamento su piano duro conmaschera di contenzione (A). Sagomatura dei volumi bersaglio che rigu-arda la lesione primitiva del solco glossotonsillare sinistro e un’adenopatiaomolaterale a partire da immagini di fusione con tomografia a emissionedi positroni-tomodensitometria (PET-TC) (B, C).
Figura 7. Paziente di 52 anni con carcinoma epidermoide del pavimento della bocca classificato T1N0. Linfoscintigrafia per reperire dei linfonodi sentinella.Visualizzazione dei punti di iniezione, migrazione linfatica bilaterale dei colloidi radiomarcati e ritrovamento di due linfonodi dei gruppi IIB e III a destra e asinistra (si ringrazia il Dott. Lumbroso, Institut Gustave Roussy, Villejuif).
Apporto delle tecniche di medicina nucleare nella gestione delle patologie della sfera otorinolaringoiatrica ¶ I – 20-902-A-01
7Otorinolaringoiatria

poter affermare con sensibilità e specificità sufficienti se sonoinvase o meno, in particolare in caso di micrometastasi.
Esecuzione praticaL’iniezione peritumorale del colloide marcato al Tc99m
permette, prima dell’intervento, di localizzare il linfonodosentinella su immagini di linfoscintigrafia e quindi, durantel’intervento, permette di stabilire la sua localizzazione precisacon l’aiuto di una sonda di rilevamento gamma intraoperatoria.La linfoscintigrafia preoperatoria è realizzata la vigilia o lamattina stessa dell’intervento per localizzare il (o i) linfonodo(i)sentinella. Il radiotracciante utilizzato è il solfuro di reniooppure un derivato dell’albumina umana marcato con Tc99m.Viene iniettato per via sottomucosa ai quattro punti cardinalidel tumore. L’attività per iniezione è dell’ordine di 4 MBq perun volume di 0,1 ml. Si consiglia di fare una premedicazioneseguita da un’anestesia locale con tetracaina al 5%, perchél’iniezione del colloide marcato è dolorosa per la sua acidità. Sirealizzano alcune immagini frontali e di profilo con una cameraa scintillazione 15-60 minuti dopo l’iniezione. La proiezione insuperficie del (o dei) linfonodo(i) sentinella è repertata sullapelle del paziente con un pennarello. Se con la linfoscintigrafiasono identificate due aree linfonodali di drenaggio, la cartogra-fia linfatica intraoperatoria e la linfadenectomia selettiva sonorealizzate sui due gruppi linfonodali, perché non è possibilepredire quale gruppo linfonodale sarebbe la sede di eventualimetastasi. Nel caso in cui l’area linfonodale non sia chiaramenteidentificata (tumore primario a contatto con il gruppo linfono-dale regionale o in sua prossimità, per esempio) oppure se sonoidentificate più di due aree linfonodali, si esegue il trattamentoabituale, che comprende uno svuotamento linfonodale selettivocon un esame istologico estemporaneo dei linfonodi prelevati.
La localizzazione in sala operatoria dei siti di drenaggiolinfatico è realizzata con l’aiuto della sonda di rilevamentogamma intraoperatoria. Essa permette una misura della radioat-tività presente a livello del (o dei) linfonodo (i) sentinella eassicura quindi l’esattezza della localizzazione. Il procedimentoinizia con un reperaggio transcutaneo del linfonodo sentinellacon la sonda di rilevamento in corrispondenza dei repericutanei posti durante la linfoscintigrafia. Questo reperaggiopermette di precisare il punto in cui deve essere realizzatal’incisione cutanea, dovendo questa posizionarsi sul tragittodell’incisione di uno svuotamento linfonodale regionale com-pleto. I tessuti sottocutanei sono dissecati per ricercare illinfonodo sentinella con la guida della sonda di rilevamentogamma.
La radioattività deve essere messa in evidenza nel linfonodosentinella e deve persistere dopo l’escissione ed essere obietti-vata ex vivo. Il tasso di radioattività nell’area linfonodale didrenaggio deve tornare al livello basale dopo l’exeresi dellinfonodo sentinella. In caso contrario, possono essere ancorapresenti dei linfonodi sentinella non rimossi nell’area didrenaggio. Si deve eseguire un’esplorazione complementare perindividuare questi linfonodi.
Il (o i) linfonodo(i) sentinella prelevato(i) è (sono) inviato(i)per lo studio istologico estemporaneo o differito con sezioniseriate in paraffina e colorazione in immunoistochimica conanticorpi anti-CK22: ciò permette un esame più approfonditodel linfonodo a rischio e una migliore diagnosi delle microme-tastasi. Se l’esame istologico estemporaneo o definitivo mostraun linfonodo metastatico, deve essere realizzato uno svuota-mento radicale modificato che preservi il nervo spinale e ilmuscolo sternocleidomastoideo, asportando i gruppi restanti I-V.Da notare che l’exeresi del tumore è realizzata dopo il gestolinfonodale.
Questa tecnica richiede tuttavia un apprendimento, cosìcome la prossimità di un reparto di medicina nucleare, e perciònon è praticabile in tutti gli ospedali.
RisultatiMolti studi sono stati dedicati alla tecnica del linfonodo
sentinella in oncologia ORL [61-66]. Una meta-analisi europea èstata realizzata nel 2005 a partire da 20 centri partecipanti su379 pazienti [66]. Il linfonodo sentinella è stato identificato nel97% dei casi (366/379). Tra questi 366 casi, 103 linfonodisentinella (29%) erano metastatici e 263 (71%) erano negativi.
Tra questi 263 casi negativi, 11 pazienti (4%) presentavanoun’adenopatia metastatica non rivelata con la tecnica dellinfonodo sentinella. È stato quindi possibile valutare al 96% ilvalore predittivo negativo della tecnica. Questo tasso del 4% diinsuccessi risultava identico in uno studio di Mamelle et al. [61],dove lo svuotamento linfonodale selettivo era utile solo in unpiccolo numero di pazienti perché il tasso di rischio di inva-sione linfonodale istologica era solo del 13% in caso di cancroclassificato T1N0 e del 34% in caso di T2N0.
Così, sono ormai possibili tre atteggiamenti nei casi classifi-cati N0 clinicamente e radiologicamente:• o l’assenza di un gesto linfonodale con la semplice sorve-
glianza, se il paziente è collaborante e accetta di essereseguito regolarmente. Questo atteggiamento non compro-mette la sopravvivenza, ma espone a riprese chirurgiche avolte difficili, se compare secondariamente un’adenopatiaclinica sospetta;
• o lo svuotamento selettivo dei gruppi I, II e III (sottomandi-bolare, sottodigastrico e sopra-omoioideo) con l’esameistologico estemporaneo dei linfonodi e, in caso di positività,uno svuotamento radicale modificato. Questo atteggiamentopermette di avere un buon controllo linfonodale con un tassodi recidive linfonodali locali isolate di circa il 5%, in partelegato alle metastasi che saltano i primi relè linfonodali [61];
• o, infine, la tecnica del linfonodo sentinella, per la quale iltasso di evoluzioni locali è sovrapponibile al precedente, macon il vantaggio di evitare uno svuotamento linfonodaleselettivo nel 77% dei pazienti [61], riducendo così la morbilità,la durata e il costo del trattamento con la stessa sicurezzaoncologica.
Prospettive per i tumori dell’orofaringee della laringe
Per i tumori dell’orofaringe e della laringe la determinazionedell’assenza di un’invasione linfonodale cervicale con la tecnicadel linfonodo sentinella permetterebbe di limitare l’irradiazionesistematica delle aree cervicali. In effetti, quest’ultima presental’inconveniente di irradiare le ghiandole salivari e di causareuna xerostomia invalidante per il paziente. Essa limita anche lepossibilità di trattamento di un eventuale secondo cancro dellevie aeree e digestive superiori, molto frequenti in questipazienti. In caso di negatività del linfonodo sentinella, unaradioterapia conformazionale con modulazione di intensità,limitata al letto tumorale, permetterebbe di evitare questiinconvenienti. La tecnica è tuttavia di realizzazione molto piùcomplessa in queste indicazioni. L’iniezione di colloide marcatosi deve eseguire in anestesia generale in endoscopia in salaoperatoria, il che richiede un’autorizzazione amministrativaparticolare da parte dell’Autorité de sûreté nucléaire [NdR: Autoritàdi sicurezza nucleare]. Il reperaggio della migrazione locale delcolloide marcato deve anche essere fatto con l’aiuto di unacamera portatile, prima di effettuare il seguito della procedura.Questa procedura si rivela altrettanto affidabile per i tumoridella cavità orale, ma permette di prevedere una diminuzioneprogressiva dei trattamenti dei piccoli tumori dell’orofaringe ilcui linfonodo sentinella è indenne da metastasi. È quindinecessario validare l’interesse oncologico e funzionale di questonuovo approccio nel quadro di studi multicentrici, per ottenereun numero sufficiente di pazienti [61, 67].
Otite maligna esternaL’otite maligna esterna è una patologia rara che colpisce
soprattutto i pazienti diabetici e che rappresenta la complicanzadi una sovrainfezione della regione auricolare da Pseudomonasaeruginosa. Può essere limitata alle parti molli periauricolari, maè possibile la distruzione di tutto l’osso timpanico o di una suaparte. A volte l’otite maligna esterna si estende in maniera deltutto torpida verso la parte inferiore della base del cranio alivello del seno sfenoidale. Questa patologia può infiltrare leparti molli sottopetrose e svilupparsi nelle regioni profondedella faccia e negli spazi pterigoideo e laterofaringeo, in manierarelativamente silente sul piano clinico. È quindi importante, inogni caso di sospetto di otite maligna esterna o, più in generale,di lesione destruente del condotto uditivo esterno, eseguire unimaging della regione [68]. Nella diagnosi iniziale la RMN è
I – 20-902-A-01 ¶ Apporto delle tecniche di medicina nucleare nella gestione delle patologie della sfera otorinolaringoiatrica
8 Otorinolaringoiatria

l’esame di prima intenzione, indispensabile per la valutazionedell’interessamento delle parti molli. La scintigrafia ossea condifosfonati al tecnezio, associando immagini a tempi precoci etardivi con il complemento di uno studio tomoscintigrafico(ormai accoppiato alla TC su macchinari ibridi PET-TC), appareessere l’esame di scelta per valutare la lesione ossea. Il limite diqueste tecniche in questa indicazione sta nella loro incapacitàa differenziare, al momento del follow-up terapeutico, leimmagini da postumi dalle immagini di infezione ancora attiva.La scintigrafia con citrato di gallio 67, come marcatore nonspecifico di fenomeni infiammatori e infettivi, eseguita conacquisizioni tomoscintigrafiche, è stata riportata come l’esamepiù efficace in questa indicazione per il follow-up e per lavalutazione di efficacia del trattamento [69, 70].
Da notare anche che, per il carattere non specifico dellafissazione del 18F-FDG nelle lesioni ipermetaboliche a voltecancerose, ma anche per i processi infettivi e infiammatori, laPET potrebbe senza dubbio rivestire un ruolo importante inquesta indicazione in sostituzione della scintigrafia con gallio,a causa di una minore irradiazione del paziente e di unamigliore risoluzione spaziale.
Scintigrafia delle paratiroidiIndicata prima di ogni reintervento per iperparatiroidismo
persistente o recidivante, prima della chirurgia per iperparatiroi-dismo in caso di precedenti di chirurgia cervicale, in particolaretiroidea, la scintigrafia delle ghiandole paratiroidi può essereinoltre proposta per guidare qualsiasi chirurgia paratiroidea (peruna riduzione della durata operatoria) e per individuareun’eventuale ectopia [71-73].
La difficoltà principale della scintigrafia al Tc99m sestamibi èquella di distinguere l’attività paratiroidea dall’attività tiroidea.Sono stati proposti vari protocolli. Schematicamente, si possonodistinguere due tipi di approccio:• le metodiche dette «di sottrazione», fondate sulle differenze
di distribuzione del Tc99m sestamibi e di un radiofarmacospecifico della tiroide (Tc99m O4 o I123);
• le metodiche temporali che sfruttano le differenze di cineticatra tessuto tiroideo e tessuto paratiroideo nella cinetica dicaptazione e di rilascio del Tc99m sestamibi, metodo detto di«doppia fase» e di analisi fattoriale di strutture dinamiche.Qualunque sia il metodo utilizzato, esso deve anche compor-
tare alcune sequenze per l’identificazione di ghiandole parati-roidee al di fuori dell’area tiroidea o «ghiandole ectopiche».Jeanguillaume et al. [74] hanno così potuto mostrare buoneprestazioni della scintigrafia delle paratiroidi in un contestopreoperatorio con una sensibilità di individuazione migliore,paragonata all’ecografia (82% vs 54%). Più recentemente, Harriset al. [75], usando una camera ibrida PET-TC, riscontrano lostesso valore di sensibilità di individuazione con, in più, laprecisione anatomica conferita dall’immagine di fusione.
Scintigrafia delle ghiandole salivariPrincipale indicazione della tecnica, la sindrome di Gougerot-
Sjögren (SGS) è sospettata per l’esistenza di una sindrome seccaclinica. La diagnosi della sindrome secca è completata conl’esame oculistico eseguendo i test di Schirmer e del rosabengala. La conferma della SGS si basa sulla biopsia delleghiandole salivari accessorie. Questo gesto semplice è realizzatoin ambulatorio e consiste in un prelievo sulla faccia mucosa dellabbro inferiore. L’esame istologico delle ghiandole salivarifornisce dati sul grado dell’infiltrato linfocitario, sull’alterazionedelle strutture ghiandolari, acini e canali escretori, e sulla fibrosidel parenchima. Le tecniche morfologiche che permettono distudiare le ghiandole salivari come la sialografia non sonoutilizzate nella pratica corrente. Lo stesso vale per la scintigrafiadelle ghiandole salivari che permette lo studio dinamico delflusso salivare dopo la stimolazione allo svuotamento conlimone o vitamina C [76-78]. L’esame consiste nell’acquisizionedinamica centrata sulle ghiandole salivari per una quarantina diminuti dopo l’iniezione endovenosa di 740 MBq di pertecnetatodi sodio (tecnezio 99m). Si può così evidenziare un ritardodell’eliminazione della saliva nel caso della sindrome secca o incaso di sindrome ostruttiva.
La sialoscintigrafia è stata recentemente proposta per lavalutazione funzionale delle ghiandole salivari, qualora essedebbano essere incluse nella pianificazione del trattamento dellaradioterapia per neoplasie ORL. Secondo Tenhunen et al. [79],essa permette di predire le sequele post-terapeutiche e, dunque,di adattare la radioterapia con la modulazione dell’intensità.
■ ConclusioniL’avvento della PET al 18F-FDG nell’oncologia della testa e
del collo ha profondamente modificato i rapporti tra medicinucleari e chirurghi ORL. Le capacità dell’imaging a corpointero del metodo e la sua specificità di imaging metabolico nefanno una tecnica molto efficace per il bilancio dell’estensionelinfonodale regionale o a distanza, come per la diagnosi delleneoplasie sincrone. Il suo ruolo è destinato a diventare fonda-mentale per la ricerca di lesioni residue e per l’individuazioneprecoce delle recidive. La valutazione della risposta dei tumoriai trattamenti con la chemioterapia e l’ottimizzazione deivolumi bersaglio alla radioterapia saranno anch’esse delleapplicazioni piene di prospettive, tanto più che la tecnica PETè in evoluzione costante. Oltre al solo apparecchio, sono incorso di validazione clinica nuovi traccianti al fine di superare ilimiti del 18F-FDG. Questi ultimi sono più specifici e riguardanoaltri metabolismi, proteici e nucleotidici, che permettono diliberarsi dagli artefatti indotti dalle reazioni flogistiche.
I limiti della PET-FDG riguardo ai piccoli tumori della cavitàorale classificati T1 o T2, N0, cioè senza alcun interessamentolinfonodale clinico o radiologico, sono già ovviati in numerosicentri grazie alla tecnica del linfonodo sentinella, che stabilisceuna nuova relazione tra le due specialità, permettendo di evitareuno svuotamento linfonodale selettivo nei tre quarti deipazienti e riducendo così la morbilità, la durata e il costo deltrattamento con la stessa sicurezza oncologica.
Infine, le altre tecniche di medicina nucleare di uso piùclassico, benché confinate ad applicazioni cliniche relativa-mente poco frequenti, non hanno tuttavia un minore interesseper il medico, che si tratti della valutazione dell’efficacia deltrattamento dell’otite maligna esterna con la tomoscintigrafiaossea con difosfonati al tecnezio e la scintigrafia al gallio 67,della ricerca degli adenomi paratiroidei nel bilancio preoperato-rio con la scintigrafia delle paratiroidi o, ancora, della valuta-zione funzionale delle ghiandole salivari mediante lasialoscintigrafia.
■ Riferimenti bibliografici[1] InternationalAgency for Research on Cancer. GLOBOCAN 2002. http:
//www-dep.iarc.fr/globocan/database.htm.[2] Marandas P. Cancers des voies aéro-digestives supérieures. Données
actuelles. Collection ORL. Paris: Masson; 2004.[3] Vuillez JP. Métabolisme glucidique des cellules tumorales : conséquen-
ces pour l’utilisation des radiopharmaceutiques analogues du glucose.Med Nucl 1998;1:9-29.
[4] Warburg O, Wind F, Neglers E. On the metabolism of the tumors in thebody. In: Warburg O, editor. The metabolism of tumors. London:Constable; 1930. p. 254-70.
[5] Brix G, Lechel U, Glatting G, Ziegler SI, Münzing W, Müller SP, et al.Radiation exposure of patients undergoing whole-body dual-modality18F-FDG PET/CT examinations. J Nucl Med 2005;46:608-13.
[6] Moretti JL, Weinmann P, Tamgac F, Rigo P. Imagerie fonctionnelle parpositons en oncologie nucléaire. Paris: Springer; 2004 (181p).
[7] Kim SY, Roh JL, Kim MR, Kim JS, Choi SH, Nam SY, et al. Use of18F-FDG PET for primary treatment strategy in patients withsquamous cell carcinoma of the oropharynx. J Nucl Med 2007;48:752-7.
[8] Roh JL, Pae KH, Choi SH, Kim JS, Lee S, Kim SB, et al. 2-18F.-Fluoro-2-deoxy-D-glucose positron emission tomography as guidance forprimary treatment in patients with advanced-stage resectable squamouscell carcinoma of the larynx and hypopharynx. Eur J Surg Oncol 2007;33:790-5.
[9] Bourguet P, Groupe de Travail SOR. FNCLCC. Recommandationspour la pratique clinique : Standards, Options et Recommandations2003 pour l’utilisation de la tomographie par émission de positons au18F.-FDG (TEP-FDG) en cancérologie. Rapport intégral. 2003(p. 135-58).
.
Apporto delle tecniche di medicina nucleare nella gestione delle patologie della sfera otorinolaringoiatrica ¶ I – 20-902-A-01
9Otorinolaringoiatria

[10] Kim MR, Roh JL, Kim JS, Lee JH, Cho KJ, Choi SH, et al. Utility of18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography in thepreoperative staging of squamous cell carcinoma of the oropharynx.Eur J Surg Oncol 2007;33:633-8.
[11] Ha PK, Hdeib A, Goldenberg D, Jacene H, Patel P, Koch W, et al. Therole of positron emission tomography and computed tomographyfusion in the management of early-stage and advanced-stage primaryhead and neck squamous cell carcinoma. Arch Otolaryngol Head NeckSurg 2006;132:12-6.
[12] Paulus P, Sambon A, Vivegnis D, Hustinx R, Moreau P, Collignon J,et al. 18FDG-PET for the assessment of primary head and neck tumors:clinical, computed tomography, and histopathological correlation in 38patients. Laryngoscope 1998;108:1578-83.
[13] Goerres GW, Schmid DT, Gratz KW, von Schulthess GK, Eyrich GK.Impact of whole body positron emission tomography on initial stagingand therapy in patients with squamous cell carcinoma of the oral cavity.Oral Oncol 2003;39:547-51.
[14] Schmid DT, Stoeckli SJ, Bandhauer F, Huguenin P, Schmid S, vonSchulthess GK, et al. Impact of positron emission tomography on theinitial staging and therapy in locoregional advanced squamous cellcarcinoma of the head and neck. Laryngoscope 2003;113:888-91.
[15] Di Martino E, Nowak B, Hassan HA, Hausmann R, Adam G, Buell U,et al. Diagnosis and staging of head and neck cancer: a comparison ofmodern imaging modalities (positron emission tomography, computedtomography, color-coded duplex sonography) with panendoscopic andhistopathologic findings. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2000;126:1457-61.
[16] Schwartz DL, Rajendran J,Yueh B, Coltrera M,AnzaiY, Krohn K, et al.Staging of head and neck squamous cell cancer with extended-fieldFDG-PET. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2003;129:1173-8.
[17] Adams S, Baum RP, Stuckensen T, Bitter K, Hor G. Prospectivecomparison of 18F-FDG PET with conventional imaging modalities(CT, MRI, US) in lymph node staging of head and neck cancer. EurJ Nucl Med 1998;25:1255-60.
[18] Schöder H, Yeung HW. Positron emission imaging of head and neckcancer, including thyroid carcinoma. Semin Nucl Med 2004;34:180-97.
[19] Schöder H, Carlson DL, Kraus DH, Stambuk HE, Gönen M, Erdi YE,et al. 18F-FDG PET/CT for detecting nodal metastases in patients withoral cancer staged N0 by clinical examination and CT/MRI. J Nucl Med2006;47:755-62.
[20] Dammann F, Horger M, Mueller-Berg M, Schlemmer H, Claussen CD,Hoffman J, et al. Rational diagnosis of squamous cell carcinoma of thehead and neck region: comparative evaluation of CT, MRI, and 18FDGPET. AJR Am J Roentgenol 2005;184:1326-31.
[21] Teknos TN, Rosenthal EL, Lee D, Taylor R, Marn CS. Positronemission tomography in the evaluation of stage III and IV head andneck cancer. Head Neck 2001;23:1056-60.
[22] Wax MK, Myers LL, Gabalski EC, Husain S, Gona JM, Nabi H.Positron emission tomography in the evaluation of synchronous lunglesions in patients with untreated head and neck cancer. ArchOtolaryngol Head Neck Surg 2002;128:703-7.
[23] Keyes Jr. JW, Chen MY, Watson Jr. NE, Greven KM, McGuirt WF,Williams 3rd DW. FDG PET evaluation of head and neck cancer: valueof imaging the thorax. Head Neck 2000;22:105-10.
[24] Perlow A, Bui C, Shreve P, Sundgren PC, Teknos TN, Mukherji SK.High incidence of chest malignancy detected by FDG PET in patientssuspected of recurrent squamous cell carcinoma of the upperaerodigestive tract. J Comput Assist Tomogr 2004;28:704-9.
[25] Fleming Jr. AJ, Smith Jr. SP, Paul CM, Hall NC, Daly BT, Agrawal A,et al. Impact of 18F.-2-fluorodeoxyglucose-positron emissiontomography/computed tomography on previously untreated head andneck cancer patients. Laryngoscope 2007;117:1173-9.
[26] Gordin A, Golz A, Keidar Z, Daitzchman M, Bar-Shalom R, Israel O.The role of FDG-PET/CT imaging in head and neck malignantconditions: impact on diagnostic accuracy and patient care.Otolaryngol Head Neck Surg 2007;137:130-7.
[27] Roh JL, Ryu CH, Choi SH, Kim JS, Lee JH, Cho KJ, et al. Clinicalutility of 18F-FDG PET for patients with salivary gland malignancies.J Nucl Med 2007;48:240-6.
[28] Cermik TF, Mavi A, Acikgoz G, Houseni M, Dadparvar S, Alavi A.FDG PET in detecting primary and recurrent malignant salivary glandtumors. Clin Nucl Med 2007;32:286-91.
[29] Jeong HS, Chung MK, Son YI, Choi JY, Kim HJ, Ko YH, et al. Role of18F-FDG PET/CT in management of high-grade salivary glandmalignancies. J Nucl Med 2007;48:1237-44.
[30] Menda Y, Graham MM. Update on 18F-fluorodeoxyglucose/positronemission tomography and positron emission tomography/computedtomography imaging of squamous head and neck cancers. Semin NuclMed 2005;35:214-9.
[31] Bronstein AD, Nyberg DA, Schwartz AN, Shuman WP, Griffin BR.Soft tissue changes after head and neck radiation: CT findings. AJNRAm J Neuroradiol 1989;10:171-5.
[32] Kitagawa Y, Nishizawa S, Sano K, Ogasawara T, Nakamura M,Sadato N, et al. Prospective comparison of 18F-FDG PET withconventional imaging modalities (MRI, CT, and 67Ga scintigraphy) inassessment of combined intraarterial chemotherapy and radiotherapyfor head and neck carcinoma. J Nucl Med 2003;44:198-206.
[33] Dalsaso TA, Lowe VJ, Dunphy FR, Martin DS, Boyd JH, Stack BC.FDG-PET and CT in evaluation of chemotherapy in advanced head andneck cancer. Clin Positron Imaging 2000;3:1-5.
[34] Andrade RS, Heron DE, Degirmenci B, Filho PA, Branstetter BF,Seethala RR, et al. Posttreatment assessment of response using FDG-PET/CT for patients treated with definitive radiation therapy for headand neck cancers. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006;65:1315-22.
[35] Klabbers BM, Lammertsma AA, Slotman BJ. The value of positronemission tomography for monitoring response to radiotherapy in headand neck cancer. Mol Imaging Biol 2003;5:257-70.
[36] Goerres GW, Schmid DT, Bandhauer F, Huguenin PU, vonSchulthess GK, Schmid S, et al. Positron emission tomography in theearly follow-up of advanced head and neck cancer. Arch OtolaryngolHead Neck Surg 2004;130:105-9.
[37] Kubota K, Yokoyama J, Yamaguchi K, Ono S, QureshyA, Itoh M, et al.FDG-PET delayed imaging for the detection of head and neck cancerrecurrence after radio-chemotherapy: comparison with MRI/CT. EurJ Nucl Med Mol Imaging 2004;31:590-5.
[38] Ryan WR, Fee Jr. WE, Le QT, Pinto HA. Positron-emissiontomography for surveillance of head and neck cancer. Laryngoscope2005;115:645-50.
[39] Porceddu SV, Jarmolowski E, Hicks RJ, Ware R, Weih L, Rischin D,et al. Utility of positron emission tomography for the detection ofdisease in residual neck nodes after (chemo)- radiotherapy in head andneck cancer. Head Neck 2005;27:175-81.
[40] Yao M, Luo P, Hoffman HT, Chang K, Graham MM, Menda Y, et al.Pathology and FDG PET correlation of residual lymph nodes in headand neck cancer after radiation treatment. Am J Clin Oncol 2007;30:264-70.
[41] Fischbein NJ, AAssar OS, Caputo GR, Kaplan MJ, Singer MI,Price DC, et al. Clinical utility of positron emission tomography with18F-fluorodeoxyglucose in detecting residual/recurrent squamous cellcarcinoma of the head and neck. AJNR Am J Neuroradiol 1998;19:1189-96.
[42] Hanasono MM, Kunda LD, Segall GM, Ku GH, Terris DJ. Uses andlimitations of FDG positron emission tomography in patients with headand neck cancer. Laryngoscope 1999;109:880-5.
[43] Stokkel MP, Terhaard CH, Hordijk GJ, Van Rijk PP. The detection oflocal recurrent head and neck cancer with fluorine-18fluorodeoxyglucose dual-head positron emission tomography. EurJ Nucl Med 1999;26:767-73.
[44] Lonneux M, Lawson G, Ide C, Bausart R, Remacle M, Pauwels S.Positron emission tomography with fluorodeoxyglucose for suspectedhead and neck tumor recurrence in the symptomatic patient.Laryngoscope 2000;110:1493-7.
[45] Lowe VJ, Boyd JH, Dunphy FR, Kim H, Dunleavy T, Collins BT, et al.Surveillance for recurrent head and neck cancer using positronemission tomography. J Clin Oncol 2000;18:651-8.
[46] Greven KM, Williams 3rd DW, McGuirt Sr. WF, Harkness BA,D’Agostino Jr. RB, Keyes Jr. JW, et al. Serial positron emissiontomography scans following radiation therapy of patients with headand neck cancer. Head Neck 2001;23:942-6.
[47] Li P, Zhuang H, Mozley PD, Denittis A, Yeh D, Machtay M, et al.Evaluation of recurrent squamous cell carcinoma of the head and neckwith FDG positron emission tomography. Clin Nucl Med 2001;26:131-5.
[48] Terhaard CH, Bongers V, Van Rijk PP, Hordijk GJ. F-18-Fluoro-deoxy-glucose positron-emission tomography scanning in detection of localrecurrence after radiotherapy for laryngeal/pharyngeal cancer. HeadNeck 2001;23:933-41.
[49] Wong RJ, Lin DT, Schöder H, Patel SG, Gonen M, Wolden S, et al.Diagnostic and prognostic value of (18)F.fluorodeoxyglucose positronemission tomography for recurrent head and neck squamous cellcarcinoma. J Clin Oncol 2002;20:4199-208.
[50] Quon A, Fischbein NJ, McDougall IR, Le QT, Loo Jr. BW, Pinto H,et al. Clinical role of 18F-FDG PET/CT in the management ofsquamous cell carcinoma of the head and neck and thyroid carcinoma.J Nucl Med 2007;48:58S-67S.
I – 20-902-A-01 ¶ Apporto delle tecniche di medicina nucleare nella gestione delle patologie della sfera otorinolaringoiatrica
10 Otorinolaringoiatria

[51] Kostakoglu L, Goldsmith SJ. PETin the assessment of therapy responsein patients with carcinoma of the head and neck and of the esophagus.J Nucl Med 2004;45:56-68.
[52] Nam SY, Lee SW, Im KC, Kim JS, Kim SY, Choi SH, et al. Earlyevaluation of the response to radiotherapy of patients with squamouscell carcinoma of the head and neck using 18FDG-PET. Oral Oncol2005;41:390-5.
[53] Breen SL, Publicover J, De Silva S, Pond G, Brock K, O’Sullivan B,et al. Intraobserver and interobserver variability in GTV delineation onFDG-PET-CT images of head and neck cancers. Int J Radiat Oncol BiolPhys 2007;68:763-70.
[54] Ciernik IF, Dizendorf E, Baumert BG, Reiner B, Burger C, Davis JB,et al. Radiation treatment planning with an integrated positron emissionand computer tomography (PET/CT): a feasibility study. Int J RadiatOncol Biol Phys 2003;57:853-63.
[55] Heron DE, Andrade RS, Flickinger J, Johnson J, Agarwala SS, Wu A,et al. Hybrid PET-CT simulation for radiation treatment planning inhead-and-neck cancers: a brief technical report. Int J Radiat Oncol BiolPhys 2004;60:1419-24.
[56] Grégoire V, BolA, Geets X, Lee J. Is PET-based treatment planning thenew standard in modern radiotherapy? The head and neck paradigm.Semin Radiat Oncol 2006;16:232-8.
[57] Geets X, Lee JA, Bol A, Lonneux M, Grégoire V. A gradient-basedmethod for segmenting FDG-PET images: methodology and valida-tion. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2007;34:1427-38.
[58] Mamelle G, Pampurik J, Luboinski B, Lancar R, Lusinchi A, Bosq J.Lymph node prognostic factors in head and neck squamous cellcarcinomas. Am J Surg 1994;168:494-8.
[59] Glass EC. Sentinel node identification using radionuclides inmelanoma and breast cancer. Cancer Treat Res 2007;135:85-100.
[60] Hyde NC, Prvulovich E, Newman L,WaddingtonWA,Visvikis D, Ell P.A new approach to pre-treatment assessment of the N0 neck in oralsquamous cell carcinoma: the role of sentinel node biopsy and positronemission tomography. Oral Oncol 2003;39:350-60.
[61] Mamelle G, Temam S, Casiraghi O, Lumbroso J, Laplanche A,Bourhis J. Role and perspectives of sentinel node biopsy in head andneck tumors. Cancer Radiother 2006;10:349-53.
[62] Mozzillo N, Chiesa F, Botti G, Caraco C, Lastoria S, Giugliano G, et al.Sentinel node biopsy in head and neck cancer. Ann Surg Oncol 2001;8:103S-105S.
[63] Civantos FJ, Gomez C, Duque C, Pedroso F, Goodwin WJ, Weed DT,et al. Sentinel node biopsy in oral cavity cancer: correlation with PETscan and immunohistochemistry. Head Neck 2003;25:1-9.
[64] Ross GL, Soutar DS, Macdonald DG, Shoaib T, Camilleri IG,Robertson AG. Improved staging of cervical metastases in clinicallynode negative patients with head and neck squamous cell carcinoma.Ann Surg Oncol 2004;11:213-8.
[65] Paleri V, Rees G, Arullendran P, Shoaib T, Krishman S. Sentinel nodebiopsy in squamous cell cancer of the oral cavity and oral pharynx: adiagnostic meta-analysis. Head Neck 2005;27:739-47.
[66] Stoeckli SJ, Pfaltz M, Ross GL, Steinert HC, Macdonald DG,Wittekind C, et al.The second international conference on sentinel nodebiopsy in mucosal head and neck cancer. Ann Surg Oncol 2005;12:919-24.
[67] Cote V, Kost K, Payne RJ, Hier MP. Sentinel lymph node biopsy insquamous cell carcinoma of the head and neck: where we stand now,and where we are going. J Otolaryngol 2007;36:344-9.
[68] Rubin Grandis J, Branstetter 4th BF, Yu VL. The changing face ofmalignant (necrotising) external otitis: clinical, radiological, andanatomic correlations. Lancet Infect Dis 2004;4:34-9.
[69] Okpala NC, Siraj QH, Nilssen E, Pringle M. Radiological andradionuclide investigation of malignant otitis externa. J Laryngol Otol2005;119:71-5.
[70] Stokkel MP, Takes RP, Van Eck-Smit BL, Baatenburg de Jong RJ. Thevalue of quantitative gallium-67 single-photon emission tomographyin the clinical management of malignant external otitis. Eur J Nucl Med1997;24:1429-32.
[71] Weber CJ, Vansant J, Alazraki N, Christy J, Watts N, Phillips LS, et al.Value of technetium 99m sestamibi iodine 123 imaging in preoperativeparathyroid surgery. Surgery 1993;114:1011-8.
[72] Taillefer R, BoucherY, Potvin C, Lambert R. Detection and localizationof parathyroid adenomas in patients with hyperparathyroidism using asingle radionuclide imaging procedure with technetium-99m-sestamibi(double-phase study). J Nucl Med 1992;33:1801-7.
[73] O’Doherty MJ, Kettle AG, Wells P, Collins RE, Coakley AJ.Parathyroid imaging with technetium-99m-sestamibi: preoperativelocalization and tissue uptake studies. J Nucl Med 1992;33:313-8.
[74] Jeanguillaume C, Urena P, Hindie E, Prieur P, Petrover M, Menoyo-CalongeV, et al. Secondary hyperparathyroidism: detection with I-123-Tc-99m-Sestamibi subtraction scintigraphy versus US. Radiology1998;207:207-13.
[75] Harris L,Yoo J, DriedgerA, Fung K, Franklin J, Gray D, et al.Accuracyof technetium-99m SPECT-CT hybrid images in predicting the preciseintraoperative anatomical location of parathyroid adenomas. HeadNeck 2008;30:509-17.
[76] Nishiyama S, Miyawaki S, Yoshinaga Y. A study to standardize quan-titative evaluation of parotid gland scintigraphy in patients withSjögren’s syndrome. J Rheumatol 2006;33:2470-4.
[77] Henriksen AM, Nossent HC. Quantitative salivary gland scintigraphycan distinguish patients with primary Sjögren’s syndrome during theevaluation of sicca symptoms. Clin Rheumatol 2007;26:1837-41.
[78] Raza H, Khan AU, Hameed A, Khan A. Quantitative evaluation ofsalivary gland dysfunction after radioiodine therapy using salivarygland scintigraphy. Nucl Med Commun 2006;27:495-9.
[79] Tenhunen M, Collan J, Kouri M, Kangasmäki A, Heikkonen J,Kairemo K, et al. Scintigraphy in prediction of the salivary glandfunction after gland-sparing intensity modulated radiation therapy forhead and neck cancer. Radiother Oncol 2008;87:260-7.
G. Bonardel ([email protected]).E. Gontier.M. Soret.H. Foehrenbach.Service de médecine nucléaire HIA Val-de-Grâce, 74, boulevard du Port-Royal, 75230 Paris cedex 05, France.
Ogni riferimento a questo articolo deve portare la menzione: Bonardel G., Gontier E., Soret M., Foehrenbach H. Apporto delle tecniche di medicina nuclearenella gestione delle patologie della sfera otorinolaringoiatrica. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Otorinolaringoiatria, 20-902-A-01, 2009.
Disponibile su www.em-consulte.com/it
Algoritmidecisionali
Iconografiasupplementare
Video-animazioni
Documentilegali
Informazioniper il paziente
Informazionisupplementari
Autovalutazione
Apporto delle tecniche di medicina nucleare nella gestione delle patologie della sfera otorinolaringoiatrica ¶ I – 20-902-A-01
11Otorinolaringoiatria