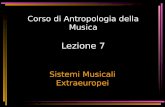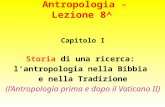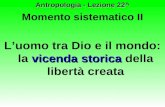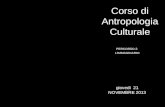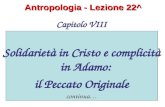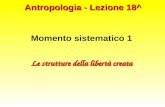Antropologia (lezione 2)
description
Transcript of Antropologia (lezione 2)
-
3 OTTOBRE 2013
Morgan, autore dello studio sugli Irochesi in questione, non , tuttavia, solo lavvocato che, innamorato dei Seneca, dedica loro unintera monografia. Morgan, di fatto, anche un antropologo che tende progressivamente a proporci una teoria generaledellastoriadellosviluppodellumanitdalleoriginiainostrigiorni.Lantropologia classica mira, infatti, a fornire teorie generali con lo scopo di dare risposta alle grandi domande che proprio allora ci si cominciava a porre: da dove veniamo?Comecisiamoevoluti?Comesiamoprogrediti?Morgan, dopo aver pubblicato la Lega degli Irochesi, va avanti nella sua ricerca teorica e, consapevole che la teoria va sempre accompagnata da unimportante dose di dati etnografici, arricchisce i suoi dati di tipo etnografico. Metodologicamente oggi il rito di passaggio dato dalla ricerca sul campo. Per essere legittimato dalla comunit scientifica lantropologo moderno deve passare del tempo sul campo e compiere ricerche in prima persona. Tale tipo di approccio nellOttocentononeranpraticatonpensato.Per pensare, scrivere e realizzare libri e grandi teorie a quali fonti si accingeva mancandoalloralaricercasulcampo?Lunico che compie qualche viaggio Morgan. Visit non solo lEst degli Stati Uniti, ma anche gli Stati Centrali, abitati dagli indiani delle praterie. Morgan ebbe, perci, una conoscenza diretta del proprio oggetto di studio. Erano, tuttavia, inchieste (tempo limitato, nessuna conoscenza della lingua) e non ricerche sul campo nel sensomodernodeltermine.Morgan, come molti altri prima e dopo di lui fecero (Tylor, Frazer, ecc.), attinse alle fonti religiose e ai classici del mondo greco e latino per conoscere le loro forme di organizzazione sociale. Ma gli evoluzionisti come Morgan pensavano anche che le societ primitive a loro contemporanee potessero rappresentare un esempio vivente del modo in cui le societ erano vissute nel passato, e se le fonti classiche permettevano unadeguata conoscenza delle antiche organizzazioni certamente non potevano fornire alcun chiarimento sulle popolazioni primitive contemporanee.
1
-
Gli antropologi dellOttocento diedero cos inizio a fitte corrispondenze con i missionari dispersi nel mondo e abituati a vivere in mezzo agli indigeni. Spesso, infatti, alla voglia di convertire le popolazioni in questione si accompagnava, in questi personaggi, anche un dilettantistico interesse antropologico. Stessa sorte tocc, in breve, anche ai funzionari coloniali delle varie nazioni. Le fonti di cui gli antropologidiquestoperiodosiservono,perci,sonosolosecondarie.Ma come dimostrare che tutte le societ, indipendentemente dai luoghi e in tempi diversi, avevano gi percorso o avrebbero percorso i medesimi stadi di sviluppo?Morgan, che nel corso dei suoi viaggi si rese conto di come le terminologie di parentela irochesi non fossero uniche nel loro genere, ebbe lidea di mandare un questionario a tutta una serie di amministratori e uomini di affari dislocati in Asia chiedendo loro di descrivergli le terminologie di parentela in uso presso i locali da loroconosciuti.Gli studi di Morgan, che nel 1871 scrisse Sistemi si consanguineit e di affinit nella famiglia umana, confluirono nella pi tarda Ancient society, composta nel 1877. In particolare, Morgan si esprime cos: Lidea di famiglia stato il risultato di unevoluzione attraverso stadi successivi di sviluppo, di cui la famigliamonogamicahacostituitolultimaforma.
Lewis Henry Morgan (18181881) , infatti, un antropologo statunitense e uno tra i maggiori teorici dellevoluzionismo sociale. Ne La societ antica (1877) formul uno schema di sviluppo unilineare di ogni societ umana suddiviso in tre stadi, ognunoconnotatodaunapeculiareformadieconomia:
Stadioselvaggio:caratterizzatodacacciaeraccolta
Stadiobarbarico:compaionoallevamento,coltivazioneeirrigazione
Stadio civile: vede lintroduzione delle macchine e il processo di industrializzazione.
2
-
Ogni stadio si differenzia in tre ulteriori livelli: inferiore, medio, superiore. In questo senso, gli strumenti tecnologici sono fondamentali per comprendere il passaggio da uno stadio allaltro. La ricerca etnologica di Morgan si rivolse soprattutto alle trib indiane del Nordamerica, tra cui quella degli Irochesi, in cui visse. Degli Irochesi Morgan studi a fondo la struttura dei legami di parentela e li classific nellopera Sistemi di consanguineit e di affinit nella famiglia umana (1871). Egli scopr che essi utilizzavano una nomenclatura classificatoria, che, a differenza di quella europea, detta nomenclatura descrittiva, non distingueva tra parenti diretti e collaterali, per cui il fratello del padre era chiamato padre, la sorella della madremadreeilorofiglifratelliesorelle.Morgan ipotizz che, nellepoca in cui si era formata, tale terminologia rispecchiasse specifiche usanze matrimoniali e una peculiare forma dellorganizzazione familiare, per cui suppose che nel passato di tali trib esistessero famiglie consanguinee in cui i fratelli sposavano le sorelle. Inoltre la discendenza matrilineare ancora presente presso gli Irochesi lasciava supporre un originariomatriarcato.
Le tesi di Morgan influenzarono profondamente Friedrich Engels
(18201895), che nella sua opera Lorigine della famiglia, della propriet privata e dello Stato (1884) accoglie esplicitamente, elogiandola, la sua teoria e riprende il suo modello evolutivo degli stadi di sviluppo della storia e, allinterno di questi, della famiglia umana. Egli, in particolare, fu attratto dalle teorie delletnologo americano che, ne La societ antica (1877), elabora unanalisi antropologica in termini di evoluzionismo sociale applicando la concezione del materialismo storico (quella per cui la struttura economica dei rapporti di produzione a determinare anche gli aspetti spirituali di una societ ed il suo modificarsi che generailcambiamentoelaprogressionestoricadellediverseformazionisociali).In Morgan, infatti, levoluzione storica delle diverse configurazioni di societ originata dallevolversi delle forme di produzione e lavoro e dal mutamento dei vincoli di parentela. Egli sostiene, infatti, che, anche se non in maniera sempre netta e precisa, possibile rilevare una certa corrispondenza tra il passaggio da unostadiodellasocietallaltroeilpassaggiodaunastrutturafamiliareallaltra.Engels, come Morgan, ritiene che lintroduzione del tab dellincesto porti ad una classificazione degli individui sulla base del legame parentale, allidentificazione
3
-
delle categorie di genitore, figlio, fratello e, conseguentemente, allemergere della prima formazione familiare, dapprima con la proibizione dei rapporti sessuali tra genitori e figli e, successivamente, nella famiglia punalua, con la restrizione del divieto anche ai rapporti tra fratelli e sorelle. In seguito, lavvento della propriet privata determin il passaggio alla famiglia monogamica e alla individuazione della discendenza per linea paterna. Lesigenza di tramandare la propriet ad una discendenza certa, infatti, rese necessario un legame tra uomo e donna stabile ed esclusivo, che assicurasse la certezza che i figli della donna fossero anche i figli biologicidelluomo.A differenza di quanto detto da Morgan e da Tylor, tuttavia, Engels non si far mai sostenitore dellidea che ad un progresso materiale corrisponda necessariamente un progresso morale delluomo. Al contrario, sostiene Engels, al progresso materiale corrisponde spesso una degenerazione morale. Un esempio di regresso , ad esempio, quello fornito dalla condizione femminile: le donne, che nello stato selvaggio godevano di un certo potere e di una certa indipendenza, con la nascita della propriet privata e della patrilinearit divengono esseri subalterni destinati esclusivamente alla riproduzione della specie e alle mansionidomestiche.
Sir Edward Burnett Tylor (18321917), antropologo ed etnologo britannico, insieme allo statunitense L. H. Morgan considerato il fondatore dell'antropologia moderna. Nell'opera Primitive culture (1871), Tylor elabor la prima definizione scientifica della nozione di cultura: cultura o civilt, intesa nel suo ampio senso etnografico, quellinsieme complesso che include le conoscenze, le credenze, larte, la morale, il diritto, il costume e qualunque altra capacit e abitudine acquisitadalluomoinquantomembrodiunasociet.Lacultura,perci:
Siritrovaovunque
un insieme complesso costituito da una serie di elementi che possiamo
ritrovareovunque
acquisita,nonconnaturataaunarazza,nsitrasmettecolsangue
Gli esseri umani ricevono la cultura dalla propria societ, e siccome le societsonotanteediverse,esistonotanteculturequantesonolesociet.
4
-
La cultura umana, come quella di un singolo individuo, di un singolo popolo o dellintera umanit, appariva in questo modo come un patrimonio ottenuto cumulativamenteeulteriormenteincrementabile.Il successo della definizione tyloriana di cultura da ricondurre alla sua ampiezza. Gran parte delle cose che vengono citate come componenti di questo insieme complesso, infatti, hanno pi a che vedere con la cultura nel senso mentale del termine che con il sociale. Non a caso, infatti, furono gli americani a sposare Tylor come padre della propria antropologia, mentre i britannici preferirono lamericano Morgan.Sempre in Primitive culture, Tylor propose tre stadi dell'evoluzione sociale che intese come stadi evolutivi della religione, dall'animismo al politeismo e infine al monoteismo. Il termine animismo stava a indicare la credenza, tipica secondo Tylor dei popoli pi primitivi, secondo la quale gli oggetti, anche quelli inerti, possedevanounanima.Tylor postul che lorigine dellanimismo fosse riconducibile allesperienza del sogno da cui i nostri progenitori dovevano aver tratto la convinzione che i fenomeni di sdoppiamento della personalit e delle apparizioni erano dovuti allesistenza di un doppio. Questo doppio, o anima, poteva condurre unesistenza indipendente dal corpo tanto durante la vita quanto dopo la morte. Pi tardi, secondo Tylor, luomo avrebbe esteso la credenza nel possesso di unanima a tutti quegli esseri e a quei fenomeni naturali che colpirono in qualche modo la sua immaginazione. Animali, piante e oggetti vennero in tal modo dotati di unanima che, potendosi distaccare dai corpi ai quali apparteneva, diede origine alla nozione ancora pi astratta di spirito, unentit del tutto autonoma e priva di un sostegno materiale. Nel corso del tempo in questo grande pantheon alcune divinit assumono un ruolo minore e altre un ruolo maggiore. Dallanimismo si passa cos allo stadio politeistico, dove si adorano diverse divinit, non tutte sullo stesso piano. Infine, si accede allultimo stadio che quello monoteistico: una divinit assurge a massima tratuttelealtre.Sta qui, in nuce, lidea che, a causa dellinarrestabilit del processo evolutivo, si potrungiornoassistere,forse,allavventodellaragione.
5
-
Abbiamo gi detto come la convinzione che i moderni popoli primitivi potessero ben rappresentare i vari stadi dellevoluzione umana spinse gli studiosi del tempo a raccogliere quante pi informazioni possibili sul loro conto. A tale scopo vennero principalmente utilizzate fonti secondarie (resoconti di missionari, funzionari coloniali, archeologi, ecc.), ma ben presto la scarsezza di queste fonti secondarie fece emergere il bisogno di procurarsi notizie pi accurate, di prima mano.
Nel 1898 lUniversit di Cambridge organizz una spedizione nello Stretto di Torres, che divide la Nuova Guinea dallAustralia. Alla missione, nata con lobiettivo di raccogliere quante pi informazioni etnografiche possibili sulle popolazioni indigene, prendono parte, fra gli altri, Alfred Cort Haddon e William Halse Rivers. Non si tratta, ancora, di vere e proprie ricerche sul campo, ma di primi e coraggiosi tentativi. lindigeno che viene chiamato a raccontare e gli studiosi, che non conoscono le lingue locali, si avvalgono dellaiuto di interpreti. Il soggiorno,inoltre,eracostrettoapochigiorni.
6