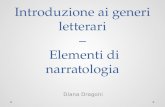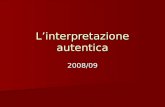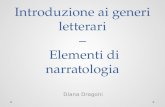ANNO SCOLASTICO 2013/2014 DOCUMENTO FINALE DEL … · - hanno capacità di espressione e...
Transcript of ANNO SCOLASTICO 2013/2014 DOCUMENTO FINALE DEL … · - hanno capacità di espressione e...
ANNO SCOLASTICO 2013/2014
DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V B
A. PARTE GENERALE
1. PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE
a) Storia del triennio della classe b) Continuità didattica del triennio c) Situazione di partenza all’inizio dell’anno in corso a) Ambiente di provenienza degli alunni
a) La classe VB, all’inizio del triennio, nell’anno scolastico 2011/2012, era composta da venti studenti, di cui dodici iscritti al P.N.I. e otto al corso tradizionale. La differenziazione del percorso didattico ha riguardato soltanto le discipline di matematica e fisica che sono state insegnate ai due gruppi seguendo programmazioni diversificate nei contenuti e nell’orario. A seguito di cambiamenti verificatisi nel corso del triennio e di trasferimenti di alunni da altri Istituti, nel corrente anno scolastico la classe è stata effettivamente costituita da ventitré studenti, otto femmine e tredici maschi, di cui quattordici alunni iscritti al P.N.I. e nove al corso tradizionale. b) Per quanto riguarda la continuità didattica si sono registrati alcuni cambiamenti: gli insegnanti presenti dalla terza alla quinta sono stati i docenti di latino, inglese, storia e filosofia, matematica e fisica del P.N.I., fisica del corso tradizionale, scienze, storia dell’arte, scienze motorie e religione; la cattedra di italiano in quarta e quinta è stata affidata alla stessa insegnante che dalla terza ha avuto la docenza del latino e, in modo analogo, per quanto riguarda la cattedra di matematica del corso tradizionale, in quarta e in quinta la classe ha avuto la stessa docente che già insegnava la fisica dalla classe terza. Pertanto le cattedre di lettere e di matematica e fisica del corso tradizionale, divise in terza, sono state accorpate in quarta e quinta e affidate, per continuità didattica, a docenti che insegnavano una delle due discipline già dall’inizio del triennio. Esaminato il prospetto generale delle docenze del triennio e incentrata l’attenzione sul corrente anno scolastico rispetto al precedente, si rileva che le discipline non hanno subito alcuna variazione di docenza. c) Dal Documento di programmazione annuale del Consiglio di Classe, approvato in data 17/10/2013, si evince che, sotto il profilo comportamentale, la classe mostra di partecipare alle attività scolastiche con attenzione e interesse, sebbene qualche studente mostri difficoltà ad affrontare gli impegni scolastici in modo costante. Dal punto di vista degli apprendimenti, in base agli esiti degli scrutini della quarta, alle osservazioni di pratica didattica e alle prime verifiche orali e scritte, la classe evidenzia un profitto diversificato: circa un quarto degli studenti, consegue risultati di ottimo livello, con punte di eccellenza, un gruppo si attesta su risultati di discreto livello e qualche alunno evidenzia difficoltà in alcune discipline scolastiche. d) Solo alcuni studenti risiedono a Montecatini Terme, mentre gli altri provengono da Comuni vicini, tuttavia non sono stati rilevati problemi legati alla pendolarità.
2. OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI) EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI
Gli studenti, dal punto di vista comportamentale, hanno mostrato correttezza e collaborazione nei rapporti interpersonali. Gli obiettivi educativi e formativi, stabiliti dal Consiglio di Classe in data 17/10/ 2013, sono stati conseguiti, in modo diversificato, in relazione alle attitudini individuali, ai livelli di partenza, alla partecipazione, all’impegno, all’applicazione allo studio e alla frequenza scolastica. Quest’ultimo
parametro ha inciso sia sul piano didattico del sistematico svolgimento di alcuni programmi disciplinari sia sul profitto individuale di qualche alunno. Diversi studenti hanno raggiunto ottimi risultati, alcuni dei quali conseguendo un profitto di chiara eccellenza, mentre la maggioranza degli alunni ha raggiunto livelli di apprendimento che oscillano tra risultati buoni e più che sufficienti , con la presenza di qualche studente che, al momento attuale, evidenzia una situazione scolastica con carenze in alcune discipline. Tenuto conto dei fattori suddetti, riguardo gli obiettivi formativi raggiunti in termini di competenze, abilità e conoscenze, gli studenti: Competenze
- sono capaci di organizzare le conoscenze, di elaborarle criticamente e di esporle in modo efficace e appropriato
Abilità
- hanno capacità di espressione e interpretazione, sanno applicare principi e regole, sono in grado di operare in modo deduttivo e induttivo
Conoscenze
- conoscono i contenuti delle discipline e la loro terminologia, con attenzione a una visione multidisciplinare.
Durante l’anno scolastico, al fine di rispondere alle diversificate esigenze degli studenti, sono state previste le seguenti attività didattiche:
- recupero in itinere
- recupero finalizzato al superamento delle insufficienze del primo trimestre (in orario curricolare durante la fase iniziale del secondo periodo valutativo)
- sportello help (in orario pomeridiano) per la durata dell’intero anno scolastico - approfondimento (in orario pomeridiano) nella fase finale dell’anno scolastico
3. TEMATICHE PLURIDISCIPLINARII docenti, pur non avendo formalizzato percorsi pluridisciplinari, hanno cercato di curare i collegamenti più significativi fra le tematiche affini delle varie materie, sollecitando gli studenti ad effettuare, anche in modo autonomo, parallelismi e relazioni tra le varie discipline, oltre che con la realtà circostante e le problematiche legate all’attualità.
4. ATTIVITA’ FORMATIVE AD INTEGRAZIONE DEI PERCORSI CURRICOLARI Nel corso dell’anno scolastico gli studenti, a classe intera, a gruppi o singolarmente, hanno partecipato alle seguenti attività:
- Olimpiadi di matematica - Olimpiadi di fisica - Olimpiadi di lingue classiche - Progetto “Orientamento universitario” - Progetto “Intercultura” Caritas diocesana - Conferenza di Higgs al Teatro Manzoni (Pistoia) - Visita didattica guidata a Roma ( Parlamento) - Visita didattica guidata a Firenze ( Galleria degli Uffizi) - Visita didattica guidata a Firenze (Palazzo Pitti) - Visita didattica guidata a Virgo (laboratorio gravitazionale) - Viaggio di istruzione in Grecia - Torneo sportivo “Gioco degli scacchi” (fase nazionale)
Si segnalano, inoltre, come attività di particolare rilievo svolte nell’arco del triennio, le seguenti: - Partecipazione a “Pistoia. Dialoghi sull’uomo” Edizione 2013 - Scambio con Waterford (U.S.A) effettuato all’inizio della classe quarta - Progetto Comenius ( avviato dalla classe terza) - Itinerario storico-artistico “Dalla Roma classica alla Roma barocca” (terza e quarta classe)
- Stage di tre giorni alla facoltà di matematica (classe quarta) - Stage di quattro giorni alla facoltà di fisica (classe quarta)
5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONEAl presente Documento è allegata la tabella dei criteri di valutazione, inserita nel P.O.F. e riconfermata nel Collegio dei docenti del 3/05/2013.
6. TIPOLOGIA DELLE PROVE EFFETTUATEDurante l’anno scolastico sono state effettuate prove formative e sommative, sia scritte che orali, prove oggettive strutturate e semistrutturate, a risposta aperta e prove pratiche. Gli studenti hanno affrontato le varie tipologie di scrittura richieste dall’Esame di Stato per la Prima prova. In funzione della preparazione all’Esame di Stato, sono state previste le simulazioni della Prima, Seconda e Terza prova, con tempi e modalità comuni a tutte le classi quinte del Liceo scientifico “Salutati”. La simulazione della Prima prova è stata eseguita il 3 marzo 2014, mentre quella della Terza prova dell’Esame di Stato, secondo la Tipologia B (trattazione sintetica di argomento), è stata suddivisa in due giorni secondo il prospetto seguente:
- il giorno 28 aprile 2014 sono stati proposti dodici quesiti (tre per ogni materia sorteggiata) inerenti le discipline di latino, inglese, filosofia e scienze (tre ore di tempo per l’esecuzione);
- il giorno 29 aprile 2014 sono stati proposti dodici quesiti ( tre per ogni materia) inerenti le discipline di inglese, storia, fisica e storia dell’arte (tre ore di tempo per l’esecuzione).
La simulazione della Seconda prova sarà effettuata il 20 maggio 2014.
7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE CHE DANNO LUOGO A CREDITI FORMATIVIIl Consiglio di Classe fa riferimento alle indicazioni e alla tabella dei crediti scolastici e crediti formativi riconfermata dal Collegio del 3/05/2013, sottolineando che debbano essere riconosciuti solo nei casi in cui gli studenti abbiano tratto, dalle loro personali esperienze, elementi di crescita culturale, umana e un maggiore grado di sensibilità ai problemi sociali.
8. ALLEGATIAlla presente sono allegati:
- Allegato B Parte disciplinare ( Consuntivo delle attività svolte e Programmi) - Prospetti della simulazione della Terza prova (con testi e schede di valutazione) e schede di
valutazione delle prove scritte di italiano e matematica - Tabella dei criteri di ammissione all’Esame di Stato - Tabella dei criteri di valutazione degli apprendimenti e dei comportamenti - Prospetto delle norme di attribuzione dei crediti scolastici e dei crediti formativi
PARTE DISCIPLINARE1. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI
1.1 MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 1.2 DOCENTE: Paolini Cheti1.3 LIBRI DI TESTO ADOTTATI:
Bologna, Rocchi Rosa fresca aulentissima, voll. 4, 5, 6 e 7, Loescher Dante Alighieri Divina Commedia: Paradiso
1.4 ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’ANNO SCOLASTICO 2013/2014 (considerando n.33 settimane di lezione) Numero ore 116 in data odierna Entro la fine dell’anno scolastico saranno presumibilmente svolte altre 14 ore per un totale di 130 ore ( rispetto alle 132 ore previste dal Piano di studi)
1.5 OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di competenze, abilità e conoscenze) Competenze
- saper analizzare testi letterari in prosa e in poesia, contestualizzandoli e operando collegamenti intertestuali e interdisciplinari
- progettare e realizzare un testo scritto che rispetti la consegna data, una progressione logica delle idee espresse e i criteri di coerenza e coesione
- utilizzare e applicare in forma corretta ed efficace le convenzioni ortografiche e morfosintattiche della lingua
Abilità
- capacità di analisi e di sintesi, oltre che di riflessione critica, nella rielaborazione personale dei testi letterari e non letterari
- capacità di cogliere nei testi letti gli elementi di continuità/alterità tra passato e presente e di attualizzarne, quando sia possibile, i contenuti e i messaggi
Conoscenze
- la storia letteraria, in termini di contesto storico-culturale, autori e opere, dall’Età napoleonica alla prima metà del Novecento
1.6 CONTENUTI Il programma svolto è allegato 1.7 METODO DI INSEGNAMENTO - lezione frontale - lezione interattiva - esercitazioni scritte - lettura, analisi e commento di testi letterari e di altro genere (t. informativi, argomentativi, narrativi, critici) - produzione scritta in conformità con le tipologie delle prove d’esame - esposizione orale di contenuti - utilizzo di strumenti audiovisivi e multimediali 1.8 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO - libri di testo - libri di narrativa - fotocopie - mezzi audiovisivi - lavagna interattiva multimediale e computer 1.9 SPAZI - aula 1.10 TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO ( possibilmente diviso in macrotematiche) Il percorso storico-culturale della letteratura è stato articolato nei seguenti moduli didattici: - Età napoleonica. Preromanticismo. Neoclassicismo. ( Settembre ore 10 )
- Romanticismo. A. Manzoni. G. Leopardi ( Ottobre- Novembre ore 37 ) - Età del Realismo. Naturalismo. Verismo. G. Verga ( Dicembre- Gennaio ore 24 ) - Decadentismo. G. D’annunzio. G.Pascoli ( Febbraio- Marzo ore 20 ) - Primo Novecento. Avanguardie. I. Svevo. L. Pirandello ( Marzo- Aprile ore 15 ) - G. Ungaretti. E. Montale. U. Saba. S. Quasimodo. Ermetismo ( Aprile- Maggio ore 20 ) - Neorealismo ( Giugno ore 4 ) Il percorso programmato di lettura e analisi dei canti del Paradiso si è svolto in parallelo a quello storico-letterario durante l’intero anno scolastico. 1.11 STRUMENTI DI VERIFICA Sono state effettuate prove di diverso tipo: per lo scritto
- prove scritte, secondo le tipologie ministeriali A, B, C e D (due nel primo periodo valutativo e quattro nel secondo )
per l’orale- verifiche orali (una nel primo trimestre, due nel secondo periodo valutativo) - verifiche scritte ( Tipologia B della Terza Prova dell’Esame di Stato; una nel primo
trimestre, due nel secondo periodo valutativo) Gli indicatori di valutazione per le prove scritte, applicati alle varie tipologie, sono stati i seguenti:
- uso delle strutture morfo-sintattiche e del sistema ortografico e interpuntivo - consistenza e appropriatezza del repertorio lessicale e dominio della semantica - competenza testuale (rispetto delle consegne, coerenza e coesione, organicità e precisione
dei dati ) - capacità di elaborazione personale e di impostazione critica e creativa
Per le prove orali sono stati valutati i seguenti aspetti: - comprensione dell’argomento - conoscenza dei contenuti - competenza critica e di collegamento riguardo gli argomenti trattati - competenza di analisi e di sintesi - adeguatezza e completezza del linguaggio disciplinare specifico - chiarezza espositiva e padronanza dei tempi a disposizione
La valutazione sommativa è stata effettuata con riferimento ai criteri di corrispondenza tra voti decimali e livelli tassonomici approvati dal Collegio dei dicenti. 1.12 ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO L’attività di recupero è stata svolta in itinere. All’inizio del secondo periodo valutativo, è stato effettuato un recupero con studio individuale, finalizzato al superamento dell’insufficienza riportata nella prima fase dell’anno scolastico. Sono state previste alcune ore di approfondimento nel secondo periodo valutativo. 2. ALTRE CONSIDERAZIONIAl termine dell’anno scolastico gli obiettivi sono stati raggiunti in modo diversificato, in relazione a vari fattori: livello di partenza, interesse, partecipazione, impegno, applicazione, frequenza scolastica e metodo di studio. Alla data attuale alcuni alunni, per la qualità dell’impegno o per lo specifico livello di partenza, evidenziano un livello sufficiente di apprendimento linguistico e letterario, mentre diversi studenti hanno conseguito un profitto ottimo ed altrettanti si attestano su risultati buoni e pienamente soddisfacenti, confermando un percorso di crescita culturale nell’arco del triennio, basato su un impegno di studio costante e sul graduale potenziamento della competenza critica e interpretativa.
Montecatini Terme, 15 maggio 2014 La docente
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA CLASSE V B Anno scolastico 2013/2014 Età napoleonicaIl gusto neoclassico. L’estetica neoclassica: la bellezza nell’armonia Lettura e analisi testualeJ.J. Winckelmann Da Pensieri sull’imitazione delle opere greche nella pittura e nella scultura
- La “quieta grandezza” del Laocoonte
Il gusto romanticoIl Romanticismo europeo: caratteri generali Il Romanticismo in Italia La polemica fra classicisti e romantici Lettura e analisi testualeMadame de Stael Da Sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni
- Esortazioni e attacchi agli intellettuali italiani
Giovanni Berchet Da Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo
- Un nuovo soggetto: il popolo
Il ruolo delle riviste La questione della lingua La letteratura romantico-risorgimentale Lettura e analisi testualeG. Mameli Canto nazionale
Giacomo Leopardi - La vita e l’opera. Il pensiero e la poetica. I Canti. La produzione in prosa. Le Operette
morali. Lo Zibaldone. Lettura e analisi testualeDallo Zibaldone
- Poesia, filosofia, scienza
- Indefinito del materiale, materialità dell’infinito. La teoria del piacere. L’indefinito come
illusione ottica
- La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo
Dai Canti
- Il passero solitario
- L’infinito
- La sera del dì di festa
- Alla luna
- A Silvia
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
- La quiete dopo la tempesta
- Il sabato del villaggio
- A se stesso
- La ginestra o fiore del deserto
Dalle Operette morali
- Dialogo della moda e della morte
- Dialogo della Natura e di un Islandese
Alessandro Manzoni- La vita e l’opera. Il pensiero e la poetica. Inni sacri e Odi civili. Le tragedie. Scritti di teoria
letteraria. - I promessi sposi. Genesi e stesura del romanzo. Le tre forme del romanzo. Le caratteristiche
del romanzo. Storia della colonna infame.
Lettura e analisi testualeDalla Lettre à M. Chauvet
- Storia, poesia e romanzesco
Dalla Lettera del 22 settembre 1823 a Cesare d’Azeglio
- Lettera sul Romanticismo
Dalle Odi
- Il cinque maggio
Da Adelchi
- Dagli atri muscosi, dai fori cadenti (coro dell’atto III)- Sparsa le trecce morbide (coro dell’atto IV, vv.1-54; 103-126)- La morte di Adelchi ( coro dell’atto V, scena 8, vv. 334-366)
Da I promessi sposi
- Quel ramo del lago di Como I- Renzo e Lucia II- Renzo, quattro capponi e un avvocato III- Come Ludovico divenne fra Cristoforo IV- L’addio al Resegone VIII- La monaca di Monza IX- X- Il ritratto del conte Egidio (da Fermo e Lucia)- Il ritratto di Geltrude (da Fermo e Lucia)- La fine e il sugo della storia XXXVIII
Da Storia della colonna infame
- La mattina del 21 giugno 1630, I La cultura del Positivismo
- Il Positivismo in letteratura: il Naturalismo. - Il romanzo naturalista e il romanzo europeo (caratteri generali)
Lettura e analisi testualeH.Taine Da La filosofia dell’arte
- L’arte non è isolata
E. e J. De Goncourt Da Germinie Lacerteux, Prefazione
- Romanzo e inchiesta sociale
E. Zola Da Il romanzo sperimentale
- Romanzo e scienza: uno stesso metodo
La Scapigliatura (caratteri generali) La letteratura post-unitaria (caratteri generali) Il Verismo in Italia. Naturalismo e Verismo in Italia (caratteri generali). Luigi Capuana e la poetica del Verismo. Giovanni Verga
- La vita. Il pensiero e la poetica - Verismo e Naturalismo - Le opere. Vita dei campi, Novelle rusticane, I Malavoglia.
Lettura e analisi testualeDa L’amante di Gramigna. Prefazione
- La poetica verista
Da I Malavoglia. Prefazione
- Il ciclo dei vinti
Da Vita dei campi
- Fantasticheria
- Rosso Malpelo
- Cavalleria rusticana
- La lupa
Da Novelle rusticane
- La roba
- Libertà
Da I Malavoglia
- La famiglia Malavoglia cap. I - La tragedia cap. III - Il ritratto dell’usuraio cap. IV - La tempesta cap. X - L’addio cap. X Il Decadentismo in Europa Quadro storico-culturale (caratteri generali). Decadentismo e modernità. L’artista decadente e le sue “maschere”. L’Estetismo. La poesia nel Decadentismo. Charles Baudelaire Lettura e analisi testualeI fiori del male
- Corrispondenze
- L’albatro
- Spleen
Lo spleen di Parigi
- La caduta dell’aureola
Oscar Wilde Lettura e analisi testualeDa Il ritratto di Dorian Gray. Prefazione
- I principi dell’Estetismo
Gabriele D’Annunzio - La vita. Il pensiero e la poetica. D’Annunzio prosatore. Il piacere. D’Annunzio poeta. Le
Laudi.Lettura e analisi testualeDa Il piacere
- L’attesa Libro I, cap.I Da Le vergini delle rocce
- Il programma politico del superuomo (Libro I)Da Alcyone
- La sera fiesolana
- La pioggia nel pineto
- L’onda
- Stabat nuda Aestas
- I pastori
Giovanni Pascoli- La vita. Il pensiero e la poetica. Il saggio Il fanciullino. Myricae. Canti di Castelvecchio.
Poemetti. Lettura e analisi testualeDa Il fanciullino
- La poetica pascoliana
Da Myricae
- Prefazione
- Scalpitio
- X Agosto
- L’assiuolo
- Temporale
- Il lampo
- Il tuono
- Lavandare
Da Canti di Castelvecchio
- Il gelsomino notturno
- Nebbia
Da Poemetti
- Digitale porpurea
Dai discorsi - La grande proletaria si è mossa
Il giornalismo italiano fra i due secoli. La nascita del giornalismo moderno. Reportage, cronaca, elzeviro. Il Primo Novecento: Le avanguardie storiche (caratteri generali)Il Futurismo Lettura e analisi testualeFilippo Tommaso Marinetti
- Primo manifesto del Futurismo
- Manifesto tecnico della letteratura futurista
L’arte prima e dopo la Prima guerra mondiale Il Dadaismo. Il Surrealismo e l’Espressionismo T.Tzara
- Manifesto del Dadaismo
A.Breton - Manifesto del Surrealismo
La cultura italiana del Primo Novecento Scrittori e Prima guerra mondiale. L’intellettuale italiano tra le due guerre. La poesia italiana tra innovazione e tradizione. Aldo Palazzeschi Da Poemi
- Chi sono?
Il “crepuscolarismo”e la “linea del crepuscolo”Lettura e analisi testualeGuido Gozzano Lettura e analisi testualeDa Colloqui
- La signorina Felicita ovvero la felicità (1-48, 73-132, 290-326)Giuseppe Ungaretti
- La vita. Il pensiero e la poetica. L’allegria. Sentimento del tempo. Il dolore. Lettura e analisiDa L’allegria
- In memoria
- Il porto sepolto
- Veglia
- Sono una creatura
- I fiumi
- San Martino del Carso
- Pellegrinaggio
- Italia
- Mattina
- Soldati
- Fratelli
- Natale
- Allegria di naufragi
- Commiato
Da Sentimento del tempo
- Di luglio
Da Il dolore
- Non gridate più
Eugenio Montale- La vita. Il pensiero e la poetica. Ossi di seppia. Le occasioni. La bufera e altro. Satura,
Xenia.
Lettura e analisi testualeDa Ossi di seppia
- In limine
- I limoni
- Non chiederci la parola
- Meriggiare pallido e assorto
- Spesso il male di vivere ho incontrato
Da Le occasioni
- Ti libero la fronte dai ghiaccioli
- Non recidere, forbice, quel volto
Da La bufera e altro
- La primavera hitleriana
- L’anguilla
Da Satura
- Caro piccolo insetto, Xenia 1
- Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, Xenia II
La narrativa del Primo Novecento Italo Svevo
- La vita. Il pensiero e la poetica. - Le opere. La coscienza di Zeno
Lettura e analisi testualeDa La coscienza di Zeno
- Prefazione
- Preambolo
- Il fumo cap.III- La morte del padre cap. IV- Un matrimonio sbagliato cap.V- Il finale cap.VIII
Luigi Pirandello- La vita. Il pensiero e la poetica. L’umorismo. Novelle per un anno. I romanzi. Il fu Mattia
Pascal. I vecchi e i giovani. Quaderni di Serafino Gubbio operatore. Uno, nessuno e
centomila. Il teatro. Lettura e analisi testualeDa L’umorismo
- Essenza, caratteri e materia dell’umorismo
Da Novelle per un anno
- Ciàula scopre la luna
- Il treno ha fischiato
- La patente
- Di sera, un geranio!
Da Il fu Mattia Pascal - Lo strappo nel cielo di carta (cap. XII) - La lanterninosofia (cap.XIII)
Da I vecchi e i giovani
- Anche la Storia “non conclude” (cap.V)
Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore
- La scrittura, la macchina e l’anima umana ( Quaderno I, cap.II) Da Uno, nessuno e centomila
- Tutto comincia da un naso (libro I, cap. I) - Non conclude (libro VIII, cap. IV)
Da Così è, (se vi pare )
- La verità velata (e non “svelata”) del finale (Atto III, scena VII)Umberto Saba
- La vita. Il pensiero e la poetica. Il Canzoniere
Lettura e analisiDal Canzoniere
- A mia moglie
- La capra
- Goal
- Amai
- Ulisse
L’Ermetismo La poesia ermetica. Poetica e linguaggio. Salvatore Quasimodo
- Il periodo ermetico. L’evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra. Lettura e analisiDa Acque e terre
- Ed è subito sera
Da Giorno dopo giorno
- Alle fronde dei salici
Il Neorealismo (caratteri generali) Lettura e analisi testualeI. Calvino Da Il sentiero dei nidi di ragno, Prefazione
- Il “neorealismo” non fu una scuola
Lettura integrale di alcune opere di narrativa del NovecentoEmilio Lussu Un anno sull’altopiano
Ignazio Silone Fontamara
Beppe Fenoglio Una questione privata
Dante AlighieriLettura e analisi testualeDa Divina Commedia: Paradiso
- Canti I, III, VI, XI, XV, XVII e XXXIII Le linee tematiche di fondo individuate nello svolgimento del programma sono le seguenti:
- Il ruolo dell’intellettuale nell’Ottocento e nel Novecento - La letteratura della memoria: ricostruire senza dimenticare - La riflessione teorica sulla letteratura. Movimenti letterari e autori - Gli aspetti formali della narrativa e della poesia
Programma da svolgere: Alla data della pubblicazione del Documento finale resta da svolgere il percorso didattico su Saba e il Neorealismo. Eventuali variazioni riguardo al programma da svolgere saranno tempestivamente comunicate agli studenti e registrate nel verbale dello scrutinio finale del mese di giugno. Montecatini Terme, 15 Maggio 2014 Gli studenti La docente
PARTE DISCIPLINARE1. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI
1.1 MATERIA: LINGUA E LETTERATURA LATINA1.2 DOCENTE: Paolini Cheti 1.3 LIBRI DI TESTO ADOTTATI: G. Garbarino, L. Pasquariello Latina volume primo Paravia G. Garbarino, L. Pasquariello Latina volume terzo Paravia 1.4 ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’ANNO SCOLASTICO 2013/2014 (considerando N. 33 settimane di lezione) N.ore 79 in data odierna Entro la fine dell’anno scolastico saranno presumibilmente svolte altre 9 ore di lezione per un totale di 88 (rispetto alle 99 ore previste dal Piano di Studi). 1.5 OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di competenze, abilità e conoscenze) Competenze
- analizzare le strutture linguistiche di un testo d’autore nella sua forma originale; - contestualizzare i brani scelti degli autori presi in esame; - individuare tematiche comuni agli autori studiati;
Abilità - tradurre i brani collegandoli al contesto letterario e storico culturale di riferimento - riconoscere gli apporti della lingua latina al lessico e alla cultura italiana;
Conoscenze - le strutture morfosintattiche della lingua latina; - gli strumenti metodologici per analizzare e contestualizzare un testo latino; - gli aspetti più rilevanti della storia letteraria dall’Età Giulio-Claudia all’Età della letteratura
cristiana con riferimenti agli autori indicati nel programma allegato; 1.6 CONTENUTI Il programma svolto è allegato 1.7 METODO DI INSEGNAMENTO - lezione frontale - lettura, costruzione diretta e traduzione guidata dei testi indicati nel programma allegato - analisi e commento dei testi letterari in lingua latina - lettura e commento di testi letterari latini in lingua italiana - pratica di traduzione - esposizione orale dei contenuti di studio mirata al potenziamento dello spirito critico e dell’uso di un registro linguistico adeguato 1.8 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO - libri di testo, schede in fotocopia, vocabolario, lavagna interattiva multimediale 1.9 SPAZI - aula 1.10 TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO (possibilmente diviso in macrotematiche) Il percorso storico-culturale della letteratura latina si è articolato nei seguenti moduli didattici: - La filosofia a Roma. Lucrezio (Settembre-Ottobre ore 8) - Età Giulio-Claudia. Seneca, Persio, Lucano, Petronio (Ottobre-Dicembre ore 29) - Età dei Flavi. Stazio, Marziale, Quintiliano, Plinio il Vecchio (Gennaio-Febbraio ore 15) - Età di Traiano e di Adriano. Giovenale, Plinio il Giovane, Tacito ( Febbr.-Marzo-Apr. ore 21) - Dall’Età degli Antonini alla crisi del IIIsecolo. Apuleio. La letteratura cristiana. Agostino ( Maggio-Giugno ore 15) 1.11 STRUMENTI DI VERIFICA Sono state effettuate prove di diverso tipo:
per la valutazione scritta- traduzione e analisi testuale di un brano d’autore; trattazione breve di argomenti letterari ( due prove nel primo trimestre e tre nel secondo periodo valutativo) per la valutazione orale- verifiche orali ( una nel primo trimestre e due nel secondo periodo valutativo) - verifiche scritte a risposta aperta (Tipologia B della Terza prova dell’Esame di Stato) ( una nel primo trimestre e una nel secondo periodo valutativo) Gli indicatori di valutazione delle prove scritte di latino sono stati i seguenti: Traduzione
- conoscenza delle strutture morfosintattiche - comprensione globale del testo - capacità di resa linguistica
Analisi del testo e trattazione di argomenti letterari- uso delle strutture grammaticali, ortografiche e interpuntive - capacità di analisi testuale (nuclei tematici e aspetti formali) - conoscenze storico-letterarie - contributi interpretativi personali e giudizi critici
Gli indicatori per la valutazione orale sono stati i seguenti: - conoscenza delle strutture morfosintattiche - acquisizione, comprensione e rielaborazione dei contenuti di studio - capacità espositiva in merito ad aderenza, chiarezza, completezza e utilizzo del lessico
specifico della disciplina. La valutazione sommativa è stata effettuata con riferimento ai criteri di corrispondenza tra voti decimali e livelli tassonomici approvati dal Collegio dei docenti. I risultati delle prove sono stati motivati esplicitamente alla classe e ai singoli studenti, attraverso l’uso costante di griglie di valutazione concordate a livello dipartimentale. 1.12 ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO L’attività di recupero è stata effettuata in itinere. E’ stato realizzato, inoltre, un recupero con studio individuale, all’inizio del secondo periodo valutativo, finalizzato al superamento dell’insufficienza riportata nel primo trimestre. Non sono state previste ore di approfondimento.
2. ALTRE CONSIDERAZIONIAl termine dell’anno scolastico gli obiettivi sono stati raggiunti in modo diversificato, in relazione a vari fattori: livello di partenza, interesse, partecipazione, impegno, applicazione, frequenza scolastica e metodo di studio. Alcuni studenti hanno raggiunto risultati eccellenti e diversi altri di buon livello, confermando un percorso di costante crescita culturale nell’arco dell’intero triennio. Qualche studente della classe, a causa di situazioni particolari quali l’impegno, il metodo di studio o la provenienza da altri percorsi scolastici, ha evidenziato carenze e difficoltà nei confronti della materia.
Montecatini Terme, 15 Maggio 2014 La docente
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA CLASSE V B Anno scolastico 2013/2014
La filosofia a Roma- Stoicismo ed Epicureismo
Lucrezio- La vita. La poetica. I precedenti letterari - Contenuto e struttura dell’opera De rerum natura. Lucrezio poeta della ragione. Il
linguaggio lucreziano Lettura e analisi testuale(Non è stata effettuata la lettura in metrica dei brani ) Da De rerum natura
- L’inno a Venere (I, 1-43) in latino- L’imperturbabilità degli dei ( I, vv.44-49) in italiano - Argomento del poema (I, vv.50-61) in italiano - Elogio di Epicuro (I, vv.62-79) in latino- L’epicureismo non può essere accusato di empietà (I, vv.80-101) in latino- La povertà della lingua e la novità della materia (I, vv.136-148) in latino - La funzione della poesia (I, vv.921-950) in italiano - “Naufragio con spettatore” (II, vv.1-19) in italiano - La “noia”esistenziale (III,vv. 1053-10759 in italiano - Il timore della morte (III, vv.830-869) in italiano - La follia d’amore (IV, vv. 1073-1140) in italiano- I mali del progresso (V, vv.1412-1457) in italiano- La peste (VI, vv.1252-1286) in italiano
Età Giulio-Claudia- Vita culturale e attività letteraria. Il rapporto tra intellettuali e potere. I generi letterari
Fedro - Le Fabulae: genere, caratteristiche e contenuti
Lettura e analisi testualeFabulae
- Il prologo ( I, prologus) in latino- La volpe e l’uva (IV, 3) in italiano - Il lupo e l’agnello (I,1) in italiano
Seneca- La vita. I Dialogi. I Trattati. Le Epistulae ad Lucilium. Lo stile della prosa senecana. Le
tragedie. L’Apocolokyntosis. Lettura e analisi testualeDe brevitate vitae:
- La vita è davvero breve? ( I, 1-4) in latino- Un esame di coscienza (3, 3-4) in latino- Cicerone”semiliber” (5, 1) in italiano - Il valore del passato (10, 2-5) in italiano - Protinus vive (8, 9 ) in latino- La galleria degli occupati (12, 1-7; 13, 1-3) in italiano - Il “sapiens” (14) in italiano - Una pace sicura (18, 1; 19,1) in latino
De clementia: - Il principe allo specchio (I, 1-4) in latino
Epistulae ad Lucilium
- Riappropriarsi di sé e del proprio tempo (1, 1) in latino, (1, 2-5) in italiano
- Lucilio e l’amicizia (6, 1-5) in italiano - Il saggio non deve mescolarsi alla folla (7, 1-3) in italiano - I posteri (8, 1-6) in italiano - “Di ogni piacere il meglio è alla fine” (12, 1-5) in italiano - Come trattare gli schiavi (47, 1 ) in latino- Libertà e schiavitù sono frutto del caso (47, 10- 11) in latino- Un naufragio volontario (53, 1-8) in italiano - Il dovere della solidarietà (95, 51-53) in latino- L’affetto per la moglie Paolina (104, 1-7) in italiano
De ira
- La lotta contro l’ira (III, 13,1-3) in latinoFedra
- La passione distruttrice dell’amore ( vv.589-684; 698-718) in italiano Lucano
- I dati biografici. Il Bellum civile. Le caratteristiche dell’epos di Lucano. I personaggi del Bellum civile. Il linguaggio poetico.
Bellum civile
Lettura e analisi testuale- Il proemio. L’argomento del poema e l’invettiva contro il popolo romano (I, vv.1-32) in
italiano - Il proemio. L’elogio di Nerone (I, 33-66) in italiano - I ritratti di Pompeo e Cesare (I, vv.129-157) in italiano - Una funesta profezia (VI, vv.750-767; 776- 820) - L’attraversamento della Libia (IX, vv.587-600; 604-618; 762-804) in italiano
Persio- I dati biografici. La poetica e le satire sulla poesia. I contenuti delle altre satire. La forma e
lo stile. Lettura e analisi testuale
- La satira un genere “controcorrente” (I, vv.13-40; 98-125) in italiano - Prologo alla Satira V ( V, vv.14-18) in latino- Invito alla filosofia (III, vv.1-34; 52-72; 94-106)
Petronio - La questione dell’autore del Satyricon. Il contenuto dell’opera. La decadenza dell’eloquenza
nel Satyricon. La questione del genere letterario. Il realismo petroniano.Lettura e analisi testualeSatyricon
- Trimalchione entra in scena (32-33) in italiano - Riflessioni sulla morte ( 34) in italiano - Presentazione dei padroni di casa (37, 1-38; 5 ) in italiano - I commensali di Trimalchione (41, 9-42; 44) in italiano - Trimalchione fa sfoggio di cultura (50, 3-7) in italiano - La matrona di Efeso (110, 6; 112, 8) in italiano
Età dei Flavi- Vita culturale e attività letteraria
Stazio- La poesia epica: Tebaide e Achilleide. La poesia d’occasione: le Silvae.
Plinio il Vecchio - Dati biografici. La Naturalis historia.
Marziale - I dati biografici. La poetica. Gli Epigrammata. I temi e lo stile.
Lettura e analisi testuale
Epigrammata
- Una poesia che sa di uomo (X, 4) in latino- Distinzione tra letteratura e vita (I, 4) in italiano - Un libro “a misura”di lettore (X, 1) in latino- Matrimoni d’interesse (I, 10; X, 8; X, 439 in italiano - Guardati dalle amicizie interessate (XI, 44) in latino- Tutto appartiene a Candido…..tranne sua moglie (III, 26) in italiano - Il console cliente (X, 10) in italiano - La “bella” Fabulla (VIII, 79) in italiano - Vivi oggi (I, 15) in italiano - Antonio Primo vive due volte (X, 23) in italiano - Che maestro insopportabile! (IX, 68) in latino - La bellezza di Bilbili ( XII, 18) in italiano - Erotion (V, 349) in italiano
Quintiliano - I dati biografici. Le finalità e i contenuti dell’Institutio oratoria. La decadenza dell’oratoria.
Lettura e analisi testualeInstitutio oratoria
- Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore ( Proemium, 9-12) in latino- Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale ( I, 1) in latino; (I, 2, 4-8) in italiano - Vantaggi dell’insegnamento collettivo ( I, 18-22) in italiano- L’importanza della ricreazione (I, 3, 8-12) in italiano- Il maestro ideale (II, 2, 4-8) in latino- Un “excursus”di storia letteraria (X, I, 85-88, 90, 93-94) in italiano- Storiografia e oratoria (X, 105-112) in italiano- Severo giudizio su Seneca ( X, I, 125-131) in italiano
Età di Traiano e di Adriano- Vita culturale e attività letteraria
Svetonio - L’opera svetoniana: De viris illustribus e De vita Caesarum
Giovenale- I dati biografici. La poetica di Giovenale. Le satire dell’indignatio. Il secondo Giovenale.
Espressionismo, forma e stile delle satire. Lettura e analisi testualeSaturae
- Il manifesto poetico di Giovenale (I, vv.22-39,147-171) in italiano - Chi è povero vive meglio in provincia (III, vv.164-189) in italiano - Roma, città crudele con i poveri (III, vv. 190-222) in italiano - Contro le donne (VI, vv. 82-113, 114-124) in italiano - Il pane e i giochi (X, 56-77) in italiano (X, 78-81) in latino
Plinio il Giovane- I dati biografici. Il Panegirico a Traiano. L’epistolario.
Lettura e analisi testualeEpistulae
- L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (VI, 16, 4-20) in italiano - Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani (X, 96, 97) in italiano
Tacito- I dati biografici e la carriera politica. L’Agricola. La Germania. Il Dialogus de oratoribus.
Le opere storiche. La lingua e lo stile. Tacito nel tempo. Lettura e analisi testualeAgricola
- La prefazione (3, 1) in latino; (3, 2-3) in italiano - Il discorso di Calgaco (30; 31, 1-3) in italiano
Germania
- Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani (4, 1) in latinoHistoriae
- La scelta del migliore (I, 16) in italiano - Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale (IV, 73-74) in italiano
Annales
- Il proemio (I, 1-3) in latino - Le ceneri di Germanico (III, 2-69) in italiano - Cremuzio Cordo (IV, 34, 1-2; 5) in latino- L’uccisione di Britannico (XIII, 15-16) in italiano - La tragedia di Agrippina (XIV, 2-5) in latino- Nerone e l’incendio di Roma (XV, 38-39) in italiano - La persecuzione dei cristiani (XV, 44, 2-5) in italiano - Il suicidio di Seneca (XV, 62-64, 1-2 in italiano, 3-4 in latino)
Dall’Età degli Antonini alla crisi del III secolo- La fine del “secolo d’oro”. La crisi del III secolo. Cultura e letteratura.
Apuleio- I dati biografici. Le Metamorfosi. Il titolo, la trama, le caratteristiche e gli intenti dell’opera.
Lettura e analisi testualeMetamorfosi
- Il proemio e l’inizio della narrazione ( I, 1-3) in italiano - Lucio diventa asino (III, 24-25) in italiano - Psiche fanciulla bellissima e fiabesca (IV, 28-31) - La prima prova imposta da Venere a Psiche (VI, 10) in italiano - Psiche è salvata da amore (VI, 20-21) in italiano - La preghiera a Iside (XI, 1-2) in italiano - Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio (XI,13-15) in italiano
La letteratura cristiana.Agostino La vita. Le Confessiones. Il De civitate Dei. L’epistolario. Lettura e analisi testuale
- L’incipit delle Confessiones: “Grande sei Signore” (I, 1) in italiano - La conversione (VIII, 12, 28-29) in italiano
Generi letterari- Prosa filosofica, satira, romanzo, oratoria, epigramma, epistolografia, biografia, storiografia
Programma da svolgere. Alla data della pubblicazione del Documento finale resta da svolgere il percorso didattico relativo alla letteratura cristiana. Eventuali variazioni riguardo al programma da svolgere saranno tempestivamente comunicate agli studenti e registrate nel verbale dello scrutinio finale del mese di giugno.
Montecatini Terme, 15 Maggio 2014 Gli studenti La docente
B – PARTE DISCIPLINARE Classe 5B
1. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI
1.1 MATERIA: INGLESE
1.2 DOCENTE: MAURIZIO QUILICONI
1.3 LIBRI DI TESTO ADOTTATI : Literature for life The catcher in the rye The Great Gatsby To kill a mockingbird Mrs Dalloway
1.4 ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 120
1.5 OBIETTIVI RAGGIUNTI: Per quanto riguarda le conoscenze gli studenti hanno raggiunto mediamente i contenuti elencati al punto successivo. Un gruppo di 5-6 ragazzi ha raggiunto ottimi risultati. In alcuni casi gli obiettivi non sono stati completamente raggiunti. Per quanto riguarda competenze e capacità ci sono stati dei miglioramenti complessivi sia nella produzione scritta che in quella orale. In questi casi la capacità è quella di saper leggere testi letterari, saperli analizzare e saper esprimere un giudizio critico.
1.6 CONTENUTI: v. programma allegato
1.7 METODO DI INSEGNAMENTO E’ stata privilegiata la lezione interattiva, cercando di sfruttare le conoscenze e le capacità dello studente per portare a termine l’obiettivo previsto.
1.8 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO Oltre al libro di testo e dei classici sono state utilizzate fotocopie di alcune parti non presenti sui libri in adozione. E’ stato usato il videoproiettore per i film in lingua originale analizzati.
1.9 SPAZI E’ stata usata l’aula speciale di videoproiezione
1.10 TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO Circa 20 ore sono state impiegate per la lettura integrale e per la visione di The Great
Gatsby, circa 20 lezioni per The Waste Land e altre 20 per Joyce e Woolf. Le restanti lezioni sono state divise tra il romanzo di Salinger e gli altri autori
1.11 STRUMENTI DI VERIFICA Per l’orale sono state effettuate interrogazioni sul programma svolto. Negli scritti sono state per lo più utilizzate domande a risposta breve, o trattazione breve, in preparazione alla terza prova.
Liceo Scientifico Statale “C: Salutati” Montecatini Terme
Programma di inglese 2013-14 Classe 5^B
1.12
Moduli di letteraturaSe non specificato diversamente si fa riferimento al volume “Literature for life” e i testi qui proposti.
The twentieth century
T.S.EliotThe Waste LandIntroduction pag. 482 The Burial of the Dead (text 108) The Fire Sermon (tutto, su fotocopia)
The love song of J. Alfred Prufrock (text 107)
F.S. Fitzgerald
The great Gatsby (lettura integrale)
Film: The Great Gatsby
JoyceThe dead (text 103)
from Ulysses Ulysses (texts 104, 105) Molly’s Monolog (su fotocopia) Structure, Themes and issues (p. 469) The mythical method (p. 471)
Virginia WoolfThe role of the novelist (pag. 511) Mrs Dalloway (lettura integrale)
George Orwell Animal Farm (texts 116, 117. 118)
From 1984 (fotocopie da Lit & lab) Big Brother How can you control memory
The United States after World War II (fotocopie)
J.D. Salinger
The catcher in the rye (lettura integrale)
The beat Generation
Jack Kerouac from On the Road (pag. 707) On the road ( text 166)
Harper Lee
To kill a mockingbird (lettura integrale)
FilmThe hours
Montecatini Terme, 13.05.2014
L’insegnante Gli studenti
B – PARTE DISCIPLINARE
1. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 1.1 MATERIA Storia e Educazione Civica1.2 DOCENTE
Marziano Almaviva
1.3 LIBRI DI TESTO ADOTTATI
Ciuffoletti, Baldocchi, Bucciarelli, Sodi, Dentro la storia, vol.2, vol.3A e 3B
1.4 ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’A.S 2013/2014
4 (considerando n. 33 settimane di lezione)
n° 75 ore (al 12/05/2013) su n° ore 99 previste dal Piano di Studio
1.5 OBIETTIVI RAGGIUNTI
Competenze
Gli studenti devono �
a) Saper individuare a partire dal proprio contesto esistenziale situazioni e contesti problematici, attraverso un’essenziale utilizzazione degli strumenti di analisi delle conoscenze apprese mediante la riflessione filosofica;
b) Saper concretizzare i principi dell’esercizio attivo della cittadinanza e dell’educazione alla convivenza previste da Cittadinanza e Costituzione, anche in relazione alle conoscenze interdisciplinari e alle categorie concettuali della tradizione filosofica e dell’indagine storica e storiografica;
c) Sapersi orientare ed intervenire attivamente in vari contesti (sociale, economico, culturale e politico) in una prospettiva che sappia mettere in relazione passato e presente.
Abilità
Gli allievi devono saper ricostruire e discutere contesti
1 servendosi delle seguenti relazioni: rapporti di causalità, relazioni temporali, interazioni tra soggetti singoli e collettivi;
2 avvalendosi anche di spunti provenienti da discipline e scienze diverse; 3 utilizzando consapevolmente i fondamentali strumenti lessicali e concettuali della
storiografia per descrivere e analizzare contesti specifici e dinamiche evolutive di lungo periodo;
4 analizzare problemi e tematiche in una prospettiva diacronica e sincronica; 5 effettuare confronti motivati nell’ambito storico anche attraverso l’analisi storiografica e
spaziare in senso orizzontale e verticale senza perdere di vista l’unità e l’organicità del discorso.
Conoscenze Gli alunni devono conoscere
1 i fatti, personaggi e le idee che permettono la ricostruzione di un’epoca
2 i termini e i concetti chiave relativi agli specifici contesti storico-culturali affrontati;3 lo sviluppo dei principali processi e tendenze di “lungo periodo”; 4 le problematiche essenziali relative all’interpretazione e alla valutazione delle fonti.
1.6 CONTENUTI
Si veda il programma allegato con la precisazione che lo svolgimento dello stesso ha termine entro il mese di maggio e che eventuali variazioni saranno esposte all’albo e comunicate a tutti i candidati.
1.7 METODI DI INSEGNAMENTO
• lezioni frontali e dialogate, finalizzate alla focalizzazione dei temi e momenti cruciali in rapporto alle fasi ed agli eventi storici considerati, attraverso le quali sono stati introdotti stimoli ad operare collegamenti, raccordi tra tematiche, sintesi, riflessioni critiche e una traccia per la realizzazione degli appunti personali; • attenzione alla terminologia specifica, attraverso la definizione e chiarificazione dei
termini attinenti alle problematiche affrontate; • riferimento costante al manuale in adozione.
1.8 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Si è usato prevalentemente il libro di testo in adozione integrato da dispense e schede preparate dal docente
1.9 SPAZI
Lo spazio utilizzato è stato quello dell'aula.
• TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO
• MODULO 1. LO STATO UNITARIO E LA COSTITUZIONE DEL REICH. (settembre –
ottobre) MODULO 2. L’ITALIA UNITA. IL TRIONFO DELLA BORGHESIA.
RIVOLUZIONE INDUSTRIALE, IDEOLOGIE BORGHESI E MOVIMENTO OPERAIO
(ottobre – dicembre) MODULO 3. L’ITALIA DA CRSIPI A GIOLITTI.��dicembre – gennaio)�
MODULO 4. LA CRISI DELL’EQUILIBRIO EUROPEO MODULO 5. LA GRANDE GUERRA
E IL MUTAMENTO DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI (gennaio – febbraio) MODULO
6. I TOTALITARISMI E LA CRISI DELLA DEMOCRAZIA (aprile –maggio) MODULO 7:
LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA GUERRA FREDDA MODULO 7: L’ITALIA
REPUBBLICANA (maggio – giugno)
• STRUMENTI DI VERIFICA
Nel corso dell’anno sono state effettuate sia verifiche orali che scritte. Le verifiche scritte hanno avuto la forma del questionario a risposta aperta sul modello della tipologia B della
terza prova dell’Esame di stato. I criteri di valutazione adottati hanno fatto riferimento al quadro generale della valutazione del P.O.F. e ai relativi parametri. I risultati delle singole prove (orali e scritte) sono stati motivati esplicitamente alla classe e ai singoli alunni e opportunamente mediante l’utilizzo costante delle griglie di valutazione concordate a livello dipartimentale.
• ATTIVITA’ DI SOSTEGNO/RECUPERO
• Durante l’anno scolastico sono state svolte costanti attività di recupero nella modalità dello
Sportello Help
Il docente
������������������� �������� �����
��������������
�
�
�
�
� ������������������������������������������������������������������������������������������������ �
�
�
�
�
!"#$"�����%&���#"&��
�
�'��#%(�#���#�����#�()&��"&#�*�����#��&�(+&#)*�%*��"*&�,����������������� ������ ��
������������������������ ��������� � ������� �� ������������������������� ������� ����������!�� ���
���� ������ ��� ��� ��"� �� ����� ��� �� �����#� $� �� � ������ � ���� ��� %&���� ����� ���'������ ���
%�� � ��������(��&������)�����
�
�'� �#%(�#�� � &�� �"&#)-#� %*���� �#"$,*�&��� "&�#�(+&#)*� &)%(��"&��*.� &%*#�#$&*�
�#"$,*�&�*��#�&�*)�#�#!*"�&#�������������*)�������+�� ,����)�������/���0��11�1����
/� ���2������3������� ������������ ��� �����-.���������/�������+����&���� � �����0����
/�1����� ��� +��� � ���� ������� *������� �� �����4� ��� #�� �� )�2������ � � ��� ��������
� ���� ������� � � (���� � �� �,��� ������ � 2�� �13� �� /���� ���� ��� �5����� /�� ����� � ��
��/���11�1���� ������� 4���� �� ��� (���� 5�,����� �� ��� ����� �/� &�3���� ������ �� �����
���� ��� � ������6�����������������78�������� ���������9����� �������� �� ���������8�����������
���:�� �������9��8������������ ������������������8��������;�����������:�� ����!�����������
����� ����& ��1��� �����3������ 6*���3��������<���������
�
�
�'��#%(�#���6&���&��%��%*!"*�&����$&#�&��&�������� �������� ���=� ����������������������
��<��������������� ����� ������������� ����������>�'��<��� �%��-������������3��� ��������/������
���� �7� /������1��� ���������� �� �������� ������ ����� ��� ����� ��*'����� � ��� ������3� �����/��
��������� ���� 6����������/�����(�8����&���6&� ���/��$�� ����? ����@����������������� ����
A���������������,��������������� ��� ����������� ������44�������������,�� ������������ ������
������ �������@� ����� ���;�,�������B�� ��� �����,��;�� ����� ��������,�� �������������
������������ $�;�� ����������� ���������C� �;������������ ����� ������B�� ������;��������
����� ���� ���� ������ ����� ����� ��B�� ���"� ������ �������*>*����������� ����B�� ������������
��>��
�
A�� %������ "� #�� /������&"� ������ /��������"� � ������ ���"� !�� ��� ��� � ���"� ?-��� �� "� !�9���"�
C�����"�D��� ���
�
�
'� �#%(�#�� ��� �"&�&� %*��6*9(&�&�"&#� *("#!*#�� ��� $������� /�� �������:� �� �� 3���� ��
*���3�� � 6�4� /��� �1��� ������ ��� �� ������"� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� � ����� ��
/����1����������� ��� ��������B������������������������� ��������1���=������� ������
������� �������D�������/����������� ������ ���9�� �����(���������%��;��������/�������������,��
�� ����������� �� �����������E������9����� ����������������������/����1�����������/� 6�;�� �8���
����3��� ��<= � >� �=� �� ��� ��� ��� �� ���� ��B�;����� ��� �� ��� ���,�� ������ ��� ����� �� ��� ���
���,�� ������ �=� ��� E������ �� ���� ��� B���� /�� �;��"� D������ �� (������ ?����� ��� +��� ;������
��������
�
�
?'��#%(�#�����$"�)%*�$(*""��*�&���(���*)�#�%*��*�"*��+&#)&�&)�*")�+&#)��&�����
3�����0��������/�� ��������;��������������������;�����8�������;���������,�� �������� �����
������ �����8� � ��,�� �������� �����=� ��� ���� ��;�����8�����;�������,�������� � �� ����� ��8� ��
��� ��������;��������-����� �8���*>*�=���������������,�� �8����� ���������;�����8����������������
;�����8������� �������� ���=���F�� �������� ���G�������������'�*�������� ����� ��3����/������ ���
*>*)=��� ������������� � �'5� ���H8����%������� ����+��;���� �� � �������8������"�;�� ���
�� ������ =� ��� ������� ������ �������� ��������� �� ���� $"� �� ������� D��� ����� �<� �� ���8� ���
�����4�/� ��)�1�����������)����<��
�
�
@'��#%(�#��&��#���&��"&��&�*�����"&�&�%*����%*�#�"�+&�����"�2� �1������������������
����������� ��� �8� ��� �,��� ������ �������8� ���,� � �������������8����(,��� ������� ����8����
(����������������;�����=�����������/��� '� �,�1������������������& ������������"������/��������
�� ��� ��� ;������ �,��� �� (����� �� �� 6������� �� ;�����68� ��� 5��� �� ��� ���� �� �����#�����
��,� ��8� �� �� � � 3����8� ��� ����� , � ���� ������ ����;��8� ������ ��� � ���� ��� � �8� ��
�� ���� � �� ���=�����"���� �"�B���;8����6;��������;&�7��������������� �����8���A�����������
))���*<���
& �/�3�0��������&� ����� 6�22���/� �����������%������������������=���������� ��� 8�����
� � �����=���� ����������;�,������ $8�������� ����������� �� �8�*>�*'*>��=����B�� �
�� D�� �8� ��� ����� ��� (��� �� �� 6;�,����� �� �� ���78� �������������� C� �� � ����� 6��;;�
����� ���7�������**)���*����
& �-��������� �3����7�0 ����������� ������������ ���������, ����;�� ����8� ��%������� �����
������ � ���� � ����%&���8� ������ �������������� ��;�8����������������&������ ������=� ���
�� �;�������;��������������� �;����8�%���"�� � �� � �� ��������� ������������8����6�,��� ����
��� �����7�����������������*�����*�)��
&��)�+&��#�,� ������ ���0�����1���������,��� ������������� ��������(�����������G���8�����
������������� ���� ��������8��������� ���� ����������������������6 ����������;���� ��
����� ��&���6"� �I�,�� � ����������� ��"� ���� ��&���C�����"� �������� ����������(�&�"� ��;�,�������
B�� �,�� ���������� �� +����!�.��������*�����*)�8����� ��+����!�.���������8� ���B������%�����
�����������J ��������� ���8������������� �� ����������� � ���8������ �������� � ������������ $8�@��
,��1"����(��&"����D�&��������*)����*>����������� �������� ���=�������;����������5�!9+"����*�>8�
�����;;���5�����;�"����*>����
& ���� �����������&������������� �����
����"&�&�/� �6�=���� �)*B�%*����B��� � �#� ���;������?�� 8����;�����������������8���5�.�
!������������������)��
�
�
C'��#%(�#7�����*�#)%��$(*""���#)%&��*�*����$(*""��-"*%%��& ���� ��/� ���������
/�� ������ ���� ��� �� ��� ��� �� ���� �� B�����8� ��� ;������ �&�� ����=� �� B������� �� ��� %��8�
����������@ �����������������������@�������������)�'������ �������;;��� ��� ��� ��������*�����
*���8� ��9����(��� '�/�������� ���B������ �,��� ���;����8������9���&�������C�����8� ���:��� ������
!�� ��"��������������;������������������+� ����9����"���+� ���������;;�������� ���B������
��#��������� ����+� ��C��� �,'(���� �������������������)��!��0�������2� ��� ��/���/� 6�
����?���� *�
��� ����/�� $������ ��/�� �� �+��� ����=� ��9���� ����� ����8� �������� ����=� ���;��� �����9���� ��
� ��,�� ���������8� �� ������=��,�� ����������������� ���8� ����� ��� ������������ �� ������������
�����8� ,����� ��� ���=� �� �������������B������������B�������� � ������>)�����*�8�B�������� �,����
������8����;�������� ����������&��&���������<�����)��
�
A�� %������ "� #�� /������&"� ������ /��������"� � ������ ���"�!�� ��� ��� � ���"� ?-��� �� 9"� !�9���"�
C�����"�D��� ���
�
���� �� �� 0������ ���//�� � �!����� ���� �� �����-��� ����� 6!� ���� E����78� ��� ��� ��
��� ������ ���� ����� � �#� � ��#�������,� ��� '� � ��+����C���&���"�2�� ������%�����"� ��
���������/�����"���6C����� ��7����������� ������������;��� � �#� �����������*����'�#�����
��,� ������@���������� ����'����� ������� ���������#�������,� ��"���@���������� �������������
�����#�������,� ���������*����*���
�
<'��#%(�#7��6&���&��"*!(���&��)��
�
��#� $��� ����� ���������)��� ����8��;��,���������������� ������;�����8�������������
� � ������������;�;���*>����������� ���������9����������� ��� �8��������������� $������ �8�
���%�� � ����������(��������� �����8������� ������ �&������*>�)8������*�����*)����
�
A�� %������ "� #�� /������&"� ������ /��������"� � ������ ���"�!�� ��� ��� � ���"� ?-��� �� /"� !�9���"�
C�����"�D��� ���
�
C�� ��� ��E���"�*�K<�K�<*��
�
���!���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������(�������� �� ���%������
C�� ����9��,,��
�������������������������������������������������1 La parte rimanente del programma sarà svolta nel periodo successivo al 2/05/2014, fino alla conclusione dell’anno scolastico. Nel caso di mancato svolgimento degli argomenti previsti copia del Programma sarà affissa, con le debite correzioni, all’Albo della scuola.
B – PARTE DISCIPLINARE
1. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 1.1 MATERIA Filosofia1.2 DOCENTE
Marziano Almaviva
1.3 LIBRI DI TESTO ADOTTATI
Abbagnano-Fornero Il nuovo protagonisti e testi della filosofia vol.2B, 3A, 3B, 3C
1.4 ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’A.S 2013/2014
(considerando n. 33 settimane di lezione)
n° 72 ore (al 12/05/2014
) su n° 99 ore previste dal Piano di Studio
1.5 OBIETTIVI RAGGIUNTI
Competenze
Gli studenti devono �
a) Saper individuare a partire dal proprio contesto esistenziale situazioni e contesti problematici, attraverso un’essenziale utilizzazione degli strumenti di analisi delle conoscenze apprese mediante la riflessione filosofica;
b) Saper effettuare in una prospettiva diacronica e sincronica semplici confronti tra diverse tradizioni e correnti filosofiche;
c) Saper concretizzare i principi dell’esercizio attivo della cittadinanza e dell’educazione alla convivenza previste da Cittadinanza e Costituzione, anche in relazione alle conoscenze interdisciplinari e alle categorie concettuali della tradizione filosofica;
Le Abilità
Gli allievi devono saper ricostruire e discutere contesti
a) Riferire in modo chiaro e coerente il pensiero dei filosofi oggetto della Programmazione;b) Utilizzare il lessico specifico; c) Acquisire consapevolezza della pluralità delle prospettive interpretative possibili in
relazione ai testi e alle tematiche studiate al fine di una comprensione consapevole dei contenuti e delle problematiche generali affrontate.
Le Conoscenze
Gli alunni devono conoscere
a) Conoscere le informazioni fondamentali e le idee guida che caratterizzano il pensiero degli autori presenti nell’allegato Programma
b) Conoscere dei termini-chiave del lessico filosofico di base c) Conoscere i termini specifici del linguaggio dei singoli autori d) Conoscere le categorie essenziali della tradizione filosofica
�
�1.6 CONTENUTI
Si veda il programma allegato, con la precisazione che lo svolgimento dello stesso ha termine entro il mese di maggio e che eventuali variazioni saranno esposte all’albo e comunicate a tutti i candidati.
1.7 METODI DI INSEGNAMENTO
• attenzione all'uso di un linguaggio adeguato a specificare correttamente concetti e teorie contestualizzandoli;
• lezioni frontali e dialogate finalizzate a: − introdurre al quadro storico in cui ogni filosofia è collocata, impostandone la
problematica con gli opportuni riferimenti agli argomenti già affrontati; − individuare i nodi tematici ricorrenti, evidenziandone i concetti portanti; − definire schemi operativi e sintetici, anche come traccia per la stesura degli appunti
personali.
1.8 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Si è usato prevalentemente il libro di testo in adozione.
1.9 SPAZI
Lo spazio utilizzato è stato quello dell'aula.
1.10 TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO
1° MODULO. IL CRITICISMO KANTIANO (settembre-ottobre); 2° MODULO: DAL KANTISMO ALL’IDEALISMO (primi di ottobre); 3° MODULO: LA FILOSOFIA HEGELIANA (ottobre-dicembre); 4° MODULO. LA SINISTRA HEGELIANA E FEUERBACH (primi di gennaio); 5° MODULO. IL PENSIERO DI KARL MARX (gennaio-febbraio); 6° MODULO. CRITICA E ROTTURA DEL SISTEMA HEGELIANO: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD (marzo-aprile); 7° MODULO . LA CRISI DELLE CERTEZZE NELLA FILOSOFIA: NIETZSCHE (prima metà di maggio); 8° MODULO. LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA (maggio); 9° MODULO. INTRODUZIONE ALL’EPISTEMOLOGIA DEL NOVECENTO (giugno)
1.11 STRUMENTI DI VERIFICA
Nel corso dell’anno sono state effettuate sia verifiche orali che scritte. Le verifiche scritte hanno avuto la forma del questionario a risposta aperta sul modello della tipologia B della terza prova dell’Esame di Stato. I criteri di valutazione adottati hanno fatto riferimento al quadro generale della valutazione del P.O.F. e ai relativi parametri. I risultati delle singole prove (orali e scritte) sono stati costantemente motivati alla classe e ai singoli alunni mediante l'utilizzo costante delle griglie di valutazione concordate a livello dipartimentale.
1.12 ATTIVITA’ DI SOSTEGNO/RECUPERO
Durante l’anno scolastico sono state svolte costanti attività di recupero nella modalità dello
Sportello Help
���������������������� �����������
����������������
�
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
!"#!�����$%�&%�"�"&%���
�
�
�'��"$(�"��%���!%�%�%��"�)�*�%�*"�
�
����!%�%���$+����!�#%"*� (!��� %��,��-�����.������������������������ ������������� ��
����������� � � ������������������ ��������������������� �������������������������� ���������
�� �� ������ ����� �� ������ ��������� ���� �������� ��� .��/�0�� �������� �� ,�������� ��� !�1���0�����
��,������������������������ ��������� ���!� ����������������������������������������� � ����
����2� /����� ��������0�� �� ��� ,���0����� /����� ������� /����� ��.���� ,����� ����� "#$� %� "&"��
�3������� ������/�����4� �� ������ �� �� ������ �� �� � ������� �� ����������� ��������� �� ��
������������'���3���������������/������������������������"&(�%�"&)��*� ��+�������,����"&-���� .���
����� ��� ����� �� �� ���������� "-(�� � / �� ������� �.��� �� �� ��������� �� � � ��������� ��������� ���
�������������"-0�%�"-$������$��������������/������������������ ���������������� ��������
������ �� ������� �� �� ���� ����� ������ �� �� �� �� ���� ����� ������ �� ������� � �� ������������ ��
�������� ��������� ������������1���������0�������.����1��/������/���������"-)�'"2(��
����!%�%���$+����!�#%"*� !��%����1�������� ����������
�
�
�'��"$(�"5�$���)�*�%��"����3%$+��%��"�
�
%������������/����/��)��������/�-���������� ���������6��� ���������������������������3��� �
��������� ��� ���� ��� 4,��� �3�/�������� ��������� �/����!� ���� ������� �� �� ���� ��� 4� ��
�������������������� ����������0#-�%�0&"���
�
�'��"$(�"5����&%�"�"&%��7+#+�%�*��
�
%��� %���$%�$+���%��+������� ����/�� ��/��/��� �������� 5�������� ����������6��������� �� �3�� ��
��������� �� �� �� ������� %/��4� ������ �� �,����5� ��� ,���0����� /����� ��������� ��� /�������!� �� ���
���������� ��������������� ��������������� ����� �������������$#-�%�$&#��
��� &+*"�+*"�"#%�� $+��"� � %!%�"!� $�1�� ��� �������� ��� ���������.��� ���3������� /���
�������������$-(�%�$-0���������0���/�����������0���7�������������8��7���������������������
��������������� ���������������������9����������6������������$-)�%�$2:��
�3+*�%��" +$%��$+��+� ��%+*8+� &%�"�"&%�7+�� ��� ��.���!� ��������� �� �� ������� ��������3� ���
����������������������$22�����):"�������������/������������5� �������� �������������������������
��������������������3������'������ ���� �;����� ��+����������������� ���,��� ���� ������ �
���������� ������� ��������� �������������+���������,��� ��������������������/������,�������
����,�������..��1�������,������..��1�!� �������3!� ������� ���� �������3����� ��� ��7���������7�����
����� +����� ��� ��� �����+�� � � ������� �� � ���� �� ���� �� �� ��� ��� �� ������������ � � ������� �� �
���� �� ��������� ������� �����3� �� �� 7����� ������� � ������������ �� �� ���3� ������� �� �� 7������
���������������� ��7��������� ������������������ ��� ������������������������ ����������� ��� ��
��������������� �� ������� �� �� ������� ��� �������� /����� �����5� �� ������ ��3� �� �� ������ � � �����
�� �������� ���������� ��������� �������� ��������� �������� ���������� ��������������,�����
�������5� ����� �� � ��������� �� ������ ����� ���� ����� ����� � ������ ����� ���������� �� +�����
�� ����,��� �� � ������� �5� ������ �� �� � ������� �� � �������� ����������� ����������� ��
�������������� ��� 1���� �� �� ����� ������ �� ������ ��� 1��!� �� �� � ������� ����� �� �� ��� ��
�� ����� ���������3��� �������������������� �������� ������������ ��������� ���� ������������):&�
%�)()��
�
��<��=����������/��5����������� �������� �; �������������� �(>��?�������@��������
�
��
�'��"$(�"������%*%��!��7+#+�%�*��+�&+(+!���7��
�
��� $����� �� ��� �������� 9�.�������� ��� ��������� �� �� ��� �� 9��� ������ ������������ ��
���������� �� �� � ������A� ��������������� �� ������� �� ��������A� ����� -"� %� -(�� &����-��9�� ; �
�������������������������������������� ���������� ��� ��������� ������������������������-$�%�
--���B����������� ������������+�����C���D��9��������,������-2�%�2"���
�
�
:'��"$(�"��%�� +*�%+!"�$%�)�!����!;���
�
�������������9��.��������/������<����������������������������� ��.����/��7�.���� ����������
�����������/������������-�����������������������3���������-��.9�����/ ������������������� ��
�� �� ����������� � ���������� �� ������3� �������� �� +��� ������������,� �� �� ������ %�� /������� /��
&����-��9����3����,���0�����/���������.���������9��1������������;� �������� ���� ������5������9�
�� �� � �������� �� � ������� ����� +������ ���� ���� �,�� �� ������3� ��� +�������,� � � ������� ���
�����0����� ������������� /����� ������� 1� ����� ����� � �� ������� �� � ��������� ��� +���� ����,���
������� �� ����������� � � ������� ������'����������� �� ��� ������� �� �� ����� ����� ":$�%�
""-���%����������/���,�������������5�>��9������� ���������� ��������� ��������""2�%�"(:���
%����,������E������������� ��������@��������������� �����!� �������� ������������������ ������� ���
������ �������� ��� ��� �F� ������������� ���������������������� ������������ � � ���������
�� �� ������ � � ������ ���������� ��,���������� �3���.���� /��� ,���1�������� ���/��0�� ��
�����//�0����� /��� ��,�������!� � � ������� ������ ������ �� � ��������� �� ���� ��� ��������� � �
��������� ��������� ��9�������������������� ����������� �������3��� ������� ���������������
��������� ������� ����������1���0����������/������/���,������������������/���������������2�
��������5� ;�G��������� �� � � ������� �� � ��������� +����,�� � � ��������� ����������� �� +�����
�����,�� ������������� �������3����������� ������������!�+�������������� ������������3����
��������������������������,������"((�%�"00��
�
��
='� �"$(�"�� �!%�%��� +� !"��(!�� $+�� �%��+��� 7+#+�%�*"5� ��7" +*7�(+!� +�
)%+!)+#��!$���
�
��7" +*7�(+!� ��� ��/���� ��������� /��� �������� %�� 1���� /�� ��>���� ���� ?� 1����2��
$���3�����0��/����������,�����3�����0��/������/��������������������0�����/�����1����2�/��
1�1����� %�� ,�����������1� ���� ������� �� ������ �� ��������������� ��� �� �������� �������(��
�,,����/�����5� ��� ������������1����� �����/����������� ; � ��������� ������������������ � �
��������� �������������� ��� � ���������� ��������������������1���/�������-���0�����/���/�������
������� ��������� ������3�� ������������)�%�(#��
�
)%+!)+#��!$�� ��� 1����/�� -��.����9�� �� ��� �,����� �3������0�� ����� ,����-���2� �� �/��� ���
����������39�.������� ������������ � ���.����������� �� �� ������ +���������,�������� � ����������
���� ���������� ���������� ���������� �?�������� �7���� �!� ����� ����������������� ����� �����
#�����/��/���3������0��������������������� �������������� �������� ��������3��.�������@����$0�%�)$���
�
�
A'��"$(�"�������!%�%�$+��+��+!�+88+�*+����&%�"�"&%�5�*%+�8��7+�
�
��� $+�%��%&%��8%"*+� $+��+� %��(�%"*%� $+���� �!�$%8%"*+��*��0��9��� ���� �� ������� ���
����������9�� /��� ,�������� �� /����� �������� /�� *��0��9��� %�� ,����/�� .��1������� @������� ��
�� ������� ��� ������� �� �� ���������� �� �� �������� ������������� �� ������� �� �� <������ �� ��
������������������� ���� �������������� ���� ������������������� ������������ �����������������
�� ����� ����� ��� ���������� �� ��� ������ � � ���� ��� �� ���� ����� �� �� ���������� �� �� ���������
������ ������� �� ������ ����������� 7������ ������� �� ������������� �� �� ����!� �� ����������������
�� ������ 7����� �� ����!� �� ������������� ������� �!� �� ������� � �� �������� �� � �� ������������ � �
����������� �������� .������������ .�� ����%��,����/�� �������������!� � �������������������
�� ������������� ����������<�����9��+� �������,��; ������������� ������������ �������� ����������
��������/��$����� �� ������� �� � ��������������9��������������1����� ����������� ���,��������
�����02$�%�$"0��
%�� +!%"$"�$%�8�!��7(��!��+��3(��%�"�*%+�8��7+��%��,����/��/��8���9����������� ������
�� ����������; ������������������������������$("�%�$(&���
�
B'��"$(�"�����!%�"�(8%"*+� �%�"�*��%�%���
&!+($��F������������1�� �������� �������� ��������� ����,��.�������1�����������:�����C���
����� �3��� ������������ �������������������;�������� ���������������������������������������������
�� ����� ��3���� ����� ���������������������������������� �������� ������� ��3������$&:�%�
$&-������� ��������� ������ �3������$&2�%�$-:����
�
<��=����������/��5����������� ���������7�9����9������5����0=��?�������@�����
�
D'��"$(�"��%*�!"$(8%"*+����3+ %��+�"�"#%��$+��*"�+�+*�"�
" +!���������,�����@��($2��� �,,�����+��������������-����0�����/�����������������/������
�,�������.��9���; ���� ������ ����������������� ��������������� ������� ��3�����������������
�� �� �������3� �� �� ��������� ����������� ��� ��������� ��3� �� �� ������� ��3� �� �� ������ �� ��
�����������������():�%�()#��
�
<��=����������/��5����������� �������� ���������� �������/������0>��?�������@�����
�
G�����������@�����"(H:)H(:"$�
�
; �1��������������������������������������������������������������������������������������������;�����6���������������� ������������������������������������������������������������������
G�������= �������
�
�������������������������������������������������i La parte rimanente del programma sarà svolta nel periodo successivo al 12/05/2014, fino alla conclusione dell’anno scolastico. Nel caso di mancato svolgimento degli argomenti previsti copia del Programma sarà affissa, con le debite correzioni, all’Albo della scuola
Liceo Scientifico "C. Salutati" – Montecatini Terme
ANNO SCOLASTICO 2013/14
classe 5B P.N.I.
1. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI
1.1 Materia: MATEMATICA PNI
1.2 Docente: Prof. Stefano Gori
1.3 Libri di testo adottati: Moduli di lineamenti di matematica, di N. Dodero, P. Baroncini, R. Manfredi,
editore Ghisetti & Corvi (Sedes), volumi vari
1.4 Ore di lezione effettuate nell’A.S. 2013/2014: n° 165 su 165 previste dal Piano di Studio
1.5 Obiettivi raggiunti
- Contribuire alla formazione culturale dell’allievo fornendo modelli interpretativi della realtà,
attraverso lo sviluppo delle capacità logico-razionali.
- Acquisire un linguaggio matematico che permetta sia di comprendere testi specifici sia di affrontare
argomenti via via più complessi e rigorosi.
- Saper utilizzare strumenti e modelli matematici in situazioni diverse.
- Raggiungere livelli sempre più elevati di astrazione e formalizzazione, tenendo però conto che il
formalismo matematico, pur essendo importante, deve essere di supporto alle idee e non fine a se
stesso.
1.6 Contenuti
Si rimanda al programma svolto.
I contenuti sono stati proposti, in generale, per temi, al fine di dare risalto ai concetti fondamentali
attorno cui si aggregano i vari argomenti; in riferimento all’itinerario didattico ritenuto più opportuno, si
sono effettuate scelte programmatiche a seconda delle esigenze specifiche e dei ritmi di apprendimento
della classe. Le diverse parti sono state trattate con diverso grado di approfondimento tenendo però
sempre presenti sia gli obiettivi formativi e culturali da raggiungere che la struttura intrinseca della
disciplina.
1.7 Metodo di insegnamento
Ogni argomento svolto in classe è stato sviluppato sia attraverso lezioni frontali che partecipate. Si è
cercato, quando possibile, di introdurre gli argomenti in forma problematica e di stimolare gli alunni
alla partecipazione attiva, alla riflessione critica e alla formulazione di ipotesi. Gli allievi sono stati
invitati a prendere appunti in classe e ad integrarli con il libro di testo durante lo studio a casa,
stimolandoli a chiarire dubbi e scambiare opinioni durante la lezione successiva. Lo svolgimento
delle attività e il maggiore o minore approfondimento è stato calibrato sui ritmi di apprendimento della
classe, dedicando un numero maggiore di ore ad argomenti che sono risultati particolarmente ostici e
quindi per attività di recupero e potenziamento.
Le attività di laboratorio si sono svolte conformemente alle disposizioni ex CM 615/96.
1.8 Mezzi e strumenti di lavoro
Gli strumenti didattici utilizzati sono stati prevalentemente la lezione frontale verbale, appunti, fotocopie
di integrazione per alcuni argomenti, libro di testo. Le lezioni di laboratorio si sono svolte in aula
informatica, dove è disponibile un computer per ciascuno studente.
1.9 Spazi
Si sono utilizzati sia lo spazio classe che il laboratorio di informatica del Liceo.
1.10 Tempi impiegati per la realizzazione del programma svolto
Sono stati rispettati i tempi previsti nel piano di lavoro depositato in segreteria didattica all’inizio dell’AS
1.11 Strumenti di verifica
Gli strumenti di valutazione prevalentemente usati sono stati: interrogazioni orali, prove scritte di tipo
tradizionale, prove semistrutturate e prove strutturate.
1.12 Attività di sostegno, recupero e approfondimento
Il recupero è stato svolto in itinere, mentre non sono state previste attività di approfondimento.
2. ALTRE CONSIDERAZIONI
nn.
PROGRAMMA PRESENTATO
(Programma svolto e/o da svolgere entro il termine delle lezioni)
1. Le funzioni continue e il calcolo dei limiti: definizione di continuità di una funzione in un punto e in un
intervallo, continuità delle funzioni elementari e della funzione composta; i teoremi sulle funzioni
continue: teorema degli zeri e teorema di Bolzano-Weierstrass; il calcolo dei limiti e le forme
indeterminate; i punti di discontinuità di una funzione e vari tipi di discontinuità.
2. La derivata di una funzione: rapporto incrementale e definizione di derivata in un punto,
significato geometrico del rapporto incrementale e della derivata in un punto, derivata sinistra e
derivata destra in un punto, funzione derivata; equazione della retta tangente in un punto al grafico
di una funzione; punti stazionari, punti a tangente verticale, punti angolosi. Derivate fondamentali.
Regole di derivazione e calcolo delle derivate; derivate di ordine superiore. Relazione tra derivabilità
e continuità. Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Lagrange, teorema di Rolle, teorema di
Cauchy e applicazioni; teorema di De L’Hospital e applicazioni per il calcolo di limiti. Differenziale
di una funzione. Polinomio di Taylor e di McLaurin. Equazioni differenziali. Metodo di derivazione
numerica.
3. Lo studio delle funzioni: le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate, massimi e minimi relativi e
assoluti, concavità e flessi; ricerca dei massimi e minimi relativi e dei flessi orizzontali mediante lo studio
del segno della derivata prima e con il metodo delle derivate successive; ricerca dei punti di flesso
mediante lo studio del segno della derivata seconda e con il metodo delle derivate successive. Gli
asintoti: orizzontali, verticali e obliqui. Lo studio di una funzione. Ricerca degli zeri di una funzione con il
metodo di bisezione, con il metodo delle secanti e con il metodo delle tangenti; implementazione dei
relativi algoritmi, teoremi di unicità e criteri di convergenza. Studio completo di funzioni. Problemi di
massimo e di minimo di geometria piana e solida.
4. Integrali: primitiva di una funzione, integrali indefiniti. Teoremi sul calcolo integrale. Integrali
fondamentali e immediati. Continuità, derivabilità e integrabilità di una funzione. Integrali per parti,
per sostituzione. Integrazione delle funzioni razionali con radici reali o complesse.
Problemi che conducono al calcolo integrale; dal calcolo di aree all’integrale definito, proprietà
dell’integrale definito; teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo dell’area racchiusa da
una curva e calcolo dell’area racchiusa da due curve. Calcolo dei volumi. Teorema della media.
Metodi di integrazione numerica.
5. Trasformazioni geometriche: a) le trasformazioni geometriche nel piano cartesiano: isometrie,
simmetrie, traslazioni, rotazioni, composizione di isometrie, trasformazioni affini e non affini,
similitudini, omotetie, dilatazioni, costruzione del grafico della funzione inversa.
6. Vettori e matrici: fondamenti di algebra lineare.
Montecatini T., 15 maggio 2014
Liceo Scientifico "C. Salutati" – Montecatini Terme
ANNO SCOLASTICO 2013/14
classe 5B P.N.I.
1. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI
1.1 Materia: FISICA
1.2 Docente: Prof. Stefano Gori
1.3 Libri di testo adottati: Elettromagnetismo, di James S. Walker, editore Zanichelli, volume 3
1.4 Ore di lezione effettuate nell’A.S. 2013/2014: n° 99 su 99 previste dal Piano di Studio
1.5 Obiettivi raggiunti
- Analizzare un fenomeno o un problema riuscendo ad individuare gli elementi significativi, le relazioni,
i dati superflui e quelli mancanti e a collegare premesse e conseguenze.
- Eseguire in modo corretto semplici misure con chiara consapevolezza delle operazioni effettuate e degli
strumenti utilizzati.
- Raccogliere, ordinare e rappresentare i dati ricavati valutando gli ordini di grandezza, le
approssimazioni e l'errore associato alla misura.
- Progettare ed eseguire semplici esperimenti.
- Esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici ed altre documentazioni. Porsi
problemi, prospettare soluzioni e modelli.
- Dedurre dalla legge teorica generale i casi particolari.
- Inquadrare in uno stesso schema logico situazioni diverse riconoscendo analogie e differenze, proprietà
varianti ed invarianti.
1.6 Contenuti
Si rimanda al programma svolto.
I contenuti sono stati proposti, in generale, per temi, al fine di dare risalto ai concetti fondamentali
attorno cui si aggregano i vari argomenti; in riferimento all’itinerario didattico ritenuto più opportuno, si
sono effettuate scelte programmatiche a seconda delle esigenze specifiche e dei ritmi di apprendimento
della classe. Le diverse parti sono state trattate con diverso grado di approfondimento tenendo però
sempre presenti sia gli obiettivi formativi e culturali da raggiungere che la struttura intrinseca della
disciplina.
1.7 Metodo di insegnamento
Ogni argomento è stato svolto in classe, sia attraverso lezioni frontali che partecipate. Si è cercato,
quando possibile, di introdurre gli argomenti in forma problematica e di stimolare gli alunni alla
partecipazione attiva, alla riflessione critica e alla formulazione di ipotesi.
Gli allievi sono stati invitati a prendere appunti in classe e ad integrarli con il libro di testo durante lo
studio a casa, stimolandoli a chiarire dubbi e scambiare opinioni durante la lezione successiva. Lo
svolgimento delle attività e il maggiore o minore approfondimento è stato calibrato sui ritmi di
apprendimento della classe, dedicando un numero maggiore di ore ad argomenti che sono risultati
particolarmente ostici e quindi per attività di recupero e potenziamento.
Le attività di laboratorio si sono svolte conformemente alle disposizioni legislative.
In alcuni casi si è lavorato “per progetti”, utilizzando le tematiche curriculari per partecipare a
concorsi riservati ai ragazzi delle scuole superiori.
1.8 Mezzi e strumenti di lavoro
Gli strumenti didattici utilizzati sono stati prevalentemente la lezione frontale verbale, appunti, fotocopie
di integrazione per alcuni argomenti, libro di testo. Le lezioni di laboratorio si sono svolte nell’aula di
fisica del Liceo.
1.9 Spazi
Si sono utilizzati sia lo spazio classe che il laboratorio di fisica del Liceo.
1.10 Tempi impiegati per la realizzazione del programma svolto
Sono stati rispettati i tempi previsti nel piano di lavoro depositato in segreteria didattica all’inizio dell’AS
1.11 Strumenti di verifica
Gli strumenti di valutazione prevalentemente usati sono stati: interrogazioni orali, prove scritte di tipo
tradizionale, prove semistrutturate e prove strutturate.
1.12 Attività di sostegno, recupero e approfondimento
Il recupero è stato svolto in itinere, mentre non sono state previste attività di approfondimento.
2. ALTRE CONSIDERAZIONI
nn.
PROGRAMMA PRESENTATO
(Programma svolto e/o da svolgere entro il termine delle lezioni)
CAPACITA' ELETTRICA
Equilibrio elettrostatico; Capacità elettrica di un conduttore; condensatori; capacità di un condensatore
piano; condensatori in serie e in parallelo; lavoro di carica di un condensatore; energia associata al campo
elettrico; polarizzazione dei dielettrici e relazione con la capacità dei condensatori.
LA CONDUZIONE NEI SOLIDI – CORRENTI - CIRCUITI
La corrente elettrica nei conduttori solidi. Legge di Ohm e resistenza elettrica; conduttività e
resistività; la forza elettromotrice e il suo legame con la differenza di potenziale; la legge di Ohm in un
circuito chiuso; resistenze in serie e in parallelo; cenni sull'uso di Voltmetri, amperometri,
galvanometri e reostati; le leggi di Kirckhoff; effetto Joule e potenza elettrica; gli elettroni di conduzione in
un metallo; cenni sulla conduzione nei liquidi; il circuito RC: processo di carica e di scarica. Principi di
conservazione e teorema di Noether.
IL CAMPO MAGNETICO
I magneti e la loro interazioni; il campo magnetico delle correnti e l'interazione magnete - corrente;
definizione del vettore campo magnetico B e la forza di Lorentz; l'interazione corrente - corrente; campo
magnetico di un filo percorso da corrente: legge di Biot e Savart; teorema della circuitazione di Ampere-
Laplace; flusso del vettore campo magnetico e teorema di Gauss per il magnetismo; relazione tra campo
elettrico e campo magnetico; il campo magnetico di una spira circolare e di un solenoide; magneti
elementari e loro interpretazione in termini di circuiti elettrici; proprietà magnetiche della materia:
sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche; ciclo di isteresi; energia associata al campo
magnetico.
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
Esperienze di Faraday sulle correnti indotte; analisi dell'induzione elettromagnetica tramite varie
esperienze; la legge di Lenz; correnti di Foucault; induttanza di un circuito e suo significato fisico;
induttanza di un solenoide; fenomeno di autoinduzione. Il trasformatore statico. Il circuito LC e il circuito
RLC (descrizione).
CORRENTI - CIRCUITI
La corrente elettrica alternata. Reattanza, impedenza, sfasamento corrente – tensione, fattore di potenza e
rifasamento. Semiconduttori, diodo a giunzione.
EQUAZIONI DI MAXWELL
La legge di Faraday-Neumann e il campo elettrico indotto; la corrente di spostamento; Equazioni di
Maxwell e loro importanza per lo studio completo dell'elettromagnetismo. Energia associata al campo
elettromagnetico. Produzione di onde elettromagnetiche. Spettro elettromagnetico.
FISICA ATOMICA
Radiazione di corpo nero. Diffusione. Ipotesi di De Broglie. Il principio di indeterminazione. Modelli
atomici. Decadimento radiattivo.
RELATIVITA’
Introduzione allo studio della relatività ristretta.
Montecatini Terme, 15 maggio 2014
Liceo Scientifico "C. Salutati" – Montecatini Terme ANNO SCOLASTICO 2013/14
classe 5B (tradizionale) Ins. Prof. Nicoletta Moscani
B - P A R T E D I S C I P L I N A R E
1. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI
1.1 Materia: MATEMATICA
1.2 Docente: Prof.ssa Nicoletta Moscani
1.3 Libri di testo adottati: Moduli di lineamenti di matematica, di N. Dodero, P. Baroncini, R.
Manfredi, editore Ghisetti & Corvi, moduli vari
1.4 Ore di lezione effettuate nell’A.S. 2013/2014: n° 89 ore su n° 99 ore previste dal Piano di
Studio
1.5 Obiettivi raggiunti - Contribuire alla formazione culturale dell’allievo fornendo modelli interpretativi della
realtà, attraverso lo sviluppo delle capacità logico-razionali.
- Acquisire un linguaggio matematico che permetta sia di comprendere testi specifici sia di
affrontare argomenti via via più complessi e rigorosi.
- Saper utilizzare strumenti e modelli matematici in situazioni diverse.
- Raggiungere livelli sempre più elevati di astrazione e formalizzazione, tenendo però conto
che il formalismo matematico, pur essendo importante, deve essere di supporto alle idee e
non fine a se stesso.
1.6 Contenuti Si rimanda al programma svolto.
I contenuti sono stati proposti, in generale, per temi, al fine di dare risalto ai concetti
fondamentali attorno cui si aggregano i vari argomenti; in riferimento all’itinerario didattico
ritenuto più opportuno, si sono effettuate scelte programmatiche a seconda delle esigenze
specifiche e dei ritmi di apprendimento della classe. Le diverse parti sono state trattate con
diverso grado di approfondimento tenendo però sempre presenti sia gli obiettivi formativi e
culturali da raggiungere che la struttura intrinseca della disciplina.
1.7 Metodo di insegnamento Ogni argomento è stato svolto in classe, sia attraverso lezioni frontali che partecipate. Si è
cercato, quando possibile, di introdurre gli argomenti in forma problematica e di stimolare
gli alunni alla partecipazione attiva, alla riflessione critica e alla formulazione di ipotesi.
Gli allievi sono stati invitati a prendere appunti in classe e ad integrarli con il libro di testo
durante lo studio a casa, stimolandoli a chiarire dubbi e scambiare opinioni durante la
lezione successiva. Lo svolgimento delle attività e il maggiore o minore approfondimento è
stato calibrato sui ritmi di apprendimento della classe, dedicando un numero maggiore di
ore ad argomenti che sono risultati particolarmente ostici e quindi per attività di recupero e
potenziamento.
1.8 Mezzi e strumenti di lavoro
Gli strumenti didattici utilizzati sono stati prevalentemente la lezione frontale verbale, appunti,
fotocopie di integrazione per alcuni argomenti, libro di testo e quaderno della teoria.
1.9 Spazi Si è utilizzato esclusivamente lo spazio classe.
1.10 Tempi impiegati per la realizzazione del programma svolto Con riferimento agli argomenti specificati nel programma svolto, allegato:
- Funzioni: settembre
- I limiti delle funzioni: ottobre
- Le funzioni continue e il calcolo dei limiti: novembre dicembre
- La derivata di una funzione: gennaio-febbraio
- Lo studio delle funzioni: febbraio-marzo
- Integrali: aprile maggio
1.11 Strumenti di verifica Gli strumenti di valutazione usati sono stati: interrogazioni orali, prove scritte di tipo
tradizionale.
1.12 Attività di sostegno, recupero e approfondimento Sono state svolte 8 ore pomeridiane di supporto all’attività didattica mattutina
(approfondimento) e 6 ore di recupero in itinere durante le ore curricolari.
PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA CLASSE 5^B (tradizionale)
A.S. 2013/2014 INS. Prof.ssa Nicoletta Moscani
- Funzioni: definizioni e classificazione, campo di esistenza, studio del segno di una
funzione e zeri di una funzione, funzioni pari e funzioni dispari.
- I limiti delle funzioni: il limite finito di una funzione in un punto, il limite destro e il limite
sinistro di una funzione in un punto, il limite infinito di una funzione in un punto, il limite finito
di una funzione per x che tende a più o meno infinito, il limite “più o meno infinito” di una
funzione per x che tende a più o meno infinito. I limiti sono stati trattati solo come tecnica di
calcolo e non attraverso la loro definizione matematica. Teoremi sui limiti: teorema dell’unicità
del limite (senza dimostrazione), teorema del confronto (senza dimostrazione), dimostrazione
del limite fondamentale per x che tende a 0 di senx/x. Limite notevole che ha come risultato
“e”.
Operazioni sui limiti. Forme indeterminate e loro risoluzione.
- Le funzioni continue: definizione di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo,
continuità delle funzioni elementari e della funzione composta; i teoremi sulle funzioni
continue: teorema degli zeri (senza dimostrazione), teorema del valori intermedi (senza
dimostrazione) e teorema di Bolzano-Weierstrass (senza dimostrazione); i punti di
discontinuità di una funzione e vari tipi di discontinuità.
- La derivata di una funzione: rapporto incrementale; definizione di derivata in un punto
come limite per h che tende a 0 del rapporto incrementale e sua applicazione al calcolo delle
derivate delle principali funzioni; significato geometrico del rapporto incrementale e della
derivata in un punto, derivata sinistra e derivata destra in un punto, funzione derivata;
equazione della retta tangente in un punto al grafico di una funzione; punti stazionari,
punti a tangente verticale, punti angolosi. Derivate elementari ottenute come limite del
rapporto incrementale (con dimostrazione). Regole di derivazione (con d imos traz ione) e
loro appl icaz ione a l calcolo delle derivate; derivate di ordine superiore. Relazione tra
derivabilità e continuità (senza dimostrazione). Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema
di Lagrange (senza dimostrazione) e sua interpretazione geometrica, teorema di Rolle (senza
dimostrazione) e sua interpretazione geometrica e teorema di Cauchy (senza dimostrazione)
con applicazioni; teorema di De L’Hopital (senza dimostrazione) e applicazioni al calcolo di
limiti.
- Lo studio delle funzioni: le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate, massimi e
minimi relativi e assoluti, concavità e flessi; ricerca dei massimi e minimi relativi e dei flessi
orizzontali mediante lo studio del segno della derivata prima e con il metodo delle derivate
successive; ricerca dei punti di flesso mediante lo studio del segno della derivata
seconda e con il metodo delle derivate successive. Gli asintoti: orizzontali, verticali e
obliqui. Lo studio di una funzione.
- Integrali: dal calcolo di aree all’integrale definito, proprietà dell’integrale definito; il
Teorema della media (senza dimostrazione) e sua interpretazione geometrica; la funzione
integrale; teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione); integrale
indefinito; integrali immediati; continuità, derivabilità e integrabilità di una funzione.
Integrali per parti, per sostituzione. Integrazione delle funzioni razionali fratte. A pplicazioni:
calcolo dell’area racchiusa da una curva e dall’asse x e calcolo dell’area racchiusa da due o
più curve. Calcolo dei volumi. Cenni sugli integrali impropri.
Gli alunni L’insegnante
Liceo Scientifico "C. Salutati" – Montecatini Terme ANNO SCOLASTICO 2013/14
classe 5B (tradizionale) Ins. Prof. Nicoletta Moscani
B - P A R T E D I S C I P L I N A R E
1. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 1.1 Materia: FISICA1.2 Docente: Prof. Nicoletta Moscani
1.3 Libro di testo adottato: “La fisica di Amaldi: idee ed esperimenti” – Volume 3, di Ugo Amaldi,
Zanichelli Editore.
1.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2013/14: n°77 su n°99 previste dal piano di
studi.
1.5 Obiettivi raggiunti: ��Conoscere gli argomenti oggetto del programma;
��Acquisire il linguaggio specifico della disciplina;
��Saper utilizzare strumenti matematici elementari per arrivare a ricavare le Leggi
fisiche;
��Collegare i concetti studiati ad alcuni fenomeni della nostra vita quotidiana.
1.6 Contenuti: si rimanda al programma svolto.
1.7 Metodo di insegnamento: Ogni argomento è stato svolto in classe, sia attraverso lezioni frontali che attraverso lezioni-
discussione, durante le quali gli studenti sono stati chiamati a formulare ipotesi sulla base
degli studi fatti e delle esperienze personali. Inoltre gli allievi hanno costruito un proprio
quaderno di teoria, a partire dagli appunti presi in classe rielaborandoli con il libro di testo
durante lo studio a casa. Il tempo e l’approfondimento dedicato a ciascun argomento è stato
calibrato sulla base delle difficoltà incontrate dagli studenti.
1.8 Mezzi e strumenti di lavoro: gli strumenti didattici utilizzati sono stati il libro di testo e il
quaderno della teoria.
1.9 Spazio: è stato utilizzato esclusivamente lo spazio classe.
1.10Tempi impiegati per la realizzazione del programma svolto:
Con riferimento al programma svolto in allegato:
��Legge di Coulomb e Campo elettrico: settembre – ottobre;
��Il potenziale elettrico: novembre;
��Fenomeni di elettrostatica: dicembre;
��La corrente elettrica: gennaio – febbraio - marzo;
��Fenomeni magnetici fondamentali: aprile;
��Il campo magnetico: aprile-maggio
��L’induzione elettromagnetica: maggio.
1.11Strumenti di verifica:
Gli strumenti usati sono stati le interrogazioni orali e quesiti a risposta aperta con un massimo
di 10 righe.
1.12Attività di sostegno/recupero e approfondimento:
Sono state effettuate in itinere 6 ore dedicate al ripasso degli argomenti svolti.
2. ALTRE CONSIDERAZIONI:
Il gruppo della 5B che segue l’ordinamento tradizionale è costituito da 9 studenti, 4 femmine e
5 maschi.
Durante il triennio ho seguito la classe in quarta e quinta per quanto riguarda matematica
mentre in fisica l’ho seguita per tutti e tre gli anni.
Questa discontinuità in matematica ha comportato alcune lacune in geometria analitica, mai
completamente superate che impediscono loro di affrontare i problemi più complessi e
articolati con la dovuta sicurezza. Per questo motivo è stato dato ampio spazio alla risoluzione
di esercizi e problemi più che all’aspetto teorico.
Dal punto di vista del rendimento in questa disciplina, la classe appare divisa in due gruppi,
uno, formato da circa metà degli studenti, che ha avuto un comportamento poco maturo ed ha
affrontato lo studio in modo superficiale e discontinuo, ottenendo risultati mediocri e, in
qualche caso, scadenti; per molti di loro rimangono numerose lacune e i risultati non sono
sufficienti, soprattutto nelle prove scritte. Gli elementi dell’altro gruppo, invece, si sono
mostrati un pò più attenti ed organizzati nello studio, ottenendo risultati differenziati, ma
comunque positivi; la loro preparazione appare più solida perché supportata da continuità
nell’impegno e autonomia di lavoro, pur con le lacune pregresse di cui ho scritto sopra.
Per quanto riguarda fisica, i risultati globali risultano migliori che in matematica, anche se
manca un vero e proprio studio sistematico della disciplina poiché la maggior parte della
classe si è limitata ad uno studio mnemonico e per lo più legato alle verifiche scritte o alle
interrogazioni, da me non programmate, ma molto “autogestite” a causa di numerose assenze
strategiche, pertanto manca a molti studenti una visione generale e un po’ approfondita. Non
mancano, comunque, in fisica studenti con risultati molto buoni.
Come considerazione generale finale posso affermare che il fatto di essere un gruppo classe
poco numeroso poteva essere per gli studenti una opportunità per studiare le due materie in
modo approfondito e invece questa opportunità non è stata concretizzata.
Numerose sono state le assenze degli studenti durante l’intero anno scolastico, tanto che in un
paio di occasioni mi sono ritrovata senza alcun studente in classe.
Il 29 aprile è stata effettuata una simulazione della terza prova tra le cui materie c’era fisica e
il 20 maggio è prevista una simulazione della seconda prova di matematica su 5 ore.
Montecatini Terme, 8 maggio 2014
L’insegnante
PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA CLASSE 5^B (tradizionale)
A.S. 2013/2014 INS. Prof.ssa Nicoletta Moscani
La carica elettrica e la Legge di Coulomb Elettrizzazione per strofinio; conduttori e isolanti; elettrizzazione per contatto; la carica elettrica;
la conservazione della carica elettrica; l’espressione matematica della Legge di Coulomb; la
costante dielettrica assoluta del vuoto; la forza di Coulomb nella materia; l’induzione
elettrostatica; confronto tra forze elettriche e gravitazionali; la polarizzazione degli isolanti. Il campo elettrico Il concetto di campo elettrico; il vettore campo elettrico; le linee di campo; il flusso del campo
elettrico e il Teorema di Gauss; il campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di
carica, da una distribuzione lineare di carica e da una sfera carica.
Il potenziale elettrico L’energia potenziale elettrica; il potenziale elettrico; il potenziale di una carica puntiforme; le
superfici equipotenziali; la deduzione del campo elettrico dal potenziale; la circuitazione del campo
elettrostatico. Fenomeni di elettrostatica La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico; il campo elettrico e il
potenziale in un conduttore in equilibrio elettrostatico; Teorema di Coulomb; relazione tra il
raggio di curvatura e la densità superficiale di carica; potere disperdente delle punte; il problema
generale dell’elettrostatica; convenzioni per lo zero del potenziale; la capacità di un conduttore; il
condensatore; condensatori in serie e parallelo; l’energia immagazzinata in un condensatore. La corrente elettrica continua La corrente elettrica; i generatori di tensione; il circuito elettrico; la prima Legge di Ohm; le Leggi
di Kirchhoff; i conduttori ohmici in serie e in parallelo; la trasformazione dell’energia elettrica; la
forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione.
La corrente elettrica nei metalli I conduttori metallici; la seconda Legge di Ohm; l’effetto Joule; la dipendenza della resistività
dalla temperatura e i superconduttori.
Fenomeni magnetici fondamentali Magneti naturali e artificiali; le linee di campo magnetico; confronto tra campo magnetico e
campo elettrico; forze che si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e correnti; la
definizione di Ampere; l’intensità del campo magnetico; la forza esercitata da un campo magnetico
su un filo percorso da corrente; il campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente; il
campo magnetico di una spira e di un solenoide.
Il campo magnetico La forza di Lorentz; il moto di una carica in un campo magnetico uniforme; il flusso e la
circuitazione del campo magnetico; le proprietà magnetiche dei materiali; il ciclo di isteresi
magnetica.
L’induzione elettromagnetica Le correnti indotte; il ruolo del flusso del campo magnetico; la Legge di Faraday – Neumann; la
Legge di Lenz.
Gli alunni L’insegnante
B – PARTE DISCIPLINARE
1. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI ( da compilarsi per ciascuna materia)
1.1 MATERIA Scienze
1.2 DOCENTE
Federica Raffaelli
1.3 LIBRI DI TESTO ADOTTATI
La Terra nello spazio e nel tempo di Lupia Palmieri – Parotto Ed Zanichelli
1.4 ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’A.S.2013/2014
(considerando n. 33 settimane di lezione)
n° ore 66 su n° ore 66 previste dal Piano di Studio
1.5 OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di competenze, abilità, conoscenze)
Competenze: gli alunni sono in grado di esporre correttamente i contenuti della disciplina e di
utilizzare la terminologia scientifica in modo appropriato; sanno descrivere e interpretare i processi
geologici; hanno capacità di analisi e di sintesi e sanno schematizzare i contenuti. Abilità: sono in
grado di operare collegamenti in relazione agli argomenti affrontati nel corso dell’anno scolastico
e generalmente alle altre discipline. Gli alunni hanno raggiunto tali obiettivi a livelli differenziati:
buoni, discreti in alcuni casi, sufficienti o più che sufficienti in altri casi . Conoscenze: hanno
acquisito conoscenze relative alle caratteristiche dei minerali, ai vari tipi di rocce e ai loro processi
di formazione. Conoscono in modo adeguato gli strati della Terra e la loro relazione con i
movimenti delle placche litosferiche nell’ambito della dinamica della litosfera, i collegamenti con i
fenomeni endogeni. Nell’ambito dell’Astronomia le conoscenze riguardano le caratteristiche e
l’evoluzione delle stelle, con particolare riferimento al Sole, l’origine e l’evoluzione dell’Universo,
i moti di rotazione e rivoluzione della Terra e relative conseguenze..
1.6 CONTENUTI (Allegare il programma svolto; indicare – se vi sono –
argomenti particolarmente approfonditi)
Vedi programma allegato
1.7 METODI DI INSEGNAMENTO (lezione frontale, lezione interattiva,
lezione/discussione, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato, etc…
Si sono effettuate lezioni frontali,lezioni dialogate al fine di un’ottimizzazione della
comprensione, si è fatto uso di video, si sono effettuate esercitazioni mirate a facilitare un
processo di sintesi degli argomenti svolti
1.8 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO (Libri di Testo, Schede,
CD – ROM, audiovisivi, dispense, etc… - computer, videoproiettori, etc…)
Si è fatto uso del libro di testo, filmati, computer, LIM
1.9 SPAZI (biblioteca, palestra, laboratori, aule speciali)
Si è utilizzata l’aula dell’insegnante , data la presenza della LIM e del computer in classe
1.10 TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO
(possibilmente diviso in macrotematiche)
Primo trimestre (settembre, ottobre, novembre, dicembre): La crosta terrestre: minerali e rocce; i
fenomeni vulcanici; i fenomeni sismici
Pentamestre (gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno) La dinamica interna della Terra,
la struttura della Terra, l’energia interna della Terra e il flusso di calore, il campo magnetico
terrestre, la struttura della crosta, la teoria della deriva dei continenti, l’espansione dei fondali
oceanici e le anomalie magnetiche, la Tettonica delle placche e verifica del modello, moti
convettivi e punti caldi. L’ambiente celeste: le stelle, posizione, caratteristiche ed evoluzione,
convettivi e punti caldi. L’ambiente celeste: le stelle, posizione, caratteristiche ed evoluzione,
origine ed evoluzione dell’Universo, il Sole e la fornace nucleare; il pianete Terra: forma e
dimensioni, coordinate geografiche, moto di rotazione e di rivoluzione e relative conseguenze.
1.11 STRUMENTI DI VERIFICA (interrogazione, prova scritta tradizionale,
prova scritto-grafica, test, questionario, etc…)
Si sono effettuate interrogazioni; si sono effettuate prove scritte: una nel primo trimestre e due
nel pentamestre, la seconda delle quali come simulazione della terza prova (tipologia B)
1.12 ATTIVITA’ DI SOSTEGNO/RECUPERO – APPROFONDIMENTO –
RISULTATI OTTENUTI
Si è svolta attività di recupero in itinere all’inizio del pentamestre con risultati in molti casi
positivi.
2. ALTRE CONSIDERAZIONI
PROGRAMMA DI SCIENZE Classe VB Anno scolastico 2013/2014
GEOLOGIA
- I minerali: composizione chimica, struttura cristallina, proprietà fisiche, classificazione, processi
di formazione.
- Le rocce: processi litogenetici e classificazione delle rocce:
- Processo magmatico: dal magma alle rocce magmatiche intrusive ed effusive,
classificazione dei magmi, classificazione delle rocce magmatiche; origine dei magmi.
- Il processo sedimentario e le rocce sedimentarie clastiche, organogene e chimiche.
- Il processo metamorfico e le rocce metamorfiche: metamorfismo di contatto e
metamorfismo regionale, facies metamorfiche, classificazione delle rocce metamorfiche. Il
ciclo litogenetico.
- I fenomeni vulcanici: attività vulcanica, magmi, edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività
vulcanica. Fenomeni legati all’attività vulcanica. Vulcanismo effusivo ed esplosivo e relativi
effetti; distribuzione geografica dei vulcani; rischio vulcanico in Italia
- Fenomeni sismici. Teoria del rimbalzo elastico. Ciclo sismico. Le onde sismiche,
propagazione e registrazione; localizzazione dell’epicentro di un terremoto Le scale
sismiche. Effetti del terremoto; gli tsunami. I terremoti e l’interno della Terra. Distribuzione
geografica dei fenomeni sismici. Previsione e prevenzione del rischio sismico.
- La tettonica delle placche: la dinamica interna della Terra, struttura interna della Terra e
relativi metodi di indagine. Energia interna della Terra : flusso di calore e temperatura
interna della Terra.
- Il campo magnetico terrestre, la “geodinamo” e il paleomagnetismo La struttura della
crosta: crosta oceanica e crosta continentale; isostasia. La teoria della deriva dei continenti e
le prove a favore. Le dorsali oceaniche e le fosse abissali, espansione e subduzione.
Anomalie magnetiche sui fondi oceanici. La tettonica delle placche: le placche litosferiche,
loro movimenti e relativi effetti: espansione dei fondali oceanici, archi magmatici, fenomeni
orogenetici ;il ciclo di Wilson; verifica del modello della tettonica delle placche; moti
convettivi e punti caldi.
ASTRONOMIA
L’ambiente celeste: le costellazioni e la Sfera celeste, le distanze astronomiche. Le caratteristiche
delle stelle, magnitudine apparente e assoluta, spettri stellari, le nebulose. Evoluzione dei corpi
celesti : la fornace nucleare del Sole e delle altre stelle, il diagramma H-R, evoluzione delle stelle.
Le galassie e la struttura dell’Universo. Origine ed evoluzione dell’Universo: legge di Hubble ed
espansione dell’Universo, l’Universo stazionario, il Big bang e l’Universo inflazionario;
l’evoluzione futura.
Il Sole : struttura della stella e fornace
- nucleare, attività solare
- Le leggi di Keplero e di gravitazione universale
- : Caratteristiche generali dei pianeti gioviani e dei pianeti terrestri
- Il pianeta Terra: forma e dimensioni della Terra
- Le coordinate geografiche
- I movimenti della Terra : prove e conseguenze del moto di rotazione e del moto di
rivoluzione.
L’insegnante Gli alunni
B – PARTE DISCIPLINARE
1. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI ( da compilarsi per ciascuna materia)
1.1 MATERIA STORIA DELL’ARTE
�
1.2 DOCENTE
PAOLA CARMEN SALAMINO
1.3 LIBRI DI TESTO ADOTTATI
L’ARTE/CORRENTI,ARTISTI,SOCIETA’/ITINERARI DI LETTURA PARALLELI
DI ADORNO MASTRANGELO
1.4 ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’A.S.__2013_/_2014
(considerando n. 33 settimane di lezione)
n° ore ………… su n° ore ………. previste dal Piano di Studio
1.5 OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di competenze, abilità, conoscenze)
CONOSCENZE:1) L’allievo conosce i criteri di lettura dell’immagine
2) Conosce i prevalenti periodi storici, politici e religiosi
entro cui hanno operato alcuni grandi autori.
3) Conosce i vari movimenti artistici che si sono susseguiti
Dal 1800 al primo decennio del novecento
COMPETENZE : 1)GLI ALUNNI SANNO COGLIERE LE DIFFERENZE TRA I VA
RI STILI E LE DIVERSITA’ DI ESPRESSIONI NELLO STESSO
AMBITO PITTORICO,SCULTOREO E ARCHITETTONICO
2) SANNO VALUTARE UNA SERIE DI OPERE CONSIDERATE
NELLA LORO COMPLESSITA’ DI REALIZZAZIONI TECNICHE
3) UTILIZZANO IN MODO APPROPRIATO LA TERMINOLOGIA
SPECIFICA
CAPACITA’ : 1) L’ALUNNO,ATTRAVERSO PERCORSI SPECIFICI DI LETTURA
HA ACQUISITO LA CAPACITA’ DI CONTESTUALIZZARE STO-
RICAMENTE L’OPERA D’ARTE COMPIENDO CONFRONTI
COMPARATIVI
2) HA FINALIZZATO E MIGLIORATO LA SUA CAPACITA’ DI
ANALISI,SINTESI E CRITICA.
1.4 CONTENUTI (Allegare il programma svolto; indicare – se vi sono –
argomenti particolarmente approfonditi)
VEDI FOGLIO ALLEGATO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.5 METODI DI INSEGNAMENTO (lezione frontale, lezione interattiva,
lezione/discussione, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato, etc…
LE LEZIONI FRONTALI SONO STATE FREQUENTI E ALTERNATE A LEZIONI
GUIDATE DA UN’ALTERNANZA DI DOMANDE E RISPOSTE BREVI PER FAR
ACQUISIRE MEGLIO I CONCETTI DI BASE. LA RICERCA PERSONALE E IL LA-
VORO DI GRUPPO, HA CONTRIBUITO AMIGLIORARE L’APPRENDIMENTO DEGLI
ARGOMENTI DI STUDIO.
1.6 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO (Libri di Testo, Schede,
CD – ROM, audiovisivi, dispense, etc… - computer, videoproiettori, etc…)
E’ STATO PRIVILEGIATO L’USO DEL TESTO IN ADOZIONE, MA SONO STATI CONSULTATI
ANCHE I TESTI FORNITI DALLA BIBLIOTECA DI CLASSE E LA RICERCA PERSONALE DEI
DATI FORNITI DAL COMPUTER.
�
�
1.9 SPAZI (biblioteca, palestra, laboratori, aule speciali)
L’AULA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE FORNITA DI LIM, E’ STATA
SUFFICIENTEMENTE ADEGUATA PER LO STUDIO DI QUESTA DISCIPLINA
�
�
1.10 TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO
(possibilmente diviso in macrotematiche)
PRIMO QUADRIMESRE:DAL 1800 AL 1850 CIRCA
SECONDO QUADRIMESTRE DAL 1850 AL PRIMO VENTENNIO DEL NOVE-
CENTO
�
1.11 STRUMENTI DI VERIFICA (interrogazione, prova scritta tradizionale,
prova scritto-grafica, test, questionario, etc…)
SONO STATE EFFETTUATE VERIFICHE ORALI E SCRITTE ANCHE CON SCHEDE
SEMISTRUTTURATE. LE VERIFICHE SI SONO SVOLTE CON LA REGOLARITA’
PROGRAMMATA. PER LA VALUTAZIONE INTERMEDIA E SOMMATIVA, SI E’
FATTO RIFERIMENTO AI CRITERI GENERALI E ALLA TASSONOMIA ELABORATA
DAL COLLEGIO DEI DOCENTI TENENDO CONTO DEL METODO DI STUDIO,DEL
PROGRESSO RISPETTO AI LIVELLI DI PARTENZA, DELL’IMPEGNO PERSONALE
E DELLA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DELLA CLASSE.
1.12 ATTIVITA’ DI SOSTEGNO/RECUPERO – APPROFONDIMENTO –
RISULTATI OTTENUTI
L’APPROFONDIMENTO E’ STATO FATTO DURANTE LE ORE DI LEZIONE DEL
MATTINO. IMPORTANTE E’ STATA LA VISITA AI MUSEI E ALLE MOSTRE D’ARTE
�
�
2. ALTRE CONSIDERAZIONI
DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO ALL’ULTIMO MESE CHE PRECEDE L’ESAME,
LA CLASSE E’ STATA CARATTERIZZATA DA DUE GRUPPI DI ALLIEVI DIVERSI TRA
LORO PER IMPEGNO E PROFITTO. POCHI ALUNNI PROVENIENTI DA ALTRE CLASSI
CON ALCUNE CARENZE DI BASE E MODESTE CONOSCENZE DELLA MATERIA,
HANNO FATTO POCO PER RECUPERARE E ADEGUARSI AL LIVELLO COGNITIVO
DELLA MAGGIOR PARTE DEI COMPAGNI. L’ALTRO GRUPPO , INVECE, HA EVIDEN-
ZIATO UNA CERTA CRESCITA DI INTERESSE CHE HA PERMESSO DI CONCLUDERE
IL RICCO PROGRAMMA COSI’ COME ERA STATO STABILITO. CIO’ E’ STATO FAVO
RITO DALLA POSSIBILITA’ DATA AGLI ALLIEVI DI PROGRAMMARE IL PROPRIO
IMPEGNO CON SCADENZE CONCORDATE PERSONALMENTE CON LA CLASSE E DI
RELAZIONARE ALLA STESSA SUGLI STUDI INDIVIDUALI. ALUNNI E INSEGNANTI
HANNO CERCATO DI CURARE I PARALLELISMI PIU’ SIGNIFICATIVI TRA LE TEMA-
TICHE AFFINE PER OPPORTUNI COLLEGAMENTI TRA ALCUNE DISCIPLINE. I RISULTATI
OTTENUTI SONO MEDIAMENTE PIU’ CHE SUFFICIENTI,CON ESEMPI DI
BUONA COMPETENZA PER ALCUNI E DI ECCELLENZA PER ALTRI. DA UN PUNTO DI VISTA
COMPORTAMENTALE LA CLASSE SI E’ DIMOSTRATA RISPETTOSA, CORRETTA E
DISPONIBILE AD OGNI MIGLIORAMENTO. L’AZIONE EDUCATIVA HA MIRATO A FORNIRE
UNA METODOLOGIA PIU’ APPROPIATA E CONSAPEVOLE PER UN MAGGIORE
APPREZZAMENTO DEL VARIO PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE .
�
�
�
�
PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DLL’ARTE CLASSE QUINTA ANNO SCOLASTICO 2013/2014
L’OTTOCENTO ARCHITETTURA DEL PRIMO OTTOCENTO (CENNI) SCULTURA: CANOVA PITTURA : DAVID-GOYA I PURISTI, I NAZARENI,I PRERAFFAELLITI E LA SCUOLA DI BARBIZON (CENNI) GERICAULT E DELACROIX COURBET,MILLET E DAUMIER I MACCHIAIOLI: FATTORI, LEGA E SIGNORINI GLI IMPRESSIONISTI: MANET,MONET,RENOIR E DEGAS IL DIVISIONISMO E IL PUNTINISMO(CENNI): SEGANTINI E SERAUT IL POST IMPRESSIONISMO: CEZANNE,GAUGUIN E VAN GOGH SCULTURA: CECIONI,MEDARDO ROSSO E VINCENZO GEMITO
IL NOVECENTO LE AVANGUARDIE- IL LIBERTY: KLIMT E GAUDI’ IL FAUVISMO:MATISSE E DERAIN CUBISMO:PICASSO E BRAQUE ESPRESSIONISMO: ENSOR E MUNCH IL PONTE:KIRCHNER IL CAVALIERE AZZURRO:KANDINSKI IL FUTURISMO:BOCCIONI E BALLA E SANT’ELIA IL DADAISMO:DUCHAMP E PICABIA LA PITTURA METAFISICA: DE CHIRICO E CARRA’ IL SURREALISMO: MIRO’, MAGRITTE E DALI’ ASTRATTISMO: LARINOV, MONDRIAN E MALEVIC LA SCUOLA DI PARIGI: MODIGLIANI E CHAGALL
L’INSEGNANTE GLI ALUNNI ---------------------------------- ------------------------------------ -------------------------------------
�
Pagina 1 di 3
B – P A R T E D I S C I P L I N A R E
1. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI Classe 5a sez. B
1.1 MATERIA: EDUCAZIONE FISICA
1.2 DOCENTE: Prof. Querci Rita
1.3 LIBRI DI TESTO ADOTTATI: In perfetto equilibrio – D’Anna - Firenze
1.4 ORE DI LEZIONE effettuate nell’a.s. 2013-2014 n°ore
1.5 OBIETTIVI RAGGIUNTI in termini di:
COMPETENZE:
Sanno utilizzare le conoscenze teoriche acquisite per ottenere un buon condizionamento muscolare e
migliorare le capacità motorie.
Sono in grado di utilizzare le attrezzature ed eseguire tecniche sportive.
Sono in grado di praticare il gioco di squadra nei vari ruoli.
ABILITÀ:
Gli alunni sanno organizzare un percorso didattico tenendo presente i vari contenuti fondamentali di
una lezione.
CONOSCENZE:
Nel corso dell’anno gli alunni hanno acquisito le conoscenze proprie della materia relativamente a:
a) importanza dell’attività motoria come strumento di benessere
b) conoscenza delle principali attività sportive e relativi regolamenti (Pallavolo, Pallacanestro,
Pallamano, Pallatamburello e Badminton)
c). Il sistema nervoso centrale e periferico. Le qualità motorie: forza, velocità, resistenza, mobilità. Il Basic Life Support.
Pagina 2 di 3
1.6 CONTENUTI DISCIPLINARI e tempi di realizzazione esposti per: Unità didattiche Moduli e/o Percorsi formativi Eventuali approfondimenti
U. D. – Modulo – Percorso Formativo – Approfondimento Periodo/ore
Corsa a ritmo uniforme e variato. 1° quadrimestre
Esercizi di potenziamento, velocità e resistenza. 1° e 2° quadrimestre
Tecnica di corsa salti e lanci. 1° e 2° quadrimestre
Esercizi di stretching. 1° e 2° quadrimestre
Andature in circuito. 1° e 2° quadrimestre
Organizzazione di giochi di squadra. Affidamento, a rotazione, di compiti di giuria 1° e 2° quadrimestre
ed arbitraggio.
Ripetizione ed automatizzazione delle varie tecniche. Propedeutici di giochi sportivi. 1° e 2° quadrimestre
Partite e tornei dei seguenti sport: Pallavolo Pallamano Palla tamburello Pallacanestro e Badminton 1° e 2° quadrimestre
Teoria: Sistema nervoso centrale e periferico. Qualità motorie: forza, velocità, resistenza, potenza.
1° e 2° quadrimestre Numero ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico
1.7 METODO DI INSEGNAMENTO: (Lezione frontale, lezione interattiva, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato, ecc.)
Esecuzione di esercizi semplici. Aumento di difficoltà.
Esercitazioni collettive.
Alternanza dei metodi prescrittivo, deduttivo ed induttivo secondo le necessità.
1.8 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO (libri di testo, schede, CD ROM, audiovisivi, dispense, computer, video-proiettori, ecc.)
Suolo e pareti.
Piccoli e grandi attrezzi.
Attrezzi specifici dei singoli sport.
Libro di testo e CD rom
Pagina 3 di 3
1.9 SPAZI (Biblioteca, Palestra, Laboratori, Aule speciali)
Palestra dell’istituto.
1.11 STRUMENTI DI VERIFICA (Interrogazione, prova scritta tradizionale, prova scritto-grafica, test, questionario, prove di laboratorio, verifiche orali ecc.)
Rilevamento oggettivo delle capacità motorie tramite l’osservazione dell’esercizio e della sua esecuzione.
Importanza del livello di motivazione, dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione attiva mostrata
Esercitazioni generali ed allestimento di partite.
Test a risposta multipla. Discussione.
1.12 ATTIVITA’ DI SOSTEGNO / RECUPERO E APPROFONDIMENTO
In itinere vengono seguiti individualmente e supportati alunni che incontrano difficoltà o che presentano un vissuto motorio carente, facendo loro eseguire esercizi mirati.
2. Altre considerazioni
• ____________________________________________________________________________________
• ____________________________________________________________________________________
• ____________________________________________________________________________________
Montecatini Terme, 07/05/2014 Firma del docente
Liceo “COLUCCIO SALUTATI” di Montecatini Terme
Materia: Educazione fisica Insegnante: Querci Rita
Programma effettivamente svolto nella classe 5°B
Anno scolastico 2013 - 2014
Parte pratica
Corsa a ritmo lento (8 – 10 minuti )
Esercizi di riscaldamento, di attivazione generale e di preatletismo.
Esercizi di coordinazione neuro-motoria, di destrezza e di agilità.
Esercizi di mobilizzazione articolare e di bonificazione muscolare a carico naturale; esercizi di
estensibilità ( stretching ) e di rilassamento.
Pagina 4 di 3
Uso polivalente dell’attrezzo palla con applicazioni ed adattamenti alle più note discipline sportive.
Pallavolo: propedeutici dei fondamentali individuali ( palleggio, bagher, battuta, schiacciata, muro )
e di squadra ( schemi di ricezione e prove di diverse situazioni di giuoco ).
Pallamano: propedeutici dei fondamentali individuali ( palleggio, passaggio, tiro in appoggio e in
elevazione ) e di squadra ( schemi di attacco e di difesa, prove di diverse situazioni di giuoco
).Giuochi propedeutici ai fondamentali di giuoco ( palla al re, ecc. )
Palla tamburello: fondamentali individuali e di squadra.
Pallacanestro: propedeutici dei fondamentali individuali ( palleggio, passaggio, arresto, tiro, virata,
ecc.) e di squadra ( dai e vai, dai e segui, difesa a uomo, ecc.). Partite di tre contro tre.
Badminton: tiri di diritto e di rovescio, battuta.
Parte teorica
Anatomia e fisiologia del sistema nervoso centrale e periferico.
Le qualità motorie: forza, velocità, resistenza, mobilità.
Montecatini Terme 07-05-2014
Gli alunni L’insegnante
���������������������������� ����������
�
�
��� ���������� �� ���������������
�
�
���� �� �����
� ��������������������
�
�
���� ��� � ���
� �������������������������
�
�
���� ������ �����������
� ����������������� ���������������������!���"�#����������������������
�
�
���� �� ���� ��� � �� �� �� ������������������
� ����$%������������&&�����'��(�����"���'�����"�����"���
�
�
���� �� ���������
� ��������#�)� *��� ������� ���������� ������� ��"�� "��� "�+������� �������� ���� ������� �� ���"��
������'��������
� �+����,)�*���������������)�
� -����������������(������"���.�����������'�������������������+����"���'�����������������/��
� -���"�(�"������.�''�����"��������������������.�������#�����"���(������"�����(�(��#���"���������
���'�����"�����"�������#�/�
� -���������������������"����������"��������������������,��������������(�������������
� ���'����#�)�*�����������������(�"��#�������"��������+�������'����,�"�����������������������
"����������������������+���#�������"���''�����"�������'����������
���� ��� �������
� -���������������� �����������������0�����������
���������� ��"����������������"��������������
���������� ����"��������������������������"���.����'����
��������-������������������������������������"�������,�������"�����,��
�����������"���������������
� -������������ ��������� ����������"�����'����� �����������������'������
����������� ������������������������'�'�����+�������"��������������������������"���������
�����������������.������"��������(�(��#�������������������
�
�
�
���� � �������� ���� ���
� 1���"����"����(���
� �#�����"����������
� ��������������"�����
� �������������''���
�
�
�
�� � � ��� ����� �����������
� ������ ��� �"�#����/� ������ �����/� "��������� "��� ���������/� ��(����� �'������������/� ����������
��"��(���(��'������ 1��
�
�
�
��!� ���� ����� ������
� 0����������������
�