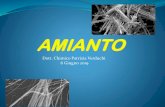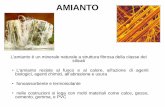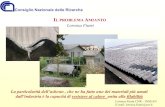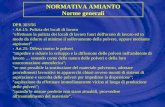Amianto: antropologia
Click here to load reader
-
Upload
olinpino -
Category
Health & Medicine
-
view
76 -
download
0
description
Transcript of Amianto: antropologia

1
1
Antropologia dell’amianto Daniele Agostini
Università degli Studi di Modena e Reggio EmiliaScuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
L'amianto e l'uomo: scoperta, paura, cultura e potere in una lotta che non è tra la natura e l'uomo ma tra alcuni uomini contro natura e tutti gli altri
2
2
Indice
• L’amianto c’è• La percezione del rischio• Il potere• Le leggi• Etica?• BAN!
In questa presentazione verranno delineati alcuni aspetti dell'evoluzione del rapporto tra l'amianto e l'Uomo, il passaggio di questo rapporto dalla sfera individuale a quella collettiva, attraverso le dinamiche del potere e del progresso civile e sociale. È una storia da raccontare, che se stupisce non è per la novità dei contenuti o la varietà degli attori: son tutte cose che conosciamo bene; ma per l'abisso che ancora si frappone tra la scelta da fare e la decisione di chi deve farla.
3
3
L’amianto c’è
È belloÈ comodoCosta pocoHa mercato
È facile da usare
coperture,canne fumarie,condotted'acqua,mattonelle perpavimentazioni,guarnizioni dicaldaie,rivestimenti ditubazioni,rivestimentiantifiamma,insonorizzanti ecoibentiapplicati aspruzzo susoffitti econtrosoffittiecc..
L'amianto preesiste all'uomo e forse è stato uno degli infiniti fattori lesivi dell'ambiente su ogni forma vivente; i depositi naturali labili sono stati dispersi e stabilizzati nei milioni di anni, quelli stabili sono stati stabilizzati dalle sedimentazioni della superficie terrestre. La scoperta del minerale da parte dell'Uomo ha permesso di sfruttarne le proprietà in scala assai limitata fin da quella che chiamiamo antichità.La diffusione delle fibre nell'ambiente umano si può considerare trascurabile fino a 200 anni fa. La rivoluzione industriale ha cambiato le cose.

4
4
L’amianto c’èL’amianto e la cellula• Non è metabolizzabile• È diffuso dalle cellule
meno fragili• Distrugge quelle più
fragili• Trasforma quelle che
resistono
L'azione dell'amianto sulle strutture biologiche dipende dalla sua particolare conformazione che è a livello microscopico uguale a quella macro (encapsi); le punte delle particelle submicroscopiche di amianto non hanno uno spessore discreto essendo ancora disarticolabili in fibrille fino al livello molecolare. Questa struttura consente un contatto tra il minerale e l’ambiente biologico che è simile a quello di un liquido, enormemente più esteso di quello di un solido normale; la sua stabilità eccezionale non ne consente una rapida neutralizzazione. Non è ancora chiarito il meccanismo lesivo della fibra minerale nella cellula. minerale rende improprio il termine "chimico" per la categoria di tossicità a cui riferirlo: si tratta di una sturuttura che può determinare danno fisico da penetrazione meccanica e rottura di organuli biologici, con capacità di produrre danno diretto a livello genetico.
5
5
L’amianto c’èDell’amianto sappiamo che
Si conosce da oltre 2000 anni la sua capacità di resistere alfuoco.L'uso industriale è cresciuto dagli ultimi decenni del 1800.I suoi danni alla salute sono noti dai primi decenni del 1900.La produzione di manufatti in amianto si riduce della metàdagli anni '80.Ormai è dappertutto.È un cancerogeno certo per l'uomo, senza un valore soglia.I tumori da amianto faranno moltissime vittime nei prossimidecenni.
Tutte le forme dell'amianto sono classificate dallo IARC nella classe 1 dei cancerogeni: cancerogeni certi per l'uomo.Le vittime previste nei prossimi anni sono da 30.000 a 50.000 in Europa.
6
6
La percezione del rischio
L’amianto fa paura• Fa vivere e morire.• È inquietante.• Va esorcizzato• La paura si supera
giocando col pericolo
I lavoratori dell'amianto sapevano che l'amianto uccide; vedevano ammalarsi e morire colleghi, amici e parenti; ma gli operai delle cave e dei comparti a rischio erano inermi di fronte al pericolo.La paura dominava e esasperava i rapporti tra le persone, sfociando in atti di iniziazione violenta con esposizioni massicce.

7
7
La percezione del rischio
La cava, la fabbricaLa percezione di molti anticipa le conoscenze scientifiche.Il lavoratore è diviso fra la coscienza di un lavororischioso e la necessità di lavorare.Nessuno lo aiuta a scegliere.La malattia è mortale, ma lontana nel tempo.L’amianto è utile, è naturale, aiuta a vivere…La consuetudine col pericolo fa dimenticare il rischio.
La conoscenza scientifica dei danni da asbesto segue all'osservazione empirica, ma è presto acquisita; tuttavia l'industria non affronta i costi di una ristrutturazione e della protezione dei lavoratori
8
8
La percezione del rischio
• I lavoratoridell’amiantosanno che diamianto si muore
• Gli scienziati losanno
• La società lo sa
International LabourOffice: Occupation andHealth, 1930, pag. 190:“Tutte le manipolazionidell’amianto… implicanoun rischio notevole e lecompagnie assicurativenon accettano i lavoratoridell’amianto…”
L'Enciclopedia dell'ILO del 1930 documenta le riserve delle società di assicurazione nel coprire i rischi dei lavoratori dell'amianto. Questo vuol dire due cose: da una parte che il rischio era noto e valutato, dall'altra che non c'era l'attenzione a rimuoverlo.
9
9
La percezione del rischio
Le FS no?“[I lavoratori], dopo un lungo periodo di
completa non conoscenza del rischio (daglianni 50, periodo in cui le F.S. decisero diimpiegare massicciamente l’amianto comecoibente termo-acustico, fino alla metà deglianni ‘70) in seguito ad alcune morti dilavoratori… si sono mobilitati…”
(A. Alberelli, Conf. Naz. Amianto, 1999)
L'Enciclopedia dell'ILO del 1930 documenta le riserve delle società di assicurazione nel coprire i rischi dei lavoratori dell'amianto. Questo vuol dire due cose: da una parte che il rischio era noto e valutato, dall'altra che non c'era l'attenzione a rimuoverlo.

10
10
Morti per mesotelioma(da Biocca M. et al., 1999)
0100200300400500600700800900
1970 1980 1990
MaschiFemmine Totale
M o r t i i n E m i l i a R o m a g n a t r a i l 1 9 8 8 e i l 1 9 9 2 m a s c h i = 1 7 6f e m m i n e = 8 4
i n m e d i a 5 2 o g n i a n n oRapporto ISTISAN 96/40
Italia
I morti della tabella pagano per esposizioni di 15-40 anni prima: si tratta di tempi in cui le conoscenze sui rischi da amianto erano ormai inconfutabili.
11
11
Fattori che influenzanola percezione del rischio
• il potenziale catastrofico• la conoscenza abituale• la comprensione del
fenomeno• l’incertezza degli esperti• la controllabilità• l’equità• i benefici
• la volontarietà• gli effetti sui bambini• gli effetti sulle generazioni
future• l’identità delle vittime• la paura• la fiducia nelle istituzioni• l’attenzione dei media
(da Biocca M. et al., 1999)
Molti fattori influenzano la percezione del rischio. Alcuni sono elencati nella tabella.
In particolare va ricordato che, a differenza degli esperti che valutano prevalentemente gli elementi obiettivi immediatamente determinati, le persone non esperte e direttamente coinvolte considerano con particolare peso le possibili conseguenze catastrofiche o che si manifestano in modo non equo, o sulle future generazioni.
12
12
Fattori che influenzanola percezione del rischio
• Rischio sconosciuto• Rischio che incute
paura
È possibile considerare aspetti della percezione del rischio legati al grado di conoscenza del pericolo e della paura che incute: sappiamo che gli esplosivi sono pericolosi ma non li temiamo molto, se crediamo che siano ben gestiti; poco sappiamo dei rischi dei campi elettrici degli elettrodomestici, ma noi dominiamo le macchine e così non ci fanno paura. Tutti conoscono i pericoli della strada e del fumo, ma ognuno li vive con tranquillità. Temiamo invece, senza certezze in proposito, le antenne della telefonia cellulare, gli OGM e i germi spaziali o dei fondi oceanici, che sfuggono al nostro controllo.Questi aspetti diventano importanti nel momento che si propongono interventi di prevenzione perché saranno efficaci solo se accetati da tutti gli interessati e solo se tutti riconoscono il pericolo e condividono la percezione del rischio. In questo campo l’opinione degli esperti sul rischio è molto lontana da quella degli operatori, che non conoscono, sottovalutano o trascurano il pericolo.In queste condizioni è prioritario l’impegno per la comunicazione del rischi per migliorarne la percezione.

13
13
Il potere
La soluzione• Una soluzione
accettabile: Rischiozero per lavoratori eabitanti
• Un’altra soluzioneNON C’È
Questo è un obiettivo della società di oggi.Chi non lo vuole?Il massimo produttore mondiale di amianto è il Canadà, che si è visto chiudere di fatto tutti i mercati degli Stati Uniti e dell’Europa Occidentale. Il secondo produttore mondiale è il Sud Africa; il massimo importatore, dopo la rinuncia degli Stati Uniti, è il Giappone. Il problema economico del Canadà non sarebbe grandioso: gli addetti alla produzione di amianto sono circa 1600 (dato 1999) e l’esportazione fornisce un cespite non fondamentale per la comunità canadese. Certo, la dismissione delle cave ha un prezzo, come ben sappiamo noi, che paghiamo per la dismissione della cava di Balangero, la più grande d’Europa.
14
14
Il potere
Lo Stato: che c’entra?• Equilibrio tra interessi
contrapposti• Definizione di valori
condivisi• Garanzia dell’affermazione
dei valori prioritariNO?
Lo Stato è il sistema moderatore degli squilibri, attraverso la solidarietà e la difesa delle classi deboli.Definisce i valori condivisi e gli strumenti per affermarli.I valori condivisi sono la chiave del prevalere dei diversi interessi in giocoÈ il garante negli scontri tra interessi contrapposti.
15
15
Il potere
Chi vuol giocarecoll’amianto?
•Chi non sa difendersi perla scarsa coscienza delproblema•Chi non sa sottrarsi permotivi economici
I Paesi poveri
L’Asbestos Institut è un’emanazione dell’industria amiantifera sostenuta dal governo canadese, che promuove l’uso sicuro del crisotilo e contrasta le iniziative unilaterali degli Stati che proibiscono l’importazione. Massimo produttore mondiale, il Canadà non contrasta le pressioni dell'industria amiantifera, che cerca di invalidare le norme restrittive poste dai consumatori storici: i paesi ricchi dell'occidente. Dopo il blocco delle importazioni, disposto con norme dagli Stati, su pressione delle comunità per i rischi che si sono resi evidenti, le rappresentanze canadesi negli organismi internazionali hanno cercato di proporre obiezioni diverse: sotto il profilo della sicurezza del lavoro e dell'ambiente, ma anche sotto l'aspetto della liceità di un blocco unilaterale in un regime di libero scambio (WTO). Anche l’Italia è stata denunciata al WTO per questo motivo.Dopo li rifiuto dell'Occidente, le esportazioni si dirigono verso il Terzo Mondo. Anche il Giappone continua a importare.

16
16
Le leggi
Legge 27 marzo 1992n. 257:
• Fine dell'amiantocome materiale utilenella storiadell'uomo
• L’amianto èfuorilegge
D.Lgs. 277/91e L.257/92:
il quadro normativopiù avanzato al
mondo: divieto diestrazione ed uso,regolamentazionedella dismissione
La Legge del 27 marzo 1992 n. 257 dispone:In Italia l'amianto non può più essere estratto dalle miniere o utilizzato per produrre manufatti. Tutto quello che si trova attualmente in circolazione e che può liberarsi nell'ambiente deve essere eliminato. La prima legge al mondo a regolare la dismissione dell'amianto e dei suoi prodotti
17
17
Le leggi
• Ord. Min. San 26.6.86• DPR 215/88• D.Lgs. 277/91
Dopo moltissimi anni di inedia, la legislazione italiana (ma non solo) si affretta a compiere passi lunghi per porre rimedio a una situazione che si è dimostrata grave.Dalle prime Restrizioni (Ord min san 26.6.86: “Restrizione all’immissione sul mercato e all’uso della crocidolite e dei prodotti che la contengono, DPR 21/5/88: estensione a tutti i tipi di amianto e a molte applicazioni, prima di tutto ai giocattoli, poi nei rivestimenti a spruzzo, nelle vernici ecc.).Un D.Lgs (277/91) interviene a tutela dei lavoratori: recepisce la Dir.CEE 83/477 (protezione dei lavoratori contro i rischi fisici, chimici e biologici), con 8 anni di ritardo. Istituisce la vigilanza sui piani di lavoro. Per gli aspetti previdenziali l’asbestosi era già tutelata nella L.780/75; una norma diversa (DPR 336/84) regola la materia per i tumori delle sierose da asbesto
18
18
Le leggi
• Ord. Min. San 26.6.86• DPR 215/88• D.Lgs. 277/91• L. 257/92
La L. 257/92 proibisce, dall’aprile 94, l’uso, la produzione, il commercio e, unilateralmente, l’importazione di amianto. Modificata dalla L.271/93 per aspetti di previdenza.La legislazione tratta: tutela dei lavoratori, agevolazioni alle imprese, tutela dell’ambiente, della salute pubblica, smaltimento dei rifiuti, sicurezza dei materiali sostitutivi, controllo delle attività di bonifica.

19
19
Le leggi
• Ord. Min. San 26.6.86• DPR 215/88• D.Lgs. 277/91• L. 257/92• DM 6.9.94• DM 26.10.95• DM 14.5.96• DM 20.8.99
DM 6.9.94: valutazione del rischio e interventi sulle strutture edilizie; DM 26.10.95: rischio e intervento sui mezzi rotabili; DM 14.5.96: i siti industriali dismessi, gli impianti, i laboratori di analisi dell’amianto;DM 20.8.99: interventi sulle navi
20
20
Le leggila Regione
Delibera n. 497/1996del Consiglio Regionaledell'Emilia- Romagna:“Piano regionale”
Quasi tutte leRegioni hannodeliberato inmateria diamianto, secondoil dettato dellaL.257/92
Il Consiglio Regionale dell'Emilia-Romagna, con delibera n. 497/1996, ha avviato il "Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", per:- conoscere e dimensionare la diffusione del problema amianto (censimento),- addestrare gli operatori dei servizi di prevenzione, istruire i lavoratori delle aziende che verranno autorizzate ai compiti di bonifica, - individuare i siti dove smaltire i residui contenenti amianto, - avviare campagne epidemiologiche per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti. Di questo parlerà la relazione seguente.
21
21
Le leggiAllora, tutto bene!
Fondi previsti per i piani (art.10)• erogati in ritardo e solo parzialmente• persi (“perenzione”)Sistema informativo• evasione dell’autonotifica di depositi• evasione della denuncia di malattie professionaliSistema previdenziale• insufficiente definizione• copertura “quantitativa”
Non scherziamo!
Criticità
Di 24 GL previsti per il 92-94 5 sono stati erogati dal 96, 16 sono andati in perenzione.Su 21, 15 piani sono stati approvati, 14 censimenti sono avviati (metà 99). Il sistema informativo è ancora inadeguato per la scarsa risposta al censimento e alla sorveglianza degli esposti; i registri dei mesoteliomi stentano a partire in diverse Regioni Benché modificata per gli aspetti più problematici, la L.257 non ha saputo far partire la contribuzione suppletiva a favore degli esposti: i titolari pagavano “a numero” alcuni contributi che ridistribuivano sui diversi operatori esposti. Si è sviluppato un contenzioso che è ancora crescente a diversi anni dalla legge (Bianchi M, Conf Naz Amianto 1999).La ricostruzione oggi delle esposizioni pregresse per l’applicazione dei benefici previdenziali previsti dall’art. 13 L.257/92 presenta grandi difficoltà di tipo documentale ed etico, in carenza di indicazioni certe e omogenee (Cottica D, ibid)

22
22
Le leggiAllora, tutto bene!
CostiI finanziamenti previsti per la bonifica sonoassolutamente insufficienti anche solo per partireEstensione• Depositi minori in numero indefinibile e grandissimo• Dispersione abusiva e accidentaleSorveglianza degli esposti•La L.257 non prevede la copertura di questi costi
Non scherziamo!
Criticità
La bonifica ha un costo spaventoso in continua crescita, che si può stimare oggi nell’ordine dei 2000 miliardi, a carico della pubblica amministrazione L'esigenza condivisa di bonificare l'ambiente comporta l'assunzione dell'onere, non essendo più possibile mettere in atto un recupero presso i beneficiari del reddito industriale e commerciale dell'amianto. I finanziamenti previsti dalla 257 sono assolutamente modesti e propongono gravi problemi etici e di definizione di priorità d’intervento (Comba et al, Conv Naz Amianto, 1999) Una direttiva del ministero della sanità (no. 98) delibera uno stanziamento per una ricerca preliminare su modelli di sorveglianza nei lavoratori già esposti a cancerogeni in genere. (Benedettini L., Conf Naz Ami). Peraltro la disposizione
23
23
Le leggiAllora, tutto bene!
“Dal 1994, dopo la promulgazione dellaLegge 257..., è iniziata la lunga fase digestione del rischio rappresentato dallaingente quantità di materiali di amianto...tuttora in opera…Con i materiali di amianto in opera dovremoconvivere a lungo, prima di potercene liberaredefinitivamente.” (M. Mariotti, 1999)
Non scherziamo!
24
24
Etica?
• La responsabilità dell’amianto nella malattiaumana era nota dal 1920, e forse prima,all’industria e ai suoi dirigenti.
• Anche i costi della bonifica tolgono risorseall’assistenza, all’ambiente, alla cultura, allaricerca, alla collaborazione internazionale;anche alla giustizia.
Non eccedere le norme volta a volta vigenti in materia di protezione dei lavoratori, in presenza di informazini certe sulla lesività delle lavorazioni, rappresenta una scelta di campo nei valori, la definizione di una cultura -che dispiace chiamare padronale- basata sulla sottovalutrazoione del benessere della salute e della vita degli altri per asservirli all'avidità economica.La responsabilità dell'industria non si limita comiunque a l danno sanitario ai dipendenti e alla collettività arrecato colle lavorazioni e colla distribuzione di prodotti con amianto. La loro responsabilità comprende il costo, economico, ambientale e umano, della demolizione del mondo fibroso che essi hanno costruito. Non si possono considerare esonerati dalla partecipazione piena a questi costi, ancorché inizialmente la coscienza lesiva fosse poco definita (a inizio secolo).Tuttavia non consta che alcun contributo venga dall'industria per il recuopero dei danni già arrecati.

25
25
Etica?
• Il D.Lgv 502/92 (art. 14) inserisce “le attivitàdi prevenzione delle malattie” tra i diritti deicittadini e non tra le prestazioni.
Non eccedere le norme volta a volta vigenti in materia di protezione dei lavoratori, in presenza di informazini certe sulla lesività delle lavorazioni, rappresenta una scelta di campo nei valori, la definizione di una cultura -che dispiace chiamare padronale- basata sulla sottovalutrazoione del benessere della salute e della vita degli altri per asservirli all'avidità economica.La responsabilità dell'industria non si limita comiunque a l danno sanitario ai dipendenti e alla collettività arrecato colle lavorazioni e colla distribuzione di prodotti con amianto. La loro responsabilità comprende il costo, economico, ambientale e umano, della demolizione del mondo fibroso che essi hanno costruito. Non si possono considerare esonerati dalla partecipazione piena a questi costi, ancorché inizialmente la coscienza lesiva fosse poco definita (a inizio secolo).Tuttavia non consta che alcun contributo venga dall'industria per il recuopero dei danni già arrecati.
26
26
BAN
Rete per la messa al bando dell’amiantoBan Asbestos network è nata dadiverse associazioni, sindacatied esperti che operano alloscopo di mettere al bando1'amianto e di verificarel’effettiva attuazione deldivieto di impiego dove già ildivieto esiste
Ban Asbestos network è nata a S. Paolo del Brasile raggruppando diverse associazioni, sindacati ed esperti che operano nelle loro nazioni allo scopo di mettere al bando 1'amianto in tutte le sue forme, oppure se già esiste il divieto di impiego, di verificare la sua effettiva attuazione.Ban Asbestos Europa interviene soprattutto nei confronti della Comunità europea al fine di omogeneizzare ed estendere a tutti i paesi dell'Unione Europea la legislazione di divieto dell'impiego di amianto, di immissione in commercio di sostituti sicuri, di provvidenze per i lavoratori e le imprese, ecc.Il discorso sembra ben avviato, si presume che presto verrà emanata una direttiva in tal senso. Le difficoltà sorte nel frattempo sono dovute alla pressione delle multinazionali dell'amianto, dell'Istituto dell'Amianto con sede in Canadà, che tentano ancora una volta di fare la distinzione fra tipi di amianto. Distinguono 1'amianto cattivo (crocidolite e anfiboli in generale), da quello buono (crisotilo), cercando di far passare 1'idea che questo può essere utilizzato in modo sicuro.In effetti la commissione scientifica che è stata insediata nell'UE è di un

altro parere e lo sono la gran parte degli studi fino ad oggi realizzati, compreso il più recente (J Peto e altri) che prevedono per i prossimi 35 anni nell'Europa occidentale un livello di mortalità per mesotelioma pari a 250.000 persone. Ban Asbestos insiste per la messa al bando totale di tutti i tipi di amianto, per la sicurezza dei sostituti, soprattutto per 1'eliminazione di qualsiasi livello di soglia superiore allo zero.Fulvio Aurora, Ban Asbestos Network, Milano(La lotta per la messa al bando dell’amianto in Europa e nel mondo, I Conferenza Nazionale sull’amianto, Roma, 1999)
27
27
Il censimento
Progetto di scalaregionale:
Conoscere perprevenirePIANO REGIONALEDI
PROTEZIONEDALL' AMIANTO
STOPAMIANTO
Togliamocelo dalla
testa
Le iniziative della Regione Emilia Romagna saranno presentate da