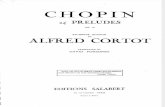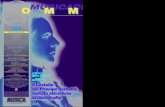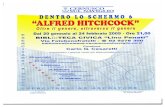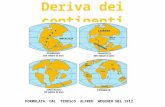Alfred Jarry e la Patafisica
-
Upload
claudio-carli -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
description
Transcript of Alfred Jarry e la Patafisica

Francesco Lamendola
IL TEATRO DI ALFRED JARRY
FRA PARADOSSO E RIVOLTA
Alfred Jarry (1873-1907) fu uno scrittore eccentrico fino alla sregolatezza e allo scandalo, fino alla morte per alcolismo. Mentre l'Europa celebrava i fasti della "belle époque", il teatro grottesco di Jarry denunciava senza posa le ipocrisie, le assurdità, le feroci violenze mascherate dalle buone maniere della società borghese, di cui fu un critico spietato ed esilarante. Il suo esperimento teatrale e letterario, radicalmente innovativo anche sul piano linguistico, fonde i toni popolareschi alla Rabelais con quelli surrealisti e dadaisti, e culmina addirittura nell'invenzione di una nuova "scienza": la patafisica. Una scienza solo in parte burlesca, definita come "la scienza delle soluzioni immaginarie", il cui fine è "lo studio delle leggi che regolano le eccezioni". La sua opera teatrale più nota, e quella che gli diede un successo di scandalo, è il dramma (o la commedia?)"Ubu re" ("Ubu roi"), del 1896, cui farà seguito, nel 1900, "Ubu incantenato" ("Ubu enchaîné"),
1

feroce parodia del potere, realizzata mediante la sistematica deformazione grottesca e lo stravolgimento verbale anarchico e volutamente enigmatico.
Quello che segue è un estratto della conferenza tenuta dal prof. Francesco Lamendola per il Gruppo teatrale degli studenti dell'Istituto Superiore Statale "Marco Casagrande" di Pieve di Soligo, il giorno 16 febbraio 1998.
IL TEATRO DI A. JARRY FRA PARADOSSO E RIVOLTA
1. PATAFISICA DEL GESTO ESEMPLARE.
È il primo novembre del 1907. Parigi sembra raccogliersi nella grigia pensosità dell'autunno incipiente: foglie che cadono sugli Champs Elisées, frusciando dolcemente; ultimi bagliori di un tramonto dorato, carichi di nostalgia per la calda stagione che è ormai soltanto un ricordo… Un uomo sta morendo nel suo letto d'ospedale. Sa di esser giunto alla fine; sa che per lui non ci sarà un'altra estate. Prima di spirare, si protende con fatica e chiede… uno stuzzicadenti! Difficile aver voglia di recitare una commedia proprio in punto di morte, non è vero? Ma allora, cosa diavolo avrà voluto dire quel poveraccio, quel semi-barbone alcoolizzato all'ospedale della Carità, dove vanno a spegnersi tutti i falliti e tutti i rifiuti della grande capitale europea? A cosa avrà voluto alludere, chiedendo quale ultimo desiderio uno stuzzicadenti, per poi scivolare nel trapasso con aria di ineffabile beatitudine? Dal momento che matto non era e nemmeno un barbone qualsiasi, ma il celebre (anzi, l'ormai ex-celebre) scrittore Alfred Jarry.
& & & & &
Si dice che il momento della morte sia anche, per definizione, il momento della verità: difficile mentire proprio lì. In genere, i filosofi e gli uomini di pensiero, gli intellettuali che hanno voluto o creduto di portare un messaggio all'umanità, muoiono in maniera coerente con la loro vita: cercano perciò di riassumere in un gesto, in una frase esemplare, l'intero messaggio della loro vita. Gesù Cristo, spirando sulla croce, volle citare un'ultima volta le Scritture: "Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?" (Salmo 21).
2

Socrate, secondo la testimonianza tramandata dal Fedone del suo discepolo Platone, prima di bere la cicuta volle intrattenersi con gli amici più intimi, parlando a lungo, con sublime distacco, dell'immortalità dell'anima. L'imperatore Augusto chiuse gli occhi nel sonno eterno dopo aver chiesto agli astanti (secondo le Vite dei dodici Cesari di Svetonio) se fosse loro sembrato che egli avesse ben recitato la commedia della vita; e pregandoli, in caso affermativo, di applaudire l'attore. Ed ora torniamo a Jarry, e al suo stuzzicadenti. Cosa avrà voluto dire, simbolicamente (e il debito di Jarry col Simbolismo è stato giustamente sottolineato dai critici)? Si direbbe che, per Jarry, il "gesto esemplare" soggiacia anch'esso alle leggi della Patafisica, la scienza dell'Universo irreale. Che non è "metafisica", perché non sta oltre la fisica; né "parafisica", perché non le si pone accanto; è qualcos'altro, ma al tempo stesso è consustanziale alla fisica. Qui cogliamo l'assoluta, commovente coerenza di Jarry: ribelle davanti alla morte, come lo era stato per tutta la sua breve vita (trentaquattro anni) davanti agli uomini. E qui cogliamo, sintetizzati al massimo, i due caposaldi della sua intera poetica: il paradosso e la rivolta. Il paradosso: perché, se la società borghese è paradossale, anche la morte, nel contesto di essa, non potrà essere che paradossale (per dirla col Laing: "in un mondo anormale, schizofrenico è chi non sa reprimere i suoi impulsi normali"). La rivolta: infatti, vivere veramente è chiedersi sempre "perché", strappare la maschera dell'inautenticità e della retorica, del moralismo, del conformismo, del perbenismo. Ecco, dunque, il senso della "missione" di Jarry: mettere in crisi le certezze dei benpensanti e anche le proprie: dal momento che, in fondo a ognuno di noi, si annida un benpensante, cioè un conformista. Il conformismo è, si potrebbe dire, la morte dell'anima (cfr. il messaggio del professor Keating ai suoi alunni nel film L'attimo fuggente di Peter Weir). Dunque, in un certo senso Jarry "voleva" morire per poter essere veramente (tema che verrà ripreso da Pirandello in Sei personaggi in cerca d'autore).
MARIONETTE COME UOMINI O UOMINI COME MARIONETTE?
Abbiamo detto che la rappresentazione di Ubu re, nel 1896, procurò al suo autore un successo di scandalo: vi furono forti reazioni tra il pubbico, la critica si spaccò nel giudicare quest'opera così radicalmente diversa da tutto quel che si era visto, fino allora, in teatro. Il tema centrale di Ubu re è lo stesso del Macbeth di Shakespeare: l'avidità di potere spinta fino al crimine e al delirio. Papà Ubu (come si fa chiamare dai suoi sudditi) è un personaggio pazzescamente ingordo, cinico, spietato, millantatore e, soprattutto, vile: di una viltà ripugnante. A volte, si badi, la realtà supera la fantasia:
3

il feroce dittatore haitiano François Duvalier, che terrorizzò il suo popolo con una polizia politica, i Tonton macoutes, ispirandosi alla magia nera del voodoo, ha molti tratti in comune con Ubu, a cominciare dal fatto che si faceva chiamare Papà Doc. E che dire del dittatore centro-africano Bokassa, che spingeva la sua macabra violenza - pare - fino a consumare festini cannibaleschi con i corpi delle sue vittime, il tutto innaffiato con casse del migliore champagne fatto venire sotto ghiaccio, in aereo, direttamente dall'Europa? Tutto, in Papà Ubu, è disgustoso, e tuttavia egli possiede una sua inesauribile, assurda, scandalosa giocondità. Non è in bilico tra farsa e tragedia: è l'una e l'altra, contemporaneamente, inverosimilmente. Abbiamo detto: un personaggio; avremmo dovuto dire: una marionetta. Nel senso letterale della parola. Nella concezione originaria del suo autore, il dramma (o la commedia?) di re Ubu avrebbe dovuto essere, né più né meno, uno spettacolo di marionette. E della marionetta, non dell'uomo, Ubu mostra di possedere tutte le caratteristiche. Ma ecco la domanda inquietante: marionette i personaggi di Jarry, o marionette gli uomini (veri, si fa per dire) di cui Jarry volle fare la spietata caricatura? I capi di Stato, i finazieri, i generali; ma anche i piccoli borghesi che sognavano ricchezza e potere, ma rabbrividivano di paura (proprio come Ubu) davanti alla sola idea di possederli e doverli poi, quindi, gestire? Repellente miscuglio di cinismo, fanfaronaggine e viltà - appunto. Teatro del grottesco, certo; ma non è ancora più assurdo un teatro (come quello tradizionale, di ascendenza naturalistica) che non ci mostra l'uomo come è, ma come potrebbe o dovrebbe essere, e come si vorrebbe che fosse? Jarry, a ben guardare, ha bene assimilato la lezione di Machiavelli: è tempo di considerare l'uomo per quello che è realmente, non per quello che si potrebbe desiderare che sia. E poi, un dubbio strisciante s'insinua nelle nostre menti: l'uomo-marionetta di Jarry, è solo una esilarante e corrosiva invenzione letteraria? Siamo proprio sicuri che non vi siano degli uomini-marionetta intorno a noi, anche ai vertici del potere, magari gonfiati oltre misura da quello che il filosofo Umberto Eco ha qualificato come "populismo mediatico"? Possiamo chiederci, infatti, perché la reazione del pubblico e della critica al fenomeno di Papà Ubu sia stata così violenta fin dall'inizio. E una risposta semplice, ma immediata, è che la borghesia francese (ed europea) non tollerava di vedersi allo specchio; inorridita, volgeva lo sguardo e accusava l'autore di oscenità. Ma oscena - avrebbe detto Jarry - era lei. Lei che celebrava il culto della ragione, della scienza e del progresso, e che di lì a poco avrebbe precipitato il mondo nel più atroce bagno di sangue della storia: la guerra del 1914-1918; e, dopo una tregua armata di vent'anni, la guerra ancora più atroce del 1939-45, suggellata dal mostruoso "fungo" atomico di Hiroshima e Nagasaki. Ecco allora che anche la violenza verbale del teatro di Jarry, anche la parolaccia (ma sempre deformata e "creativa": merdra!, e non mai merda!) assume una sua ragion d'essere come forma di aggressione a una realtà profondamente oscena: quella mascherata dal finto perbenismo borghese.
4

2. LA RIVOLTA COME RIVENDICAZIONE DI AUTENTICITA'.
Gli uomini peggiori della belle époque cavalcavano la tigre dell'irrazionalismo decadentista, inneggianti allo splendore della violenza e delle stragi (Marinetti, D'Annunzio). I migliori, cercavano disperatamente una strada verso l'autenticità, ma spesso non riuscivano a trovarla (Carlo Michaelstadter). Jarry fu uno di questi ultimi: la sua ansia di coerenza ha qualche cosa di assoluto, di religioso. A partire dal 1896 egli, anche nella sua vita privata, parla, gestisce, si comporta esattamente come il suo grottesco personaggio: Ubu. Dopo il successo ottenuto, avrebbe potuto rientrare nei ranghi e costruirsi una carriera letteraria riconosciuta dall'establishment ufficiale; lo avrebbero presto perdonato, se avesse lasciato intendere d'aver solo voluto scherzare. Il fatto è che non volle. Fedele a sé stesso, si ridusse in estrema povertà. Le riviste letterarie gli rifiutavano la pubblicazione dei suoi scritti. Eppure, continuava a lavorare intensamente, perfezionando ed arricchendo il suo personale "universo" ubuesco. Alla prima opera seguivano Ubu incatenato, Ubu becco, Almanacco illustrato di papà Ubu, Faustroll e la patafisica; quest'ultimo personaggio suggerisce una sorta di incrocio tra Faust, colui che vende l'anima al diavolo, e il "troll", personaggio grottesco e dispettoso del folklore norvegese, di cui si trova traccia anche nel Peer Gynt di Henryk Ibsen). Sappiamo che André Gide rifiutò la pubblicazione della Recherche di Proust perché "profumava troppo di conti"; Popesco rifiutò di pubblicare i lavori di Jarry perché "odoravano di latrina".
& & & & &
Possiamo ora domandarci se, accanto alla feroce pars destruens, vi sia nel teatro di Alfred Jarry una pars costruens; e la domanda è certamente legittima. Possiamo chiederci se Jarry fu solo un anarcoide, sbeffeggiatore di tutto e di tutti (anche della democrazia: nell'Ubu incatenato, bersaglio della sua satira è la società democratica), privo di consistenza ideologica e sostanzialmente qualunquista; o ebbe una sua "verità", anche politica, da affermare? Secondo noi l'ebbe, ma nascosta dietro il riso amaro della satira (un po' come certo Pirandello, un po' come certo Leopardi delle Operette morali): e precisamente che la vita va vissuta senza compromessi, con autenticità. Può anche sembrare poco, ma è tutto. La sua stessa enorme cultura (fu uno scrittore coltissimo, anche se può non apparire evidente), la sua smisurata curiosità intellettuale (si interessò praticamente di tutto), escludono che egli si sia divertito a fare il "provocatore senza problema" (parafrasando un'espressione di Benedetto Croce). Solo che egli era convinto vi fosse una tale muraglia di inautenticità, stupidità, violenza, assurdità nella società borghese, che volle essere in primo luogo un
5

demistificatore. Come lo era stato Rabelais, come lo sono tutti i grandi moralisti; e sia pure di un moralismo paradossale, dolente e risentito. "Vivere è il carnevale dell'Essere "- è stato scritto; è giusto, quindi, tentare di non-vivere, rifiutare la propria nascita fisiologica e crearsi un personaggio fittizio: Ubu, allora, può considerarsi come il "doppio" dello stesso Jarry (cfr. l'ottima introduzione di Jean-Louis Barrault e la ricca e stimolante presentazione di Lucio Chiavarelli a Tutto il teatro di Jarry, Roma, Newton Compton, 1974). Un aneddoto? Un giorno Jarry si mise a sparare col fucile nel giardino ove solevano giocare i figli della sua vicina di casa. Alla donna che, terrorizzata e sgomenta, si era presentata a protestare, egli rispose, sillabando le parole come un robot: "Non-si-preoccupi-signora-ne-faremo-degli-altri-ne-faremo-degli altri".
Si potrebbe istituire un parallelo fra Jarry e Rimbaud. Anche quest'ultimo volle farsi campione di un totale déréglement; solo che, alla fine, Rimbaud scelse la fuga, sia geografica (andò a fare il mercante d'armi in Africa), sia da sé stesso (non scrisse mai più un verso dopo la sua stagione prodigiosa dell'adolescenza e della prima giovinezza). Jarry, invece, rimase ben saldo al suo posto, a combattere (se ci è lecito citare san Paolo) la "buona battaglia" contro i filistei della borghesia parigina, che ormai da tempo lo evitavano come un lebbroso.
& & & & &
Dietro gli apparenti splendori della belle époque, l'Europa covava un cancro mortale: la violenza sfrenata del sistema (economico, politico, sociale, culturale), appena dissimulata sotto una vernice di "civiltà", ma che sarebbe esplosa pochi anni dopo nella più orrenda carneficina della storia: la guerra mondiale. Mentre i tromboni sfiatati del nazionalismo, dell'irrazionalismo, di un grottesco e malinteso superomismo, osannati dalla critica e dal pubblico (borghese) contribuivano a preparare il terreno per la catastrofe (Ernst Jünger, nel 1914, inciterà i giovani soldati a gettarsi all'assalto delle trincee nemiche come ci si getta sul corpo di una donna), pochi intellettuali come Jarry - pensoso, dietro la maschera comica - intuivano il pericolo e lanciavano un disperato grido d'allarme. Ma l'Europa "perbene" non volle ascoltarli, li derise e li emarginò. Magari, come il direttore di quella prestigiosa rivista letteraria parigina, rifiutandosi di pubblicare i loro scritti, perché "emanavano odore di latrina".
3. DISTRUGGERE PER RICOSTRUIRE, ANZI DISTRUGGERE RICOSTRUENDO.
6

Ecco allora che la pars costruens dell'opera di Jarry si trova nascosta proprio fra le pieghe della pars destruens, a cominciare dall'uso del linguaggio. Un linguaggio che assale le convenzioni (e il "buon gusto") borghesi; e, contemporaneamente, svela nuove dimensioni ludiche e creative (quindi liberatrici) nella parola. Ma, in fondo, non è precisamente quel che ha fatto il gran padre Dante, specialmente nella prima cantica del suo immortale poema? La violenza verbale di Ubu è, evidentemente, funzionale alla violenza dei contenuti: cioè, direttamente proporzionale alla violenza dei contenuti che si prefigge di colpire; l'enorme violenza della società borghese, dei suoi riti, della sua sfacciata ipocrisia. "Che cos'è mai svaligiare una banca - è stato detto - in confronto al fondare una banca?".
Tuttavia la violenza del linguaggio, in Jarry, non è solo oscenità: se così fosse, sarebbe fine a sé stessa. E, del resto, ripetiamo che Jarry fu uno scrittore estremamente còlto - così còlto da far apparire "leggera", impalpabile, aerea la sua enorme cultura (cfr. il "socratico "so di non sapere"). Sarebbe stata semplicemente sberleffo? Così la intesero - e sbagliarono, in buona o in mala fede - i critici benpensanti. La violenza linguistica del teatro di Ubu-Jarry è gioco e invenzione; ha una dimensione ludica e una dimensione creativa. "Merdra", per esempio - lo abbiamo già osservato - non è "semplicemente" una parolaccia, ma un'invenzione lessicale vera e propria (a cui l'autore rimase sempre fedele). E così è tutto il linguaggio di Jarry: scoppiettante di comicità e inventiva, come uno spettacolo pirotecnico. Vi è, in esso, una doppia valenza: dissacrante e dissolvente da una parte (la pars destruens, appunto), giocosa e inventiva dall'altra (la pars costruens).
Anche in Dante, nell'Inferno, vi è una comicità ardita, a volte linguisticamente oscena: eppure nessuno si è mai sognato di mettere in dubbio, per questo, l'assoluta serietà del messaggio di Dante. Evidentemente, perché si è capito che quella oscenità è funzionale al particolare contesto, linguistico e contenutistico, della prima cantica della Commedia. Sappiamo bene che Jarry non è Dante; ma, d'altra parte, non si può adottare un criterio di giudizio per Dante, e un criterio pregiudizialmente diverso (e negativo) per tutti quelli che non sono Dante. È un procedimento metodologicamente scorretto. (A parte il fatto che ci è dati parecchio da fare per "addomesticare" il messaggio di Dante, e in parte ci si è riusciti; ma uno come Jarry, è veramente difficile addomesticarlo).
& & & & &
Ebbene, questa doppia valenza nel teatro di Jarry non riguarda solo la sfera del linguaggio ma anche, e a maggior ragione, quella dei contenuti. "Non si può mettere
7

vino nuovo in otri vecchi", ha detto qualcuno. Non si possono veicolare contenuti rivoluzionari in una forma tradizionale: questa sembra essere stata la lezione di Alfred Jarry. Una lezione che volle impartire fino all'ultimo ai suoi contemporanei. Anche sul letto di morte, all'Ospedale della Carità; anche domandando, come ultimo desiderio, uno stuzzicadenti. Per farsene che cosa, poi? Cosa può farsene, un moribondo, dello stuzzicadenti? Dei residui di quale mai pasto dovrà ripulirsi, prima di affrontare il momento supremo? Diavolo d'un Jarry. Perfino dal letto di morte, continua a stupirci, a provocarci. E, soprattutto, a interrogarci.
& & & & &
Francesco Lamendola
8