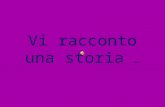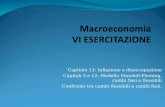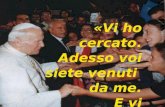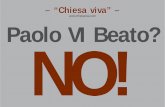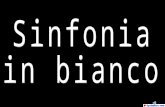AEOLO VI
-
Upload
enrico-santus -
Category
Documents
-
view
214 -
download
2
description
Transcript of AEOLO VI
3
Redazione [email protected]
Direzione: dire t tore.aeo lo@gmai l .com Leonardo Cosmai (d i ret tore responsabi le )
Enr ico Santus (d ire tto re ed i tor iale )
Amministrazione Teresa De Mar t in, Enr ico Santus
Comitato redazionale: redaz ione.aeo lo@gmai l .com Francesco Chio falo , Si lv ia L i tte r io (capo redat tor i )
Luca Capron i, N ico la Mar ia Carucc i , Andrea Cors ig l ia, Te resa
De Mar t in, Francesca Mi lazzo, Fab iana Pe l legr ino, G iorg ia Santaera, Renata Sch iavo, Mar i lena Scuotto, Matteo Tars i
Ufficio Stampa: uf f i c io .s tampa.aeo lo@gmai l .com
Andrea Cors ig l ia, S i lv ia L i t ter io , G iorg i a Santae ra
Eventi: eventi . aeo lo@gmai l .com
Er ica Bernardi , Mar i lena Scuo tto
Pubblicità: pubbl ic i ta.aeo lo@gmai l .com
Teresa Occhipint i
Editing e correzione bozze N ico la Mar ia Carucc i , F rancesco Chio falo , Andrea Cors ig l ia
Grafica e impaginazione Giacomo Gucc ine l l i (g raf ico ) A lessandro Russo ( logo)
Enr ico Santus ( impag inaz ione car taceo e web)
Distribuzione: d is tr ibuz ione.aeo lo@gmai l . com Francesca Mi lazzo
wwwwww..aaeeoolloo.. ii tt
4
Con i patrocini di
UNIVERSITA' DI PISA
arDSU TOSCANA
Aeolo, Anno II, Numero 4 ISSN – 2036 – 1386 Aeolo (Pisa) Registrata al Tribunale di Milano,
n. 354 del 29/07/2009
Felici Editore S.r.l. – Via Carducci, 60 – 56010 – Loc. La Fontina, Ghezzano – San Giuliano Terme (PI).
© 2010 AEOLO
© 2010 Felici Editore S.r.l., Pisa
5
Sommario REDAZIONE ....................................................................... 3 MAFIA, RIFORME E QUEER ...................................... 7
Enrico Santus ............................................................... 11 VENTO: LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
LA MAFIA DA MOLTO VICINO .......................... ........ 12 di Enrico Santus e Giorgia Santaera ........................... 12
SPROFONDO NORD ....................................................... 20 di Giovanni Giovannetti ............................................... 20
DUE VOLTI ....................................................................... 33 di Emilia Lacroce ........................................................ 33
INTERVISTA A JOŽE PIRJEVEC ................................ 36 di Primož Sturman ....................................................... 36
LIBERA. ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE ............................................................ 42
di Paolo Martinelli ...................................................... 42 UNA VITA DI RICERCA IN ONORE DI PEPPINO
IMPASTATO .......................................................................... 51 di Enrico Santus ........................................................... 51
LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA IN FRANCIA ... 60 di Luca Caproni ........................................................... 60
NÉ LA VIPERA NÉ LA MAFIA ..................................... 64 di Laura Sanna ............................................................ 64
CRIMINALI IN UN MONDO GLOBALIZZATO ......... 71 di Marina Calculli ....................................................... 71
“LE MIE PRIGIONI” DI UN BOSS ................................ 76 di Paolo Antonio Guerrieri .......................................... 76
BUFERA IN SALA: LA MAFIA ...................................... 85 di Morena Mancinelli .................................................. 85
L’ISTRUZIONE COME LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA .................................................................... 90
di Teresa Occhipinti .................................................... 90
BUFERE
6
KARL JASPERS E LA TORRE DI HOLDERLIN ........ 95 di Mauro Savino .......................................................... 95
SPIFFERI
LEHMAN BROTHERS .................................................. 105 Ivan Pozzoni .............................................................. 106
DOVE SAREBBERO FINITI I LIQUAMI DEL CESSO ................................................................................................ 107
di Roberto Lisi ........................................................... 107 LE STELLE ..................................................................... 116
Renata Schiavo .......................................................... 116 LE STELLE INTERMITTENTI ........................... ......... 117
di Lorenzo Spurio ...................................................... 117 A[D] INCASTRO ............................................................. 120
Riccardo Raimondo ................................................... 120 A GIUGNO, SE NON PRIMA ........................................ 122
Andrej Hočevar .......................................................... 122 ARRIVO IN RITARDO .................................................. 123
Andrej Hočevar .......................................................... 123
INTERVENTI E LE ALTRE DOVE SONO? ......................................... 125
di Eloisa Morra.......................................................... 125 COME PUBBLICARE UN LIBRO ............................... 133
di Enrico Santus ......................................................... 133 SILVIA CHE SEPPELLISCE I MORTI .................... ... 134
di Andrea Corsiglia ................................................... 134 ZOO COL SEMAFORO ................................................. 144
di Fabiana Pellegrino ................................................ 144
7
Mafia, riforme e queer
Editoriale
Come un flash-back. Si ritorna sempre alle origini, che si voglia o
meno. Sono serviti tre anni per riportarmi indietro, a quando mi capitò di vedere a teatro il monologo "Il Macero". Era il 25 ottobre 2007 e sul palco recitava Roberto Solofria. Ricordo camion d'immondizia e tanta Camorra.
Ero seduto nella mia poltroncina. D'un tratto, quando ancora lo spettacolo non era ancora terminato, si accesero abbaglianti le luci in sala e una voce aggressiva ci colse alle spalle per chiedere: "E voi cosa avete fatto per evitare tutto questo?".
Mi guardai attorno. Cercai nei volti dei miei vicini la risposta che non trovavo nella mia coscienza. Sul palcoscenico della realtà, adesso c'eravamo noi. La nostra sicurezza era svanita in un istante; profonde crepe attraversavano le nostre posizioni moralistiche di spettatori; la poltrona era diventata scomoda, la luce fastidiosa, la lingua impastata. Scoppiò un dibattito che si prolungò per diversi minuti. Poi si spense. Per molti per sempre, per me mai più.
Conobbi gli organizzatori di quell'evento qualche giorno più tardi, durante una riunione notturna presso la facoltà di Scienze Naturali dell'Università di Pisa. Eravamo seduti su comodi divanetti proprio davanti ai laboratori dove i ricercatori facevano nottata. Il loro gruppo non era riconosciuto ufficialmente da nessuna istituzione: si facevano chiamare “Spertejo, in un intrecciarsi d'Esperienze”; lottavano contro la mafia, la mala politica e l'indifferenza.
Lavorai insieme a questi piccoli Don Chisciotte per un anno circa, organizzando numerose iniziative di sensibilizzazione, tra cui reading, laboratori maieutici, proiezioni non autorizzate e flash-mob (allora non andavano di moda), che ottenevano il solo risultato di ridicolizzarci.
Nell'aprile 2008, dopo aver imparato molto dai miei compagni,
8
decisi di fondare una rivista. Il gruppo mi sostenne per il reperimento dei fondi e mi incoraggiò. Conobbi in quei giorni delle persone che sarebbero poi diventate i redattori di Aeolo.
Le iniziative contro la mafia si susseguirono con più lentezza, ma non mancarono mai. Sopratutto non mancarono mai le nostre letture e i nostri articoli. Poi, nel marzo 2010, fui selezionato per partecipare ad una serie di seminari di Roberto Saviano presso la Scuola Normale Superiore. Dalle ceneri di quelle lezioni nacque il Progetto Spartacus, un gruppo di ricerca sulle tematiche di mafia.
Questo numero. Nacque così l'idea di dedicare un intero
numero alla criminalità organizzata. Parallelamente alla sua realizzazione, sono partite iniziative di sensibilizzazione sul territorio nazionale, come reading e "Contro la mafia ci metto la faccia". Quest'ultima ha spinto centinaia di lettori a inviarci un loro primo piano esplicitando la loro avversione al fenomeno mafioso. Parte dei volti sono stampati nelle pagine seguenti del presente volume, altri sono reperibili sul sito della rivista e sulla pagina Facebook “Aeolo”.
Aeolo VI gode di importantissime collaborazioni, provenienti da diverse zone del territorio nazionale ed europeo. Tra queste, è bene segnalare quelle con Umberto Santino (fondatore e presidente del Centro di documentazione "Giuseppe Impastato" di Palermo), Massimo Ciancimino (figlio di Don Vito, uno degli anelli di congiunzione tra le istituzioni e Cosa nostra), Jože Pirjevec (professore di Storia contemporanea presso l'Univerza na Primorskem-Università del Litorale, a Capodistria in Slovenia), Davide Barletti (regista di Fine Pena Mai). Ad esse, si aggiungono gli articoli che trattano il fenomeno mafioso nelle regioni del Nord, come l'intervento di Giovanni Giovannetti, e quello di Laura Sanna, che si occupa invece della Sardegna.
9
Insomma, un numero fortemente tematico, che ha voluto accendere ancor più i riflettori su zone solitamente considerate immuni al fenomeno mafioso.
Il ddl Gelmini. In questi mesi si è assistito ad una lunga serie di
manifestazioni studentesche contro il ddl Gelmini. Si è trattato, per lo più, di proteste partecipate e intelligenti, che – poste in continuità con l'Onda di due anni fa – hanno conquistato i monumenti simbolo del patrimonio culturale di questo Paese, in netto contrasto con un governo in cui il ministro Giulio Tremonti può permettersi di dire che «la Divina Commedia non si mette nel panino».
Se poi i manifestanti hanno preso di mira non più solo la riforma Gelmini (di cui si trovano anticipazioni in un quaderno dell'associazione Treellle del 2003), ma l'intero governo, ciò è conseguenza di un'arroganza che per lunghi mesi ha ignorato o addirittura deriso le manifestazioni, paragonando gli stessi studenti a “ultras” e definendoli “fuori corso”, nonché “potenziali assassini”.
Ciò, naturalmente, ha agevolato la congiuntura tra gli universitari e gli altri soggetti che soffrono le conseguenze della crisi. Non per niente lo slogan che ha mosso la manifestazione dello scorso 14 dicembre era: «Tutti uniti contro la crisi», anch'esso in netta opposizione ad un governo che ha pensato di arginare i problemi adottando un volgare ottimismo demagogico.
Al di là degli errori e dei meriti dei manifestanti, è importante sottolineare la reazione del governo: la proposta di estendere alle manifestazioni democratiche la Daspo (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive), dimostra che la destra non può fare a meno della metafora calcistica in politica: "scendere in campo", "squadra di governo", "autogol" sono tutte espressioni che continuiamo a sentire da troppo tempo. Non resta che attendere il 90° minuto.
Il prossimo numero. Ed ora, prima di lasciarvi alla lettura del
volume, desidero introdurre – con le parole di Nicola Maria Carucci
10
e Francesco Chiofalo – i due temi che tratteremo nel prossimo numero di Aeolo, previsto per giugno 2011: Queer as Folk – Folk is Queer.
In un Paese che si fregia di Istituti millenari, che ha elaborato ed
esportato il diritto e la civiltà, esistono oggi donne e uomini che non hanno accesso a meccanismi di riconoscimento e previdenza sociale, a causa del loro desiderio progettuale di legarsi ad una persona dello stesso sesso.
Questa curiosa aberrazione delle norme – in grado di generare unioni giuridicamente “fantasma” ma praticamente molto diffuse – è di gran lunga superata altrove, ma caldamente raccomandata dai nostri politici: l’Italia rimane uno degli ultimi paesi europei a non aver ratificato il trattato di Lisbona, che rende imprescindibile dalle azioni dei governi la lotta all’omofobia ed al machismo.
Recenti dichiarazioni omofobe, come quelle di Buttiglione o i motti di spirito del Premier Berlusconi, sarebbero deliziose testimonianze di un gretto oscurantismo catecumenico se non fossero pronunciate dai politici della maggioranza vigente, in pieno possesso delle nostre risorse e della facoltà di legiferare.
Eppure l’omosessualità, l’essere “bizzarro”, l’essere “QUEER” nella storia dell’uomo ha avuto piacevoli significati: di libertà, di vivacità intellettuale, di apertura mentale verso nuove idee, e tutt’ora è, in alte parti del mondo e in qualche regione d’Italia, un sentimento, una eccentrica ed implacabile forza creatrice difficile da sopire.
Pulsioni e moti d’animo contrari alla voce di chi ci rappresenta dilagano ovunque, e raccogliere le più rappresentative di queste vicende, connesse ad un modo tutto particolare di essere “differenti” e non “diversi”, è il migliore omaggio che una rivista di cultura e letteratura possa fare al bacino di giovani menti dalla quale
11
proviene. Il tema del prossimo numero darà voce a tutte queste persone che vivono nell’ombra, per loro scelta ma soprattutto a causa di un’idea culturale che si ha di loro; le stesse che urlano silenziosamente nella loro quotidiana realtà, attraverso le loro parole, i loro lavori, i loro familiari, ma soprattutto attraverso le loro vite.
Dalla voce del nostro capo di Stato: «La lotta contro ogni sopruso […] e contro l’omofobia fa tutt’uno con la causa del rifiuto dell’intolleranza e della violenza, in larga misura oggi alimentata dall’ignoranza, dalla perdita dei valori ideali e morali, da un allontanamento spesso inconsapevole dei principi su cui la nostra Costituzione ha fondato la convivenza della nazione democratica».
Prima di lasciarvi alla lettura, desidero dedicare questo numero a
Francesca Cappelli, un'amica che con me seguì i seminari di Roberto Saviano della Normale e con cui avremmo dovuto incontrarci per parlare di giornalismo, se la sua prematura scomparsa non l'avesse impedito.
Buona lettura e al prossimo numero.
Enrico Santus
Pisa, 23 dicembre 2010
SEZIONE TEMATICA
12
La mafia da molto vicino
Intervista a Massimo Ciancimino
di Enrico Santus e Giorgia Santaera
Massimo Ciancimino nasce nel 1963 a Palermo. Figlio di Vito Alfio Ciancimino, politico che ebbe un ruolo di cerniera tra Stato e mafia, oggi è testimone di giustizia nelle indagini avviate dalle Procure di Palermo e Caltanissetta sulla stagione stragista del 1992-93 e sulla conseguente trattativa tra servizi segreti e Cosa Nostra. Vive
sotto scorta lontano dalla sua città natale a causa di ripetute minacce subite. Nell'aprile 2010 esce per Feltrinelli il libro Don Vito, scritto insieme al giornalista Francesco La Licata. Il memoriale, che ha fatto molto discutere, racconta uno spaccato di trent'anni di vita dell'autore insieme al padre, ex sindaco di Palermo condannato per mafia.
Sono le 10:30 circa di una tiepida mattina di novembre. Massimo Ciancimino risponde al telefono con voce cordiale: «La prossima intervista – ci promettiamo – sarà davanti a un caffè».
Enrico Santus: Partiamo dal testo: Don Vito è un memoriale molto dettagliato sulle relazioni segrete tra Stato e mafia. Come è nata l'idea di scriverlo? Come avete proceduto per la stesura e il recupero dei dati?
Si tratta di un’idea vecchia; la volontà di raccontare la storia di mio padre, la sua verità. Un’idea che è anche un atto di accusa e che ha
13
fatto da supporto alle indagini della magistratura. Io mi limito soltanto a raccontare i fatti che conosco insieme a Francesco La Licata, giornalista che si occupa di antimafia. Per quanto riguarda la raccolta dati e le fonti, da palermitani non abbiamo bisogno di giornali o riviste. Sono cose che – specialmente per me – rimangono nella memoria, appunto.
E. S.: Hai anche dimostrato di avere delle buone competenze linguistiche e buona capacità narrativa nella stesura del libro...
Mi piace molto scrivere; credo sia stato questo a farmi acquisire nel tempo un poco di tecnica narrativa.
E. S.: Il primo capitolo di “Don Vito” racconta la perdita dell'innocenza, ovvero quando scopristi la vera identità dell'ing. Lo Verde grazie ad alcune foto della rivista settimanale "Epoca", mentre aspettavi che il barbiere terminasse di radere tuo padre. Prima d'allora non avevi mai dubitato dei suoi rapporti? Che impressione ti aveva fatto sapere che la mafia ti toccava così da vicino?
Quando hai 15-16 anni, specialmente in quel periodo – fine anni ‘70, inizi ‘80 – la mafia è qualcosa che ti affascina. Ti accorgevi che il potere mafioso veniva ostentato. Oggi, al contrario, il potere viene celato; oggi la mafia cerca di non farsi scoprire. In quegli anni la mafia era, come dire, “ben vestita”, e anche molto attenta al gusto e – se così si può dire – “elegante”, legata al senso del rispetto. A quell'età sei affascinato dal potere e non capisci se è un potere positivo, che fa del bene, oppure negativo, che fa del male.
Grandi sogni, grandi disponibilità e un senso di rivalsa. A certa gente non potevi fare nulla: entravano nelle discoteche, conquistavano facilmente le ragazze... e fu proprio questa la paura di mio padre una volta che mi accorsi della vera identità di Lo Verde.
14
Giorgia Santaera: Esattamente di cosa ebbe timore tuo padre?
Temeva il fatto che il mio accesso diretto ad un capo della mafia potesse farmi perdere la testa, potesse farmi vantare della sua conoscenza. Non era preoccupato che facessi qualche stupidaggine ma che, in qualche modo, mi pavoneggiassi o mi vantassi in giro di questa mia conoscenza. Mi diceva: "Guarda che in questo caso non posso proteggerti nemmeno io".
E. S.: Quindi, quanto e in che modo ti ha cambiato la vita essere il figlio di quel Don Vito Ciancimino che è passato alla storia come uno dei principali punti di contatto tra politica e mafia, in particolare con Bernardo Provenzano?
Beh... me l'ha cambiata fino a un certo punto. Provenzano, almeno, non metteva mai la propria faccia in quelli che erano gli incontri di mio padre. E poi quel nome buffo e goffo: "ing. Lo Verde". No! Mi ha cambiato la vita molto di più rendermi conto che agli incontri arrivavano procuratori, capi della polizia, magistrati; questo sì che mi metteva in soggezione. Mi imbarazzava quella gente perché non riuscivo a capire come potessero sedersi tutti insieme a uno stesso tavolo così tranquillamente e con tale complicità. Questo la diceva lunga sul livello di collusione che aveva già raggiunto Cosa Nostra in quel periodo...
G. S.: In questi ultimi giorni molte dichiarazioni hanno avvalorato le tue rivelazioni, però allo stesso tempo vieni indagato dalla Magistratura di Palermo. Cosa rispondi a queste accuse? Ti ritieni in qualche modo responsabile?
15
Ho ricevuto l’avviso di garanzia la settimana scorsa. Un avviso di garanzia, un'accusa che mi muove la magistratura ma che porta, come punti di prova, le mie stesse dichiarazioni e il materiale che io stesso ho fornito e dato da supporto alla magistratura. Questo mi amareggia. Ho sempre detto che credo di non aver dato mai quella sensazione... penso che il 416 bis non si riferisca soltanto alla frequentazione di persone che hanno o hanno avuto a che fare con la mafia... ci deve essere anche una volontà di favoreggiare l'associazione criminale. Credo che questo in tutta la mia vita – e lo dicono anche i fatti – l'ho sempre rigettato. Anche quando portavo i pizzini l'intento non era quello di agevolare la criminalità organizzata. Poi ribadisco; non devo essere io a giudicare me stesso: non mi sottraggo da nessun processo, non sono Senatore e non sono cugino di Mubarak, per cui...
G. S.: Ma allora come mai hai deciso di parlare così tardi e perché oggi sei così determinato nonostante le minacce che hai ricevuto?
Ho deciso di parlare quando i magistrati hanno deciso di ascoltarmi. Si tratta di una domanda legittima che mi fanno tutti e a cui io rispondo – altrettanto legittimamente – che, finché nessuno è interessato, io non ho voglia di raccontare fatti che sicuramente – come si dimostra – possono evidenziare indizi di reato nei miei confronti, oppure distruggere quella serenità che è tornata in famiglia dopo la morte di mio padre. Io non volevo far passare questo periodo di vita a mio figlio. Adesso è un processo importante, ci sono magistrati disponibili ad ascoltare e vagliare le mie dichiarazioni e quindi ho deciso di fare questo sacrificio.
E. S.: Cosa rispondi al generale Mario Mori, ex comandante del Ros, che ti accusa di utilizzare programmi grafici per modificare le lettere di tuo padre spostando e ritagliando a piacere?
16
Ha già risposto la magistratura. L'unico documento a cui si riferisce Mori è quello consegnato durante l'ultima udienza del 2 ottobre scorso, quando ho consegnato un documento che è un collage e accompagnando tale consegna con la dichiarazione di aver incollato due documenti fotocopiati, proprio perché così li avrei dovuti pubblicare sul libro. Quindi solo una questione di comodità – tra l'altro annunciata in anticipo – e non un imbroglio. Non è materiale costruito per farci su processi o elementi probatori. Quindi, alla domanda se ho mai usato photoshop, rispondo: "No, è semplicemente un collage!".
G. S.: Ad un certo punto, nel 1992, si ha la fine degli equilibri. La mafia passa alla strategia della violenza, delle stragi. Perché? Come avete vissuto quel periodo in casa tua?
In quel periodo, mio padre e mia madre vivevano già in case differenti. Si respirava l'aria che si respirava in tutta Italia; una sensazione di sconfitta. Eravamo rimasti spiazzati, anche perché – secondo la logica – Cosa Nostra deve convivere con lo Stato e non contrapporsi. La contrapposizione non giova infatti ai suoi interessi, che hanno bisogno di stare all'ombra dello Stato. Poi, per quanto riguarda la trattativa... è stato un tentativo di mettere fine alle stragi. Fu Riina il primo a cercarla e poi intervenne Bernardo Provenzano, che alla fine decise di mettere da parte l'ala sanguinaria di Cosa Nostra, specialmente dopo aver visto la reazione di mio padre e di molti pentiti.
E. S.: Il capitano Antonello Angeli ha ammesso di aver trovato il "papello" durante una perquisizione in casa tua nel 2005 e di aver avuto ordine dal colonello Giammarco Sottili di lasciarlo perdere...
17
Ciò conferma le mie dichiarazioni e il fatto che ci siano state anomalie. Non posso che provare amarezza visto che tutto questo evidenzia che la volontà non era quella di accertare i fatti, ma di occultarli. Inoltre, mi pongo il problema se altri documenti utili nel mio processo non siano stati fatti sparire. Ricordiamoci che ben quattordici documenti sono stati trovati solo l'anno scorso.
E. S.: Qual è l'opinione delle Procure sul "papello"?
Il "papello" è stato accettato con la collocazione temporale che dico io, sia per l'inchiostro che per la carta. Non è ancora chiaro chi sia l'autore. I magistrati hanno detto che i venti esami di comparazione erano troppo limitati per permettere l'attribuzione precisa. Hanno, infatti, a loro disposizione pochi verbali e pochi documenti. Attualmente stanno ancora cercando di capire chi l'abbia scritto, ma secondo me non è questo l'importante. Di fatto c'è un contropapello che riprende i punti fondamentali ed è stato accertato che sia stato scritto da mio padre. Quella è l'autentica prova, visto che lui si richiama a un "papello".
E. S.: Parliamo della serie di riconiscimenti che sono avvenuti: il pentito Gaspare Spatuzza ha riconosciuto il funzionario dell'Aisi Lorenzo Narracci come colui che stava nel garage mentre veniva imbottita di tritolo la Fiat 126 che avrebbe provocato la strage di Via D'Amelio. Tu stesso avevi riconosciuto Narracci in un incontro con il boss Gaetano Scotto, oggi all'ergastolo per la strage Borsellino... e poi ci sarebbe da parlare di Piraino...
Certo, attraverso le ricognizioni Spatuzza riconosce Narracci. Però bisogna stare attenti a non rovinare la vita di una persona, visto che in parte il dubbio rimane. Anche io l'ho indicato con sicurezza, ma nel riconoscimento tra tante persone comunque non si è mai certi al cento per cento. Stesso discorso vale per Rosario Piraino, su cui ho
18
fatto delle ricognizioni e credo sia proprio lui quel capitano che mi "invitò" a desistere dalle dichiarazioni.
G. S.: Da dove arrivarono gli investimenti che portarono alla nascita di Milano 2 e in che modo questo ha a che fare con l’ascesa politica di Berlusconi e del partito politico Forza Italia? Che ne pensava tuo padre e quali erano i rapporti?
Ci sono scritti che certificano operazioni in banca che mio padre ha accompagnato. Ciò che mio padre racconta l'ho scritto, l'ho portato ai magistrati e saranno loro a valutarli. E’ chiaro che ci sono stati investimenti nei settori immobiliari. Non è chiaro, invece, quanta sia la responsabilità morale e quanta quella legale...
20
Sprofondo nord
di Giovanni Giovannetti1
“A quello gli taglio le orecchie e gliele infilo su per il culo”. Non è la voce di un macellaio alle prese con un bovino recalcitrante alla macellazione, ma il linguaggio mafioso dell'assessore pavese ai Lavori pubblici Luigi Greco, sorpreso a intimorire un noto avvocato della città. L’ex
direttore sanitario dell'Asl pavese, il post-democristiano Carlo Antonio Chiriaco ,arrestato in una retata antindrangheta nel luglio del 2010, sembra aver preso parte alla riscossione di interessi usurari e ad estorsioni, come risulta da un intercettazione del marzo 2010: “Questo diceva che non li aveva, eravamo andati io, Franchino Buda e Beppe Ilacqua [...] Io guardavo Franchino, e Franchino si alzava e giù un ceffone, e io a tartassarlo, sempre con la stessa domanda, ma quando lei ha cercato i soldi al professore il professore ce li ha dati, si, e ora perché non li vuole tornare, e questo, al settimo schiaffo... l'abbiamo portato a casa... ha preso si soldi... li ha dati e via”.
La notte del 13 luglio, Sant’ Enrico, 152 arrestati, tutti affiliati alla sezione lombarda della 'Ndrangheta. Arrestati per concorso
1 Giovanni Giovannetti (Lucca, 1955). Fotogiornalista, è nel comitato di direzione della rivista "Il primo amore". Nel 2004 ha fondato le edizioni Effigie.
21
in associazione mafiosa e corruzione: Carlo Antonio Chiriaco, l'imprenditore edile Francesco Bertucca (capo della ‘Locale’ pavese), l'avvocato Pino Neri di Pavia che, insieme ai fratelli Mandalari di Bollate e a Cosimo Barranca di Segrate, era ai vertici della “Lombardia”, un supergruppo criminale. Coinvolti anche l'assessore al Commercio del Comune di Pavia Pietro Trivi, l'assessore ai Lavori pubblici Luigi Greco e il presidente della Commissione comunale Territorio Dante Labate, già socio in affari con la moglie di Neri nell'immobiliare Vittoria.
Nell’indagine, coordinata dal procuratore aggiunto di Milano Ilda Bocassini, si afferma che l’odontoiatra calabrese Chiriaco era un affiliato «a completa disposizione» di Neri e del capo della Locale milanese Barranca “una risorsa insostituibile per la 'Ndrangheta in Lombardia”.
Nel 2003 Chiriaco viene indagato, poi condannato nel 2007, per concorso in esercizio abusivo della professione medica. Dalle intercettazioni emerge anche un traffico di false lauree in medicina con la Bulgaria. La Procura antimafia si sofferma sul rapporto tra il direttore sanitario dell'Asl pavese e Anna Maria Cangianello, Georgita Lupu detta Carmen e Gesualdo Abenavoli, tre “colleghi”, ora indagati per abusivo esercizio di una professione, lesioni personali e truffa. Conversando con Pietro Trivi (un consigliere comunale), il 12 ottobre 2009, Chiriaco precisa che la Cangianiello “qui ha una laurea riconosciuta... dal Ministero... […]... se l’è comprata in Bulgaria attraverso la 'Ndrangheta... […]”. Trivi : “E quindi se l'è comprata la laurea?”; e Chiriaco: "Comprata, va bene!" Comprata!". Aggiunge che il traffico di lauree false era gestito dalla famiglia Sergi di Buccinasco.
Con queste credenziali nel 2008 Chiriaco otterrà, dal direttore generale Simona Mariani, già consigliere regionale di Forza
22
Italia dal 1995 al 2000, la direzione sanitaria dell'Asl pavese. Da essa dipendono gli ospedali della provincia e alcuni centri d'eccellenza, eroga servizi a 530.000 assistiti. Un'azienda in mano a questo tale.
Nella sua Ordinanza, il Gip Andrea Ghinetti rileva che Chiriaco “è in costante contatto con membri direttivi del sodalizio con i quali, dalla propria privilegiata posizione, intesse rapporti di reciproco interesse rendendo possibile la devastante penetrazione del sodalizio nel tessuto economico, politico e amministrativo pavese”.
Esempio di questa capacità della 'Ndrangheta di tessere relazioni è il suo incontro con la Massoneria, di cui Neri fa parte: come leggiamo nelle richieste della Procura Antimafia, “la capacità di fare sistema da parte dell’associazione risulta notevolmente potenziata nell’ambito massonico[…] l’ingresso nelle logge massoniche costituisce il momento di collegamento con ceti sociali in grado di fornire sbocchi per investimenti imprenditoriali, coperture a vari livelli, con conseguente integrazione della 'Ndrangheta nella società civile e abbandono di un atteggiamento di contrapposizione nei confronti di quest’ultima[…] costituisce un momento in cui il sodalizio criminoso passa da corpo separato a componente della società, e pertanto più pericoloso in quanto in grado di mimetizzarsi”.
La 'Ndrangheta ha colonizzato la Lombardia con venti “Locali”, di cui quindici individuate a Milano. Come sottolineano i magistrati della Procura antimafia, “la 'Ndrangheta è largamente presente e attiva in Lombardia, sia in termini di attività sia in termini di associati. In un’intercettazione ambientale del dicembre 2009 Chiriaco si vanta di essere stato insieme a Neri e
23
Pizzata “il capo della N'ndrangheta a Pavia”. L'impresario edile Salvatore Pizzata, socio del Neri e confratello in Massoneria, lo ricordiamo tra gli esponenti di punta della 'Ndrangheta rurale al nord, quella dei sequestri di persona, mediatore tra la cosca Nirta-Strangio e i famigliari di Cesare Casella dopo il suo rapimento nel 1988. Neri era giunto studente a Pavia sul finire degli anni Settanta, poi laureato fuoricorso con una tesi sulla 'Ndrangheta. Arrestato una prima volta il 15 giugno 1994, l'insospettabile tributarista, sarà condannato a nove anni di reclusione per traffico di droga, pena in gran parte scontata agli arresti domiciliari. Secondo gli investigatori, «Neri appare come al centro di un comitato d'affari che, grazie ad appoggi ed entrature nel mondo politico, riesce ad aggiudicarsi lucrose iniziative immobiliari».
Il 30 dicembre 2009 Chiriaco indica nel deputato Gian Carlo Abelli, già vice coordinatore di Forza Italia, il politico ‘amico’ su cui fare convergere i voti delle Locali.
Alle elezioni regionali del marzo 2010 Abelli e Angelo Gianmario, l'altro beneficiario, hanno ottenuto un risultato inferiore alle attese. Tuttavia, secondo gli investigatori “a fronte dell'impegno elettorale profuso dalle famiglie Neri e Barranca a favore dei candidati indicati da Chiriaco, gli esponenti della 'Ndrangheta si aspettavano dei precisi ritorni di carattere economico”.
Da vertigine le pagine dell'Ordinanza sui rapporti tra Chiriaco, Neri e i Filippi, l'ex vicesindaco Ettore e il figlio Luca, ex consigliere comunale, ora nel Cda di Asm.
Alle elezioni amministrative pavesi del 2009, con “sole” 251 preferenze Rocco Del Prete è il primo dei non eletti nella lista Rinnovare Pavia dei Filippi. Del Prete viene indicato «nella piena disponibilità di Pino Neri e il fatto era noto a Neri, Chiriaco e
24
Filippi [...] Deluse le attese di Neri e Del Prete, in vista delle elezioni regionali 2010 Filippi riprende i contatti elettorali con Neri sempre sotto l'egida di Chiriaco. Dopo diversi incarichi presso i Lavori pubblici comunali, non a caso Rocco Del Prete è infine assunto nel maggio 2010 ad Asm Lavoro, guarda il caso, presieduta da Luca Filippi.
Intrallazzi, favoritismi. Da antologia alcuni colloqui tra Luca Filippi e Chiriaco. Nell'agosto 2009 l'Asl esegue dei controlli in un locale di proprietà di Luca. Filippi contatta immediatamente Chiriaco : “Mi hai rotto i coglioni! Tutti i giorni mi mandi l'Asl nei locali”, chiedendo, com'è evidente, un suo intervento risolutivo. Con la radiomobile Chiriaco fa subito presente a un funzionario dell'Asl che il controllo dal Filippi costituiva un problema di carattere politico e dunque andava eseguito con una certa morbidezza’.
Chiriaco possedeva quote in tre società occulte: la Melhouse srl, la Carriebean International Society srl e la P.F.P. srl. Melhouse ha gestito il ristorante La Cueva a Pavia, di cui l'assessore Greco deteneva il 34 per cento. Secondo gli inquirenti Greco è il titolare apparente perché i reali soci sono Chiriaco e Giuseppe Romeo. Quest'ultimo è il nipote di Salvatore Pizzata, condannato nel 1996 per associazione mafiosa e nel 1997 per narcotraffico.
Il 21 febbraio 2009 gli investigatori intercettano una conversazione tra Chiriaco e la sua compagna Danlis Ermelisa Segura Rosis. I due sono in auto, di fronte al ristorante La Cueva:
25
Chiriaco: " Sto stronzo … […] appena fallisce, ce lo compriamo noi [...]".
Chiriaco: “[…] Io andrei da questi qua a minacciarli ... andatevene fuori dai coglioni se no vi faccio saltare! ... anzi gli mandavo quelli di Platì... gli mettono una bomba! ...una bomba nei... (inc.)...”
Segura: “Esce su tutti i telegiornali i primi indagati sono quelli a fianco...”
Chiriaco “No, a fianco... al... nel suo locale... dopo un mese, due mesi, uno va e gli fa un'offerta per... per rilevare il locale, no? ... ovviamente gli offre poco... se questo non capisce , un'altra bomba? (sarcastico) [...]”.
Il quotidiano locale ne scrive come se la minaccia fosse per il ristorante, con l'assessore nei panni della vittima. E perché mai avrebbe dovuto lanciare attentati dinamitardi se, a dar retta al Chiriaco (e agli inquirenti) lui e Greco ne condividevano la proprietà? Rileggiamo allora, più attentamente le parole di Segura: una volta esplosa la bomba, «...i primi indagati sono quelli a fianco». I due non stanno parlando del ristorante La Cueva, ma del bar confinante, il Billà, che Chiriaco si proponeva di rilevare con i suoi mezzi assai spicci.
Il 1° dicembre 2008 in Consiglio comunale di Pavia si discute la proposta di costituire la Commissione antimafia. C'è chi la sostiene apertamente e chi, come Trivi, tenta di soffocarla proponendo un più blando “Osservatorio” e chi, è il caso di Luca Filippi, la vede come conseguenza di un “ingiustificato allarmismo”.
Interviene Trivi (Pdl) e tratta l'arresto di Pelle: «Da parte di un giornale locale sono state fatte delle insinuazioni partendo da un fatto di cronaca vero e accertato […] Un giornale locale ha preteso di costruire tutta una rete di protezione a tutela della
26
latitanza di questo “Pakistan”, con notizie assolutamente infondate e non verificate, notizie che hanno notevolmente danneggiato l'attività di un personaggio pubblico pavese».
Il 18 settembre alla clinica Maugeri è arrestato il boss della 'Ndrangheta Ciccio Pelle “Pakistan”, ricoverato sotto falso nome. Nelle stesse ore a Castel Volturno un commando guidato da Giuseppe Setola, fuggito dagli arresti domiciliari di Pavia, in cura alla Maugeri per un presunto problema agli occhi, in trenta secondi uccide sei inermi immigrati ghanesi. Dopo la fuga da Pavia, in soli cinque mesi, la banda Setola ammazza sedici persone. Il «personaggio pubblico pavese» cui l'indagato Trivi allude è ,guarda il caso, Carlo Antonio Chiriaco, dal 2008 direttore sanitario dell'Asl, dal quale dipendono i ricoveri.
Nel consiglio comunale del 1° dicembre 2008 in difesa di Chiriaco interviene anche Dante Labate: “Associare il suo nome a questo Ciccio Pelle è una cosa vergognosa. Non per niente, il giornale che ha scritto una cosa del genere è stato querelato[…]”.Come ora sappiamo, era tutto vero. Secondo l'antimafia si sarebbe trattato di un favore alle cosche di San Luca con l'intermediazione di Cosimo Barranca, il capo della Locale milanese.
Trivi lo ritroviamo tra gli avvocati schierati a difesa di Rosanna Gariboldi, la moglie di Abelli, imprigionata il 20 ottobre 2009, per il riciclaggio monegasco del denaro sporco di Giuseppe Grossi, un amico di famiglia. Ebbene, secondo gli investigatori, il direttore sanitario dell'Asl pavese Chiriaco si era reso disponibile a creare false prove per dimostrare la sua "incompatibilità" col regime carcerario.
27
Ha proprio ragione Marco Vitale quando, sul Corriere della Sera del 28 luglio, afferma che “la Lombardia si sta muovendo, fatte le dovute e per ora grandi distinzioni, verso il modello Calabria”. Vitale pone l'accento sulla corruzione, aggiungendo che “la sottovalutazione del fenomeno è la premessa prima per il radicamento e lo sviluppo delle mafie”.
Lo si è visto bene a Pavia, luogo dove, parola dell'ex poliziotto e vicesindaco Ettore Filippi, “la mafia non esiste”; luogo dove – lamentava il figlio Luca in Consiglio comunale – la denuncia dei segnali di penetrazione mafiosa in città è frutto di esagerazioni; luogo dove il consiglieri comunali Valerio Gimigliano e Carlo Alberto Conti definirono “superfluo” un emendamento antimafia alle linee guida del Piano di governo del territorio.
Urbanistica? Terreni? Affari? E perché mai dovrebbero interessare alle cosche. È forse solo un caso se, nelle intercettazioni, Neri parla di “cose carine, occasioni buone da prendere volando”, come l'acquisto all'asta per 5.000 euro di 11.000 metri quadrati di terreno a Borgo Priolo. O, sempre a Pavia, di “soldi da investire” che Chiriaco dovrà “riciclare” in un affare.
Sempre per caso, Chiriaco e merenderos progettano una cittadella tra l'idroscalo e il gasometro di piazza Europa, con il conforto di 15-20 milioni in fondi europei Chiriaco parla di «provvigioni» del 20 per cento destinate a Trivi e al presidente della Commissione comunale Territorio, il calabrese Dante Labate (ex An).
Urbanistica, terreni, affari e molto altro. Ma, per Gimigliano, l'Ordine del Giorno antimafia era “superfluo”.
A Chiriaco viene anche contestata l'intestazione fittizia di numerosi beni a vari prestanome; di mantenere rapporti con
28
varie amministrazioni comunali al fine di ottenere favoritismi quali l'aggiudicazione di appalti, il mutamento di Piani regolatori; di mantenere rapporti privilegiati con esponenti del mondo bancario al fine di sostenere finanziariamente investimenti occulti ed iniziative immobiliari; di essersi attivato per il mutamento del Prg di Pavia e per la pratica edilizia inerente l’Immobiliare Bivio Vela s.r.l. al fine di sostenere i suoi interessi e di soggetti a lui legati.
Fra le tante cariche di Chiriaco si segnala quella nel Cda della Dental Building spa – fortemente voluta da Abelli e Formigoni, era una partecipata al 60 per cento dell'ospedale milanese San Paolo – presso cui Pasquale Libri ha lavorato come funzionario amministrativo. Il 19 luglio scorso il trentasettenne Libri muore cadendo dall'ottavo piano giù nel vano scale: suicidio o suicidato? Dopo la chiusura della fallimentare Dental Building, Libri lo ritroviamo dipendente al San Paolo, di cui è direttore generale il pavese Giuseppe Catarisano (altro componente del Cda di D.B., già direttore amministrativo del San Paolo), padre del consigliere comunale di Pavia Armando Catarisano. Sua moglie ha mantenuto quote dell’Azzurra srl (settore costruzioni costituita nel 1997) con Rosanna Gariboldi (moglie di Giancarlo Abelli, incarcerata per riciclaggio di denaro sporco) e Barbara Magnani, moglie del chirurgo Pier Paolo Brega Massone, quest'ultimo dietro le sbarre per lo scandalo dei trapianti facili al Santa Rita . Azzurra è ormai in liquidazione.
Come ammette Chiriaco, la sua «squadra funziona che è una meraviglia». Pasquale Libri era parente del boss Rocco Musolino e in rapporti con le cosche di Platì. Alla San Paolo si
29
occupava degli appalti. Non è forse per caso se l'Antimafia sta indagando sulla ristrutturazione del milanese Pio Albergo Trivulzio: un filone di ricerca legittimato da alcune intercettazioni. Giova qui ricordare che un'altra inchiesta della Dda sta verificando le possibili infiltrazioni della 'Ndrangheta negli appalti di tre strutture del San Matteo di Pavia. Come è emerso poi anche dalle indagini della Procura antimafia «i lavori li avrebbe dovuti svolgere la Makeall spa, una società di Milano considerata nella totale disponibilità della 'Ndrangheta per lavori di ogni tipo» (Davide Carlucci, “la Repubblica”, 11 agosto 2010).
Modello lombardo o siculo-calabrese? Al “capitale di rischio” si sostituisce il ricavato esentasse dal narcotraffico, dalla vecchia usura, dal traffico d'armi e dei rifiuti. Non solo appalti: le mafie sembrano ormai puntare al vitalizio della gestione. Un business legale.
Ne troviamo traccia in una conversazione del 30 gennaio 2010 tra Carlo Chiriaco e Antonio Dieni. Era presente Pino Neri e Carlo Chiriaco spiega come funziona il meccanismo. : “La Regione copre il 60 per cento delle spese con la quota, che è il contratto... da un minimo di 36 euro a, un massimo di 60 euro.... più e grave, più la Regione ti dà. Tu capisci che se hai 120 posti letto ed hai una media di 45/50 euro al giorno, sono 7500 euro al giorno, poi tu stabilisci che la retta deve essere di 100 euro al giorno, la differenza te la dà il privato che ...”
Antonio Dieni: “.... 700, 800 li ha....”
Chiriaco: “... l'altro prezzo lo integrano i familiari e se non ha i familiari, te lo integra addirittura il comune, funziona così”.
Dieni: “ Soldi sicuri”.
Nelle pagine dell'inchiesta, il nome di Libri ricorre con una certa frequenza (è più volte intercettato a conversare con Chiriaco) in relazione al consigliere regionale Angelo Gianmario
30
(Pdl), di cui le cosche avrebbero favorito l'elezione. Per qualche tempo Libri e la moglie Sonia Suraci, nipote del boss Musolino, hanno avuto casa a Pavia.
Il 13 dicembre 2008 è intercettata una conversazione tra Libri e Chiriaco sulla costellazione delle principali famiglie mafiose di Reggio Calabria e dintorni. Il 23 luglio 2008 a Salto della Vecchia, Musolino aveva subito un attentato, ora, si sente in pericolo e vuole andarsene:
Il 25 aprile 2009 Chiriaco e Libri tornano sull'argomento:
Libri: “Ma secondo te gli conviene comprare case?”
Chiriaco: “Guarda … io …”
Libri: “Uhm…”
Chiriaco: “Ho la possibilità di fargli fare begli affari …”
Libri: “E glielo dico … Ma lui guarda, non lo so …”.
Chiriaco: “Tutta roba …”
Libri: “Pulita …”
Chiriaco: “Pulita … di noi ti puoi fidare …”.
Libri: “Uhm…”
Chiriaco: “Io so come gestirgli, in… in attività immobiliare… eh, faccio un esempio…”
Chiriaco: “A lui conviene comprarsi interi caseggiati … cioè fare un'operazione unica di venti, quindici milioni di euro”.
Libri: “E infatti lei sta guardando questo … in teoria, però no … poi ha sempre degli scatti secondo me verso cose … non tanto … anche perché lui dice che ormai l'attività sua è …
33
Due volti
di Emilia Lacroce
Due volti, due espressioni opposte: il sorriso di un bambino e il terrore di una donna. È questo quello che mi viene in mente se ripenso alla manifestazione “No ‘ndrangheta”, svoltasi a Reggio Calabria lo scorso 25 settembre. La donna terrorizzata era una commerciante che
guardava il corteo attraverso la vetrina: entro nel negozio, in mano solo un taccuino rosso e la macchina fotografica; lei la guarda, la scambia per un registratore e mi volge uno sguardo impaurito. La rassicuro, ma non basta…di ‘ndrangheta e di manifestazioni non vuole parlare.
Il sorriso è quello di un bimbo che sfilava con i suoi genitori e quello di tante bimbe sui pattini, o sul palco, in piazza Duomo, a fianco al procuratore Di Landro.
Due volti, una medaglia a due facce, un Giano bifronte: è la mia Calabria. La paura di parlare e il coraggio di lottare. Eravamo in tanti a Reggio...ma ancora pochi.
La manifestazione “No ‘ndrangheta” è stata organizzata dal “Quotidiano della Calabria” in seguito alle ultime intimidazioni subite dal procuratore della città, Salvatore Di Landro. La ‘ndrangheta si è fatta ripetutamente sentire in questi mesi, l’ultima volta con una bomba contro il portone della sua abitazione. All’iniziativa contro la criminalità organizzata hanno partecipato sindaci arrivati da ogni parte della regione con i propri gonfaloni, parlamentari calabresi e componenti del
34
Consiglio e della Giunta della Regione Calabria. Tantissime le associazioni presenti, i sindacati, i movimenti. C’erano anche i ragazzi di “Ammazzateci tutti”: osservare loro significa avere davanti il fallimento di quella parte dell’antimafia calabrese fatta di conferenze, di interviste, di protagonismi vuoti che non trascinano il resto della società civile, non la coinvolgono e inevitabilmente muoiono.
Lungo il corso di Reggio, mentre il corteo si dirigeva verso il palco di piazza Duomo, i sorrisetti di tante persone ferme sui marciapiedi sembravano dirci “poveri illusi, pensate che manifestare serva a qualcosa…”. Non pensiamo che risolva qualcosa ma serve a darci speranza, serve a dirci: ci siamo, la Calabria c’è, c’è l’antimafia di cui abbiamo bisogno, quella del giorno prima e non del giorno dopo, come ha ricordato dal palco don Pino Demasi, referente di Libera per la Piana di Gioia Tauro.
“I mafiosi temono che il meccanismo di paura su cui si reggono i loro affari possa essere d’improvviso arrestato”: è Roberto Saviano a parlare, con una lettera letta da un giovane attore; questo meccanismo di paura si rompe decidendo di esserci, di resistere, di parlare, di gridare, di restare a difendere la nostra terra, per riappropriarcene. La mafia di tutto questo ha paura. Armiamoci di speranza che genera coraggio, perché, come diceva A. de Saint-Exupery ,“non ereditiamo la terra dai nostri avi, ce la facciamo prestare dai nostri figli”.
36
Intervista a Jože Pirjevec
Sottotito lo
di Primož Sturman
Jože Pirjevec (Trieste 1940) insegna Storia contemporanea presso l'Univerza na Primorskem-Università del Litorale che ha la propria sede a Capodistria in Slovenia. È autore di saggi e ricerche storiografiche sulla Jugoslavia, nonché sui paesi
dell'Europa orientale. Tra le sue opere più importanti in lingua italiana possiamo annoverare Tito, Stalin e l'Occidente (Editoriale Stampa Triestina, Trieste, 1985), Il giorno di San Vito. Jugoslavia 1918-1992: storia di una tragedia (Nuova Eri, Torino, 1993), Storia degli sloveni in Italia (con Milica Kacin Wohinz, Marsilio, Venezia, 1998), Le guerre jugoslave (Giulio Einaudi, Torino, 2001), Foibe, Una storia d'Italia (Giulio Einaudi, Torino, 2009). Ottimo conoscitore della storia dell'est europeo, Pirjevec ci ha nell'intervista che segue dischiuso gli orizzonti sulle vicende della nascita e dell'evoluzione della criminalità organizzata nei paesi dell’area danubiana e balcanica.
Primož Sturman: Professor Pirjevec, da quale sostrato germoglia, quando nasce e come si sviluppa la criminalità organizzata nei Balcani?
37
Nella coscienza collettiva balcanica lo stato è stato per lungo tempo inteso come nemico. Mi riferisco qui in particolar modo all'Impero ottomano. Infatti, i turchi venivano visti come oppressori, per questo nel periodo della dominazione ottomana si sono sviluppate molte organizzazioni clandestine, per esempio le čete, locuzione dalla quale deriva la parola cetnici, ma anche i kleptes, gli hajduki, gli armatoloi e via dicendo. Queste organizzazioni criminali sfidavano lo stato ottomano di allora. Anche dopo la nascita degli stati nazionali indipendenti – la Serbia per esempio si formò dopo le rivolte del 1803 e del 1815 –, questi ultimi furono molto dispotici, quindi lontani da ogni forma di democrazia. La gente continuava perciò a sentirsi oppressa. La tradizione dello stato inteso come nemico e dell'esigenza del tener conto in primo luogo del proprio particolare infischiandosene del bene pubblico è ancora oggi molto radicata nei Balcani. Quest'area è difatti parecchio frammentata dal punto di vista nazionale, linguistico e religioso. È difficile quindi in un contesto del genere trovare punti di convergenza ed è altrettanto complicato parlare di una coscienza civile sviluppata, tipica della Scandinavia o dell'Europa centrale.
Come si sviluppa e quali aspetti assume quindi la criminalità organizzata sullo scenario balcanico?
Dopo la prima guerra mondiale e la nascita del Regno dei serbi, dei croati e degli sloveni, poi Regno di Jugoslavia, il nuovo stato non è ben visto da molti, specie dagli albanesi del Kosovo e dai macedoni. Costoro si organizzano clandestinamente, compiendo una serie di azioni terroristiche e praticando di sovente il contrabbando. Queste organizzazioni sono quindi terroristiche e criminali allo stesso tempo.
38
Possiamo assistere a dei mutamenti significativi con l'avvento del regime comunista?
Nemmeno i regimi comunisti del dopoguerra sanno estirpare la criminalità organizzata, poiché questi stessi sistemi sono loro stessi corrotti. La Jugoslavia di Tito, specie dopo il 1948, quando le viene imposto l'embargo da parte dell'URSS di Stalin, fa ampio ricorso al contrabbando per questioni legate alla sopravvivenza. Molto attivi sono in questo senso i servizi segreti jugoslavi (UDBA). Poco tempo fa ho infatti reperito dei documenti che comprovano il fiorire rigoglioso del contrabbando in quel periodo, diretto non dall'UDBA centrale, ma dalle sue cellule locali. Nel 1951 ci sono notizie di una nave dell'UDBA slovena, chiamata Martin Krpan
1. Il capitale così accumulato viene successivamente investito nello sviluppo economico e industriale di questa repubblica jugoslava.
Trieste è in quel periodo il naturale sbocco commerciale dell'intera Jugoslavia.
La città di Trieste vive negli anni Settanta un fenomeno quasi unico nella storia. Molti jugoslavi sono infatti impiegati all'estero e inviano ai propri parenti ingenti somme di denaro che poi si riversano sulle colonne di automobili e autobus in direzione della
1 Martin Krpan – eroe letterario sloveno, dedito al contrabbando per professione, creato dallo scrittore Fran Levstik (1831-1887) sulla base di racconti popolari.
39
città giuliana. Il contrabbando che parte da Trieste arriva sino a Vladivostok sull'Oceano pacifico. Si contrabbanda vestiario, oro, ma anche pezzi di ricambio, piccoli elettrodomestici e caffè. Verso la fine degli anni Settanta il ministro delle finanze svizzero divulga la notizia di ingenti somme, depositate su conti segreti in Svizzera, intestati a cittadini jugoslavi.
L'esplosione si verifica quindi con lo sfacelo della Jugoslavia negli anni Novanta.
Forse già prima. Lo stato socialista, ormai orfano di Tito, morto nel 1980, entra presto in crisi. Nel 1981 c'è un'imponente rivolta albanese nel Kosovo, duramente repressa dal regime. Gli albanesi si organizzano in uno stato parallelo, dotato di proprie strutture: scuole, ospedali e quant'altro. I finanziamenti provengono dall'attività dalle bande albanesi che nell'Europa occidentale si erano specializzate nel traffico di droga.
Arriviamo quindi allo scoppio vero e proprio della guerra.
L'aspetto criminale si diffonde in tutti i Balcani, in particolare nel Montenegro, in Serbia, Bosnia ed Erzegovina, ma anche in Croazia, specialmente dopo il 1991 e il 1992, date che segnano la dissoluzione della Jugoslavia. Alla fine del 1991 le Nazioni unite impongono infatti un embargo sulla vendita delle armi a questi paesi, ufficialmente per arginare la guerra. Non è quindi concesso il commercio legale d'armi e questo dà adito ad un fiorente commercio illegale. Tutti quanti vi sono implicati, anche gli stati occidentali, compresi gli USA che chiudono entrambi gli occhi quando è l'Iran a fornire armi agli eserciti dei croati e dei musulmani della Bosnia.
40
È secondo lei verosimile l'ipotesi che l'esplosivo, utilizzato nel 1992 per l'attentato in cui perirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e la scorta, sia stato acquistato illegalmente nell'Ex-Jugoslavia?
Sì, lo è. L'Armata popolare jugoslava era, infatti, molto ben armata e i depositi d'armi nel 1992 vengono saccheggiati un po' da tutti. Il presidente croato Franjo Tuñman già nel settembre del 1991 ordina di occupare le caserme jugoslave. La maggior parte degli armamenti rimane comunque in mano ai serbi della Bosnia, organizzati militarmente da Ratko Mladić. La Bosnia è infatti disseminata di depositi di armi, poiché la Jugoslavia sin dal 1948 aveva elaborato la dottrina che in caso di invasione del paese da parte delle truppe del Patto di Varsavia prevedeva il ritiro dell'esercito nelle zone montuose della Bosnia sino alla costa, mentre nelle aree pianeggianti sarebbe stata organizzata la guerriglia partigiana.
Se non sbaglio anche la città di Sarajevo conosce durante l'ultima guerra un fiorente traffico illegale.
La storia di Sarajevo è molto particolare. Nel 1992 inizia difatti il suo assedio che dura sino al 1995. La difesa contro i serbi viene in un primo momento organizzata dai gangster presenti in città allo scoppio della guerra. Sotto l'aeroporto viene scavato un tunnel che collega la città con il monte Bjelašnica e attraverso il quale vengono portate in città molte merci: viveri, armi ecc. Nel 1993 l'allora capo del governo bosniaco Haris Silajñić reprime queste bande, ma il contrabbando continua a
41
fiorire. Quasi tutte le elite politiche balcaniche di questo periodo si compromettono con i traffici illegali.
Per esempio?
Voglio in questa sede citare Mirjana Marković, moglie di Slobodan Milošević, ma anche il presidente montenegrino Milo Đukanović. In Croazia il clan degli erzegovesi ricopre molti incarichi importanti durante l'era Tuñman. Risalgono a questo periodo anche i traffici illeciti che vedono protagonisti la criminalità organizzata montenegrina e le mafie italiane, specie la Sacra corona unita, che realizzano un fiorente traffico di sigarette.
La criminalità organizzata è quindi autoctona e trova nei Balcani un terreno molto fertile.
La simbiosi tra le elite politiche dei Balcani e la criminalità organizzata in questo periodo è quasi totale e questo fatto ancora oggi condiziona la vita sociale dei Balcani. La situazione odierna del Kosovo ha dell'incredibile, poiché la corruzione regna sovrana e le mafie locali detengono in mano tutto il potere. È quindi una situazione per certi versi molto simile a quella che possiamo riscontrare nel Mezzogiorno italiano.
42
Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie
Da 15 anni a serviz io del la legalità
di Paolo Martinelli
Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie nasce formalmente il 25 marzo del 1995 su ispirazione di don Luigi Ciotti, all’indomani delle stragi di Capaci e di via D’Amelio. In realtà questa novità nel panorama della lotta alla mafia ha origini motivazionali
ben più lontane nel tempo. Nell’ormai lontano 1982, in seguito all’omicidio del generale Dalla Chiesa, il parlamento italiano approvò una legge che pose le basi per la nascita dell’associazione. La legge Rognoni-La Torre (n. 646 del 13/09/1982) introdusse, infatti, per la prima volta il termine “mafia” all’interno dell’ordinamento italiano, grazie all’elaborazione dell’art. 416 bis del codice penale. Con questo articolo fu possibile introdurre il reato di associazione di stampo mafioso oltre che il sequestro e la confisca dei beni acquisiti illecitamente al fine di colpire il potere economico delle mafie. Gli anni successivi, ricchi di eventi decisivi nell’attività di contrasto alla mafia siciliana (costituzione del pool antimafia della procura di Palermo, istituzione del maxiprocesso, proliferarsi del fenomeno dei collaboratori di giustizia) portarono alla stagione
43
stragista scatenata dai “corleonesi”, che culminò con l’omicidio dei giudici Falcone e Borsellino e con le bombe di Roma e Firenze. Fu allora che la disperazione e lo sdegno della società civile venne costruttivamente canalizzata nella costituzione di una associazione organizzata sotto forma di coordinamento che oggi conta circa 1500 tra gruppi, scuole, realtà di base, territorialmente impegnate per costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di diffondere la cultura della legalità. La prima grande iniziativa dell’associazione fu un elemento fondamentale, che pose con grande successo le basi per il lavoro che sarebbe poi stato portato avanti, con impegno e coerenza, negli anni successivi. Nel 1996 Libera raccolse oltre un milione di firme per presentare una legge di iniziativa popolare che prevedesse il riutilizzo ad uso sociale dei beni confiscati alle mafie. Questa importante novità, introdotta dalla legge n°109 del 1996, ha permesso il riutilizzo ad uso sociale di quei terreni o quei beni acquisiti illecitamente dai mafiosi che venivano loro sottratti in virtù della legge Rognoni-La torre, ma che venivano lasciati incolti o in abbandono dallo Stato, fornendo sul territorio ad elevata densità mafiosa l’immagine di uno Stato incapace di gestire le risorse acquisite.
Nello specifico la legge 109/96 si occupa della gestione dei beni immobili (case, terreni, fondi) che possono essere conservati al patrimonio dello stato per specifiche finalità istituzionali (ad es. giustizia, ordine pubblico, protezione civile) oppure trasferiti al patrimonio del comune sul cui territorio sono situate al fine di un riutilizzo ad uso istituzionale oppure sociale. Entro un anno dall’acquisizione del bene, l’amministrazione comunale interessata deve scegliere se optare per un’amministrazione diretta dello stesso (ad es. uffici comunali, scuole, asili, parchi pubblici, centri sociali o di aggregazione ecc.) oppure per un’assegnazione pubblica in concessione
44
gratuita a enti, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche e centri di recupero per tossicodipendenti, ecc. Generalmente gli immobili confiscati per reati legati al traffico di stupefacenti vengono prioritariamente trasferiti al comune ed assegnati ad associazioni, comunità terapeutiche per tossicodipendenze. La proposta di assegnazione viene effettuata dall’Ufficio del territorio del Ministero delle Finanze entro 90 giorni ,una volta definito il valore del bene, sentiti i pareri del Prefetto e del Sindaco. Infine, entro 30 giorni dalla proposta, il Direttore centrale del demanio del Ministero delle Finanze emetterà il provvedimento di assegnazione.
Sconcertanti sono i dati resi pubblici dall’Agenzia del Demanio sui beni sequestrati, che a giugno 2009 si attestavano a circa 9000 beni e oltre 1000 aziende ripartite su tutto il territorio nazionale per un ammontare di oltre 600 milioni di euro. La diffusione del fenomeno è stata ulteriormente confermata da Mario Morcone, direttore dell' Agenzia per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che in occasione dell’assemblea dell’OSCE svoltasi a Palermo lo scorso settembre ha dichiarato che sono oltre 11 mila i beni confiscati tra cui un migliaio di aziende italiane. A partire da questa esperienza Libera, insieme ad altre realtà impegnate nella lotta alla criminalità organizzata, si è prodigata nella diffusione del concetto di “antimafia sociale”, una nuova cultura dell’antimafia che tramite il risveglio delle coscienze, l’istruzione, il lavoro, la memoria, la tutela e la rivendicazione dei diritti, possa prevenire il dilagare di fenomeni delinquenziali e sostenere l’opera dei magistrati e degli organi di polizia
45
impegnati nel contrasto repressivo delle mafie e delle criminalità organizzate.
La gestione e la rimessa a coltura dei terreni confiscati attraverso cooperative agricole sociali ha permesso, col tempo, lo sviluppo del marchio Libera Terra come certificato di garanzia di prodotti alimentari (pasta, vino, olio, miele, ortaggi, ecc.) provenienti dalle terre riscattate: si tratta di alimenti biologici coltivati nel rispetto dei cicli naturali e delle tradizioni locali, ma soprattutto frutto della legalità e del riscatto sociale, spesso attraverso inserimenti lavorativi di persone svantaggiate. Negli ultimi anni la crescita della produzione, grazie alla nascita di nuove cooperative e allo sviluppo di quelle originarie, ha permesso una maggiore offerta di prodotti, a cui è corrisposta la necessità di un ampliamento della rete di distribuzione dei prodotti a marchio Libera Terra. Infatti, oltre alla commercializzazione tramite i punti vendita Coop, si sta sviluppando una rete sempre più numerosa che, ad oggi, conta quindici botteghe sparse sul territorio nazionale. Le botteghe dei “Saperi e Sapori di Legalità”, nate da esperienze associative differenti, hanno l’obiettivo di coniugare la promozione e la diffusione dei prodotti Libera Terra, in collaborazione con i coordinamenti territoriali di Libera, con la trasmissione dei valori, delle storie e dei volti delle persone che lavorano sui terreni confiscati.
La diffusione di questi prodotti, importante sostegno economico per le cooperative, diventa attraverso le botteghe opportunità per la creazioni di vere e proprie relazioni personali che non permettono di tacere alle intimidazioni e agli atti vandalici che molto spesso le cooperative stesse subiscono.
In quest’ottica sono nate le esperienze estive (e non) dei campi di lavoro frequentati da giovani provenienti da tutta Italia e
46
dall’estero, che, ogni anno, sono ospiti delle cooperative che gestiscono i terreni confiscati, facendo esperienza diretta di volontariato e di formazione civile, incontrando personalmente i volti dell’antimafia e approfondendo lo studio del fenomeno mafioso attraverso incontri e seminari al fine di sviluppare un protagonismo capace di un impegno di responsabilità e condivisione. La campagna “E!State liberi” 2010 ha coinvolto circa 3000 volontari provenienti da tutta Italia ospiti di dodici diverse località ripartite nelle quattro regioni ad elevata intensità mafiosa.
Un altro elemento cardine dell’antimafia sociale è l’importanza di fare memoria delle vittime innocenti, che, con il loro impegno e con la loro coerenza, sono diventati esempio di coraggio e perseveranza in questa difficile battaglia. L’obiettivo è di ricercare una condivisione ed avviare cammini comuni con i familiari delle vittime affinché, avendo subito un lutto e risorgendo dal proprio dramma, possano trasformare il dolore in uno strumento non violento di impegno e di azione di pace quotidiana alla ricerca di una giustizia vera.
Attraverso la sua azione Libera, oltre a dare assistenza legale e psicologica ai familiari, ha elaborato una banca dati per restituire il “diritto della memoria” a coloro i quali è stato negato il diritto alla vita, ricostruendo le storie delle vittime, associando ai loro nomi un volto. A partire dal 1995, inoltre, ogni 21 marzo (primo giorno di primavera simbolo di speranza e di riscatto) Libera dà testimonianza pubblica di ciò, dedicando un’intera giornata alla Memoria e all’Impegno per ricordare questi morti, incontrando i familiari ed organizzando insieme a loro un corteo pubblico lungo il quale vengono ricordati i nomi delle oltre
47
settecento vittime conosciute dal 1893 ad oggi e, come recita il manifesto, di “...tutti gli altri di cui non siamo ancora riusciti a conoscere il nome.”
L’antimafia della memoria rimarrebbe lettera morta se tutto ciò non fosse accompagnato da un impegno giornaliero nella creazione di una cultura della legalità intesa non come mero rispetto delle leggi e semplice azione sanzionatoria e coercitiva nei confronti di chi non le rispetta, ma come concetto strettamente legato a quelli di solidarietà, responsabilità civile, cittadinanza attiva, inclusione, partecipazione, tutela e affermazione dei diritti individuali e collettivi, nel tentativo di opporsi a quel concetto di “legalismo” che tende a separare il dettato formale della legge dallo scopo sociale per cui la legge stessa viene elaborata. Quest’ultima pericolosa logica, infatti, rischierebbe di legalizzare ciò che, nei fatti, risulta ingiusto per la collettività.
Nel tentativo di effettuare una rovesciamento di questi schemi mentali, che troppo spesso tendono a farsi spazio nell’ottica comune, Libera ha dedicato un importante spazio delle proprie attività alla formazione e all’informazione.
Rispetto alla formazione Libera (riconosciuta come ente di formazione accreditato presso il ministero dell’istruzione) ha avviato una serie di attività in collaborazione con scuole, università, associazioni al fine di formare ed informare migliaia di studenti, cittadini ed operatori a queste tematiche avvalendosi di strumenti diversi a seconda dei destinatari: da riviste e periodici (Animazione Sociale, Narcomafie) a percorsi di formazione sul tema della cittadinanza (Progetto Abitare i margini) e della legalità (Progetto Sapere per saper essere), dallo sviluppo di archivi e database (Liberanet, Banca dati del Gruppo Abele) alla pubblicazione di volumi, dalla creazione di concorsi nazionale in
48
tema di educazione alla legalità (Progetto Regoliamoci) alla promozione di iniziative per la diffusione di una cultura dello sport che rinneghi l’utilizzo di sostanze dopanti ed il perseguimento della vittoria ad ogni costo (Progetto Libera Sport).
In materia di informazione, invece, è nata nel 2007 la Fondazione Libera Informazione con l’obiettivo di mettere in rete le diverse realtà raccogliendo e diffondendo notizie, informazioni, spunti e progetti, ma soprattutto con l’obiettivo di esercitare opera di pressione sui mass media al fine di dare spazio a notizie che spesso faticano a trovare spazio nei palinsesti di radio e tv e sulle colonne dei giornali. Ciò è stato possibile anche grazie alla creazione dell’Osservatorio multimediale sull'informazione per la legalità contro le mafie che rappresenta un punto di collegamento, di sostegno e di visibilità per i giovani e le iniziative editoriali che nei territori mantengono alta la denuncia.
I settori di ricerca e formazione di Libera diventano centrali nell’elaborazione delle relazioni e dei rapporti presentati in occasione di “Contromafie” evento definito “stati generali dell’antimafia” dove gli associati, gli operatori, le cooperative, le associazioni, i cittadini e le istituzioni si incontrano per fare il punto sullo stato della lotta alle mafie.
Lo sviluppo di una coscienza in contrasto alla diffusione dei fenomeni mafiosi e malavitosi, non può però prescindere dalla consapevolezza che questo è un fenomeno organizzativo, militare e culturale che non conosce confini territoriali. Questo ha portato alla necessità di sviluppare una rete internazionale di società civile e associazionismo che monitori la dimensione
49
transnazionale del fenomeno che si fonda su alleanze e complicità che vanno ad accrescere i guadagni illeciti attraverso settori criminali come il traffico di esseri umani, di sostanze stupefacenti, di armi, ecomafie, sfruttamento del lavoro (e del lavoro minorile), riciclaggio di denaro sporco ecc. In tal senso Libera si è fatta portavoce di una campagna per l’estensione a livello europeo della legge sull’uso sociale dei beni confiscati, il riconoscimento del reato associativo ed un rafforzamento della cooperazione investigativa e giudiziaria. In tal senso, la nascita di FLARE (Freedom, Legality And Rights in Europe) ha proprio l’obiettivo di monitorare, reagire e contrastare le reti criminali internazionali attraverso un’azione di denuncia propositiva verso le istituzioni europee affinché attuino politiche conformi alla cultura della legalità, alla partecipazione democratica e alla promozione dei diritti.
A livello internazionale altri progetti vengono portati avanti in America latina con l’obiettivo di fare memoria; è il caso della ricerca degli esuli scapati, negli anni ’70, dalla dittatura militare argentina ,spesso a loro stessa insaputa perché ancora neonati, oggi sparsi in tutto il mondo sotto altra identità per evitare le persecuzioni e la sorte di molti loro connazionali, tristemente conosciuti come desaparecidos. Altre importanti iniziative hanno, invece, l’obiettivo di rendere giustizia alle vittime e alle persone che subiscono violenze in diverse parti del mondo, è il caso ad esempio del pProgetto sull’osservatorio andino, in Colombia, con l’obiettivo di documentare ed analizzare la realtà colombiana dando voce alle vittime e alle organizzazioni popolari, ai movimenti sociali, alle ONG per i diritti umani, che lavorano in prima linea a fianco delle vittime del conflitto.
51
Una vita di ricerca in onore di Peppino Impastato
Intervista a Umberto Santino
di Enrico Santus
Umberto Santino ha fondato e dirige il Centro siciliano di documentazione "Giuseppe Impastato" di Palermo. Da decenni é uno dei militanti democratici più impegnati contro la mafia ed i suoi
complici. È uno dei massimi studiosi a livello internazionale di questioni concernenti i poteri criminali, i mercati illegali, i rapporti tra economia, politica e criminalità. Innumerevoli le sue opere, che si sono concentrate sopratutto sulla criminalità organizzata in Sicilia.
Enrico Santus: Inizierei proprio da una notizia di qualche giorno fa, ovvero la diffida legale a Roberto Saviano per le pagine 6-7 del libro La parola contro la camorra. Perché avete preso questa decisione? Lasciando da parte l'ammirazione per il rigore e lo scrupolo con cui lavorate, nonché la scarsa propensione all'apparire sui media (in un testo parla del Centro come "poco telegenico"), ci si potrebbe chiedere: visto che state dalla stessa parte della barricata, non si poteva "chiudere un occhio"?
Ci siamo decisi a inviare una lettera di diffida all'editore Einaudi perché dopo il lancio del libro di Saviano La parola contro la camorra sulle pagine del quotidiano "La Repubblica"
52
avevo inviato una lettera in cui documentavo, date alla mano, che l'affermazione che i film I cento passi aveva "riaperto il processo" ai responsabili del delitto Impastato non rispondeva al vero. Le inchieste erano state aperte, chiuse e riaperte varie volte e i processi ai mandanti erano cominciati prima dell'uscita del film. E la Commissione parlamentare antimafia, anche per nostra sollecitazione, già nel 1998, aveva costituito un comitato per indagare sul depistaggio delle indagini. La lettera, inviata il 25 marzo, fu pubblicata il 3 aprile, dopo un nostro sollecito (ci hanno detto che volevano controllare le date e chiedere a Saviano di replicare) con un grosso taglio. Da allora non è accaduto nulla, Saviano non si è fatto vivo e il libro ha continuato a circolare. Ora ho incaricato due avvocati di fare la diffida e non posso che prendere atto che, a parte il "Corriere della sera" e "Liberazione", nessun altro giornale ha riportato la notizia. Si è creato il mito del “profeta-eroe-martire” che pronuncia la Parola, come il Verbo del Vangelo di Giovanni, e qualsiasi critica, anche la più fondata, è vista come un peccato mortale, un delitto di lesa maestà. Il bigottismo imperante è una forma di omertà. Non si tratta di "chiudere un occhio" ma di affermare la verità dei fatti e non so se si possa parlare della "stessa barricata". Noi siamo per un'analisi rigorosa e documentata, un impegno quotidiano, un'antimafia sociale, lontano dai protagonismi mediatici che vogliono l'eroe alla testa della Guerra Santa contro il Male del mondo. E siamo lontanissimi dal giovane Saviano quando dice che il ministro Maroni "sul fronte antimafia è uno dei migliori ministri dell'Interno di sempre". Maroni è un leghista, cioè razzista dalla testa ai piedi, e si gloria degli arresti dei mafiosi operati da forze dell'ordine che non hanno neppure la benzina
53
per far camminare le macchine e da magistrati che quando indagano su Berlusconi e condannano Dell'Utri sono marchiati come "toghe rosse". Questo ecumenismo somiglia, molto da vicino, al vecchio qualunquismo.
Quanto alla poca "telegenicità" del Centro, voglio precisare che ci hanno intervistato televisioni nazionali ed estere. Le prime o non hanno mandato in onda nulla (La storia siamo noi, L'elmo di Scipio) o qualche coriandolo (Blu notte), qualcosa di più in uno speciale Tg3, Primo piano dedicato a Peppino Impastato. Altre ci hanno dedicato maggiore attenzione. Per fare un esempio, della scarsa attenzione dei media, a cominciare dai giornali di sinistra, L’unità e Il manifesto, quando nel 1979, nel primo anniversario dell'assassinio di Peppino, abbiamo organizzato una manifestazione nazionale contro la mafia (la prima della storia d'Italia) non ci hanno dedicato neppure una riga. Gli unici giornali che ci dettero una mano, Il quotidiano dei lavoratori e Lotta continua chiusero poco dopo.
Il Centro Peppino Impastato nasce dal primo centro di studi sulla mafia fondato in Italia, nel 1977. I fondatori siete voi, Umberto Santino e Anna Puglisi. Solo dopo la morte di Peppino Impastato, il 9 maggio 1978, il Centro viene rinominato. Di cosa si occupa?
Il Centro siciliano di documentazione è stato intitolato a Giuseppe Impastato nel 1980 quando si è costituito formalmente come associazione culturale. Il Centro fa ricerca, interviene nelle scuole, sostiene le iniziative che si svolgono sul territorio. Abbiamo avuto un ruolo decisivo nella vicenda di Peppino, per salvarne la memoria, da chi lo voleva terrorista e suicida, e per ottenere giustizia. E' una battaglia vinta, anche se con pesante ritardo: i mandanti dell'assassinio sono stati condannati, la
54
Commissione parlamentare antimafia nel 2000 ha approvato una relazione sul depistaggio delle indagini da parte di rappresentati delle forze dell'ordine e della magistratura. Un fatto storico. Ho proposto che si seguisse questo esempio anche per fatti gravissimi della storia d'Italia su cui non c'è, ed è difficile che ci sia, una verità giudiziaria adeguata: da Portella della Ginestra alle stragi del '92 e del '93, ma la mia proposta, avanzata tra l'altro nell'introduzione al volume Peppino Impastato: anatomia di un depistaggio, in cui abbiamo fatto pubblicare la relazione della Commissione antimafia, non è stata accolta.
Da dove ottenete i finanziamenti e quali risultati avete conseguito in questi 33 anni di attività? Quanto è difficile lottare contro la mafia in terra di mafia?
Siamo totalmente autofinanziati, perché contestiamo le modalità clientelari di erogazione del denaro pubblico. Abbiamo chiesto alla Regione siciliana una legge che regoli l'assegnazione di fondi pubblici in base a criteri oggettivi, ma finora non ci siamo riusciti. Chiediamo che venga destinata al Centro il 5 per mille, ma sono pochi spiccioli. I risultati sono le nostre ricerche, sulle idee di mafia, sull'omicidio, sulle imprese mafiose, sulla mafia finanziaria, su mafia e politica, sul traffico internazionale di droghe, sul ruolo delle donne, su mafie e globalizzazione, sulle lotte contro la mafia, che hanno dato un contributo significativo alla lettura dei fenomeni di criminalità mafiosa (oggi molti parlano di "borghesia mafiosa", di mafia come "soggetto politico", espressioni che per anni sono state considerate fuorvianti e ideologizzate); abbiamo recuperato una memoria cancellata, con vari strumenti come la
55
mia Storia del movimento antimafia e l'Agenda dell'antimafia. Nelle scuole abbiamo cercato di dotare gli insegnanti di strumenti critici necessari per andare oltre gli stereotipi e le iniziative sporadiche o spettacolari. E' difficile, e rischioso, lottare la mafia in Sicilia, ma c'è da affrontare l'isolamento dei media, più interessati a creare miti che a una corretta informazione. E abbiamo il problema di dare continuità al Centro, ma non so se riusciremo a realizzare il Memoriale della lotta alla mafia, una struttura complessa che sia percorso museale, biblioteca, videoteca, archivio, istituto di ricerca, spazio di socializzazione, che proponiamo da tempo.
Lei ha scritto tanto anche sulla Trattativa Stato-Mafia. In questo numero abbiamo un'intervista a Massimo Ciancimino, figlio di Don Vito, uno dei principali anelli di connessione tra le istituzioni e Cosa Nostra. Cosa cambiano le affermazioni di Massimo Ciancimino rispetto a quanto già si sapeva? Perché sono importanti?
Le dichiarazioni di Massimo Ciancimino hanno un vizio di fondo: presentare il padre Vito come il deus ex machina onnipresente e onnipotente. Vito Ciancimino ha avuto certamente un ruolo, è stato condannato come personaggio mafioso, ma è stato certamente minore rispetto a quello di un Lima e di un Andreotti. Sulla "trattativa" il figlio di Ciancimino ha fatto dichiarazioni ed esibito documenti, come il famoso papello, e tocca alla magistratura accertare se sono prove convincenti. Penso però che il quadro sia molto più complesso di quello rappresentato da Ciancimino figlio. Pare che tutto si limiti al padre, a due uomini delle forze dell'ordine, a un fantomatico uomo dei servizi segreti e a qualche politico che però ha smentito. Non so se ci sarà una verità giudiziaria sulle vicende
56
più tragiche degli ultimi decenni e l'attuale Commissione parlamentare antimafia non ha nessuna volontà di ricostruire la verità storica.
Il Divo. Andreotti, intendo naturalmente. Saprebbe dirmi chi è o, meglio, chi fu prima del 1980?
Non vedo perché si debba distinguere un prima e dopo il 1980. La verità giudiziaria vuole Andreotti associato a delinquere fino a quella data, ma con la prescrizione, e innocente anzi antimafioso da quella data in poi. Ma questa non è la realtà storica. Andreotti ha rappresentato il punto - uno dei punti - di congiunzione tra mafia, politica e istituzioni per tutto il corso della prima Repubblica, prima e dopo il 1980. I rapporti con Lima sono durati fino alla sua morte, nel 1992. Le responsabilità di Andreotti, al di là di quelle giudiziarie, accertate "all'italiana", mezzo colpevole e mezzo assolto, sono soprattutto etico-politiche. E il film mi è parso più la caricatura di Belzebù che una ricostruzione convincente di una realtà complessa.
Se è vero che ormai una gran parte dei capitali della mafia sono investiti nel mercato legale, qual è il futuro di Cosa Nostra? La sua attività quanto è intrecciata all'economia e alla politica? Questo fenomeno andrà crescendo o diminuendo?
Fin dalle origini la mafia siciliana è stata modello di accumulazione e sistema di potere, in proprio (signoria territoriale) e in collegamento con settori del potere istituzionale.
57
Dagli anni '70 in poi si parla di “mafia finanziaria” con una lievitazione esponenziale dell'accumulazione illegale e l'uso dei capitali nel circuito imprenditoriale, ma soprattutto in quello finanziario. E ciò in collegamento con i processi di “finanziarizzazione” dell'economia, per cui quella produttiva è ridotta a una parte minima della complessiva ed è cresciuta, e tende a crescere ancora, l'economia speculativa, con un forte tasso di opacità del sistema finanziario che rende difficile distinguere capitali illegali e legali.
Il nostro Premier parla della mafia italiana come "solamente" la sesta al mondo. Ha affermato di volerla mettere al tappeto entro fine legislatura. Tornando alla realtà, che ruolo ha la mafia italiana nel mondo?
Cosa nostra ha ricevuto dei colpi per l'effetto boomerang dei grandi delitti e delle stragi del '92 e '93. Nel frattempo ha perso il ruolo primario nel traffico di droghe, per l'emergere di altre mafie, nazionali e internazionali. Berlusconi nega recisamente il ruolo delle mafie nel rapporto con la politica, perché il suo sistema di potere è assimilabile a quello mafioso poiché si regge su due gambe: la legalizzazione dell'illegalità con le leggi ad personam e l'impunità a ogni costo. La sua azione è al di fuori della Costituzione che sancisce l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Altro che lotta alla mafia! La favorisce in tutti i modi, con i condoni e con lo scudo fiscale che consente il rientro parziale dei capitali trasferiti illegalmente all'estero mantenendo l'anonimato e con una tassa irrisoria. I colpi alla mafia militare li danno le forze dell'ordine e la magistratura, anche il 41 bis è rivolto contro l'ala militare, mentre la borghesia mafiosa e il modello mafioso di arricchimento e di potere coincidono con il berlusconismo.
58
Una volta lei partecipò a Pisa a un laboratorio maieutico nello stile proposto da Danilo Dolci. Non ne fu particolarmente felice: si lamentò di quel metodo perché faceva uscire troppi luoghi comuni. "Danilo Dolci – precisò – non lasciava fantasticare la gente che partecipava ai suoi laboratori, ma la guidava in una direzione che lui già aveva chiara". Mi sbaglio? Qual è secondo lei un metodo partecipativo per lo studio della mafia?
Penso che in primo luogo ci sia bisogno di studiare, documentarsi, non credere che abbiamo la verità in fondo al nostro inconscio e che con il metodo socratico-platonico-dolciano la facciamo emergere. Un metodo partecipativo dovrebbe significare far parte di gruppi di studio e documentazione e crearli se non ci sono, non chiacchierare a ruota libera.
60
La criminalità organizzata in Francia
di Luca Caproni
Anche in Francia, la criminalità non manca di organizzazione. Ai nostri cugini d’oltralpe non dispiace, tra gli altri, il luogo comune dell’Italia come terra di mafiosi e allora, quando c’è da raccontare delle stragi tra i milieux del crimine marsigliese, si parla di estate siciliana (Eté sicilien à Marseille, titola il prestigioso Journal du dimanche del 7 settembre scorso). Ma, evidentemente, anche a Marsiglia fa caldo, se è vero che nel 2010 si sono già registrati 32 regolamenti di conti riconducibili al crimine organizzato per un totale di 15 morti. Cifre in aumento rispetto agli anni precedenti.
Anche in Francia, la criminalità organizzata è piuttosto un affare del sud. Benché, naturalmente, nel mondo dell’economia globale, nessuno che voglia stare al passo con i tempi si contenti di restare nel suo cantuccio. I luoghi in cui le piante affondano le loro radici, ci hanno ormai insegnato, non coincidono sempre con i luoghi in cui danno i loro frutti. Di sicuro, i centri territoriali più caldi di Francia sono la Corsica – dove l’eterna questione identitaria e indipendentista si intreccia in modo quasi indissolubile con quella più recente dell’affarismo – e Marsiglia – che grazie soprattutto al suo porto ha creato un agglomerato criminale che si estende su tutta la regione, fino a Nizza.
La più importante organizzazione criminale corsa sfoggia un nome quasi poetico, preso a prestito da un bar del porto vecchio
61
di Bastia : Brise de mer. I suoi piatti forti sono estorsione e ricatto. Imprenditori dichiarano di essere stati obbligati ad acquistare inserzioni pubblicitarie su U Rimbombu, settimanale nazionalista corso, per scongiurare ritorsioni. La lista degli attentati rivendicati dal Fronte Nazionale di Liberazione Corso (FNLC) a partire dal ’76, anno della sua fondazione ufficiale, sconsiglia a tutti di non prendere sul serio le minacce. Da manuale il caso del trasporto valute in Corsica: per anni la Brise de mer ha attaccato i furgoni che trasportavano denaro, fino a che non ha fondato una sua società, la Bastia Securità, che garantisce consegne sicure. A ciò si aggiungono la gestione di locali notturni, videopoker e furti a mano armata. Famoso quello del 1990 ai danni dell’UBS, a Ginevra, in cui cinque uomini realizzarono un colpo da 19 milioni di euro, mai ritrovati, che potrebbero esser stati reinvestiti in paradisi fiscali. La Brise de mer ha inoltre rapporti stretti con il Clan dei marsigliesi.
La principale attività illecita di Marsiglia è il traffico di stupefacenti. Non che le altre siano trascurate, per carità. Solo, il traffico di stupefacenti può qui contare sul porto più importante di Francia, storico accesso al Mediterraneo. La French connection, attiva già dagli anni ’30 del Novecento, era una rete criminale che trattava ed esportava eroina negli Stati Uniti e in Canada. Per dare un’idea del volume d’affari, si calcola che, all’inizio degli anni ’70, poco prima di essere sgominata, la French connection fornisse circa il 90% dell’eroina consumata negli Stati Uniti. Con l’assassinio di Francis Vanverberghe detto il Belga, nel 2000, il milieu marsigliese appare sconvolto da guerre di successione, come dimostrano i recenti omicidi. In questa situazione in cui gli interessi di singoli gruppi criminali prevalgono sugli interessi comuni, la Brise de mer, sola organizzazione dotata di struttura, sembra poter raccogliere l’eredità del Belga. Tutto questo fa sì che la regione Provenza-
62
Alpi-Costa Azzurra sia la prima in Francia per tasso di criminalità, e che Marsiglia sia amministrata, cosa leggermente sorprendente, da un sindaco di destra (UMP). Come Nizza, dove tra l’altro il Fronte Nazionale – partito di estrema destra scomparso dal parlamento con le ultime elezioni e considerato dagli osservatori omologo alla nostra Lega Nord, che invece prolifera – aveva raccolto nel 2007 circa il 15% dei voti.
Altre città ospitano organizzazioni criminali. A Grenoble e nelle sue periferie il ricco mercato della droga viene conteso da qualche anno da clan di magrebini – dopo esser stato dominato da emigrati di origine italiana negli anni ’80 e ’90. Parigi, la capitale delle capitali, non può vantare una sua mafia: sono i corsi e i marsigliesi a occuparsi dei suoi consumi di droga. Discorso a parte per la mafia cinese, che a Parigi concentra i suoi interessi nell’immobiliare e nell’immigrazione clandestina, ma che, più in generale, pare gestisca da qui tutta la rete criminale cinese in Europa – i cui tentacoli in Italia non sono trascurabili.
Le mafie italiane non sembrano molto presenti in Francia. Non come altrove, almeno. Bernardo Provenzano, comunque, scelse Marsiglia per farsi operare di prostata – operazione regolarmente rimborsata dalla Regione Sicilia di cui presidente era, al tempo, Totò Cuffaro. E nella stessa clinica pare che siano stati operati anche altri mafiosi, tra cui il boss Paolo Di Lauro – rimborsato pure lui? Chissà. Di Lauro possedeva attività commerciali a Nizza, a Lione, a Parigi. Varie piste evidenziano i rapporti tra le organizzazioni criminali italiane e quelle francesi. Nel 2008, ad esempio, una maxi-partita di droga da 180 kg fu scoperta in un container nel porto di Rotterdam: le indagini
63
hanno stabilito che la merce doveva giungere in Francia e che i marsigliesi si erano avvalsi della collaborazione del camorrista Umberto Naviglia e dei suoi contatti sudamericani. Gaetan Zampa, boss marsigliese di origine, guarda caso, italiana, disse nel 1983 ai poliziotti, dopo il suo arresto, che per tenere Marsiglia era indispensabile avere buoni rapporti con i gruppi corsi e con la mafia siciliana. Le cose, tutto sommato, non sembrano essere cambiate molto da allora.
Leonardo Cosmai – Barca affonda
64
Né la vipera né la mafia
Pillo le di cr iminalità organizzata in Sardegna
di Laura Sanna
Mentre negli anni novanta le mafie si espandevano in Italia, la Sardegna non subiva la colonizzazione. Non che nell'isola non ci fosse criminalità, tutt'altro, ma era di altro tipo. Le cosche facevano (e fanno) affari nella regione ed è quasi scontato immaginare la loro interferenza nei traffici di stupefacenti, ma la mafia come organizzazione capillare, e in un rapporto organico con i residenti, non aveva attecchito. Questo, secondo il sociologo calabrese Pino Arlacchi è accaduto perchè la giustizia, in buona parte dell'isola, è sempre stata un fatto personale, che non poteva essere delegata né allo Stato né a un eventuale “stato parallelo” come la mafia. Ma forse oggi bisogna pensare diversamente il fenomeno mafioso. Qualche tempo fa Tonio Dall'Olio, dell'Associazione Libera, spiegò, ai ragazzi di una scuola superiore, che per capire come la criminalità organizzata si radichi e diventi parte integrante di una comunità, non si deve immaginare un mondo diviso in mafia e non-mafia. Tra i due concetti c'è infatti la vastissima area grigia detta mafiosità, fatta di comportamenti più o meno illegali, ammiccanti e furbetti, collusi e omertosi, che preparano il terreno all'insediarsi della criminalità vera e propria, dal bar del quartiere fino alle istituzioni. E le cronache ci dimostrano che la Sardegna non è indenne da questo fenomeno.
65
Quasi duemila chilometri di costa e una posizione centrale nel Mediterraneo nell'ultimo decennio hanno fatto dell'isola sarda una delle basi del narcotraffico e se nel 2008 i sequestri di narcotici erano in ribasso, rispetto all’anno precedente, nel 2009 il dato è decuplicato. Ed è dal traffico di droga che partiamo per raccontare la prima storia sarda di criminalità che fa il balzo per diventare un sistema che va oltre il suo habitat per intrufolarsi nell'amministrazione pubblica.
Era un sistema organizzatissimo quello messo in piedi da una banda di trafficanti che si muoveva lungo la rotta Africa–Spagna–Sardegna, finché non fu smantellato, cinque anni fa, da un'operazione della Guardia di Finanza avviata già dal 2002. In questo caso il ricavato del traffico della droga era investito anche in attività immobiliari e a fare da tramite in queste transazioni era un consigliere comunale, presidente della commissione urbanistica e membro del consiglio di amministrazione del locale Consorzio di bonifica: un connubio tra colletti bianchi e criminalità che fino ad allora era sconosciuto a Iglesias, cittadina investita dalla crisi ma non al punto di doversi reinventare un futuro come capitale del narcotraffico. Nel luglio del 2005 Marcello Spiga, il consigliere in questione, fu prelevato da casa sua all'alba dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza. Spiga , come scritto nel provvedimento del pubblico ministero, aveva il compito di riciclare i soldi provento del traffico «mettendo a disposizione dell’associazione i propri contatti e le competenze professionali nel settore finanziario e immobiliare, l’autorità derivante dalle cariche rivestite in seno ad enti locali amministrativi». Quantità ingenti di droga e guadagni in proporzione: era necessario investire i soldi in attività pulite, perchè fruttassero meglio. E qui interveniva Spiga, che, essendo geometra, conosceva bene i terreni e il loro valore, le zone più interessanti in cui investire e i possibili venditori. Le
66
intercettazioni ambientali hanno raccontato molto di questa banda, il resto lo hanno fatto altri riscontri e interrogatori che hanno portato, in diverse fasi, al sequestro di 11 tonnellate di hascisc, 133 grammi di cocaina, 47 di eroina, uno yacht, cinque auto, tre moto e quasi 4000 metri quadri di terreno edificabile appartenuto a un altro esponente di spicco della banda, Gianluca Bollocco, che è stato assegnato dal tribunale al comune di Iglesias.
La seconda storia sarda passa invece per un settore in cui le mafie hanno cominciato a investire di recente: quello delle energie alternative. In questo caso la vicenda è ancora da accertare, non sono stati ancora celebrati processi, ma la rete che emerge racconta di rapporti poco chiari e condizionamenti reciproci tra imprenditori e politici e di imprese di cui ancora bisogna capire l'origine.
L'hanno chiamato P3 provocando lo sdegno di Licio Gelli, ma se non era un'associazione segreta forte e ramificata come la Propaganda 2 sicuramente il “Comitato d'affari” interessato alla redditizia produzione di energia eolica in Sardegna aveva un ampio potere di persuasione, ingenti capitali e alleati nei posti giusti. L'inchiesta, avviata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma nel 2008 , riguardava episodi di corruzione ai danni della pubblica amministrazione anche in altre zone d’Italia, però è in seguito alle intercettazioni sul caso sardo che sono emersi i nomi eccellenti e partiti avvisi di garanzia e arresti. Ai primi di luglio sono finiti in carcere Arcangelo Martino, imprenditore edile, Pasquale Lombardi, magistrato tributarista, e Flavio Carboni, imprenditore di Torralba, centro del sassarese. Il reato ipotizzato per loro è di associazione a delinquere semplice e
67
violazione della legge Anselmi sulle associazioni segrete: avrebbero messo in piedi “una associazione per delinquere diretta a realizzare una serie indeterminata di delitti” volta “a condizionare il funzionamento degli organi costituzionali nonché degli apparati della pubblica amministrazione”, scrive il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nel capo di imputazione dell'ordinanza di arresto. Ma prima che scattassero le manette nel registro degli indagati erano stati iscritti, assieme ai tre, Ignazio Farris, direttore generale dell'Arpas (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente), Franco Piga, commissario dell'Autorità d'ambito per la gestione delle acque e Pinello Cossu, politico iglesiente con un passato da assessore in Provincia di Cagliari. Seguiti poi dal presidente della Regione Ugo Cappellacci e dall'ex assessore all'Urbanistica della stessa Giunta, Gabriele Asunis. Secondo gli inquirenti, Flavio Carboni sarebbe stato il referente di un gruppo di imprenditori del settore delle energie rinnovabili interessati a investire in Sardegna e dalle intercettazioni raccolte sembra avesse un notevole appeal sul mondo politico isolano tanto da essere di fatto lui a indicare Ignazio Farris come direttore generale dell'Arpas. Ma l'ipotesi dei magistrati è che il “Comitato d'affari” avesse anche il compito di gestire le tangenti per rendere più celere e sicuro l'iter delle pratiche per l'avvio degli impianti eolici, che dall'Arpas dovevano essere sottoposti o meno alla Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). I soldi per l'operazione sarebbero transitati attraverso il Credito cooperativo fiorentino amministrato da Denis Verdini,coordinatore nazionale del Partito delle Libertà, finito in pieno nell'inchiesta. Alcune delle società interessate all'affaire sembra siano in odore mafia e infatti e c'è un nome ricorrente che solleva più di un sospetto, quello di Luigi Franzinelli, che in Sicilia è stato condannato per corruzione in concorso con esponenti della cupola a cui pare facciano riferimento alcune
68
piccole società affidatesi a Carboni.
Il 24 settembre a Ottana la notte è scossa prima dall'esplosione di una bomba e successivamente dai colpi di fucile contro la casa del sindaco, Gian Paolo Marras, che feriscono la moglie. Ultimo di una serie di attentati nell'entroterra sardo che rendono gli amministratori “uomini in trincea”.
Nell'agosto del 2008 a Lanusei arriva dalla Calabria un nuovo Procuratore capo: si chiama Domenico Fiordalisi e si attiva subito per minare il sistema criminale ogliastrino, che non gliela perdona: le minacce non tardano ad arrivare e Fiordalisi è sottoposto a misure di sicurezza straordinarie. Prima la residenza in caserma, poi l'allontanamento della sua famiglia da Lanusei. La sua macchia è stata quella di essere troppo zelante nel lavoro e così lui, che in Calabria, terra di 'Ndrangheta, non aveva mai avuto paura per la propria incolumità, si ritrova in Sardegna a vivere minacciato e sotto stretta sorveglianza. Gli attentati contro le istituzioni nell'isola sono tutt'altro che un'eccezione, ogni anno se ne contano un'ottantina, il numero più alto in Italia: bombe, colpi di fucile, uliveti incendiati, tutti modi per dire che “stai sbagliando qualcosa” e attorno a queste azioni c'è spesso il silenzio complice delle comunità. Omertà dovuta a paura ma anche all'approvazione del gesto. Le parole di Fiordalisi sull'Ogliastra sono illuminanti circa l’evoluzione della criminalità sarda, oggi ben poco individualistica e senza alcuna aura di eroismo. Il magistrato parla di zone del territorio sotto un controllo criminale analogo a quello di famiglie di tipo mafioso, controllate da delinquenti agguerriti a cui si contrappone una presenza dello Stato piuttosto scarsa. E non è un caso che proprio in Ogliastra ci sia stata la prima condanna per
69
associazione mafiosa, quella di Maria Ausilia Piroddi, sindacalista della Cgil, giudicata colpevole per una serie di delitti avvenuti tra il 1996 e il 1999.
In Sardegna esiste una criminalità organizzata diffusa e in contatto con la delinquenza internazionale: è un potere in grado di entrare nelle istituzioni, che controlla capillarmente alcune aree ed un silenzio omertoso protegge le azioni delle bande. Di certo, la mafia siciliana, tragicamente più conosciuta, è interessata a investire nell'isola e già arriva ai gradi più alti dell'amministrazione per tutelare i suoi nuovi interessi. È abbastanza per dire che se in Sardegna ancora Cosa Nostra non è ancora stanziata massicciamente, la zona grigia che la precede è indice di una preoccupante fase di espansione.
71
Criminali in un mondo globalizzato
di Marina Calculli
L’avvento dell’era globale ci ha abituati a pensare il mondo in cui viviamo come un sistema di reti sempre più interconnesse tra di loro. Dalla caduta del Muro di Berlino stiamo assistendo ad un progressivo processo di sfaldamento delle frontiere tra
gli stati: le barriere commerciali sono cadute, le imprese si sono internazionalizzate, le informazioni viaggiano da un capo all’altro del pianeta alla velocità con cui si clicca “invio” sulla tastiera del computer. Ed esattamente come l’apertura dei mercati ha portato alla proliferazione di imprese multinazionali e transnazionali, allo stesso modo le organizzazioni criminali hanno riformulato la loro natura su scala globale, estendendo i propri tentacoli in differenti stati, dandosi una struttura gerarchica, efficiente e in grado di controllare ampie fette dell’economia. Molti di questi gruppi hanno una storia antica: pensiamo alla Mafia siciliana, ad alcune organizzazioni criminali russe, alle Triadi cinesi o alla Yakuza giapponese; altri sono più recenti, come i cosiddetti Cartelli colombiani o le organizzazioni mafiose dell’Europa dell’Est, proliferate dopo la disgregazione dell’URSS e l’introduzione del libero del mercato nello spazio ex-sovietico. Vecchie o recenti che siano, in ogni caso, tali organizzazioni hanno mostrato una sorprendente capacità di adattarsi alle dinamiche del mondo globale, sfruttando i progressi tecnologici della nuova era, infiltrandosi nelle reti economiche e finanziarie e rendendo tra l’altro sempre più sfocato il confine tra ciò che è lecito e ciò che non lo è. Molti dei
72
profitti derivanti dai traffici criminali, infatti, vengono spesso investiti in circuiti del tutto legali, i cui fili di origine sono facilmente occultabili o semplicemente si perdono ai crocevia dei tragitti contorti che seguono i nuovi prodotti finanziari.
Se, inoltre, il nuovo volto che le imprese del crimine sono state in grado di darsi ha fatto sì che si moltiplicassero per loro affari e profitti, sembra sempre più difficile riuscire ad intercettare e disintegrare i traffici illeciti che esse conducono. Gli organi di polizia e di giustizia penale sono ancora troppo ancorati agli iter nazionali e in ritardo imbarazzante rispetto alla velocità con cui si ramificano le reti globali mentre l’impatto del mercato illecito cresce e rischia sempre più non soltanto di intaccare le economie nazionali ma di competere con gli stati sul terreno della sovranità.
- Dove si dispiega l’impatto del mercato del Crimine? Un recente rapporto dell’UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) pubblicato nel giugno del 2010 mostra che i settori privilegiati in cui le organizzazioni criminali transnazionali operano sono principalmente il commercio illecito di droga, il traffico di esseri umani, l’immigrazione clandestina e il traffico d’armi. E’ inoltre interessante notare come questi mercati prelevino risorse in paesi poveri mentre i profitti vengano recepiti prevalentemente nei paesi ricchi. Un esempio significativo è quello del mercato dell’oppio. Il primo paese produttore di oppio è, come noto, l’Afghanistan; la produzione, la raffinazione e il commercio di droga proveniente da questo paese produce ben
73
55 miliardi di dollari annui e, nonostante gli sforzi e le risorse (mal) impiegate dall’amministrazione americana dall’inizio della guerra afghana – rappresenta un mercato in espansione. Del profitto complessivo, tuttavia, solamente il 5% (2,3 miliardi di dollari) va ai coltivatori e ai traders afgani.
La regione che fa registrare il più alto tasso di traffico illecito di eroina è invece proprio l’Europa, con 20 miliardi di dollari annui. A dimostrazione di quanto l’enorme e virtuosa costruzione di uno spazio economico e politico europeo sia ancora molto fragile nel suo tessuto istituzionale e di vigilanza. Se guardiamo poi le cifre del traffico di esseri umani e d’immigrati clandestini, si stima che le vittime in Europa ogni anno raggiungano quasi le 140.000 persone, per un introito complessivo di tre miliardi di dollari. In America invece entrano illecitamente ogni anno circa 3 milioni di esseri umani provenienti principalmente dall’America Latina, con proventi che sfiorano i 6 miliardi di dollari.
- Una minaccia allo Stato. Oltre a questi tre principali settori, sembra che la tendenza delle organizzazioni criminali si stia diversificando progressivamente nei tempi recenti, proprio secondo i modelli più virtuosi delle strategie di impresa. Questi recenti trends appaiono ancora più preoccupanti quando si va a vedere quali sono effettivamente le nuove fette di mercato colpite. In primo luogo il prelevamento di risorse naturali – un mercato che intacca principalmente il Sud Est asiatico e l’Africa e rischia di danneggiare violentemente il già fragile ecosistema di alcune regioni del mondo, oltre a determinare ingenti perdite nei bilanci degli stati colpiti. In secondo luogo la pirateria marittima, che viola gli spazi territoriali degli stati, mettendo in crisi il concetto stesso di legittimità di un confine. Infine, un campo estremamente sensibile per gli effetti che potrebbe
74
procurare non solo alle economie nazionali ma all’intera macchina amministrativa di uno stato, è il cosiddetto Cybercrime. Il fenomeno non è nuovo – l’attività degli hacker preoccupa infatti da anni gli organi di polizia internazionali, anche in virtù delle cifre consistenti di violazione dell’identità personale (si stima che solo nel 2009 circa 1 milione e mezzo di persone abbia subito un attacco informatico che ha determinato una perdita complessiva di circa 2,5 miliardi di dollari). Tuttavia i progressi tecnologici in campo cibernetico hanno raggiunto un livello tale per cui determinati softwere potrebbero addirittura infiltrarsi e bloccare i più sensibili centri del funzionamento di uno stato: centrali elettriche, condotti petroliferi, centrali di controllo del traffico aereo, impianti nucleari e militari. Un caso recente e rilevante è quello del famoso virus Stuxnet, che ha intaccato il Supervisory Control and Data Acquisition della centrale atomica di Busher in Iran, diffondendosi poi rapidamente in milioni di computer della Repubblica islamica.
La potenza e le capacità di questi software ha portato addirittura a ventilare l’ipotesi che in un futuro imminente potremmo assistere ad una guerra cibernetica, una nuova forma di conflitto non più condotta con le armi classiche ma dagli effetti decisamente più devastanti. Se un attacco informatico dovesse, infatti, riuscire a mandare in tilt i principali centri dell’amministrazione statale, questo deruberebbe in un tempo brevissimo il legittimo esercizio di sovranità dello Stato sui suoi cittadini, facendoci sprofondare in uno stato di anarchia difficilmente gestibile. Una forma di guerra di questo tipo non solo sconvolgerebbe i tradizionali schemi di condotta di conflitto ma farebbe cadere il principale pilastro su cui una guerra si
75
costruisce: l’identificazione di un nemico chiaro e definito. Nel caso di guerra cibernetica come farebbe di fatto un governo ad identificare la fonte dell’attacco?
Appare chiaro, dunque, che i nuovi mezzi della criminalità internazionale non rappresentano più soltanto un fenomeno importante ma marginale nello svolgimento delle relazioni internazionali e, se vogliamo, nello svolgimento consueto delle vite degli individui; con essi rischiamo, quindi di farci ritrovare drammaticamente impreparati di fronte all’ingerenza di attori dall’identità oscura, che metterebbe a repentaglio gli schemi consolidati con cui abbiamo imparato a convivere e costruire le società e di fronte ai quali non sapremmo facilmente e rapidamente inventarci un’alternativa. La sfida che gli Stati – unici attori legittimi del Sistema internazionale – dovranno cercare di superare di fronte alle minacce dalle associazioni criminali e terroristiche nel futuro imminente è quella di sorvegliare e mantenere saldi i pilastri su cui si fonda la propria sovranità.
76
“Le mie prigioni” di un boss
Intervista a Davide Barlett i, regista di “Fine pena
mai”
di Paolo Antonio Guerrieri
Il dogma della separazione tra vita normale e vita mafiosa, Italia sana e sud mafioso é smentito ogni giorno dalla cronaca giudiziaria, politica ed economica. Se non guardiamo ai grandi appalti e ai giochi di potere parlamentari inquinati e pilotati dagli
ingenti capitali della malavita, ma ci concentriamo sul percorso di una singola vita, capire come un’esistenza venga assorbita dalla mafia può essere uno sforzo nuovo e una riflessione che libera da luoghi comuni e steccati scontati.
Il racconto di un’esistenza di mafia è proposto nel film “Fine pena mai” di Davide Barletti e Lorenzo Conte, tratto dal romanzo autobiografico “Vista di interni” di Antonio Perrone, ex boss della malavita salentina. Davide Barletti ha accettato di rispondere ad alcune domande per Aeolo. Gli telefono, gli parlo della nostra rivista e del suo impegno per la testimonianza civile attraverso l’arte, la bellezza e le idee. Cominciamo poi a parlare del film.
Paolo Guerrieri: I film sulla mafia costituiscono uno dei grandi filoni narrativi della cinematografia mondiale. Nel vostro film però la novità salta agli occhi. È ispirato all’
77
autobiografia scritta di suo pugno dall’uomo di mafia. Le società malavitose si reggono sulla consegna del silenzio e sul comandamento dell’omertà. I pentiti offrono le loro parole solo ai giudici, ai giornali magari, ma non si raccontano. In questo caso esiste un racconto del tutto personale. E’ questo profilo di unicità che vi ha avvicinato alla storia di Antonio Perrone?
Il progetto è nato dal libro e più precisamente dalla sua scoperta casuale. In una bacarella di libri usati abbiamo trovato “Vista di interni”, di Antonio Perrone. Non era il bestseller in una vetrina patinata, ma uno dei mille titoli le cui copertine ingombravano la bancarella. Manni editore, che lo ha pubblicato, è una casa editrice di medie dimensioni del Salento. Avremmo potuto non leggerlo mai: per di più la copertina era anonima. L’incontro tra noi e quelle pagine è stat più che mai fortuito, ma su questo incontro è nato il progetto “Fine pena mai”.
Il progetto ha incluso il film e il successivo documentario “Diario di uno scuro”. Sicuramente quindi l’ispirazione è stato il resoconto in prima persona da parte di una persona che la società civile senza tanti giri di parole bolla come un “mafioso”.
Il libro infatti è nato in carcere...
Esattamente. La storia è quella di Antonio Perrone, salentino di Trepuzzi. Perrone è in carcere dal 1989. Ha scritto il libro a cavallo tra la fine degli anni ’90 e gli anni 2000, mentre era sottoposto al regime carcerario di detenzione dura, indicato in genere come 41Bis. Lui si è fatto 16 anni, la bellezza di 16 anni di carcere duro, di carcere da isolamento. Precisamente gli é stato imposto il 41Bis a partire dal ’92 e ne è uscito nel 2008. Attualmente è sempre in carcere ma in regime di detenzione normale. Considera che la sua è una delle più lunghe
78
applicazioni continuative del carcere duro. E’ un veterano dell’isolamento. Ed è chiaro che emerge una questione di sproporzione della pena.
Era un pesce piccolo alla fine?
Attenzione. Antonio Perrone è in carcere per cose gravi, perchè i reati di mafia sono violazioni gravissime del diritto. Partiamo da questo presupposto. Tuttavia, non si può nascondere che lui sia tra quelli che hanno pagato di più per le sue colpe. E’ una proporzione triste da fare, ma rispetto ad altre carriere mafiose tieni presente che a Perrone non è stato contestato nessun omicidio.
Il film insiste molto sulla privazione della libertà. Il 41Bis per il protagonista è la cancellazione stessa della libertà. Storicamente, se leggi speciali furono il modo con cui lo Stato derogò alla purezza dei suoi principi per affrontare l’emergenza terroristica, il 41Bis ha rappresentato la stessa eccezione alla purezza del diritto adottata in questo caso per la mafia. Negli anni è poi diventato motivo di contenzioso tra mafiosi e Stato. L’attulità della cronaca giudiziaria parla di trattative e di bombe legate alla storia dell’applicazione del carcere duro. Mi sono chiesto: costruendo il film e riprendendo il racconto di Perrone vi siete posti il problema di non delegittimatare uno strumento che comunque si è rilevato decisivo nella riaffermazione della Stato sulle mafie?
79
Ti rispondo tornando per un attimo alla storia e alla personalità di Antonio Perrone. Precisare il personaggio mi permette di spiegarti come il 41Bis entra nella vicenda e come abbiamo deciso di raccontarlo. Noi ci siamo trovati di fronte al primo resoconto autobiografico di un condannato per mafia. La narrazione era priva di vittimismi e di reticenze. Il libro abbraccia l’intera vicenda di Perrone. Lui non nasce nel segno di un destino mafioso. Viene invece da una famiglia borghese e negli anni ’70 era iscritto a psicologia all’Università di Padova, che in quegli anni era la culla della estrema sinistra. Probabilmemte una prima svolta nella sua vicenda umana è l’incontro con le droghe psichedeliche: da qui in poi convive con una imperante ricerca dell’eccesso che lo porta verso una banda di strada. Lungo questa china poi arriverà l’affiliazione alla Sacra Corona Unita.
Come vedi si tratta di un percorso di affiliazione diverso dalla tradizioni classiche siciliane o calabresi. In questo non c’è nessuna giustificazione. La mafia va combattuta. Però nel fenomeno complessivo è giusto continuare ad indagare ed a distinguere le singole vicende personali. Perrone allora si è trovato nel tritacarne della giusta risposta all’emergenza mafiosa insorta nel ’92 dopo gli attentati di Falcone e Borsellino. A ridosso di quella stagione furono comminati ben 600 41Bis. L’applicazione del carcere duro avviene mediante decreto che deve essere rinnovato anno dopo anno. Nel caso di Perrone la persistenza delle stesse motivazioni per 16 anni fa venire dei dubbi in merito alla possibilità di trovarci di fronte ad una situazione in cui uno strumento giusto viene dispensato in modo eccessivo. In questi 16 anni Perrone si è progressivamente dissociato dal suo passato.
Tutta questo insieme di elementi costituivano la nostra materia: un percorso di arrivo alla malavita fuori dai canoni, il
80
racconto di questo percorso e del successivo allontanamento in prima persona. Sicuramente anche il tema della durezza della pena scontata. Si sono fatte battaglie civili sulle modalità di applicazione del carcere duro. I radicali e quello che resta dei sani garantisti italiani – i garantisti non berlusconiani - hanno alimentato un dibattito incisivo su questa materia. Ti cito il libro “Tortura Democratica” di Marco D’Elia e purtroppo non mi ricordo l’altro autore ( n.d.r.: e di Maurizio Turco, “ Tortura democratica - inchiesta sulla Comunità del 41 bis reale”, di Sergio D’Elia e Maurizio Turco, edizioni Marsilio).
In definitiva nel nostro lavoro non c’era alcuna messa in discussione di uno strumento giusto, che correttamente, per la sua natura emergenziale, hai collegato alle disposizione prese in materia di lotta al terrorismo. D’altro canto però c’era il legittimo interesse per una vicenda personale in cui vedevamo una deformazione di questo strumento. E’ proprio di uno stato democratico interrograsi sull’equilibrio tra pena e diritti del condannato.
Diciamo allora che la critica non è allo strumento. Possiamo dire che vi siete concentrati su una sua possibile applicazione eccessiva. Del resto riconoscere i casi in cui un provvedimento risulta snaturato a causa di un suo uso opinabile significa in primo luogo cercare di difendere il provvedimento stesso, distinguendo tra uso sbagliato e natura corretta.
Esatto, sono d’accordo. La nostra battaglia non era politica, non ci interessava il caso politico di Perrone. La valutazione
81
sulla natura e sulla severità della sua pena insiste unicamente sul lato umano. E’ una valutazione che discende dalla lettura delle sue parole di pentimento e dalla tensione quasi letteraria con cui si racconta.
Emerge decisamente nel film il prevalere del lato umano.
A noi interessava cogliere la storia di un pentimento che è prima di tutto umano. Perrone non si è pentito nelle aule dei tribunali, ma si è dissociato umanamente dal suo passato. Sta scontando completamente la sua pena, come è giusto che sia. Nel modo in cui ci rivela la forza disgregante del fenomeno dell’eroina degli anni ’80, nel modo in cui parla delle bande armate che fiancheggiavano le organizzazione mafiose noi abbiamo colto il segno di una debolezza, di una sconfitta. Ci è piaciuto l’idea di riproporre su pellicola la stessa tensione umana e ripeto quasi letteraria della sua storia.
A proposito di tensione letteraria, all’inizio del film come sottotitolo compare “Paradiso Perduto”. Leggendola ho pensato al Paradise Lost di Milton. Il Lucifero del poema inglese è un eroe nero che preferisce essere principe all’Inferno piuttosto che servo in Paradiso. Potrebbe essere la versione poetica di una certa rincorsa alla vita degli eccessi che per Perrone è il primo gradino verso l’adesione alla logica malavitosa. Voi stessi avevate usato il sottotilo come citazione o il Paradiso è piuttosto la rinuncia alla vita che tocca a Perrone dopo l’arresto?
Sì, sì, la citazione è voluta. E’ voluta nel suo riferimento letterario, è voluta per la bellezza del titolo “Paradiso Perduto”. E’ vero anche che Perrone aveva il Paradiso. Era bello ed intelligente con una moglie bellissima ed intelligente. Venivano
82
da famiglie agiate. La sua storia sembra quella del ragazzo innamorato del ruolo dell’attore ribelle che è rimasto quasi involontariamente nella parte del duro e puro e non é riuscito ad uscirne in tempo e si è alla fine bruciato. Io chiaramente ti parlo del Perrone del libro...
Non vi siete mai visti, ma avete intrattenuto con lui una corrispondenza epistolare, no?
All’epoca in cui il film era in lavorazione lui era ancora al 41Bis, quindi vedersi era impossibile. Ci siamo scritti e circa due anni fa era stata organizzata per lui una videoproiezione privata che non credo sia stata poi fatta.
Quindi lui non ha visto il film?
La videoproiezione sarebbe stata un’eccezione ai sui diritti di carcerato e si è rifiutato di godere di questo privilegio.
Continua ancora a fare il “duro e puro”... il rischio dei film a tema malavitoso è sempre quello di creare dei miti negativi. Voi avete lavorato con Claudio Santamaria, il “Dandy” di Romanzo Criminale, che tra cinema e televisione ha costruito l’immaginario del criminale eroe maledetto. Questa scelta non era rischiosa nel senso che poteva appensantire il film con il solito stereotipo dell’eroe maledetto.
Nella scelta degli attori abbiamo rispettato una verità biografica. Se vedessi le foto di Antonio Perrone e di sua moglie
83
o vedessi il documentario, che ha esteso il lavoro del film, ti accorgeresti che loro erano la classica coppia di bellissimi. Loro erano diversi dall’ambiente circostante e in questo senso la loro esperienza attraverso la droga prima a la criminalità poi contiene un messaggio di trasversalità. L’eroina degli anni ’80 é stato quanto di più tasversale sia esistito sul piano sociale...
Sarei comunque ipocrita se non ammettessi che se la produzione ti mette a disposizione attori affermati sei più sicuro di essere distruibuito nelle sale cinematografiche ed automaticamente sei più sicuro sulla sorte del film.
Alla bellezza dei protagonistai fa da contraltare la “bruttezza” dei personaggi della cerchia dei mafiosi. E’ quasi caricaturale il contrasto.
Hai colto bene. Noi abbiamo cercato di lavorare per archetipi al punto che tutto il film è pervaso da questa rappresentazione eccessiva quasi parossistica della realtà. Perrone è il boss del cinema con moglie e vestiti belli. Gli altri personaggi si alternano marcando all’etremo i loro tratti caratteristici. E’ come se tutta la Puglia fosse un teatro a cielo aperto in cui si muovono non persone ma maschere nell’atto di rappresentare l’ennesima tragedia del sud.
Anche il paesaggio è esasperato. Il presente dietro le sbarre di Perrone è un’oscurità fatta di colori glaciali. Il passato e gli anni ’80 sono rappresentati con colori caldi portati quasi alla saturazione. I cieli incombono sulle scene quasi fossero le quinte di sipario di questo teatro all’aperto. La cadenza salentina è molto marcata, al limite della ostentazione.
84
Sì, abbiamo usato una tecnica che si chiama Salta-Sbianca. Consiste nel lavare la pellicola e come effetto si ha una sorta di aura metafisica sulle immagini. Direi meglio, si stempera il realismo e si va verso una sorta di iperrealismo. L’intento era quello di creare una rappresentazione al limite del fotoromanzo, in cui i singoli personaggi diventassero maschere esemplari.
Quello che ho colto è che il Perrone di “Fine pena mai” non è un eroe maledetto. E’ quasi casuale la sua carriera malavitosa; è più frutto di non volontà e di una incapacità di fermarsi...
Questo abbiamo voluto rappresentare e questo ci è parso di cogliere nel libro. Alla mafia ci si può arrivare da ogni direzione quando si è troppo deboli per fermarsi. Per Perrone l’alt ad una vita di eccessi e di rincorse è stato il carcere. Lui si è fermato tardi e la fine della sua corsa è stato il 41Bis.
85
Bufera in sala: la mafia
«Ti farò una proposta che non potrai r if iutare».
Un v iaggio attraverso i l c inema cr iminale
di Morena Mancinelli
Spesso ci si chiede perché poeti e scrittori cantino tanto la tristezza e il dolore e così poco la felicità. Forse perché in fondo l’animo umano ritiene il dolore più attraente del piacere? E perché i cineasti frequentano così il cosiddetto “cinema criminale”? Non sarà che questo tipo di
cinema, colmo di mafia e criminalità variamente organizzata, invade gli schermi e i discorsi non per denunciare un malcostume ma perché riempie le sale? Verrebbe da pensare che l’animo umano insieme al dolore ami anche il male. Sin dalla tenera età si gioca a guardie e ladri azzuffandosi per fare il ladro e storcendo il naso e battendo i piedi se capita di dover fare la guardia. Quasi che, per dirla con la forza del “diritto”, oltrepassati ormai gli steccati del “vivere onestamente” anche i confini più ampi del “non nuocere” siano diventati troppo stretti. Quasi che l’atavico istinto umano propenda verso il dionisiaco e verso il caos, e che il diritto e la filosofia siano solo armi scariche contro il male esplosivamente atomico. La parola ai fatti, anzi agli schermi e alle immagini che li riempiono. Salvo che non se ne abbia un’esperienza diretta, l’immaginario collettivo sulla mafia e sulla criminalità organizzata in genere è costruito dai mass media, in primis dal cinema. Il racconto di mafia sul grande schermo ha sin dal suo esordio assunto le caratteristiche di
86
tema popolare, la funzione di richiamo delle masse, di versione post-moderna del panem et circenses, oscillando nei generi tra commedia, gangster-movie, dramma e parodia. I paesi che più hanno portato la mafia al cinema sono stati l’Italia e gli Stati Uniti, sarà forse perché la mafia è nata in Italia e dagli italiani è stata esportata oltreoceano su grandi navi che, a differenza del Titanic, non sono affondate? O sarà anche questo un luogo comune veicolato dai media? Il cinema criminale induce a pensare la mafia in modo mitico, epurandola del brutto, spettacolarizzandola, tenendone solo l’aspetto quasi ludico. Ne sono un esempio: le proposte del Padrino che non si possono rifiutare, l’intoccabile Robert De Niro perfetto Al Capone tutto capello impomatato, Opera, charleston, spaghetti in compagnia della lupara piuttosto che del mandolino, o quei bravi ragazzi (mafiosi) di Martin Scorsese. E si rifletta sul fatto che tre dei migliori film di mafia di tutti i tempi – Il Padrino, Gli intoccabili, Quei bravi ragazzi appunto – sono stati firmati da tre registi italoamericani – rispettivamente Francis-Ford Coppola, Brian De Palma, Martin Scorsese – per chiudere il cerchio sul luogo comune di cui si diceva. Bravi ragazzi in realtà cattivi, simpatiche canaglie mitizzate, mostri presentati come eroi, delle vere e proprie macchiette come il Carlo Brigante di Carlito’s Way, altro capolavoro di Brian De Palma. La rappresentazione della mafia al cinema procede per affreschi gattopardeschi, da tragedia greca, sentimentalismi da romanzo popolare che diventa criminale, introspezioni psicologiche e tradizioni patriarcali di uomini d’onore. In queste rappresentazioni la donna spesso si oppone alla mafia e alle sue logiche, alle brutture del mondo. Ma è realtà o ancora solo immaginario? Soffermandosi sulla figura
87
che della donna contemporanea emerge dalla cronaca, dalla politica, dal mondo del lavoro, l’icona del personaggio femminile eroico si appanna come i fotogrammi di un film in bianco e nero dell’epoca del muto. I cattivi del cinema “criminalmente organizzato” sono troppo spesso giustificati, con un passato difficile che li ha portati a non essere dei bravi ragazzi comunemente intesi. Il modo in cui sono rappresentati induce a cercarli, guardarli, ammirarli. La visione in sala diventa allora quasi uno scenario onirico in cui, per il tramite della rappresentazione, si vivono le pulsioni più nascoste e da non dirsi. Assume la stessa funzione catartica della tragedia greca, per cui assistere alle vicende di Edipo purifica dai desideri più inconfessabili. Contro il dannoso conformismo retorico e gli stereotipi cinematografici frequentati dal cinema criminale italoamericano, ma anche italiano (basti pensare al Romanzo Criminale di Michele Placido), si schierano alcune voci che emergono dal coro. E’ il caso del Tano da Morire di Roberta Torre, primo film musicale sulla mafia, dissacrante, visionario, dirompente. Usando la canzone e la satira prende genialmente a picconate il mondo mafioso. Ma è soprattutto il caso del Gomorra del geniale Matteo Garrone, che molto deve all’omonimo romanzo di Roberto Saviano capolavoro di anti-retorica. Nel film di Garrone, claustrofobico, immersivo, tridimensionale, la distanza tra spettatore e personaggi è annullata poiché non c’è la rassicurante voce di Saviano a narrare gli eventi come nel libro. Lo spettatore è buttato nello schermo, con le orecchie invase dal rumore degli spari e gli occhi atterriti dal colore del sangue che si staglia su una fotografia plumbea. Un film che rappresenta la realtà mafiosa per quello che è: brutale, squallida, per nulla attraente o eroica e che così non corre il rischio di generare emulazione ma solo nausea nei confronti dei “bravi” ragazzi mafiosi. Uno dei pochi
88
film che non saranno responsabili quando, alla consueta domanda «Che vuoi fare da grande?» un bambino risponderà «Il Padrino». Bambino cui, se forza e coscienza saranno in grado di vincere sull’immaginario, si risponderà: «Ma il Padrino non è un mestiere!»…«Ahhh allora voglio fare il gangster» dirà lui.
Che i venti si raccolgano, che si prepari la bufera.
Che lo spettacolo abbia inizio.
90
L’istruzione come lotta alla criminalità organizzata
di Teresa Occhipinti
Quanta responsabilità ha l’insegnamento della storia della criminalità organizzata nelle scuole italiane? Dalle testimonianze di docenti delle scuole superiori di alcune delle più importanti città d’Italia sembra evidente che i programmi ministeriali non danno specifiche indicazioni a riguardo.
Tra gli insegnanti intervistati ci sono voci discordanti: alcuni pensano ci dovrebbe essere uno specifico riferimento nei programmi, un chiaro messaggio dello Stato, che attraverso la scuola cerca di formare cittadini onesti in grado di riconoscere e combattere l’illegalità e l’immoralità di alcune realtà criminali. Altri affermano che dato lo stato in cui versa il nostro Paese lo studio e la conoscenza delle realtà criminali dovrebbe essere implicito. Tutti i professori interpellati però hanno sottolineato che nello specifico il trattamento della storia della criminalità è a discrezione dei docenti, che ne trattano nei programmi di storia e italiano del quarto e quinto anno. In alcuni licei vengono anche organizzati veri e propri laboratori di approfondimento. Per citarne uno “cittadinanza e costituzione” organizzato negli anni passati nel liceo scientifico Calamandrei di Napoli, tra i fautori di tale corso il professor Voccia il quale mette in evidenzia l’importanza dell’insegnare l’educazione civica e rimarca come sia fondamentale permettere agli studenti di cogliere che ciò che è legale non ha niente a che vedere con la moralità, che è la spina dorsale del cittadino.
91
Nel 2008 il ministro Gelmini ha annunciato l’inserimento dell’educazione civica nelle scuole, date le testimonianze raccolte, attualmente non esiste ancora un orario di lezioni specifico della materia nelle scuole superiori, non risulta nemmeno essere materia d’esame alla maturità.
Alcuni docenti sottolineano la pericolosità di slegare il trattamento dell’argomento criminalità dal suo contesto storico-politico; circoscrivere questo tema e farne un oggetto specifico rischia di destoricizzarlo ed impedire non solo la sua comprensione ma anche la sua contestualizzazione economico-politica.
Per meglio comprendere come la criminalità organizzata influisce quotidianamente sulla qualità di vita di tutti, molti insegnanti leggono quotidiani in classe, mettendo in risalto le conseguenze socio-economiche che alcune realtà hanno sul Paese.
Indubbiamente rilevante il dato di malcontento registrato nei docenti, insoddisfatti dei programmi ministeriali e del numero di ore di storia presenti in licei e istituti, al solo discapito degli studenti.
Anche gli studenti hanno lamentato la limitata quantità di ore, l’impossibilità di approfondire gli argomenti più complessi, come il concetto del crimine organizzato e la sua storia, fa sì che ciò si ripercuota sulla loro vita quotidiana, cioè sulla capacità di comprendere come muti la qualità della vita se si subisce, direttamente o indirettamente, l’effetto di queste organizzazioni .
Valentina, studentessa all’ultimo anno nel liceo scientifico Dini di Pisa, dice di essere rimasta molto colpita da un corso di approfondimento sul tema della criminalità tenuto nella sua scuola. Quasi improvvisamente è divenuta consapevole di queste realtà a volte disumane, che dice le fanno rabbia, ma
92
quando le viene chiesto se ha paura, la risposta risulta negativa. Sono troppo lontane queste realtà orribili, fatte di violenza e omertà, raccontate così in saltuari incontri sembrano quasi dei documentari di tribù straniere, incomprensibili nel loro stile di vita perché figli di una terra diversa, promotori di codici dal linguaggio incomprensibile. E se le si chiede se è in grado di comprendere le ripercussioni che le attività criminali hanno sulla vita di tutti giorni, dal punto di vista economico ad esempio, ovviamente ammette di non rendersene conto ed è forse per questo che la paura di un futuro incerto non la preoccupa.
Chi vive in realtà diverse, reagisce in modo diverso. Si stupisce Dario, studente milanese, ormai maggiorenne, impegnato a documentarsi su giornali e mezzi di informazione di come giorno dopo giorno si affacciano sempre di più prove, che le organizzazioni criminali abbiano sconfinato i limiti comunemente attribuitigli dall’opinione pubblica. Ad oggi risulta che l’economia lombarda è mossa anche da organizzazioni illecite, che hanno radici nella politica, ciò preoccupa lo studente che fa fatica a capire i linguaggi giornalistici o si trova in difficoltà davanti alle omissioni di alcuni mezzi di informazione pubblica.
Lui, come altri suoi coetanei, si sente disorientato.
Daniele, giovane studente napoletano si chiede dove sta la voglia di combattere queste realtà criminali, dove leggere questo desiderio nella scuola, primo mezzo di formazione per la mente dei cittadini di domani, dove trovare la denuncia di queste realtà, dov’è la serietà nell’affrontare questi argomenti?
Com’è noto alla cronaca il 5 Settembre di quest’anno è morto Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, comune del Cilento, ucciso
93
in un agguato in pieno stile camorristico. Da anni la camorra non infieriva così duramente nei confronti di un politico. Nella scuola di Daniele è stato osservato un minuto di silenzio in sua memoria, al quale hanno seguito settimane di silenzio che invece aiutano a dimenticare.
La responsabilità della formazione fornita dalle scuole pubbliche, a qualsiasi età, si presenta come fondamentale. Fondamentali sono i mezzi con i quali si distribuisce il sapere, i modi e anche la consapevolezza che le priorità dell’insegnamento sono impartite dal contesto sociale. La conoscenza d’insieme, ampia e completa è l’ambizione inarrivabile di tutte le realtà scolastiche che si rispettino. La verità forse più banale è che la conoscenza è un’arma più forte dei proiettili o delle diffamazioni, e per poterla usare in futuro c’è bisogno che le nuove generazioni possano essere consapevoli e quindi poter dire: io so di non sapere.
95
Karl Jaspers e la torre di Holderlin
di Mauro Savino
Le fasi della malattia di Holderlin vengono descritte da Jaspers1 attraverso la ricostruzione fattane da W. Lange2.
Seguendo Lange, dunque, si possono riscontrare nella patografia di Holderlin le prime avvisaglie dell’incipiente schizofrenia a partire già dal 1800, quando Holderlin aveva trent’anni: compaiono i primi segni di “spaesamento e solitudine”3, accompagnati da momenti di “irritabilità eccessiva”.4
Nel 1801-18025, la malattia diventa palese agli occhi degli amici e nel 1806 verrà internato presso la clinica psichiatrica dell’Università di Tubinga a causa della frequenza con cui si ripetono violenti squassi emotivi.
Dal 1807 viene ospitato da un falegname svevo, Ernst Zimmer, che gli aveva fatto visita dopo aver letto Hyperion, e che si era offerto di prendersene cura.
Zimmer alloggiò Holderlin in una torre di sua proprietà sulle rive del Neckar, dove il poeta attraversò lo stadio finale di una
1 K. Jaspers, Genio e follia. Strinberg e Van Gogh, trad.it., Cortina, Milano, 2001. D’ora in poi: Jaspers. 2 W. Lange, Holderlin.Eine Pathografie, Stuttgart,1909. 3 Jaspers, p. 119. Cfr., comunque, infra, n. 18. 4 Ivi. 5 E’ del 1802 l’episodio riportato da Lange e citato da Jaspers, che vede Holderlin abbandonare Bordeaux, dov’era istitutore, a causa di una forte crisi di agitazione, cui seguiranno crisi anche di natura violenta e stati di estrema lontananza dal mondo, testimoniati, tra gli altri, dall’amico Schelling.
96
schizofrenia catatonica che lo accompagnerà fino alla morte, avvenuta nel 1843.
Dopo questo breve excursus, Jaspers delimita il campo della sua indagine: dal punto di vista psichiatrico, il valore estetico di un’opera o il giudizio che ne da il suo autore diventano secondari1 rispetto al discorso vertente sul rapporto malattia/arte. Entrambi quei momenti interpretativi, infatti, portano a considerare l’opera d’ arte come avente una vita propria, circoscritta dal suo solo valore estetico, come “prodotto della natura”2 per dirla con Jaspers, dunque indipendente da circostanze di sorta, come la malattia. Ciò che qui interessa invece, è stabilire proprio il nesso dell’opera d’arte con la psicosi, ragion per cui la vita dell’artista diventa momento fondante dell’analisi.
Non a caso, dunque, la prima circostanza su cui Jaspers si intrattiene è quella che verte sulla forte discordanza esistente tra i giudizi sull’opera di Holderlin nel periodo che va dal 1801 al 1805, e che vede la schizofrenia farsi strada nella psiche di Holderlin.
1 Sebbene, ha cura di precisare Jaspers: “così come una perla nasce dal difetto di una conchiglia, la schizofrenia può far nascere opere incomparabili. E come non si pensa alla malattia della conchiglia ammirandone la perla, così di fronte alla forza vitale di un’opera non pensiamo alla schizofrenia che forse era condizione della sua nascita.” (Jaspers, p. 120). 2 Jaspers, p.120.
97
Così, se Lange considera la poesia di Holderlin di questi anni decisamente inferiore a quella espressa precedentemente, Von Hellingrath vi rinviene invece l’acme del suo magistero.
E Jaspers si chiede: “La poesia di Holderlin ha veramente subito, dal 1801 in poi, cambiamenti che le hanno dato un volto nuovo?”1
La risposta passa, date le premesse, per un’analisi di tipo non contenutistico (dunque estetico) dell’opera di Holderlin ma di natura oggettiva, strutturale, stilistica, legata insomma alla “vita propria dell’opera poetica”2: la poesia come fatto consentirebbe di individuarne l’eventuale nesso con la vicenda morbosa.
Tuttavia, il momento estetico non è del tutto eludibile. Jaspers avverte infatti che una ricerca documentale resta fine a sé stessa se non è accompagnata da una interpretazione estetica, da un lavoro interiore di comprensione.3 E’ stata del resto, proprio l’etichetta di incomprensibile riservata da molti alla poesia di Holderlin di quegli anni, a farne il semplice parto d’un folle, qualcosa di confuso, vuoto, privo di reale valore artistico e dunque di poco momento dal punto di vista di un’evoluzione stilistica, reale o presunta che sia: la psicosi ha fatto il suo ingresso, la poesia è uscita di scena.
Jaspers invece, si sforza di comprendere il portato estetico della poesia di Holderlin, senza dimenticare quell’analisi oggettiva che proviene dagli specialisti dello stile.
Cosa ci dicono dunque gli specialisti?
1 Ivi, p. 121. 2 Ivi. 3 Cfr. ivi:“Identificare i sintomi suppone già una certa comprensione interiore, un’interpretazione razionale dei dati non sarebbe sufficiente.”
98
Jaspers confronta le opinioni di Von Hellingrath e di Dilthey, che paiono convergere sul fatto che il nuovo stile inaugurato da Holderlin dopo il 1801 sarebbe ingenerato da uno sviluppo meramente intellettuale; la psicosi semmai vi gioca un ruolo coadiuvante: essa non determina ex se la “particolare indipendenza ed energia delle immagini”1 cui si riferisce Dilthey a proposito dei Canti della notte.
Il dato stilistico più rilevante appare essere la conversione al verso libero di Holderlin:“La cosa più ricca di avvenire in quest’ultima epoca di Holderlin è che tutta la sua evoluzione poetica urgeva verso la totale liberazione dal ritmo interiore del sentimento dalle forme metriche chiuse”.2
Per la verità Dilthey colloca questo passaggio già in epoca precedente all’insorgere della malattia. Sennonché di tale evoluzione praeter morbum egli porta come esempio i Canti della notte, che però sono coevi alla schizofrenia.
Ma allora, si chiede Jaspers, esiste o no “qualcosa che si possa designare come specificamente schizofrenico”3?
Peraltro la domanda non investe solo la produzione di Holderlin dal 1801 al 1805. Jaspers rileva infatti come il periodo successivo sia caratterizzato da una nuova metamorfosi: le
1 W. Dilthey, Esperienza vissuta e poesia, tr.it., Il Melangolo, Genova, 1999, pp. 465-466, cit. in Jaspers, p.122. 2 Ivi. 3 Jaspers, p. 124.
99
poesie di Holderlin si fanno “più semplici, più infantili, si potrebbe anche dire più vuote.”1
La risposta, per Jaspers, può derivare soltanto da una comparazione tra “il sorgere dello stile nuovo e la curva del processo morboso”.2
Se volessimo rifarci alla nomenclatura junghiana dei tipi psicologici, Holderlin rientrerebbe nella categoria del “tipo introverso [che] si rivolge a forme di percezione e di conoscenza che rappresentano la disposizione soggettiva e ricettiva di fronte allo stimolo sensoriale” e che “non parte dall’esperienza concreta per ritornare alle cose oggettive ma mira al contenuto soggettivo”; i fatti pertanto, “hanno un’importanza secondaria, mentre hanno valore lo sviluppo e l’esposizione dell’idea soggettiva, dell’immagine simbolica originaria che in forma più o meno oscura è sempre presente nello sguardo del tipo introverso”3.
E tale introversione certo si manifestava, in quanto lontananza dal mondo, già prima della psicosi (vicenda che non si compie mai tutta d’un colpo, ma che ha antecedenti a volte assai lontani nel tempo), come è dato di riscontrare attraverso le
1 Ivi. 2 Ivi. 3 C.G.Jung, Tipi psicologici, tr.it., Boringhieri, Milano, 1992, passim. Questa visione junghiana non ci pare configgere con il tentativo, spesso disperato, di adattarsi alla realtà, di essere “capaci di vivere”, per dirla con Kafka. E’ anzi proprio la delusione, il senso di inadeguatezza e di inappartenenza al mondo a generare spesso quel ripiegamento su sé stessi, quella presa d’atto della propria alterità che tormentò Holderlin.
100
testimonianze raccolte da Dilthey1 come quella che vede Holderlin affermare, nel 1798: “ Vorrei vivere per l’arte alla quale appartiene il mio cuore, e invece debbo faticare tra gli uomini, tanto che spesso sono assai stanco di vivere”. O nel 1795: “Il disgusto di me stesso e di quello che mi circonda mi ha sospinto all’astrazione”.
Con l’insorgere della malattia Jaspers rileva come “questa coscienza di sè [diventi] a poco a poco, serena e ferma”2: la dolorosa frattura con il mondo viene ora compensata da un’accettazione sempre più consapevole della propria solitudine, che assume però adesso una valenza catartica. Scrive Holderlin nel 18013: “Finalmente lo sento, solo nella forza piena è amore pieno. […] Più sicuro un uomo è di sé, più è raccolto nel meglio della sua vita, più facilmente il suo spirito abbandona i sentimenti inferiori per ritrovare ciò che gli è essenziale”.
Quali gli effetti sull’opera?
Jaspers pone in evidenza come la poesia di Holderlin rifletta sempre più questa distanza dalla realtà. Ma c’è di più. In Holderlin c’è non solo un progressivo congedarsi dalla dimensione ontica. E’ la stessa epoca contemporanea a venir meno: Holderlin si sceglie una nuova patria, la Grecia antica. Il presente è obliato. Il mondo classico apre le porte ad un
1 Dilthey, Esperienza vissuta e poesia, cit., p. 382, cit. in Jaspers, p. 125 e ss. 2 Jaspers, p. 127. 3 Ivi.
101
universo mitico nel quale il poeta consumerà il suo esilio dal mondo e dal tempo.
Va detto che in Holderlin il senso di una vicinanza dell’uomo al mondo greco, al divino, alla natura, precede la malattia. Ma si tratta sempre di una nostalgia della bellezza e dell’assoluto. Durante la psicosi invece, si riscontra “Un sentimento di presenza immediata che lo colma e lo innalza in una sfera più vasta, più impersonale e fuori dal tempo. Holderlin avverte una presenza mitica nella quale la cosiddetta realtà dell’uomo atteggiato naturalisticamente non è separata dall’assoluto, dal divino. Ecco perché l’anelito si ritira, e aumenta in lui un senso di appagamento”.1
Nel 1802 Holderlin scrive: “Più la studio, più la natura della mia patria mi tocca profondamente. Il temporale […] in quanto potenza e forma fra le forme del cielo, la sua luce che plasma nelle nazioni e nei principi il destino acciocché qualcosa ci appaia sacro, il suo andare e venire, il carattere particolare delle foreste e l’incontro in uno stesso luogo di vari aspetti della natura, così come tutti i luoghi sacri della terra sono raccolti in uno stesso punto, e la luce filosofica nella mia finestra, ecco cos’è la mia gioia”2.
E’ proprio lo slancio di Holderlin verso il mondo classico a comportare quella liberazione dalle forme metriche tradizionali già rilevata da Dithley e ribadita da Jaspers, il quale sostiene che essa rappresenta “il risultato di una visione laboriosamente disciplinata, un sensualismo immediato” e che “in questa
1 Jaspers, p. 128. 2 Jaspers, p. 129.
102
intensità si può ravvisare la causa dell’eccitazione morbosa, insieme euforica e metafisica.”1
Fin qui dunque, si assiste di sicuro ad un nuovo registro di pensiero, ad un ritorno in termini creativi di inedite pulsioni. Ma non abbiamo ancora reso contezza della natura dei rapporti eventualmente istituibili tra i nuovi valori estetici espressi da Holderlin con l’insorgere della malattia, la mutata concezione del mondo e la malattia stessa.
Jaspers propone una soluzione di sintesi.
Da un lato è possibile affermare che l’evoluzione stilistica di Holderlin sia in linea con le sue aspirazioni di sempre, che il delirio avrebbe solo rafforzato.
Dall’altro si potrebbe concepire la schizofrenia come fattore condizionante dell’opera.
Per Jaspers, tra le due soluzioni non si da contraddizione.
Posto che “la schizofrenia in sé non è d’ordine spirituale”2, lo spirito essendo al di là dell’opposizione salute/malattia, come dimostra il fatto che “molti malati non si esaltano in una visione del mondo”3, e che dunque dipende non dalla schizofrenia ma dal “terreno sul quale la malattia si impianta”4, l’an ed il quomodo della creazione artistica, si può allora dire che “La schizofrenia permette talvolta all’uomo di conferire un senso alla
1 Ivi. 2 Jaspers, p. 120 e 129. 3 Ivi. 4 Ivi.
103
sua malattia e di valorizzarla legandola alla propria esperienza spirituale”.1
Non esiste una maestria schizofrenica, come non esistono i maestri schizofrenici di Prinzhorn. Esiste la poesia. Il resto è questione di fertilizzanti2. Certo non si nega come alcuni siano più potenti di altri, e come la schizofrenia consenta quella “unica fioritura impensabile nell’uomo normale” e che finisce poi “per distruggere tutto.”3
1 Ivi. 2 Accenniamo en passant che a simili conclusioni si è giunti anche nell’ambito di esperienze relative agli stati alterati di coscienza. Da Boudelaire a Cocteau ad Huxley, la natura di quel fenomeno che Huxley descrive come “ingresso nella psiche dell’Intelletto in Genere” dipende dalle predisposizioni e dalla formazione individuali: “Un pastore continuerà a vedere pascoli e vacche” dice Baudelaire nei Paradisi artificiali. 3 Jaspers, p. 130.
105
Lehman Brothers
Correndo sciancato come scarso debuttante
ai balli sfrenati della bolla immobiliare,
mi sono accorto con mesi di ritardo
d’esser morto di ferita d’arma
in grosso taglio, messo al corrente
d’esser sotto conto, durante un’escursione
al campo santo.
È il libero mercato, scotto da certificato, in testa alla finanza,
creativa, compulsiva, beccata ad armeggiare,
le mani nella borsa, con nobile burbanza.
Cadono banche,
titoli scendono come stelle nella
notte dell’Ade, innescando catene
di suicidi tra schiavi altolocati,
in tazze nude.
106
Libero mercato,
nato intorno al ‘900, autotreno trainante
in movimento, liberaci, animali
sul bordo della strada, dalle tue manie di investimento.
Ivan Pozzoni
107
Dove sarebbero finiti i liquami del cesso
di Roberto Lisi
Due sposi. Il parere di lui e il parere di lei. Lo sguardo di lui, lo sguardo di lei.
“Era una vacca…” disse il ragazzo mentre la ragazza continuava a toccare le ossa umide con un bastone:
“Non credo sia una vacca, mi pare piccola.”
“Ti ricordi di quella pecora che è stata avvelenata?”
“Parla piano” disse la ragazza, “o i vicini ci sentiranno.”
“Cosa vuoi che me ne importi?”
“Perché tutti devono sapere che nel nostro terreno è stata seppellita una carcassa?”
Nel frattempo un operaio aveva spento la ruspa ed era sceso a terra per vedere da vicino lo scheletro. Le ossa di una bestia di cui si vedeva soltanto la spina dorsale e le costole frantumate dalla pala meccanica, le zampe anteriori e una zampa posteriore, la coda e parte del collo. Il resto era ancora nascosto nel terreno.
Padre Stecchino era di ritorno dal magazzino edile con alcuni tubi in PVC.
L’operaio scaricò i tubi dalla mustang decappottabile:
“Padre, venite a vedere cosa c’è nella buca” disse.
Padre si avvicinò, e si sporse dal bordo di quello che era solo il cominciamento di un cratere grande.
“Mi sembra uno scheletro.” Disse Padre Stecchino mentre scendeva dentro la buca per toccare le ossa.
108
“Amore i vicini ci stanno guardando?” Chiese la ragazza.
Le ossa scintillavano.
“Con la pala meccanica devi scavare lo scheletro senza romperlo, e poi butta tutto nella mia macchina.” Disse Padre Stecchino all’operaio.
Padre uscì dalla buca e l’operaio si mise a lavoro; i due sposini, al sicuro in un lato del giardino, osservavano la ruspa e si scacciavano via dal capo i moscerini a vicenda.
La pala meccanica sollevò lentamente un boccone di terra, e Padre iniziò a gridare all’operaio di posare tutto nei sedili posteriori della mustang.
Se io fossi stato l’anima di quella decappottabile, avrei dimostrato una personalità meno remissiva.
La macchina invece assorbì il colpo molleggiando sulle sospensioni, come uno studente che molleggia sui tendini d’Achille per accomodare una borsa piena di libri sulle spalle.
Poi Padre salì in macchina, mise in moto e sparì.
I due sposi credettero che la decisione di portare via lo scheletro fosse dovuta alla necessità di andarlo a smaltire, secondo la normativa cogente.
L’operaio sudato riprese a scavare.
*
Sotto il sole le ossa brillavano molto, il movimento dell’automobile faceva cadere sull’asfalto manciate di terra, l’aria piegava qualche gladiolo ancora attaccato alla zolla enorme.
109
La mustang sfrecciava come una zattera surreale, appena uscita da un negozio di cappellini per signore eccentriche.
Per quello che riguarda il conducente della mustang, Padre era solo un soprannome, Stecchino il cognome. Padre era titolare di una ditta edile, e aveva un figlio, Natalino, di undici anni, che era solito ricevere delle bestiole in regalo. Morte soprattutto.
Una volta Padre aveva caricato nel cofano della mustang un volpacchiotto incidentato e lo aveva ucciso davanti a Natalino, a bastonate. Poi avevano provato a tagliare la coda per farla conciare da qualcuno e abbellirci la mustang. I pidocchi però si staccavano dal corpo morto del canide come uno sciame di locuste e alla volpe venne semplicemente dato fuoco prima che iniziasse la putrescenza.
*
La moglie di Padre stava lavando i piatti, e solo quando ricevette inaspettatamente un mazzo di gladioli si decise a guardare nel cortile. Natalino, sopra il cumulo di terra, cercava di disseppellire lo scheletro con le mani.
“Ma che cazzo hai portato?”
“Un fossile.” Disse padre ridendo.
“Devi per forza portare schifezze? Altrimenti non sei contento.”
La signora Stecchino uscì fuori di casa con i fiori in braccio e si avvicinò al ragazzino che aveva quasi scoperto la testa del fossile:
“Vammi a prendere un cucchiaio.”
110
“Ma che cos’è?” Chiese la donna. “Mamma, che palle, ti ho detto di andarmi a prendere un cucchiaio!”
“Fai come dice.” Disse Padre, e la donna andò dentro casa di corsa a prendere il cucchiaio. Dopo aver eseguito l’ordine, intimorita e nervosa, fece alcuni passi indietro, e quando Padre le poggiò la mano sulla spalla, iniziò a picchiare sulla testa del marito utilizzando i gladioli come fossero dei manganelli.
Il ragazzino nel frattempo prese a cavare terra infilando il cucchiaio nel teschio, nel buco che pensava avesse contenuto l’occhio sinistro di una grossa capra o di un puledro ancestrale.
I genitori erano andati a litigare in casa, e nel piazzale arrivavano grida ovattate:
“Cosa devi farci con uno scheletro! È orribile, voglio che lo butti via.”
“A te interessa solo fumare, e non pulisci la casa.”
“Che c’entra questo. Non ti permettere. Anche tu hai i tuoi vizi. Le ho trovate le bottiglie di grappa nella tua stanza. Fai schifo! Sei un porco.”
*
Natalino si rese conto di essere osservato. Dietro le sue spalle un’anziana signora vigilava completamente nuda.
“Sto pulendo un fossile.” Spiegò il ragazzino alla vicina di casa, pazza, che era solita vagare di notte, denudata per il caldo e per il freddo.
111
L’anziana, come un’ombra, scalza, si avvicinò alla macchina e sfiorò con la mano sinistra le ossa brillanti.
Al centro del teschio era ormai evidente il corno appuntito.
“Vuoi qualcosa da bere?” Chiese il ragazzino. E andò dentro casa per prendere dal frigo una bottiglia di Coca Cola.
La donna nuda si chiamava Bianca; si dissetò fissando lo scheletro.
Poi nel quartiere scese la calma, e tutte le famiglie si rinchiusero dentro le abitazioni per il sonnellino pomeridiano.
Gli Stecchino scaricarono lo scheletro nel piazzale e lo lasciarono lì fino al giorno seguente. Al mattino il ragazzino uscì con il cucchiaio. La mustang era piena di rondini, e tirando il cucchiaio sulla carrozzeria, Natalino le fece scappare.
Il teschio dell’unicorno non c’era più.
Il ragazzino tenne con se uno stinco che chiuse in una scatola per ciabatte, e fece buttare il resto dello scheletro.
Il giorno dopo, Bianca – vestita – trascinava il teschio tenendolo per il corno; lasciando una scia nella strada polverosa. Lasciò il teschio nel cortile degli Stecchino, e da quel momento nessuno la vide più girare nuda.
*
Natalino crebbe, e divenne molto effeminato. Dimostrò che in molti di coloro che venivano a contatto con il teschio d’unicorno, guarivano da malattie terribili.
“Natalino? Una ragazza malata di aids.”
112
“Va bene falla entrare, ma fate in fretta.”
Così una donna magrissima venne fatta avvicinare allo scheletro che era posto al centro di una grande sala.
“Già stargli vicino dovrebbe darle forza…” Disse Natalino che non voleva far avvicinare troppo la donna malata al teschio magico.
La donna invece si avvicinò subito e volle toccare il corno che evidentemente riteneva la parte più potente. Poi fece qualche carezza al muso orribile.
“Basta, basta, basta!” Disse Natalino, e fece allontanare la donna in lacrime.
Altri pellegrini avevano pagato il biglietto.
Il teschio aveva ispirato almeno cinque romanzieri, diecimila giornalisti, e diversi documentaristi.
In Giappone, alcuni scienziati erano riuscito a clonare l’unicorno utilizzando lo stinco che Natalino aveva conservato nella scatola.
Nelle librerie e nelle edicole i romanzi che parlavano degli unicorni si moltiplicarono sempre di più. Le multinazionali dei giocattoli producevano piccoli unicorni di gomma con le code da tingere e pettinare. In Italia vennero aperti Bar e circoli dell’unicorno, e addirittura una clinica veterinaria assunse il nome “Clinica dell’Unicorno”. Persone per bene giuravano di essere state guarite da questo o quel male dopo aver toccato il teschio, e non facevano che aumentare il flusso dei disperati verso la reliquia.
113
Anche molti cattolici vedevano nello scheletro la prova che la teoria dell’evoluzione era completamente sbagliata; il teschio apparteneva all’esemplare di una specie che non aveva fatto in tempo a salpare sull’Arca di Noè.
Natalino manteneva contatti sempre molto stretti con il Giappone, e teneva monitorata a distanza la fronte del puledro. Ogni giorno gli scienziati sfregavano la testa del clone con le speranza di sentirci un bozzetto, e invece nulla.
In tutto il mondo si era parlato della clonazione dell’unicorno. Le lastre fatte al teschio mostravano chiaramente che il corno faceva parte dell’osso frontale, e che la bestia era cresciuta con il fardello.
Ogni giorno centinaia di fedeli si chinavano davanti al teschio, protendevano la mano dominante verso la reliquia prima di avvicinare la stessa mano alla bocca aperta, come a voler mangiare un etere medicamentoso.
Poi il fedele piangeva, o sveniva, iniziava ad avere allucinazioni, o rideva.
Un uomo aveva cercato addirittura di distruggere il teschio, e i fedeli l’avevano fermato uccidendolo a calci e pugni.
Lo Stato italiano aveva cercato di espropriare la reliquia per metterla al sicuro in una villa in Sardegna.
Si erano costituiti gruppi di cavalieri dell’unicorno che giuravano fedeltà all’orribile cranio.
Fantasy divenne il nome di una religione che credeva negli esseri leggendari.
In un paese si tenne ogni anno una manifestazione popolare, ed una foto del teschio veniva fatta girare per le strade.
114
*
Una notte, gli adepti della religione di Fantasy entrarono nel museo in cui era custodita la reliquia e la portarono via.
Dall’altra parte del mondo un piccolo pony crebbe, senza corno, e senza mostrare potere di guarigione. Natalino venne assassinato, ma con un testamento, donò a Fantasy fino all’ultimo spicciolo.
116
Le Stelle
Non riuscirò ad avere paura.
il corpo sa tutto, non risponderà mai alle mie domande,
ma esso sa già tutto. Urlando,
dice quello che vuole dire, solo quando lo desidera dire.
Il mio capriccioso interrogare
non può che essere secondario: poiché l’immanente è divino
e, ogni giorno, ripetutamente, la storia ne incarna la vita
che pulsa forte ed incontenibile.
Ecco, il corpo è un profeta stordito,
Stordito da una vitalità insostenibile, mentre si annullano sangue, terra ed eterno.
Ora tutto va bene.
Renata Schiavo
117
Le stelle intermittenti
di Lorenzo Spurio
Ogni volta che mia madre mi sgridava, correvo in soffitta e mi mettevo a guardare le stelle. Erano belle. Alcune mandavano una luce intermittente come se si trattasse di un’abatjour accesa e spenta di continuo. Altre avevano una luminosità continua. A me piacevano di più quelle che si accendevano e si spegnevano perché,in fondo, avevano qualcosa di più misterioso. Spesso fissavo la stessa stella che si oscurava e poi ritornava ad essere lucente per minuti di seguito poi, chiudevo gli occhi per alcuni secondi e, quando li riaprivo, cercavo di indovinare quale era la mia stella. A volte mi riusciva ma nella maggioranza dei casi no. Di tutta prima mi convincevo che quella che vedevo era proprio la mia stella ma poi ne vedevo altre vicine molto simili ed entravo improvvisamente in crisi cosicché mi infastidivo e ripetevo il gioco anche tre o quattro volte di seguito. Passavo delle intere nottate in soffitta ad ammirare le stelle. La mamma, avendo la sua camera di letto al piano inferiore, credeva che mi trovassi a dormire. Ed in realtà lo ero perché nel mio colloquio con le stelle c’era qualcosa di anormale o di surreale. Era come se mi trovassi nello stato di torpore che precede il sonno. Per la mamma stavo dormendo ed invece io trovavo la mia pace contemplando l’infinità della volta azzurra soffermandomi ogni volta su alcune stelle che, più che sembrarmi delle stelle, per me erano dei lumini fiochi e distanti che venivano lambiti da un vento freddo e regolare che le faceva spegnere e riaccendere al tempo stesso.
Quando morì la nonna, la mamma prese ad accatastare una serie di cose appartenute alla nonna nella soffitta. Inizialmente
118
fui infastidito da questo perché, pur volendo bene alla nonna, non volevo che il mio spazio fosse condiviso con altri. Più volte avevo pensato di dire alla mamma che siccome la nonna era morta anche i suoi vestiti e la sua poltrona avremmo dovuto buttare via. Non mi azzardai mai a farlo, temendo che la mamma mi dicesse qualcosa di brutto. Così nel giro di poco tempo la soffitta fu riempita di vestiti, coperte e della poltrona appartenuta alla nonna. Quando la mamma credeva che dormissi, io andavo ogni volta a sistemare la roba in maniera che prendesse lo spazio più piccolo possibile e che potessi quindi continuare a stendermi sotto il lucernaio. Ogni volta la mamma non si accorgeva che qualcuno spostava la roba appartenuta a sua madre. Visto che quello che importava alla mamma era accatastare le robe della nonna in soffitta e non di conservarle come ricordo, un giorno presi una gonna della nonna e la tagliai a brandelli con un paio di forbici arrugginite, anch’esse appartenute alla nonna. Disposi i pezzi della gonna della nonna sul pavimento in maniera confusa, non so per quale motivo ma poi fui infastidito dalla vista di quei brandelli e cosi decisi di buttarli via ma non sapendo dove gettarli in modo che mia madre non li vedesse, li gettai ingenuamente dalla fessura del lucernaio.
Notavo che la mamma era cambiata molto dopo la morte della nonna, forse stava ancora soffrendo la sua mancanza. Cercavo di starle vicino ma questo non serviva ad alleviare il suo dispiacere che si fece tanto più acuto quando capii che la mamma faceva utilizzo di gocce che avrebbero dovuto tenerla su di morale. Non ci riuscivano a tenerla su. Il suo volto era diventato molto pallido ed aveva gli occhi molto infossati. A volte
119
facevo difficoltà anche a sentire la sua voce poiché aveva cominciato a parlare con un tono flebile, forse ulteriore segno della sua debolezza. Cominciavo a pensare che anche la mamma presto sarebbe morta e allora sarei stato costretto ad ammassare le sue cose in soffitta per liberare la casa. Cercavo di rifuggire quel pensiero perché avrebbe significato la fine del mio svago notturno.
Una sera, dopo essermi assicurato che la mamma avesse preso la sua dose di gocce per star tranquilla e per dormire, andai in soffitta e mi sdraiai sotto il lucernaio. Non c’erano stelle. Non riuscivo a vedere nessuna stella, nemmeno quelle che normalmente emanavano una luce continua. Pensai che forse la causa della mancanza di stelle era che c’era cattivo tempo e per questo c’era una cattiva visibilità. Chiusi gli occhi più volte, sperando di trovar le stelle una volta che tornavo a riaprirli. Niente. Allora mi alzai e cercai di forzare la piccola finestrella del lucernaio, quando mi accorsi di una cosa che mi mise di cattivo umore. Il vetro del lucernaio era completamente ricoperto dai brandelli di gonna della nonna che la sera prima avevo tagliuzzato, impedendomi la vista delle stelle. Tolsi subito quei pezzi di stoffa e mi sdraiai ad ammirare le stelle ma non provai nessun piacere nel farlo. Ad un certo punto mi alzai e mi sedetti sulla poltrona che era stata della nonna e scoppiai a piangere.
120
A[d] incastro
Odi note, toni d'onde,
selvagge come il glastro. Leggere, come spuma sulle sponde,
carezzando l'alabastro dello scoglio si calano nei fratti come sonde
a[d] incastro e sibilano sinfonie profonde.
Riccardo Raimondo
122
A giugno, se non prima
Tutto sarà buono, se avremo
fresca sete e vino schietto,
se gli aerei avranno ritardi quanto più lunghi, così durante le attese potremo scrivere
quante più buone poesie da leggere a colui che ci attende all'altro capo:
è pericoloso per troppo tempo fare il poeta
che nulla scrive; la lingua si ammala
oppure s'inizia a portare la terra a qualche passo sopra la testa. Non vedo l'ora
di leggere la tua storia –
non ho alba
di quello che racconti, non posso sbagliare: perché pensi tanto alla conclusione,
io ho appena iniziato.
Andrej Hočevar1
1 Traduzione dallo sloveno di Primož Sturman
123
Arrivo in ritardo
Nella fredda acqua del lago
galleggiano poche foglie spazientite,
nelle castagne, prossime alla maturazione si sta destando un senso di disagio:
non sarai qui
quando cadranno a terra.
La giornata con le proprie ultime forze preleva gocce dai nostri corpi
e senza troppo interesse
si ritira in favore della sera: non è più estate
e non è ancora pieno autunno.
Andrej Hočevar1
1 Traduzione dallo sloveno di Primož Sturman
125
E le altre dove sono?
Intervista ad Anaïs Ginori
di Eloisa Morra
Anaïs Ginori è giornalista de la Repubblica: nel febbraio 2010 ha pubblicato il libro-inchiesta Pensare l’impossibile. Donne che non si arrendono (Fandango libri, 2010). Eloisa Morra l’ha incontrata per noi.
Eloisa Morra: Anaïs, iniziamo dalle tue esperienze lavorative: quali gli aspetti più profondi e curiosi che, guardando a ritroso, ti hanno spinta verso il giornalismo? Devi aver iniziato molto giovane, visti gli articoli e i libri: Pensare l’impossibile è il terzo, preceduto da Le parole di Genova (2001) e Non calpestate le farfalle (2007).
Da piccola fabbricavo in casa un giornalino con le notizie della mia famiglia e dei miei amici. Poi cercavo anche di venderlo, e i miei genitori, inteneriti, mi davano una paghetta. Insomma, ho capito presto di voler fare questo mestiere, a dire il vero, se mi fosse andata male, non avrei saputo cos’altro fare. Durante gli studi all’università ho iniziato subito a cercare lavoro. Ho fatto stage in redazioni francesi e italiane, perché sono bilingue, mia madre è francese. Alla fine, sono riuscita a mettere un piede a La Repubblica come collaboratrice, ho fatto tutta la trafila, passando per i supplementi, poi l’assunzione alla
126
redazione locale di Firenze. Ogni esperienza è servita.
Per i giovani che oggi vorrebbero iniziare a muovere i primi passi verso la professione di giornalista la strada sembra quanto mai in salita: tirocini che spesso assomigliano a vere corse ad ostacoli, impossibilità di riuscire ad avere i ‘giusti contatti’ per iniziare a lavorare se non si proviene dalle Scuole di Giornalismo, richiesta di una flessibilità di orari e capacità non adeguatamente retribuite. Insomma, l’impressione che si ha dall’esterno, da ‘non addetti ai lavori’, è che il giornalismo, almeno in Italia, stia quasi per trasformarsi nella “nuova casta”. Sei d’accordo con questa analisi impietosa? Quali sono i tuoi consigli per chi adesso vorrebbe iniziare?
Credo che la tua analisi non valga solo per i giornali ma per qualsiasi percorso lavorativo in Italia. Nei giornali c’è una mancanza di opportunità forse maggiore perché attraversiamo un momento di crisi congiunturale e strutturale. Forse dopo si riapriranno le porte per i giovani, almeno lo spero. Penso che l’unica cosa che valga sia leggere tanto i giornali, essere aggiornati e curiosi, fare tante proposte, andare da qualcuno non dicendo “vorrei fare” ma: "guarda cosa ho fatto”.
Parliamo del libro: le storie sono molto varie, tutte interessanti ed in qualche modo tristi e divertenti allo stesso tempo; dopo aver finito di leggerlo, ti confesso che mi sono chiesta “Ma come è successo?” Come abbiamo fatto a perdere così tanti treni?’ . Non parlo soltanto del
127
femminismo, ma della quasi assoluta mancanza di consapevolezza, nelle persone della mia età, di come sono andate le cose nel nostro paese negli ultimi cinquant’anni. È come se si fosse persa la memoria di ciò che è stato, e si stia quasi cercando di ricostruire un filo rosso per farci ritrovare la strada che abbiamo perso. Si vede che il libro è stato scritto per i più giovani.
Di questo ti ringrazio e chiedo: c’è stato un momento particolare che ti ha spinto verso questa avventura? In quanto tempo hai raccolto le testimonianze? Con quali criteri hai operato una selezione?
E’ un libro scritto d’impulso, mi sembrava necessario. Ho organizzato un viaggio intorno alle storie che più mi avevano colpito. Mi è bastato fare il mio mestiere, ovvero porre domande e cercare qualcuno che può dare risposte. Ne è uscito un racconto corale di come siamo e di com’eravamo. Sono testimonianze di donne diverse fra loro, che vengono da tante generazioni. Ogni voce parla di un segnale di degrado della condizione femminile (lavoro, immagine, violenza, maternità, etc.) e propone una possibile reazione. Non c’è una Soluzione, con la ‘s’ maiuscola, ma tanti esempi di resistenza. Alla fine, mi sembra che il libro sia meno pessimista di come l’avevo immaginato. Sottotraccia, c’è sempre la forza delle donne.
Mi hanno molto colpito le pagine in cui parli della attuale modificazione/mistificazione del linguaggio televisivo, che invece di esprimere sembra mirare a nascondere la verità dei fatti. In questo senso sembrano sempre attuali (anche se derivavano da tutt’altro contesto storico e culturale) le parole di Italo Calvino nel suo intervento sull’ antilingua:
128
«Nell’ antilingua i significati sono sempre allontanati, relegati in fondo ad una prospettiva di vocaboli che di per se stessi non vogliono dire niente o vogliono dire qualcosa di vago e sfuggente». È una domanda complessa, lo so, ma quali credi siano i migliori strumenti per riuscire a combattere questa ‘deriva del linguaggio’?
Prendiamo la parola “escort”. Nel libro sono partita da questo nuovo vocabolo perché mi sembrava che ci allontanasse dalla realtà. Dava una falsa rappresentazione. “Escort” trasmette l’idea che la prostituzione sia glamour, che le donne che vendono il proprio corpo lo fanno in piena libertà, ben pagate, bevendo champagne in saloni affrescati. Non è così. La prostituzione in Italia è al 99% una condizione di schiavitù, sono donne in mano alla criminalità organizzata, costrette a stare sui marciapiedi per pochi euro e spesso vittime di violenze senza poterle neanche denunciare.
Diverse delle storie che hai raccontato riguardano donne che hanno viaggiato e sono riuscite ad avere qual quid in più studiando o lavorando all’estero per diversi periodi. Anche per te è stato così?
E’ vero. Molte delle donne ‘che non si arrendono’ hanno vissuto all’estero. Daniela Del Boca è un’economista che insegna tra Torino e New York. Lorella Zanardo è stata manager negli Usa e in altri paesi europei. Credo che la distanza permetta di vedere meglio la situazione dell’Italia, che è di arretramento assoluto per la condizione femminile. In Francia, dove c’è parte della mia famiglia, le donne sono più dell’80% della forza lavoro
129
(quasi il doppio che da noi) eppure questo è il paese del baby-boom: 2,3 figli per donna, contro 1,2 in Italia.
Mi ha molto colpito, nel libro, la differenza di opinioni delle donne più giovani ed esponenti del movimento femminista degli anni ’70 sia sulla questione del backlash (il contraccolpo del maschilismo dopo l’avanzata del femminismo) sia in generale sulla attuale condizione e considerazione del ruolo della donna nella società italiana. Sembra quasi che le seconde, ad esempio Luisa Muraro, siano molto più ottimiste delle più giovani, come se l’innegabile miglioramento della situazione rispetto a trenta anni fa giustifichi l’assenza di una ‘ resistenza’ forte e dialogante oggi. Credi che si possano sviluppare dei flussi di dialogo concreto e serio fra le femministe di un tempo e le ragazze di oggi? In che modo?
Molte delle protagoniste delle battaglie femministe degli anni settanta non capiscono lo scontento delle giovani d’oggi. Ai loro tempi bisognava ottenere diritti elementari, come quello del divorzio, dell’aborto, esisteva ancora il delitto d’onore, le donne erano fuori dalle università, dalla magistratura… Oggi la discriminazione delle donne non è più nelle leggi, ma nella realtà. Esistono presunte libertà e vere costrizioni. Le ragazze che ho incontrato non vogliono tutte fare le veline. Ma provano un senso di disillusione perché studiano come e meglio dei maschi ma sanno che, molto probabilmente, troveranno meno facilmente lavoro, avranno impieghi più precari, avranno una carriera frenata rispetto ai colleghi uomini. E se vorranno avere una famiglia, pagheranno un prezzo altissimo.
Parliamo della televisione e del ruolo della donna nei
130
programmi della Tv italiana e di come dare visibilità ai modelli positivi e, aggiungerei, reali. Il documentario di Lorella Zanardo, Il corpo delle donne ed il libro omonimo, sono stati fondamentali segnali di dissenso nei confronti dei tre ruoli che vengono di solito assegnati alle donne in Tv: decorazioni senza spessore, puri oggetti erotici, o “donne-prosciutto” da umiliare pubblicamente. Quali credi siano gli strumenti adatti da un lato a creare degli “anticorpi” nei tanti, ragazze e ragazzi giovani, che guardano abitualmente la Tv, dall’altro a dare visibilità a dei diversi modelli di donna?
Mi sembra che altri tipi di donne capaci e meritevoli esistano eccome. Il problema è che i giovani fanno fatica a conoscerli e vederli abitualmente.
In proposito ti cito una ricerca del Censis. Nella tv italiana, le donne sono prigioniere di ruoli di moda/spettacolo/bellezza (38% delle trasmissioni) e raramente sono rappresentate in programmi dedicati alla cultura (6,6%), alla politica (4,8%), alla realizzazione professionale (2%). Trovare in un varietà italiano una donna valorizzata per le sue “capacità umane e professionali”, è praticamente impossibile. Si tratta poi di solito di figure “comprimarie”, con un maschio “dominante”. Appena il 10,3% dei programmi d’intrattenimento sono condotti da donne. Da un punto di vista anagrafico la discriminazione è clamorosa: solo il 4,8% dei programmi propone figure con un’età sopra ai quarant’anni. Gli anticorpi si sviluppano vedendo altri modelli femminili di successo. Quello che gli americani chiamano ‘role model’. Ci sono donne con capacità e coraggio che possano servire d’ispirazione per le più giovani. Nel libro, ne ho scelte
131
soltanto alcune. Ovviamente ce ne sono tante, basta cercarle nelle università, nelle aziende, a volte anche in politica. Sono esempi di come il mondo femminile sta cambiando, anche in Italia.
Quali i tuoi prossimi progetti ed impegni?
I primi di giugno sarò al Festival Letterature della Basilica di Massenzio ai Fori Imperiali con due miei monologhi: il tema è l’amore, in questo caso l’amore per il corpo. Il primo monologo, che verrà recitato da Isabella Ragonese, sarà quello della «velina», il tipo di donna che imperversa in televisione, che parla di come per lei il corpo sia un vero e proprio «strumento» di lavoro; il secondo, che leggerò io stessa, darà voce alla «velata», una donna occidentale che decide di convertirsi all’ Islam e di coprire il proprio corpo con un velo che lascia scoperti soltanto gli occhi.
Il tema comune è il concetto di una femminilità in pericolo, minacciata dagli stereotipi.
133
Come pubblicare un libro
Recensione al manuale di Andrea Mucciolo
di Enrico Santus
Dopo appena un anno da "Come diventare scrittori oggi", la Eremon Edizioni ha scommesso nuovamente su Andrea Mucciolo, in libreria col suo secondo manuale "Come pubblicare un libro".
L'autore ancora una volta si rivolge agli scrittori esordienti che vorrebbero pubblicare le loro opere senza cadere
nella pericolosa ragnatela dell'editoria a pagamento. Le opportunità, da quanto emerge nel testo di Mucciolo, ci sono, specialmente nelle riviste di settore. Un po' più difficile (ma non impossibile) è trovare editori onesti: l'autore dedica un'intera sezione del libro ai più comuni rischi nascosti nelle clausole contrattuali.
Il passaggio dal primo al secondo manuale è morbido: ogni capitolo è introdotto da una citazione, alcune informazioni sono state semplicemente rielaborate, altre invece arricchiscono il contenuto del predecessore.
Mucciolo, che sa di rivolgersi ad un pubblico variegato e spesso confuso, decide di utilizzare un linguaggio semplice e diretto (qualche volta troppo), arricchendo il testo con numerosi esempi tratti dalla propria esperienza personale o inventati ad hoc. Alcune interviste a editori o autori emergenti rendono il volume più vivo e attuale.
134
Silvia che seppellisce i morti
di Andrea Corsiglia
Col desiderio di fuggire da una vita
amara, Silvia abbandona la propria casa e vagabonda in compagnia del suo gatto per colline e paesi, incontrando amici e sconosciuti, alla ricerca di se stessa e di una gerbera fuori stagione. I pensieri tornano a suo figlio Davide, perso nel viaggio allucinato di una tossicodipendenza feroce; tornano al suo ex, Umberto, donnaiolo avvenente e spaccone, professionista del furto,
smarrito in una vita da fuorilegge che ora chiede il conto. Seguiamo le loro esistenze randagie scorrere indipendenti e parallele; ma anche Davide e Umberto pensano a Silvia, e infine la cercano. Nel contempo, sulle sue tracce s’è messo anche uno spasimante monomaniaco che, nutrito dall’odio per il rifiuto ricevuto da Silvia, è disposto a tutto pur di vendicarsi. Gli incontri-scontri dei protagonisti formano progressivamente un intreccio fitto, una trama con colpi di scena, ribaltamenti di senso e di prospettiva, sostenuta da uno stile che sa misurare la caratura delle parole, nel ritrarre il reale come nelle incursioni visionarie. Un amalgama letterario e psicologico che avvince il lettore dalle prime battute sino al sorprendente finale.
135
Claudio Bagnasco è un giovane scrittore genovese. Giovane, ma con già all’attivo intensi interventi nelle riviste letterarie “Nuova Corrente” e “Testuale”, un romanzo d’esordio, Luciana (Carabba, 2007) e diversi racconti pubblicati nell’antologia Genovainedita (De Ferrari, 2008).
Silvia che seppellisce i morti è il suo nuovo lavoro, edito da Il Maestrale, nelle librerie dal 10 novembre scorso. Romanzi intensi quelli scritti da Bagnasco, che affascinano per la tensione emotiva e per lo stile puntuale, trascinante. L’abbiamo incontrato nella sua Genova, per meglio comprendere come sia possibile, ancora oggi, puntare a una scrittura di qualità evitando facili compromessi editoriali. L’abbiamo incontrato per indagare più da vicino la sua Silvia.
Silvia che seppellisce i morti è il tuo secondo romanzo,
Luciana il primo. Due nomi di donna nei titoli, e due protagonisti femminili.
Cosa ti ha portato a questa scelta, insolita per la narrativa italiana?
Gentile Andrea, intanto permettimi di salutare tutti i lettori di
Aeolo, e di ringraziare te e la rivista per lo spazio concessomi. Per rispondere alla domanda: ma, chissà. Le mie due
protagoniste sono donne perché – e qui mi si scuserà se sono a filo di retorica – ho sempre associato la tenacia alla femminilità; e in entrambi i romanzi la tenacia è uno dei motori della narrazione. Poi, dei due nomi Luciana e Silvia, mi hanno interessato le suggestioni etimologiche e letterarie (lascio all’abilità dei lettori di Aeolo rinvenire, nei luoghi della letteratura, nobili ascendenze dell’uno e dell’altro nome).
Infine c’è il caso, sovrano nella vita e nella scrittura. Per dire: due mie raccolte di racconti, di più o meno prossima
136
pubblicazione, s’intitolano In un corpo solo e Mentre aspetto; sono dedicate rispettivamente alla sorpresa e alla morte, e in entrambe le raccolte le figure femminili perdono la centralità che hanno nei due romanzi.
Qual è il sentimento che ha ispirato il romanzo, la riflessione
da cui ha preso vita questo inseguirsi di vite smarrite, ai margini della società ?
Lo spunto iniziale è quasi aneddotico: una sera mi
presentarono Silvia, un’attrice teatrale (una brava attrice teatrale, che qui saluto, siccome ci vediamo sempre meno). Silvia era in crisi per una storia d’amore naufragata. Mi colpirono il suo pianto improvviso - lì al tavolo con me, uno sconosciuto – e la sua repentina reazione: asciugarsi le lacrime, dire una parolaccia apotropaica, sforzarsi di riprendere la chiacchierata interrotta. Dieci minuti dopo, avevo in mente il titolo. Poi, come per ogni cosa che scrivo, la trama è scaturita da un lento sedimentarsi di appunti, idee, collegamenti, visioni, fantasmi e quant’altro.
Infine: non so dire se i personaggi di Silvia siano vite smarrite o ai margini della società. Certo sono tutte figure giunte – più o meno consciamente – a un punto cruciale delle proprie esistenze.
Cosa intendi per punto cruciale?
137
In una piccola ma illuminante recensione a quel capolavoro che è L’opera lasciata sola di Cesare Viviani, Enrico Testa parlò di attimi in cui la vita si presenta in veste di destino. Ecco: quelli sono i punti cruciali dell’esistenza.
Il motivo della ricerca è dominante in entrambi i romanzi, è il
motore che muove la narrazione, dettandone i tempi. Cosa ti ha spinto a indugiare
su questo tema? Mi pare che tutto ci sfugga; e che, per quanto nell’epoca della
tecnologia e dell’informatica sino all’ossessività il desiderio di possesso dell’esistente, la natura e l’inconoscibile ci soverchino.
Tuttavia, la ricerca – quando siamo consapevoli che sia solo un friabile contrafforte al nulla in cui siamo sospesi, e non una narcisistica volontà di addomesticarlo, questo nulla – può fungere da dolce e innocente sollievo.
Lo stile della tua scrittura è molto sorvegliato, attento. Puoi
spiegarci il perché di questa scelta? Questa domanda sottintende qualcosa di perverso: che sia
possibile scrivere (parlo di scrittura professionale) adoperando uno stile non sorvegliato, non attento. Come se un pittore si mettesse a dipingere senza saper distinguere il nero dal grigio, o un sacerdote azzardasse la predica domenicale confondendo l’Ecclesiaste con l’Apocalisse di S. Giovanni.
Stavo perdendo tempo: so bene che oggigiorno la disattenzione alla parola (che è disattenzione alla vita) è grande, anche tra chi lavora nel mondo editoriale, scrittori compresi. Io cerco soltanto, per quanto mi è possibile, di rimanere immune
138
almeno da questo peccato. Sei uno scrittore giovane ma già ti distingui per l’abilità
narrativa e per la cifra stilistica. Come sei arrivato a così felici esiti?
Che io sia arrivato “a così felici esiti”, Andrea, lo dici tu; perciò
ti assumi tu – lasciami fare una battuta – la responsabilità di questa frase.
Mi ripeto: uno stile sorvegliato mi pare il minimo grado di onestà, per pubblicare un libro senza che la notte ci vengano a visitare atroci incubi, e di giorno non meno tremendi sensi di colpa.
Per la (presunta) abilità narrativa è questione di molto lavoro. Leggere, leggere, leggere; e scrivere, leggersi, rileggersi. Questo, naturalmente, in estrema sintesi.
Che consigli ti sentiresti di dare a un aspirante scrittore, sia
per quel che riguarda la formazione che sul come muoversi nell’intricato mondo delle
case editrici ? Andiamo con ordine. Sulla formazione: leggere di tutto. I classici di ieri e di oggi
(che so, da Omero a Cormac McCharty) per imparare a scrivere; ma anche i quotidiani, i fumetti, le riviste, i blog, le pubblicità sugli autobus, per seguire gli inevitabili mutamenti linguistici, sia
139
diacronici (nel tempo) che sincronici (i vari livelli di scrittura in un unico periodo storico).
E Platone, per imparare a ragionare (e a scrivere) con logicità, cosa che oggi mi pare non sappia fare quasi più nessuno.
Poi, una regola aurea per quanto concerne lo scrivere: scrivete una cosa breve, correggete una sola volta, lasciate nel cassetto per mesi, poi rileggete. La cosa vi apparirà orribile. Scrivete un’altra cosa breve e rifate tutta l’operazione. Quando, forse dopo anni, la cosa ripresa dal cassetto smetterà di farvi orrore, datela magari in lettura a qualcuno che possa restituirvi un giudizio sincero e attendibile (e quindi meglio il severo docente universitario che non il vostro migliore amico il quale incondizionatamente vi adora).
Non abbiate fretta: e qui mi collego all’ultima parte della domanda. Cercate, se proprio non resistete alla tentazione di spedire il vostro dattiloscritto a qualche casa editrice, un editore il cui catalogo sia affine a ciò che avete scritto. Niente romanzi erotici alle Edizioni Paoline, ecco.
E infine, per cortesia, state alla larga dalle case editrici a pagamento. Se il tizio X della casa editrice a pagamento Y, affascinato dal vostro romanzo, vi chiederà di sborsare una somma, parlando di partecipazione al rischio d’impresa, ditegli che il rischio d’impresa di uno scrittore è tutto il tempo adoperato nella lettura, nella scrittura e nel labor limae.
E poi, con un paragone un poco greve, pubblicare a pagamento e dire: “questo è il mio libro” non mi pare diverso dal presentarsi agli amici a braccetto di una prostituta (o di un gigolo) e dire: “questa è la mia fidanzata” (o fidanzato).
E’ possibile oggi, nell’epoca della comunicazione
inessenziale, fare letteratura che non sia intrattenimento,
140
distrazione? Tutta la letteratura, ma forse più genericamente ogni nostro
gesto, è intrattenimento e soprattutto distrazione. Distrazione dalla paura della morte.
Aeolo, in questo numero, si è occupato della criminalità
organizzata. La parola “mafia” che sentimenti le suscita? Mi riesce difficile rispondere a questa domanda, perchè
detesto sia fare la figura del buono, che quella dell’eccentrico. Proviamo così, istituendo un ponte col discorso fin qui svolto:
la mafia, come ogni organizzazione criminale, fa perno sulla paura. Paura degli affiliati, paura di coloro che sanno ma non denunciano.
La conoscenza, quando – come dicevamo prima – è disgiunta dall’ansia di possesso, può dare alcuni aiuti in questo senso. Può, per esempio, restituire il senso infinitesimale della nostra singola esistenza; e dunque, passo successivo, può persuadere che vivere nel costante soccorso reciproco – anziché nel costante antagonismo con l’altro – sia l’unica possibilità di alleviare di quel poco la marginalità della vita, e l’assurdità della morte.
Ecco allora che la paura si trasformerebbe da strumento di sopraffazione a strumento di solidarietà.
Mafia e romanzi che parlano di mafia. Anche questo un “buon
affare?”
141
In cauda venenum, vero? Non so (o forse so ma nicchio) se questa domanda si riferisca a uno specifico scrittore.
Io penso una sola e semplice cosa: che ciascuno debba fare ciò che sa fare. Senza sconfinare, per colpa della vanità, in ambiti che non gli competono; però certamente facendo con tutto il coraggio possibile, e con tutta la solidarietà possibile da parte di chi possa offrirgliela, ciò che – per propria indole e per pubblica approvazione – sa fare.
142
Zoo col semaforo
di Fabiana Pellegrino
Un bestiario fantastico fermo al
semaforo. Quello di Paolo Piccirillo è un mondo animale umano, troppo umano. È un bosco disincantato in bilico tra realtà e finzione. È una visione scoperta dal buco della serratura di casa nostra. Piccirillo si immerge nel mondo e ne esce ora come un’anatra pneumatica, ora come un polipo curioso, ora come una sogliola rossa, ora come un granchio con gli occhi che si incrociano. Ogni
volta ha uno sguardo diverso e assieme uguale. Creare un bestiario fatto d’immagini e parole è forse la sua maniera per comprendere qualcosa di altrimenti oscuro: la vita, l’amore, l’amicizia. Emozioni che prendono le forme di animali abbandonando quelle umane, troppo poco umane. La leggerezza delle bestie corrisponde alla fatica di vivere degli uomini. “Zoo col semaforo”, pubblicato dalla casa editrice Nutrimenti, è una favola al contrario, è un insieme di pezzi di destini che diventano una storia unica. È un racconto che assomiglia a un film girato al rovescio, è una porta spalancata sul mondo che si guarda a testa in giù. Piccirillo usa tutti i suoi ventidue anni e la sua fantasia per creare e disfare quello che conosce da una vita. Caserta e la desolazione degli spazi sub-
143
metropolitani, il grigio della tangenziale e un mercato rionale che diventa un circo di personaggi umani e disumani. Una grande parata di assurdi punti di vita che assieme costruiscono un grandioso affresco in cui la bestia diventa umana e viceversa. Il punto di vista è quello degli animali, l’autore ha le zampe catramose, la schiena rossa per non mimetizzarsi col mondo, l’indecisione della zecca e gli occhi al contrario. Ogni pagina crea un mostro buono che spezza le aspettative e ruba tenerezza, rispetto e coinvolgimento al lettore. Ogni bestia, poi, ha la sua resurrezione. Questo colpisce dell’immaginazione di Paolo Piccirillo: la sorte umana affidata a chi umano non è. Un bestiario in cui si è curiosi di vivere, ci si meraviglia del mondo fuori dall’acqua, si esiste senza nascondersi. Un bosco fantastico in cui si tenta, si cambia, si rischia, esattamente come non si fa nell’altro mondo. Gli animali diventano quello che noi non siamo più, ricordano quello che noi abbiamo ormai dimenticato, osano dove noi abbiamo rinunciato. “L’anatra pneumatica era felice sempre nel momento sbagliato”, è sempre lei che “sporca di grasso sul petto e sulle ali” si confonde tra le marmitte e “ne era soddisfatta perché le marmitte stanno bene solo quando non sono costrette a fare quello per cui sono state inventate”. Esattamente come l’anatra, esattamente come noi. Una rivoluzionaria esistenziale che decide per sé. Il sospetto, naturalmente, è che l’anatra non sia soltanto questo. E poi c’è la sogliola rossa, diversa da tutte le altre che “passano tutta la vita a non esistere”. “La sogliola rossa invece esisteva, eccome. Lei la vita la passava a scavare buchi in cui sotterrarsi. L’unico modo che aveva per essere come le altre sogliole era scomparire sotto la sabbia, sotterrandosi anche gli occhi”. La sogliola passa la sua vita a scavarsi un posto in cui sopravvivere, finisce cieca sotto la sabbia per sparire e non esistere. Eppure lei è semplicemente diversa dalle altre sogliole.
144
Lei, invece di scomparire, si attacca a uno scoglio e resta lì ferma e compiaciuta di quell’indifferenza. E sopravvive. E il gatto che salta giù da sette piani perché è curioso di capire cosa c’è oltre il suo balcone. “Era la prima volta che i suoi cuscinetti rosa toccavano l’asfalto della strada. L’asfalto era sporco, caldo nonostante l’inverno. E lui si ricordò di quando stava con gli occhi chiusi sul davanzale della casa nuova e della casa vecchia, e pensò invece a quanto era bello tenerli aperti gli occhi in quel momento, quando per la prima volta vedeva il mondo da lì”. È questo il filo conduttore che disegna il bestiario di Paolo Piccirillo: gli occhi aperti. I suoi animali sperano e guardano, sognano e provano. Muoiono, ma conoscono. Resistono. Come i due pitbull protagonisti, assieme ai loro padroni, di questa storia fatta di mille frammenti.
Un mercato rionale del casertano, una bancarella che vende animali che appartiene a Salvatore, un albanese che in realtà si chiama Slator. Un banco che si tiene in piedi perché usa il semaforo della strada come pilastro. La bancarella è uno zoo col semaforo. Un giorno che Salvatore non c’è, il suo pitbull attacca il figlio del macellaio del paese. Il cane finisce massacrato e abbandonato sulla tangenziale, dove c’è Carmine a raccoglierlo. Carmine, o’ Schiattamuort, tutti i giorni va a pregare sulla lapide di suo figlio, morto azzannato proprio da un pitbull, il secondo di questa storia. Destini che si incontrano, per caso, tra bestie non addomesticate alla vita e uomini addestrati alla morte. Quello che colpisce, ancora, di questo romanzo, è la maniera in cui Paolo Piccirillo compone la storia scomponendola in pezzi tutti da risistemare man mano. Una scrittura elastica, visiva, fortemente contemporanea, fatta di cinema e di immagini più
145
che di visioni letterarie. La lettura è piuttosto un percorso a ritroso nella storia, si comincia dalla fine e scorrendo le pagine, le vicende si ricompongono come se fossero tessere di un puzzle disegnato a testa in giù. Ogni volta lo scrittore ci consegna un tassello di questa storia, a ogni pagina ci concede una spiegazione che poi aumenta il caos calmo del racconto. Sono concessioni di sostanza le sue. Ci spiega, mano a mano, i personaggi del quadro che sta lì, pieno e incomprensibile, fin dalla prima riga del suo romanzo. Eppure abbiamo bisogno di lui per capirlo e questo ci lega profondamente alla storia. Questa conquista di senso progressiva corrisponde alla costruzione dell’identità del racconto, che poggia, a sua volta, sui contorni di bestie e uomini che prendono forma. È un disegno che si compone a ritroso, fatto di apparizioni fantastiche che un senso, pure in questo mondo di catrame e sporcizia, di morte e mare, ce l’hanno. Quello di Piccirillo è un film girato al contrario, è un flash-back continuo e irreversibile. Ogni personaggio, animale o umano che sia, conquista la sua pienezza sulle pagine. Una pienezza di vita e non solo di parole. Qualcosa che è umano pur appartenendo alle bestie, di qualunque razza siano.