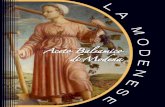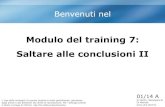2 il menù è DA NON SALTARE “la conoscenza · Interni ed esterni dell’anima Sul Vinceti, noto...
Transcript of 2 il menù è DA NON SALTARE “la conoscenza · Interni ed esterni dell’anima Sul Vinceti, noto...
Magari istituendo severissimepene per chi osi ripetere in pub-blico che “con la cultura non simangia.” … si prendano a esempioe guida gli umili e furbi ambulantidi Piazza dei Miracoli a Pisa, cheapparecchiano le loro bancarelle all’ombra del Battistero e della Primaziale poi-ché sanno bene che è solo grazie all’accostamento o alla vici-nanza, concettuale e per-sino fisica, allasublime grandezza dell’arte italiana cheriusciranno a vendere la loropaccottiglia.
[Bisogna] investire in quel bene immensoe immensamente delicato che èla conoscenza... “
edoardo nesi 22/10/2012
2
RIUNIONEDI FAMIGLIA
uesta settimanail menù è
DA NON SALTARE
Laicitàin bilico
Siliani a pagina 2
Q
GALLERIE&PLATEE
Di Benedetto a pagina 5
ICON
Rosi a pagina 6
ICON
Interni ed esternidell’anima
Sul Vinceti, noto fiutatored’ossa
Gavioli a pagina 7
a pagina 4
La tradizionedel viverein villa a Firenze
La pubblicitàdisincarnata
La Melandri, il MaXXI e gli attributi
CCUO
.com sabato 3 novembre 2012no2 PAG.2
E’, forse, una condizione fisio-logica della laicità quel suostare in bilico danzando coninstabile e leggero equilibrio
sulla fune tesa fra la tutela dei dirittiumani e la preoccupazione per le di-verse identità e culture contempora-nee. Lo si direbbe ascoltando l’intensodialogo, organizzato dalla Fondazione“Ernesto Balducci”, fra Gustavo Zagre-belsky e Massimo Cacciari, lo scorso19 ottobre in Palazzo Vecchio, “Laicitàin bilico”. Introdotto da un’impegnatarelazione di Pierluigi Onorato (presi-dente del Comitato Scientifico dellaFondazione), il dialogo ha toccato lecontraddizioni quotidiane del nostrovivere in una società in cui tante e di-verse culture interagiscono in un pro-scenio globale. Riferiamo qui soloalcuni stralci del dialogo.Gustavo Zagrebelsky Stiamo af-frontando un tema che è, per sua na-tura, aperto alle oscillazioni, contrastie perfino conflitti. Per fortuna è così,perché il tema della laicità contrap-pone due modi di vedere l’esistenza.Usiamo le forme del Qoelet, “sopra esotto il sole”. Noi viviamo sotto il sole,ma ci sono coloro che cercano qual-cosa sopra il sole. Il sopra e il sottosono necessariamente in tensione. Setrovassimo la formula vorrebbe dire oche il sopra schiaccia il sotto (ierocra-zia, teocrazia), o il sotto (l’esperienzasecolare) assorbe quella religiosa perfarne uno strumento. E’ vitale tenereaperta la tensione. Può esserci una ci-vitas senza religio, una vita sociale e po-litica della città senza una religione? E’una domanda che pongo non in rela-zione alle situazioni storiche, perché èchiaro che le nostre società de factoconoscono una ricca esperienza reli-giosa. Ma la domanda è categoriale.Risalendo indietro nel tempo c’è untesto, che ci è pervenuto attraverso unaconfutazione di S.Agostino, di MarcoTerenzio Varrone un erudito del I° se-colo a.c., che si è interrogato sulle fun-zioni della religione tanto da suscitarela confutazione di S.Agostino nella“Città di Dio”. Per Varrone ci sono treforme di religione: mitica che si cele-bra nei teatri i cui sacerdoti sono icommedianti, naturale in cui l’espe-rienza religiosa e lo studio di Dio sonomateria scientifica e i cui sacerdotisono i filosofi e i templi le accademie,e poi c’è la religio civilis che si celebranelle chiese pubbliche costruite con isoldi della città dentro le quali ope-rano i sacerdoti. Dice Varrone: le cittàsi fondano e immediatamente sidanno i loro Dèi. Noi non ci doman-diamo il perché, giacché dobbiamoobbedire ad altri uomini. Qual è il fon-damento del dovere di obbedienza? E’interesse dei governanti dire che lalegge che loro producono non deri-vano da un loro arbitrio ma da un’in-vestitura superiore. Quindi la religiocivilis serve a cementare l’obbedienzadi una città, a fondare il legame sociale.S.Agostino non può essere d’accordo
di Simone [email protected]
DA NON SALTARE
con questa visione e la rovescia: primac’è Dio e poi ci sono le città. La reli-gione è il fondamento della vita civilee non il contrario. In ogni caso, oppo-ste le convinzioni ma identico il puntod’arrivo: non può esserci una cittàsenza legame religioso. E noi sap-piamo bene che perfino le rivoluzioniatee si sono date i loro Dèi: quella fran-cese la Dea Ragione e Robespierre hadetto che non esiste maggior criminepolitico che l’ateismo fondando ilculto dell’Essere Supremo. Il costituzionalista tedesco Ernst-Wol-fgang Böckenförde è diventato famosoper il suo dictum: lo Stato liberale se-colarizzato vive di presupposti cheesso stesso non è in grado di garantire;questo è il grande rischio che si è as-sunto per il suo grande amore per la li-bertà. Qui la libertà è da intendersicome diritto di impossessarsi di beni(materiali, ma anche culturali o spiri-tuali), il singolo che richiede sempredi più per sé . Questa richiesta, nellesocietà basate sulla libertà, si rivolgeallo Stato e così facendo ne erode le ri-sorse. Una volta che si sono ricono-sciuti i diritti politici, si generano idiritti sociali, si riconoscono e si gene-rano nuove esigenze che si riversanosullo Stato; questo aumenta la pres-sione fiscale; ma ad un certo punto siincontra un limite e con grande fru-strazione: la crisi fiscale dello Stato. Daqui parte la riflessione di Böcken-förde, ma non nel senso che la reli-gione cattolica venga indicata come ilcemento di fronte al disfacimento mo-rale della nostra società, bensì comeun appello ai cattolici affinché si impe-gnino nella vita pubblica. Nella vulgataitaliana invece questa posizione è statautilizzata per sostenere le richieste diinvestire la religione di un ruolo civile.Ma l’ammonimento di Böckenfördeva considerato: viviamo in una societàche erode progressivamente le sue basidi stabilità per essere fedele al suo im-printing, l’amore per la libertà. E’ unproblema serio: nessuna vita socialepuò esistere senza un terzo. I tentatividi concepire la vita sociale solo in unrapporto orizzontale, uno-l’altro, conlogiche contrattualistiche pure, non ri-solvono il problema. Noi possiamostabilire patti sociali fra di noi, ma senon c’è un terzo che possa garantirnel’osservanza, questi patti non valgononulla. Locke, nell’ “Epistola sulla tolle-ranza”, dice che i diritti civili nonavrebbero dovuto essere riconosciuti
per i papisti perché la loro fe-deltà non era al re d’Inghilterra
ma al Papa di Roma, mapoi aggiunge agli atei, per-ché essi non stanno ai patti.
Noi viviamosotto il sole,ma ci sono coloro che
cercano qualcosa
sopra il sole.Il sopra e
il sotto sononecessaria-
mentein tensione Cioè non possono riferirsi ad un terzo
come garante dei patti stipulati. Ora,non necessariamente questo elementoterzo deve essere la religione. Però l’ap-pello a qualcosa che vada al di là dellanostra sfera individuale e che ci unificaagli altri, è indispensabile. Ecco perchéalla domanda “ci può essere una so-cietà senza religio?”, risponderei nega-tivamente. Naturalmente non è dettoche la religio sia la religione che cono-sciamo. Può essere la religione assuntacome questo elemento terzo? Questopoteva essere prima dell’età moderna,quando ancora non si riconosceva ilpluralismo. Oggi non può essere la re-ligione l’elemento esclusivo o predo-minante. Valorizzare solo unareligione, significa svalorizzare tutte lealtre componenti della società. Iocredo che nessuna vita sociale, tantomeno se basata sulla democrazia, puòprescindere da questa dimensione
Laicità in
“
Un dialogotra Zagrebelskye Cacciari
CCUO
.com sabato 3 novembre 2012no2 PAG.3DA NON SALTARE
terza, ma se vogliamo vivere in demo-crazia nel rispetto della libertà di tutti,questa dimensione terza deve esserecostruita e non imposta e in questa co-struzione c’è spazio per tutti coloroche rispettano l’eguale possibilità deglialtri di contribuire, che quindi dannoprova di tolleranza, di apertura, di ca-pacità di dialogo. C’è dietro tutto que-sto una sfida, perché oggi abbiamo difronte un corpus di dottrine sociali edetiche molto forte ed molto visibileche proviene dal magistero dellachiesa cattolica: in questa situazionestorica il peso della Chiesa nel crearequesta terzietà sia predominante. Maè una condizione di fatto. Spetta a chinon si riconosce in questa prospettivadimostrare di essere capaci di dare illoro contributo al consenso etico difondo della nostra società.Massimo Cacciari Io credo che icattolici farebbero meglio a leggersi
S.Agostino piuttosto che il Böcken-förde. Per Agostino la città è formatada cittadini della città degli uomini edi quella di Dio ma sono tutti cives. Lacittà è per sua natura plurale. Agostinoera romano. Nulla di più lontano da luil’idea di poter ridurre la città ad unum.E’ la critica fondamentale di Aristotelea Platone: la città è molti, conflitto. Lacittà è polemus: Pico vi rileva la stessaradice di polis. E’ un peccato di certisettori della Chiesa introdurre la falsaidea della riduzione ad unum e non va-lorizzare invece il momento in cui lacittà di Dio, all’interno della città plu-rale, testimonia se stessa, come città diDio. Il problema è se siamo capaci ditollerare questa tensione, laddove per“tolleranza” penso al suo significatovero, “tollere”, elevare, mettere alla luce;non sopportazione. Siamo in grado,laici e credenti, di valorizzare la cittàcome contraddizione, di rendere co-stituente il conflitto? Questo è il puntodella grande tradizione politologica daMachiavelli a Hobbes a Locke. Romaha conquistato il mondo grazie allelotte fra patrizi e plebei e ha comin-ciato a decadere quando si è iniziato aridurla ad uno solo. Il punto fonda-mentale della tensione è chiaro: all’in-terno della città giocano due posizioninon conciliabili a tavolino. Da un latoc’è la tradizione della filosofia politica,della laicità nel mondo moderno-con-temporaneo che non dice semplice-mente “c’è qui l’organizzazione statualeautonoma rispetto alla religio”. Non c’èmai stata una divisione pacifica dicompetenze, di campi, perché la posi-zione laica, che ha le sue radici nelpensiero Medievale, è una posizione dibattaglia contro le sette, contro i “se-duttori del popolo” diceva Hobbes, ele sette sono quelle che pretendono diorganizzarsi autonomamente e che ri-fiutano la figura del Leviatano, che hain mano i simboli dei due poteri. Ilpunto di vista di questa tradizionelaica è che la posizione dell’Uomo re-ligioso è inferiore a quella della razio-nalità filosofica e la fede è un affareprivato. Che però è illogico perchénon è mai esistita né può esistere unaposizione di fede che possa lì essere re-legata perché l’uomo di fede deve te-stimoniarsi. Dall’altra parte, però,quando si dice “date a Cesare ciò cheè di Cesare”, si afferma una cosa moltocomplessa: l’interpretazione che èstata data a queste parole di Gesù era“restituisci a Cesare la moneta perchélì sta il suo segno, ma tutto il resto –anima e corpo – è di Dio”. Una po-sizione altrettanto irreali-stica perché nonpuò esistere un
potere politico che non abbia niente ache fare né con il corpo né con l’anima,se non altro perché deve esibire dei va-lori per ottenere il consenso. La di-mensione della religio civilis èimmanente ad ogni espressione di po-tere politico; non basta avere la pro-pria faccia sulla moneta. Ne sappiamoqualcosa in questo periodo: la monetanon fa società, non crea famiglie poli-tiche, non crea valori. La dialettica deivalori dobbiamo declinarla nello spa-zio della democrazia, ma dobbiamosapere che essi sono tutti “valutati” di-ceva Nietzsche, sottoposti a interpre-tazioni. Io credo che la strada giusta siaquella indicata da Zagrebelsky: discu-tiamo quale sia questa terzietà, masono dei valori in questa accezione. Lalibertà, che ha un timbro essenzial-mente individuale. E l’uguaglianza,che dice che questa libertà non deveessere in contraddizione con la ricercaalmeno di parità di opportunità. Li-bertà e uguaglianza sono in contrasto,perché io potrei volere la libertà perdifferenziarmi da te, non per essertiuguale. Certo essi sono i principi dellademocrazia: ognuno di noi vuole es-sere libero (cioè distinguersi dall’al-tro), eppure le democrazie si reggonoperché creano condizioni di ugua-glianza. Cosa tiene insieme queste duecose? Il terzo è la solidarietà, la fratel-lanza. Perché il nostro anelito ad esserelibero deve legarsi ad un rapporto disimpatia con il prossimo, altrimentiesso disfa i fondamenti della civitas.Questa fratellanza non può derivare dauna particolare etica o religione per-ché farebbe venir meno il pluralismosu cui si fonda la società democratica.Per S.Agostino questo conflitto è irri-solvibile sul piano storico, sul pianovaloriale, ma solo sul piano escatolo-gico. Le due città non possono giun-gere a conciliazione. Se vogliamosuperare la contraddizione, allora dob-biamo declinare quel terzo sposandolocon il primo, libertà. Il dilemma ècome l’essere libero possa comporsicon fratellanza. Il costituzionalismo ciprova, ma bisogna sapere che lo puòfare solo presentando dei valori che,però, sono sempre “valutati”, interpre-tati e interpretabili, non valori-religio.Occorre tollerare questa situazione.Ma allora dobbiamo comprendere chela Chiesa è titolata a proporre la religiocome fondamento della civitas, magarinelle forme dell’etica, ma sappiamoche è un trucco perché quando un cre-dente presenta un’etica, per lui è un va-lore assoluto. Però occorre ammetterloperché si fonda sulla necessaria fragi-lità della società democratica, basatasul pluralismo e dunque sul conflitto.
bilico
Siamoin grado,
laici e credenti,
di valorizzare la città come
contraddi-zione,
di rendere costituente il conflitto?
“
CCUO
.com sabato 3 novembre 2012no2 PAG.4
Registrazione del Tribunale di Firenzen. 5894 del 2/10/2012
direttoresimone silianiredazione
sara chiarelloaldo frangioni
rosaclelia ganzerlimichele morrocchiprogetto graficoemiliano bacci
editoreNem Nuovi Eventi Musicali
Viale dei Mille 131, 50131 Firenzecontatti
www.culturacommestibile.comredazione@[email protected]
www.facebook.com/cultura.commestibile
“ “Con la culturanon si mangia
Giulio Tremonti
LE SORELLE MARX
La Melandri, il MaXXIe gli attributiCi saremmo aspettate di tutto nella vitama di difendere Giovanna Melandri pro-prio non ci sarebbe passato in mentenemmeno dopo abbondanti brindisini colrosolio che ci piace tanto. Perché la Si-gnora, già ministro, non è tra le compa-gnie più gradevoli che noi si sia incontratoné abbia molto a cuore di farsi ben volereper simpatia e affabilità. Almeno a nostrogiudizio. Tuttavia, la vicenda della no-mina alla presidenza della Fondazionedel MAXXI di Roma da parte dell’at-tuale governo della Melandri ci ha spintoa fare alcune considerazioni.La prima èche solo in questo povero Paese la nominadi un ex-ministro alla cultura, peraltrocompetente e che di cultura si è sempre oc-cupato, alla guida di una fondazione cul-turale sia vista come uno scandalo. E sibadi non sulla base di un giudizio sul-l’operato della suddetta quale ministro,ma per il semplice fatto che si nomina unex-ministro. Ci domandiamo cosa ne sa-rebbe stato di Jack Lang in questa nostraItalia, visto che questi ha costruito largaparte della propria fortuna culturale (e
immaginiamo economica) propriodall’essere stato ministro con Mit-terrand. La seconda questione è
circa il concetto di merito.Ci si è scandalizzati per-ché in questo Paese l’esser
stato un politico ha più valore dei titoli edelle competenze. E giù con la retoricadella fuga dei cervelli, del laureato che falo spazzino, e via via… peccato che nes-suno si è fermato a vedere quale incarico èstato offerto a Melandri, complice l’infor-mazione che ha riportato la notizia cheMelandri avrebbe diretto il MAXXI. Pec-cato che non sia così e che a GiovannaMelandri non è stato proposto di diven-tare il direttore o il curatore di un museodi arte contemporanea ma di fare la pre-sidente della Fondazione culturale cheamministra e dirige il museo. Ecco oraspecificate quali doti e titoli debba dete-nere il presidente di una siffatta fonda-zione. Magari deve conoscere imeccanismi istituzionali e tecnici che re-golano il mondo delle istituzioni culturaliitaliane? Deve avere una rete di relazionied autorevolezza in modo da garantireattenzione e “cura” al proprio museo? E cidite in un Paese in cui la cultura è al 99%affare pubblico quale figura migliore diun ex ministro assomma queste caratteri-stiche? Il discredito verso la politica haormai raggiunto livelli tali (molto percolpa della politica stessa sia chiaro) chesiamo arrivati al punto che per far di-spetto alla moglie il marito ha già messo“gli attributi” sul ceppo. Non resta che ta-gliarli.
ZAPRUDER
Pillolea 8mmQuando l’uomo di oggi cerca la sal-vezza, non cerca la salvezza dell’anima.Cerca la salvezza totale. E allora le reli-gioni che fanno? Esortano a pregare diooppure si impegnano a mobilitare tuttele energie dello spirito perchè l’uomo fi-nalmente avvii un capitolo nuovo dellasua storia, che è il capitolo della pace, dacui è espunta cioè la legge della forzacome strumento del diritto, come stru-mento di verità? Ora questo è un capi-tolo completamente nuovo per lereligioni monoteistiche il cui dio grondadi sangue. Le religioni sono state subal-terne a culture fra loro aggressive. Iltempo nuovo è il superamento delle reli-gioni, e quindi anche del cristianesimocosì com’è, che deve quindi rigenerarsi,perchè per me questa fine non è unamorte: mi viene in mente il motto evan-gelico "se il chicco di grano non muorenon darà frutto". Questo cristianesimodeve morire per dare frutto. Morire vuoldire trovare la propria fecondità sorgiva,il proprio annuncio profetico. Quindi iosono ottimista. non in senso trionfali-stico, perchè io non penso ad una conver-sione di tutti gli uomini al cristianesimo.Penso alla presenza nel mondo di un fer-mento evangelico, rappresentato da co-munità di fede, che è un fermento disalvezza per tutti, anche per quelli chenon si convertono. Questo è un principioper me fondamentale. Perchè mi dà sere-nità nel guardare la pluralità delle cul-ture e delle religioni nel mondo.
Ernesto Balducci
I CUGINI ENGELS
Sul Vinceti,noto fiutatore
d’ossaL’inno di guerra di Giuseppe Ga-ribaldi scritto dal poeta Luigi
Mercantini nel1858 e musicato
da Alessio Oli-vieri aveva unglorioso inci-pit: “Si scopron
le tombe, si levano i morti; I martirinostri son tutti risorti...”. E’ parso diudire questo pugnace e glorioso inno loscorso 24 ottobre intorno a mezzodìdalle parti di Sant’Orsola quando Sil-vano Vinceti – presidente della V In-ternazionale della Cultura il poconoto Comitato per la valorizzazionedei beni storici artistici e culturali – haaperto la tomba terragna che secondolui poteva contenere i resti dellaMonna Lisa, alias Lisa Gherardini.Così, il Vinceti Silvano ha scalzato ilSeracini Maurizio dalla vetta dellaclassifica mondiale delle prime trombe(ovvero, tromboni) della cultura eresta l’unico a dominare il palcosce-nico della cultura-spettacolo. D’altraparte il Vinceti è recidivo, un segugio,un vero cane da tartufi, anzi da ossa:già nel 2009 si era messo alla sensa-zionalistica ricerca delle ossa di Mi-chelangelo Merisi da Caravaggio. Maquesto “Indiana Jones de’ noantri” hauna vera mania per la ricerca di ossadi morti: apprendiamo dalle sue inter-viste che prima di Caravaggio, è an-dato in cerca di Petrarca, Boiardo (conl’immancabile libro-scoop), Pico dellaMirandola, Poliziano e Leopardi. Ecom’è che nasce questa passione necro-fila? Per caso, come ci confessa il Vin-ceti: lui, che non legge il “Corriere dellaSera”, un giorno lo compra e legge diun’archeologa testimone oculare del ri-trovamento dei resti ossei del Caravag-gio e da lì nasce il desiderio di dargligiusta sepoltura. Ma i ritrovamentisono assai meno certi degli annunci einfatti se ne sono perse le tracce. Cheperò gli sono valsi una consulenza alministero al turismo di Maria VittoriaBrambilla e una pagina sul “WallStreet Journal” che ironicamente tito-lava: “Prossimamente su Csi: Rinasci-mento, chi uccise Caravaggio?”.P.S. In questi giorni si sfornano e sivendono a Volterra i famosi biscottichiamati “ossi di morto” se il Vincetiva nella città etrusca è certo che delleossa le trova, inpasticceriaperò, senza bi-sogna di sca-vare.
RIUNIONE DI FAMIGLIA
Essendo dei fedeli seguaci di Pierre Bayard, autore del celebre volume “Come par-lare di un libro senza averlo mai letto”, evitiamo accuratamente di sfogliare i libriche ci vengono sottoposti per la consueta recensione. Guardiamo la copertina, met-
tiamo il volume nella libreria perpoterlo vedere di costola mentreguardiamo la televisione, certevolte, eccezionalmente diamoun’occhiata anche alla quarta dicoperta per decifrare il codice abarre che, per chi sa leggerlocome noi, da informazioni utilis-sime. Ma per “L’accoppiatore difantasmi” di Frank Hakman(Neroni editore) abbiamo fattouna strappo alla nostra rigidaregola. Ci ha attratto quel titoloche può far pensare ad un tor-bido e maniaco personaggio cheattrae coppie ectoplasmaticheper assistere ai loro eterei rap-porti sessuali. Curiosità super-morbosa la nostra? Ma? Sta difatto che abbiamo iniziato le let-tura e dopo 232 pagine, scorsesenza interruzione, questo ac-coppiatore non veniva fuori,anzi, quello che noi pensavamo
fosse un super guardone noir non era altro che un banale Ghostbuster che inseguivai fantasmi per poterli uccidere. Attività per altro assai ossimorosa quanto l’arduo “Oviva morte” del Petrarca. Ci siamo infine accorti che tutto l’equivoco nasceva da unorrendo refuso della copertina, infatti nel frontespizio il titolo giusto era: “L’accop-patore di fantasmi”. Ci siamo così convinti che dobbiamo approfondire di più lanostra attenzione ai libri e leggere, oltre alla coperta anche il frontespizio.
CCUO
.com sabato 3 novembre 2012no2 PAG.5
“PURIOR HIC AER LATE /HIC PROSPECTUS INURBEM” è il testo del-l’epigrafe su un pilone
in pietraforte del cancello al n. 8 di viaTrento. Liberamente tradotto suonacosì: “Qui (c’è) aria più pura in abbon-danza, qui un affaccio sulla città”.L’epigrafe chiarisce meglio di ogni di-scorso le ragioni di una scelta residen-ziale elitaria che a Firenze è statarinnovata per ben sette secoli. Il cancello costituisce l’accesso a unavilla in stile neoduecentesco costruitanegli anni Venti del secolo scorso.L’ignoto fondatore, nell’apporre la la-pide, forse non ebbe piena consapevo-lezza del fatto che essa sintetizzava, inun latino raffinato, il pensiero che haspinto quasi trenta generazioni di fio-rentini (e anglo-fiorentini) a realizzarela propria casa sulle pendici collinari,fino a formare quella “città in villa” cheè diventata una delle attrattive più spe-cifiche e celebrate di Firenze.A partire dalla forzata quarantena del1348, che relegò in collina, secondo lafinzione letteraria del Decamerone, lagiovane Fiammetta, i suoi nove com-pagni di narrazione e tutti i benestantiin grado di lasciare la città per evitarela Peste Nera, ogni fiorentino agiatoha coltivato l’ambizione di una resi-denza sugli spalti dell’anfiteatro colli-nare.Tuttavia il primo argomento (la pu-rezza dell’aria) aveva avuto un realefondamento solo finché Firenze erastata una città ‘d’antico regime’, comedicono gli urbanisti. Ossia finché fu af-flitta dal fetore e dai miasmi, cometutte le città prive di quei dispositivitecnico-igienici che sono propri dellacittà moderna: acquedotto, fognature,cimiteri, impianti isolati per la macel-lazione e per il trattamento dei restiorganici. Tutte opere di cui Firenze cominciò adotarsi già negli ultimi anni del Gran-
Lontano dai fetori e dai miasmi
di Gaetano di [email protected]
ducato e che sul principio del Nove-cento erano ormai perfettamente a re-gime. Negli anni Venti perciò la cittànon aveva più un’aria tanto meno re-spirabile di quella che potevano van-tare le sue colline, e queste perconverso non distavano abbastanzadalla città per poter millantare un’ariadavvero pura.Viceversa il secondo argomento (l’af-faccio sulla città) aveva allora e con-serva ancora oggi tutta la sua fascinosafondatezza. Firenze è infatti una dellepoche città di rilevanti dimensioni chepossa essere contemplata nella sua in-terezza da una molteplicità pratica-mente illimitata di punti di veduta,grazie a due circostanze rare: lo svi-luppo urbano è stato rigorosamentecircoscritto dentro la conca; le collinecircondano la città molto da presso. La qualità di questa visione è talmenteelevata che il “panorama di Firenze”,celebrato come icona fin dal 1471 (Ve-duta della Catena, Francesco di LorenzoRosselli), costituisce una delle rappre-sentazioni più conosciute dal turismouniversale. E doveva essere così già ametà dell’Ottocento, se il Poggi in-ventò per goderlo il più noto belve-dere del mondo, piazzaleMichelangelo. L’ambizione di possedere ed ostentareuna propria, irripetibile angolazionedi questa veduta, da tutti conosciuta eammirata, è stata, è e probabilmentesarà il principale fattore di attrazionedella residenza suburbana in collinaper molte generazioni ancora di fortu-nati.
In alto Firenze, laMappa della Catena
A fianco l’epigrafe su un pilone del cancello dell’edificio
in via Trento (sotto)
La tradizionedel vivere invilla a Firenze
CCUO
.com sabato 3 novembre 2012no2 PAG.6
Passando davanti alla GalleriaAlessandro Bagnai siamo ob-bligati a entrare, qualcosa ci at-trae in modo irresistibile,
qualcosa che percepiamo al di là dallebelle opere esposte, qualcosa che ciparla di libertà, quella vera, quella in-teriore che ci permette di essere distac-cati ma allo stesso tempo partecipi allavita. Vedere le dodici opere, in tecnicamista su manifesti, di Paolo Leonardoè un impatto emotivo oltre che visivo;sono manifesti pubblicitari deconte-stualizzati che l’artista stacca e riela-bora nel suo studio fino a trasformarliin altro. La libertà sta nel riappropriarsidella pubblicità riportandola a una di-mensione emozionale, empatica e so-prattutto pittorica. E’ la libertà diaffermare la nostra unicità oltre l’im-maginario collettivo. Paolo Leonardoinveste le immagini femminili dei ma-nifesti con la pittura e la sua emotività,le devia, le porta su un altro territorioche ricorda la trasformazione delbruco in farfalla così che lo spirito/far-falla delle figure femminili è liberodalla materia/pubblicità. Affascinantidonne in nero escono dallo sfondobianco argento, librandosi nello spaziodella Galleria. Sono farfalle, sono li-bere, sono belle; la loro avvenenza nonè più stereotipata ma è la loro essenza.Paolo Leonardo chiama “disincarna-zione della pubblicità” il suo modo diintervenire sui manifesti propagandi-stici per deformarne il senso e farnealtro dove la pittura s’impadronisce delmarketing e dove l’artista ricerca unrapporto empatico ed emotivo con leimmagini. In esse vede un potenziale ein alcune anche un potere magico e, at-traverso l’intervento pittorico, istauraun dialogo con esse.Dopo la morte, la disincarnazione è unprocesso dove lo spirito cade in unsonno profondo e subisce una trasfor-mazione fino a che “la catena d’ar-gento” che lo lega alla materia si spezza,solo allora sarà libero di seguire il suopercorso nel mondo dell’aldilà. Losfondo argento delle opere di PaoloLeonardo si spezza per fare volare vialo spirito; questo è ciò che accade aimanifesti che l’artista stacca, strappa, civa sopra con la pittura cambiandonecompletamente forma e soprattuttocontenuto. Il messaggio non è piùquello della pubblicità ma tutt’altro, ilmessaggio è di rielaborare con la no-stra empatia, con la nostra unicità, conla nostra emotività le immagini che lasocietà ci propina. La libertà maggioreè essere in grado di reinterpretarle efarle nostre, instaurando con esse unarelazione. Le figure diventano evoca-tive e Paolo Leonardo ci lascia una sug-gestione, un’atmosfera e la possibilitàdi creare noi stessi una storia.Completa la bella mostra di Paolo Leo-nardo una video-proiezione di AlbertoMomo che documenta il lavoro per-formativo dell’artista a Parigi. La mo-stra sarà visitabile fino al 15 dicembre2012.
Paolo Leonardodisincarnala pubblicità
di Angela [email protected]
ICON
CCUO
.com sabato 3 novembre 2012no2 PAG.7ICON
Ha inaugurato il 26 Ottobre aSpazioBlue la prima mostrabolognese dell’artista Mika-yel Ohanjanyan, in/outside of
me. Mikayel, artista armeno, vive elavora da molti anni a FirenzeSpazio-Blue è un progetto culturale con spa-zio annesso che punta il suo sguardosulle nuove leve dell’arte contempo-ranea. Luogo di ricerca, la missiondello staff, composta da giovani cu-ratori e critici, è quella di indagare lenuove tendenze culturali del pano-rama nazionale e internazionale.Con questa mostra ha aperto leporte al progetto dell’artista armenoper l’anniversario dei cinquant’annidel gemellaggio Italia-Armenia.
Mikayel Ohanjanyan, vincitore delPremio Targetti 2010, inizia il suopercorso dagli studi classici, utiliz-zando elementi tradizionali per, poi,maturare il suo pensiero verso la ri-cerca della forma e dei nuovi mate-riali. Tutta la mostra è incentrata sulconcetto di tensione. Tensione den-tro e fuori, da destra a sinistra, cheesplode e implode cercando l’agita-zione interna della nostra società. Ilgioco della contrapposizione delcubo, elemento che si ripete ossessi-vamente, nelle sue opere, esprime lasua netta opposizione con le corde.Le corde diventano domande incerca di risposte, enigmiirrisolti, elastici tesi,che vogliono incurio-sire, ricercare e dialo-gare con un’apparenterigidità. Una società ir-requieta, costretta e ra-pida che non lasciaspazio al dubbio. Il cuborappresenta noi stessi, ilpunto di concentramento,quello focale in cui si fissalo sguardo, diviene l’ele-mento accentratore delcarattere, si trasformanella scoperta di uno spa-zio interiore, conciliante,in cui rifugiarci. Il pro-getto creativo di Ohan-janyan parte dallostudio degli statid’animo, di se stesso,prima di indagare glialtri, per poi espan-dersi al di fuori di sé.
Internied esternidell’animadi Simone Gavioli
di Tommaso [email protected]
MikayelOhanjanyan
artistaarmeno-fiorentino
allo SpazioBluedi Bologna
La settima artea San Casciano
In un’epoca dominata dal 3D, dalle pay-tve dall’indottrinamento televisivo di massa,il Gruppo Cineforum dell’Arci di S.Ca-sciano promuove la quinta edizione di unarassegna di arte cinematografica nata perconsentire al pubblico di confrontarsi e discuotersi dal torpore della crisi e dall’indi-vidualismo consumistico (la nostra“quarta dimensione”).Quest’anno ab-biamo scelto film di ogni epoca di diversipaesi del mondo (tra le new entry dell’an-nata troviamo anche l’Iran e la Sud Corea)per far scoprire strade poco battute, manon per questo meno interessanti. Nelleprime serate abbiamo affrontato prevalen-temente i temi della rivoluzione, dell’ami-cizia e della differenza tra ceti sociali in trefilm di genere completamente diversi.Abbiamo iniziato lo scorso 12 ottobre de-dicando l’apertura a uno dei più grandimaestri del cinema italiano: Sergio Leone.Il suo “Giù la testa” (secondo capitolo della“trilogia del tempo” insieme a C’era unavolta il West e C’era una volta in America)narra la storia di un amicizia fra un peonesmessicano e un ribelle irlandese nel pe-riodo della rivoluzione messicana ai tempidi Pancho Villa e Emiliano Zapata. Unvero e proprio classico senza tempo.La seconda sera è stata la volta del film ri-velazione dell’anno: il francese “QuasiAmici” di Nakache e Toledano. Una pelli-cola che narra la storia di un ricco tetraple-gico (un grande Cluzet) che incontra un“aspirante” badante proveniente dalle pe-riferie di Parigi desideroso, in realtà, di unsussidio di disoccupazione. La loro diver-sità totale unirà i loro universi. Un film chescalda il cuore perchè elogia l’amiciziacome mezzo (e fine) per superare le diver-sità, la differenza tra diverse classi sociali diappartenenza. Altra novità di quest’annataè stato il genere “Cinecomic”, oggi più chemai di moda grazie soprattutto al “Cava-liere Oscuro” di Christopher Nolan. Il filmscelto è stato il celebrato “V per vendetta”dei fratelli Wachowski (autori del famige-rato Matrix). Pellicola che fa un’analisi so-ciologica perfetta in tempi di crisi. E’tremendamente attuale e riprende nume-rosi temi: la paura,il caos, il controllo, lacrisi, l’oppressione, il disgusto per la classepolitica, la voglia di rivoluzione,la macchi-nazione mediatica. Il pubblico è rimasta abocca aperta di fronte a un finale che do-vrebbe ispirarci e farci riflettere per il no-stro futuro.Woody Allen diceva che “l’arte del cinemasi ispira alla vita, mentre la vita si ispira allatv”. Perché sono le idee che fanno decol-lare la società e se queste resistono agliabusi,alle classificazioni e alle paure, pos-sono trasformare l’essenza umana. E ricor-date che non sono i governi a fare icambiamenti, ma le persone con le loroazioni. Non è che, forse, sotto la nostra (pi-randelliana) maschera rivoluzionaria, ab-biamo una maledetta paura delcambiamento?
CINEFORUM
CCUO
.com sabato 3 novembre 2012no2 PAG.8
Durante una partita di soft air,una specie di simulazionedella guerra con armi ad ariacompressa e proiettili di pla-
stica, un gruppo di giovani si avven-tura in un bosco all’apparenzainnocuo. Il divertimento viene inter-rotto da un banale incidente, un canefinisce sotto le ruote del fuoristradasul quale i ragazzi stanno viaggiando.Da quel momento inizia l’incubo. Lacaccia e la guerra che fino ad alloraerano state un gioco diventano reali,spuntano improvvisamente tre scono-sciuti con armi vere che si aggirano nelbosco armati fino ai denti. “At the endof the day” è come lo definisce il suoregista Cosimo Alemà, un “horrormetafisico”, una spietata lotta tra ilcacciatore e la preda. Ispirato visiva-mente ad “Un tranquillo weekend dipaura” è l’esordio di un autore che si èfatto le ossa nel video clip per anni coni maggiori artisti della scena italiana.Siamo nell’archetipo trash del bosco edel gruppo di giovani minacciati dauna forza oscura e violenta. Inquie-tante e spaventosa la comparsa im-provvisa dei tre giustizieri che vivonosottoterra in una specie di base mili-tare abbandonata. Nella pellicola si in-trecciano progressivamente varieinfluenze cinematografiche che vannodal western allo splatter degli anni’80,unite da uno stile di regia veloce e ser-rato. La storia e la sceneggiatura inesi-stenti sono sostenute da una serie diclichè e citazioni di cinema di serie B,riportate ai nostri giorni ed esaltate datecnologie di ripresa ad alta defini-zione, usate in maniera tecnicamenteeccellente. Film crudo, sadico e ru-vido nella sua semplicità di struttura,mostra la morte nella sua lenta agonia,disturbando lo spettatore con dettaglie soffermandosi sulla banalità delcorpo massacrato e martoriato. Inte-ressante l’ambientazione della vicendache si svolge tutta in esterni con lucediurna e con colori molto densi ecaldi. Uno dei pregi maggiori del filmè infatti proprio la sua qualità fotogra-fica. La scelta di Alemà è molto corag-giosa e va premiata la sua volontà didirigere un film di genere che possafunzionare anche su mercati esteri,lontano dagli standard produttivi e di-stributivi del cinema nostrano. Tuttigli attori sono anglofoni, come nei mi-gliori film di Lucio Fulci, facce truci,anglosassoni, adatte ad un incubo dasottobosco e balestra.
At the end of the dayL’incubo del gioco
La vita, dove fiorisce
di Duccio [email protected]
di Franco Manescalchi
Vi sono momenti nella vita in cui, guar-dando la nostra esistenza, si avverteun’accensione particolare e più che maici si interroga sul senso dell’accadere.Intuizioni scaturite dalle occasioni piùvarie, talvolta improvvise, apparse inmodo epifanico, essenziale, direi per-fino sacro, perché, oltrepassando leggie tempi umani, sembrano rivelarciquanto inestricabili e presenti sianonella realtà tracce di divino. Una sortadi chiamata a cui si è invitati a rispon-dere, un’occasione per dire ciò che ab-biamo visto. La perdita di una personacara dopo un lungo periodo di decadi-mento fisico, luoghi, muri testimoni dimemorie che credevo definitivamentesepolte, tra una notte di Pasqua ed unautunno, sono state per la poetessaquesta occasione. La poetessa ha vo-luto rispondere, tentare di salvare inparte questa luce, offrire una risonanzaalla poetica sia percepita, di un luogocosì intimo eppure desolato come l’in-terporto di Guasticce. Interporto To-scano “Amerigo Vespucci” è la dizionecompleta del “suo” Interporto est, ov-vero una struttura di scambio per tra-sporti intermodali che ha avuto avvionel 1995, nell’area di Guasticce, piccolafrazione di Collesalvetti, in provincia diLivorno. Quest’area pianeggiante, alconfine tra Livorno e Pisa, costeggiatadalla strada di grande comunicazione
KINO&VIDEO
SPIRITI DI MATERIA
Firenze-Pisa-Livorno (con due uscite :Interporto Toscano Est ed InterportoToscano Ovest), a soli 10 minuti d’autodal mare, ha origini paludose e, per que-sto suo terreno cedevole ed estrema-mente povero, a lungo è rimasta esclusada qualsiasi progetto agricolo o di inse-diamento urbano. È sembrata dunque lazona ideale per l’espansione del porto diLivorno, sempre più a corto di spazi, so-prattutto per lo stoccaggio delle merci edei container. Soltanto una poetessacome Annalisa Macchia poteva giungereall’elegia, nel trattare luoghi umidi e cariai margini di contrade più illustri e illu-strate, perché sa piegare il verso al sermohumilis conservandone l’alta liricità.Nel leggerla si pensa a Pascoli, a Caproni,a Bertolucci e a tutti quei poeti che sonoripartiti dalle radici delle parole per darevalenza poetica al quotidiano.Nella sostanza la rivisitazione del propriopaese, per la morte del padre, riparte dalcimitero e muove fra presenze memorie,tra persone che si impongono attraversoil ricordo stesso dell’essere stata bambina,li, e luoghi un tempo amati, ridotti adessoad un’ombra di se stessi.Davvero Annalisa Macchia è riuscita amettere insieme, con grande tenerezza,tre mondi: se stessa e il suo viaggio, lepersone amate e amare nel loro scompa-rire o nel loro essere presenza degli ultimiall’angolo di una strada, e la natura fattadi tante cose, di tante piccole creature chesolo uno sguardo giovane sa vedere e
ammirare la lorocreaturalità. Matutto, tutto ha questorespiro, la parola stessa è impregnatadall’aria del tempo, si fa verso, nel cuoredel poeta, come un campo di girasoli in-namorati del sole.
interporto esta M.A.F.
Corre la mia campagna livornese.Ingoia terreni strinaticiminiere a un passo dalle spiagge pini sbilenchi miasmi ammassi di vetture.
Interporto est. Ci siamo:il ciabattare per le vie del paesedonne grasse uomini a torso nudola parlata verace un po’ sboccatamuri sghembi ai lati del cancelloil cigolio alla spinta della manoclic della chiave nella portai mobili dei nonnitarli gechi ragni zanzarefantasmirinchiusi in cassetti e in bauliaspettano l’estate.
Me lo dico ogni annoforse non è più il caso.E rimango. Continuoa ricucire ogni strappo del tempo.
Annalisa Macchia,inedito, in corso di stampa
CCUO
.com sabato 3 novembre 2012no2 PAG.9ODORE DI LIBRI
Non c’è niente da fare. Il Nove-cento per Giampiero Mughiniè una meravigliosa ossessione,un luogo della vita e della
mente che non è possibile abbando-nare. In tutta la sua ormai consistentebibliografia, Mughini il Novecento loha sempre avuto come faro del suoraccontare, partenza e approdo ad untempo, comunque cornice e affrescodi un’ esperienza che è contempora-neamente intellettuale ed intima, lasua stessa vita. Era dunque inevitabileche giungesse il momento in cui ilNovecento fosse apertamente omag-giato in un suo testo il cui titolo è vo-lutamente ingannatore. Già perché didare l’addio al secolo breve Mughininon se lo sogna davvero. Non lo strap-perete nemmeno con la tortura dallaricerca e dallo studio di libri, oggetti,foto, musica, film, mobili (e moltoaltro ancora) che appartengano algenio ed all’ inventiva del secoloscorso. L’”addio” del titolo non èquello dell’autore dunque, ma quellodella nostra epoca, della modernitàche si allontana alla velocità della luceda tutto ciò che il Novecento ha rap-presentato. Nel bene e nel male, s’intende. Secolola cui densità è tanto pesante quantosfuggente, magmatica, folle, dramma-tica e meravigliosa. Secolo colmo disfumature ed individualità, in nettacontrapposizione con il chiassoso einsulso coro (così tremendamenteomologato) di questo scorcio con-temporaneo. Il libro ha una strutturacircolare. Inizia dal personale dell’au-tore, si proietta nella Storia (sì, con la“esse” maiuscola) ed a poco a pocodeclina nuovamente nel personale,dove dolcemente “muore”. Il primobreve capitolo è infatti dedicato all’in-gresso di Mughini nel mondo delgiornalismo romano, dopodiché siviene proiettati nella Russia post rivo-luzione d’ottobre per seguire il tragicodestino di uno dei suoi alfieri, LevTrockij, assassinato in Messico per or-dine di Stalin. Dalla Russia il “viaggio”si sposta alla Parigi di Vichy. E’ questoil segmento più corposo e anche piùcoraggioso del libro, laddove si vannoa ricostruire le vite “non parallele” dialcuni dei così detti collabos, quelli traesponenti politici ed intellettuali fran-cesi che strinsero un patto col diavoloe tributarono il loro sostegno agli oc-cupanti nazi ed al loro governo fantoc-cio guidato da Pétain. Tra i tanti,Pierre Drieu la Rochelle, Robert Bra-
Il Novecentoà la Mughini
di Giacomo [email protected] sillach e so-
p r a t t u t t oLouis-FerdinandCéline. Destini
diversi edemblema-tici dello
squasso interiore diuna Nazione che in
poche settimane si era trovata schiac-ciata dal tallone hitleriano. A Parigisubentra, nel racconto mughiniano,New York e più precisamente un loftdove un eccentrico artista sta dandovita ad uno dei polmoni dell’ avan-guardia dei Sessanta. E’ la factory diAndy Warhol e ad una band di giova-notti vogliosi di stupire e sperimen-tare, i Velvet Underground, il guruWarhol sovrappone l’algida Nico,icona della “Dolce vita” felliniana. Nenasce forse il disco di maggiore in-fluenza per il rock dei successivi qua-rant’anni: quel “banana album” (pervia dell’ inequivocabile cover diven-tata manifesto di un periodo) chesuona ancora oggi attualissimo. Sitorna poi in Francia per una breve gal-leria di “cattive ragazze,” Carla Bruniin Sarkozy, Colette Peignot e BrigitteBardot. Donne che sono penetrate nelmidollo degli uomini che le hanno de-siderate al punto che di quelle pas-sioni ne porteranno per sempre ledolorose stimmate. La memoria sipiega poi verso il cupo frangente delterrorismo italiano, una ferita che Mu-ghini avverte sempre viva in virtùdella vicinanza e della condivisioneumana che egli ha avuto con molti dicoloro che in quella stagione scelserodi imbracciare un’arma ed usarla con-tro il “nemico”, cioè l’avversario poli-tico. Il viaggio, come detto, si chiudecon un ritorno alla sfera la più intima,quella della stessa casa di Mughini,casa che in ogni stanza tributa unomaggio senza soluzione di conti-nuità ai grandi del design italiano, daBruno Munari a Gaetano Pesce, pas-sando per Mario Bellini e Carlo Mol-lino. Proprio un’opera di Pesce ilManodidio Ashtray, un posacenere aforma di mano con un foro sul palmoda cui sgorga il rosso del sangue e chetrova posto nello studio di Mughini, èemblema di quel Novecento in cuiGiampiero ci conduce per mano conquella maestria e quel sapere chepochi come lui possono vantare. Unsecolo dove genio, coraggio, passione,utopia, sono stati impastati col sanguee con le lacrime. Un secolo indimen-ticabile. Altro che addio, vero Giam-piero?
Giampiero Mughini, Addio gran secolo crudele dei nostri vent’anni, Bompiani2012
CCUO
.com sabato 3 novembre 2012no2 PAG.10
Con il nome di “pietre fieso-lane” si indica una particolareclasse di monumenti fune-rari, stele e cippi, diffusi a
nord dell’Arno, che hanno in co-mune il materiale (arenaria), la tec-nica decorativa a rilievo, ed unaiconografia legata a modelli artisticicomuni, per i quali è stato ipotiz-zato il centro di produzione a Fie-sole, dato l’elevato numero diesemplari lì rinvenuti. Repertidi questo tipo sono affiorati inalcuni poderi del piccolo borgodi Vierle (Comune di Londa),centro del Valdarno Superiore,ubicato a metà strada tra il monteFalterona (Lago degli Idoli) ed ilfiume Sieve, il cui toponimo è rite-nuto di origine etrusca. Nelle imme-diate vicinanze di Casa al Nespolo futrovato un frammento lapideo, incor-porato in un muro di una stalla del ca-sale. Questa pietra, acquisita dai proprie-tari, marchesi Dufour Berte, alla finedegli anni ’60 dello scorso secolo, ri-sulta essere la parte inferiore di unastele funeraria, sulla quale si conservala raffigurazione, inquadrata da unacornice, dei piedi e di parte dellegambe di una figura eretta, incedenteverso sinistra. Il personaggio rappre-sentato era sicuramente maschile datala presenza, sul lato sinistro della cor-nice, di un elemento verticale e retti-lineo interpretabile come l’asta di unalancia. Il rinvenimento di questanuova lapide sembra di notevole im-portanza topografica: il casale del Ne-spolo si trova, infatti, nelle immediatevicinanze del Podere Il Trebbio, dovenel 1871 vennero alla luce due stelericcamente decorate, oggi conservateal Museo Archeologico Nazionale diFirenze. Nella prima è raffigurato di
profilo un personaggio fem-minile eretto e incedenteverso sinistra; nella se-conda è visibile, sempre diprofilo, un personaggiofemminile seduto. Quest’ultimo monumento
scultoreo è di particolare inte-resse. La stele, poggiante su unapiccola base quadrangolare, hauna forma ovoidale, rastremataverso l’alto, ed è coronata da un
ornato a palmetta, motivo questo cheappartiene a modelli propri dellaGrecia microasiatica, in partico-lare della Ionia. Sempre ionica,ricorrente in particolare nellestele funerarie di Samo, è in-fine la figura della defunta se-duta in trono, che porge con ladestra alzata un ramoscello dimelagrano, quale offerta aglidei inferi. Ibrido, infine, è lostile della Sfinge alata, mostromortuario, che adorna il latoposteriore della stele: la fi-gurazione a testa umanafemminile richiama ilmondo greco, mentre laposizione rampante delcorpo, con una zampa solle-vata, appartiene all’iconografiaetrusca. E’ da aggiungere, in-fine, che a Vierle i contadiniconservano, ben vivo e precisodi particolari, il ricordo che negli
anni ’20 del secolo scorso, da uncampo sito tra la Casa al Nespolo eil greto del torrente Moscia, fuportato via “un sasso scolpito”molto eroso dall’acqua. Dallostesso breve ambito, dunque,sono giunti a noi quattro monu-menti di scultura etrusca tardo-arcaica, databili al secondoventicinquennio del VI sec. a.C.,che risentono dell’influsso stili-stico greco, sintomo di una fortevitalità della città e del territoriodi Fiesole in tale periodo. Que-ste stele, presumibilmenteparte di una vera e propria ne-cropoli a tutt’oggi inesplorata,testimoniano inoltre che ilcentro etrusco di Vierle rive-
stiva una certa importanza, qualeinsediamento preposto al con-trollo della viabilità che dal Casen-tino conduceva verso il fiumeSieve.
Quattro pietre fiesolaneavvistate a Vierle
di Alberto [email protected]
di Annamaria M. [email protected]
EX CAVO
Due stele funerarie rinvenuta nel 1871 nelle vicinanze del Podere Il Trebbio, Vierle.
Moz-art non digita, è tutto di cartaVISTE&RIVISTE
Udite, udite! con un coraggio davvero daleoni, Bruno Corà ,con alcuni amici, hafondato una nuova rivista cartacea .-.esottolineo cartacea, dato i tempi.-. di artecontemporanea. Si chiama “Moz-art”, ènata da Ali§no editrice di Perugia ed è
stata presentata il 26 otto-bre alla Biblioteca degliUffizi. Il nome dice giàqualcosa: non solo arti vi-sive ma, con l’ammic-cante richiamo algrande musicista,apertura alla musicae alle altre forme delcontemporaneo:teatro, letteratura,filosofia, ecc. Le fi-nalità sono tante edencomiabili:primo, far leggere escrivere su carta, ilche comporta mag-giore accuratezza eriflessione. Cosed’altri tempi, da“passatisti”, scherzaCorà, che ne è il di-rettore. Ma in-somma è il caso dirallentare un po’, pervedere davveroquello che suc-
cede intorno, raccogliere le idee e ri-par-tire con nuove esperienze. Sapere checosa ci si porta dietro serve a guardare inavanti con sguardo più consapevole,come insiste Renato Ranaldi, che ricorda,giustamente, il debito che ancora oggiabbiamo con le arti degli anni Venti eTrenta; per non parlare delle direttricidate dalle avanguardie del Novecento esulle quali ancora camminiamo, che sivoglia ammettere o no. Lo ricorda Da-niele Lombardi, anche se attualmentesembra si siano dimenticate, e soprat-tutto non si siano incentivate le speri-mentazioni venute dopo, e tutt’ora vivacima pressoché ignorate, nel campo dellamusica, che comunque continuano aproporsi, pur faticosamente, grazie adiniziative ‘di nicchia’.La denuncia della poca attenzione, o ad-dirittura della mortificazione, da partedella politica nei confronti delle arti edella cultura in genere, è stata comune atutti gli interventi alla presentazione: èuna specie di inevitabile litania che si di-pana ad ogni occasione culturale, perchépurtroppo è un dato di fatto incontesta-bile. A dare un colpo d’ala al discorso, nono-stante tutto.-. ma sono voli di Icaro.-. èstato Bizhan Bassiri, appellandosi inmodo assoluto alla poesia, che, come sisa, continua a germogliare ignorata, es-sendo di nessun richiamo per il grandepubblico.Meno pessimistico, se vogliamo, è stato il
discorso di Cauteruccio, il quale, nono-stante le enormi difficoltà, col suo teatrodi avanguardia a Scandicci, continua araccogliere un pubblico non vasto ma af-fezionato e partecipe .Il merito è senz’al-tro tutto suo che si è inventato un teatrocapace di coinvolge tutte le arti: musica,danza, canto, arti visive,col ricorso a pro-iezioni o installazioni sempre di grandequalità.Quanto all’ esigere riconoscimenti, l’arch.Alessandro Gioli si dice rassegnato,anche verso se stesso oltre che verso glialtri, a non averne. Opera ,continua adoperare, senza chiedere giudizi. Ma certola sua raffinata arte di disegnatore ne avràdi positivi, specie in una rivista all’inse-gna della consapevolezza come Moz/art.La rivista sarà multilingue. Oltre all’ita-liano e all’inglese, adotterà la lingua origi-nale di ogni autore.
CCUO
.com sabato 3 novembre 2012no2 PAG.11
di Federica [email protected]
ICON
Alla Strozzina di Palazzo Strozziin Firenze fino al 27 Gennaio2013 è possibile visitare all’in-terno della Mostra “Francis
Bacon e la condizione esistenzialenell’arte contemporanea” tre operedella video artista svedese NathalieDjurberg ( 1978) che attraverso l’usodella tecnica dello stop – motion rie-sce a raccontare storie ed ambienta-zioni dal sapore nero. L’artista,sostenuta in Italia dalla FondazionePrada, lavora con la materia per visua-lizzare sogni ed incubi in favole lugu-bri e scioccanti. Nei video presentialla mostra il corpo femminile deisuoi personaggi viene spesso sezio-nato, si decompone, si riforma in me-tamorfosi e rinascite che seguonol’andamento grottesco delle sue sto-rie. Interessanti le installazioni nellequali lo spettatore deve entrare pervedere le sue opere. In Of Course I am Working WithMagic lo spettatore deve entrare in unmenhir di gomma piuma per trovarsipoi davanti ad un video, in Das Wal-dhäuschen (Casetta nel bosco) ci sideve sedere all’interno di una minu-scola casetta delle favole per assisterealla decomposizione di un pupazzo didonna che cammina in un bosco po-polato da strani animaletti di pongo.In Once Removed on My Mother’sSide una figlia dalla magrezza impres-
La mostra segna l’incontro tra dueartisti e amici, nel confronto tradue paesi, tra due generazioni edue indoli diverse. L’allestimento
crea percorsi paralleli: quello di Fran-gioni, che scardina i suoi “trittici” pergiocare con la verticalità e quello di Ja-khnagiev che crea un lungo tragitto pa-ratattico. Il loro è un dialogosimultaneo che si incontra nel colorema assolutamente diverso nell’intentoe nella concezione.Alexander Jakhnagiev, artista di originibulgare ma italiano d’adozione, dàespressione alla propria personalitàpoliedrica attraverso azioni performa-tive provocatorie e di body painting; lasua arte é una combinazione simulta-nea di colpi veloci di colori e tramenere nate da una gestualità libera. Condirette pennellate sulla tela rivelaun’interiorità complessa, realizzando“uno spazio che è insieme specchio ecampo di battaglia, scacchiera di giococontrollato e terreno di conflitto” se-condo la definizione di Danilo Mae-stosi. Davanti alle sue tele è
Due artisti,due amici,tanti colori
Bacon alla Strozzina
percepibile agli occhi la volontà distacco della pittura dal supporto, il suoastrattismo lirico, ma efficace, sembravolersene liberare. Tenta la levitazionee colpisce con vivacità espressionista. Icolori si confondono, ma qua non èpresente la leggera joie de vivre, il suodistacco diventa un divincolarsi che sianima di tensione.Aldo Frangioni nasce, vive e lavora aFiesole, affermandosi come una origi-nale personalità nel campo della cul-tura. Artista curioso e conoscitoreattento delle grandi Avanguardie stori-che, subisce la fascinazione soprattuttodei colori freddi e serigrafici della Pop
ICON
sionante si prende cura di una madrefin troppo ingombrante che finisceper schiacciarla con il suo enormepeso. Una video arte cupa ed intelli-gente tra i Fratelli Grimm, Tim Bur-ton e David Lynch. Francis Bacon ela condizione esistenziale nell’artecontemporanea è organizzata dalCentro di Cultura ContemporaneaStrozzina in collaborazione con laDublin City Gallery The Hugh Lane(Dublino).v
art, in riferimento anche alle cromiepiatte e bidimensionali definite del de-corativismo; la sua arte è un originaleraccordo storico tra i grandi Movi-menti artistici. L’azione del pittore èdeterminata e decisa, nutre il supportoin cartone con tre stesure di colore perintriderlo in profondità. Ne risulta unavivace pittura bidimensionale con-nessa strettamente al piano, doveforme mobili e grafismi si alternano asimboli misteriosi e rampicanti “capo-grossiani” che corrono sulla superficie. Lo spazio viene vivificato facendoemergere il piano. Aldo Frangioni ela-bora una cifra riconoscibile, propria,
captando gli impulsi del passato e pon-derandone gli elementi. Se Frangioni sonda la superficie e at-tinge con equilibrio ad un passatosempre presente, Jakhnagiev, pur con-servando analogie astratte, gioca conla dimensione e sceglie di vivere inevi-tabilmente la sua emotività per riflet-terla. Ma se è vero che Frangioni sisalda e Jakhnagiev si distacca, vero èanche che il sentimento del primovibra più facilmente in superficie men-tre l’altro lo trattiene. Due artisti che si confrontano, si allon-tanano, si vincolano in una stretta poli-croma: uno traccia, l’altro scivola.
Alla Galleria Tornabuoni la mostra di Frangioni e Jakhnagiev
CCUO
.com sabato 3 novembre 2012no2 PAG.12KINO&VIDEO
Il titolo che propongo mi pare adattoe beneaugurante al riavvio della no-stra amata Cultura Commestibiledopo “L’intervallo” di forzata as-
senza. Un bel film, particolare nella am-bientazione e nello svolgimento, dueminorenni veri, bravi nell’essere i ra-gazzi che forse veramente sono; il regi-sta è un documentarista alla sua primaprova cinematografica; straordinario ilracconto dalla stringata e asciutta sem-plicità e dalla grande potenza metafo-rica. Il Manicomio di NapoliCapodichino in totale abbandono è illuogo ove si svolge la vicenda-incontrofra due ragazzi, lei prigioniera, lui suocustode, lei bella, lui no, lei vispissima,lui no. Due ragazzi però con pensieri,emozioni, interessi da ragazzi, inascol-tati e inesprimibili in quanto pensati ir-realizzabili. Due vite il cui potenziale di affetti ed in-telligenza è reso vano dall’essere vissutein un mondo dove regna il degrado,pieno di cose rotte, invaso da erbacce,senza alcuna luce e dove l’acqua è soloquella delle fogne, un mondo vuoto,minaccioso però, un mondo dove in-combono rifiuti, calcinacci e topi. I dueperò sono due ragazzi e in questo lorocomune essere, in un intervallo, stralciodi un tempo inesistente, riescono a tro-varsi, giocare, conoscersi e, direi, fidarsi.Inutile. Il violento gioco cui allude la ra-gazza e che li stringe va avanti, non ciserve vederlo rappresentato in dettaglioper sapere che i contenuti di follia, pre-varicazione e crudeltà che avrebberopotuto essere rinchiusi in un manico-mio, in una prigione, sono disseminatiin tutta la città e hanno invaso il mondo.La malavita è uno stile di vita, le mi-nacce anche, la mancanza di vie altreuna costante realtà, lì a Napoli senz’al-tro, ma anche altrove purtroppo. Il gio-vane cicciottello sa il verso degli uccelli,sa le loro abitudini, racconta cose bellecosì tanto da non essere credibili, vor-rebbe fare il cuoco. La ragazza falsa-mente vissuta si identifica con la suicidadella stanza 13, altra ragazzina quindi-cenne che immagina ingannata da unadulto e abbandonata incinta. E’ pic-cola in realtà e anche se fa la sbruffonaha paura dei topi e di stare sola; rinun-cia a scappare per lealtà verso il suo gen-tile e come lei incolpevole, carceriere,per proteggerlo da quelle pericolosevendette che la faranno cedere al ricattoe agli ordini dei mandanti la sua prigio-nia, dei malavitosi che comandano laloro vita. Due ragazzi che potrebberoessere belli, resi brutti e sporchi così pernaturale essenza malevolutiva delmondo che li accoglie. Due carrettiniper le granite, bianchi e fioriti sem-brano anche troppo belli in un cosìsquallido mondo. E bravo Leonardo DiCostanzo!!!
L’intervallodi Cristina Pucci
La locandina e la protagonista Francesca Riso in una scena del film
di Barbara, cuoca di Pane e [email protected]
I ravioli ripieni di manna dal cieloMENÙ
Patata: solanum tuberosum. La famigliaè quella delle Solanaceae (melanzane,pomodori) e viene da terre che an-cora, non ho visitato come avrei vo-luto: Messico, Cile, Bolivia e Perù. InEuropa arrivò con gli Spagnoli, neltardo 1500. E’ sicuro che sia stata la“manna dal cielo” per i più poveri eforse per questo vivere la sua presenzacome “carestia perenne”, ne vieneusato il nome sempre in maniera pocosimpatica: per definire un atteggia-mento non proprio “sveglio”, ottuso;oppure per indicare una persona stu-pida, o troppo ingenua. Diviene anche“concetto” di poca grazia, goffaggine(sembri un sacco di patate), e se èanche vero che se ne ricava un alcoolper fare alcuni tipi di vodka, “spirito dipatata” si oppone di forza a “presenzadi spirito”. Il tutto senza scordare l’ im-mancabile riferimento all”organo ri-produttivo femminile”. Comunquesia, a noi piacciono. Le più comuni:pasta gialla (fritte, forno, insalata)pasta bianca (purè, gnocchi.croc-chette) - buccia rossa (cartoccio, forno,fritte) - Patate novelle (lesse o in fornoma con la buccia). Allora via di ravioli di pasta di patate,ripieni di patate. Per 24 pezzi: 500 grdi patate lessate e sbucciate - 150 gr difarina bianca 00 - sale. Schiacciare lepatate direttamente in una ciotola,unitela farina setacciata, il sale e impa-state bene. Fate freddare in frigo, co-perto Per la minestra di patate.tritiamo 2 costole di sedano, 2 carote e1 cipolla media e rosoliamo a fuocoalto con olio, salvia e alloro. Unire 1 kgdi patate “nude” e a tocchetti e roso-lare. Ora 150 gr.di pomodoro, acqua obrodo di verdura a coprire per mez-z’ora. Frullate senza alloro e salvia,unite sale e pepe. Pesatene 500 gr eamalgamate (ora che è calda) 10 gr di
colla di pesce già ammollata; far rap-prendere in frigo. La minestra avan-zata si gustata come tale, magari concrostini di pane, quella “indurita” dallacolla, la mettiamo in una sacca da pa-sticceria con la bocchetta liscia dimedia misura, per confezionare i ra-
violi stendendo la pasta col mattarello.Fate un rettangolo, mettete l’impastodistanziato di circa 2/3 cm. Chiudete iravioli e tagliate con la rotella. Lessatee servite con burro, salvia e sale affu-micato. Mangiare benissimo, spen-dendo pochissimo.













![Home [] · Web viewConoscere le regole dei giochi che richiedono l’uso di piccoli attrezzi. Sa divertirsi durante l’attività ludico-motoria. Sa correre, saltare, strisciare,](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/6127d13e09f47868f9720a24/home-web-view-conoscere-le-regole-dei-giochi-che-richiedono-lauso-di-piccoli.jpg)