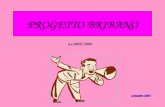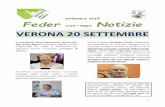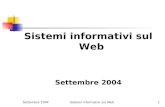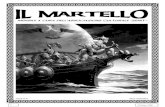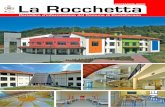120921 - Settembre
description
Transcript of 120921 - Settembre

pure non mancavano e alle quali glistessi autori non attribuiscono moltaimportanza, e mi concentro invecesui punti che toccavano le (allora) vi-cinissime elezioni cantonali, dunqueun argomento che in molti modi po-teva aver almeno sfiorato gli studen-ti. Ebbene è del tutto deludente che,dopo mesi di campagna elettorale, apoca distanza dalle elezioni, solo il25% degli studenti conoscesse il no-me dei cinque Consiglieri di Stato,ma soprattutto che il 36% non ri-cordasse nemmeno un nome. Que-sto sembra confermare la mia ipote-si, e cioè che il significato e i mecca-nismi delle elezioni siano stati argo-menti del tutto assenti dall’ambitoscolastico. Altra conferma può venireda un fatto curioso: nell’indicare lacomposizione partitica del nuovoGran Consiglio, gli studenti hannosistematicamente gonfiato i numeridei partiti che, in misura maggiore ominore, avevano vinto le elezioni (laLega, l’UDC e i Verdi) e parallela-mente diminuito i numeri dei trepartiti tradizionali (PLR, PPD e PS).Da un dato simile si può trarre unasola conclusione: che l’informazioneagli studenti non era arrivata in for-ma corretta attraverso la scuola, masi basava piuttosto sulle non rare ap-prossimazioni dei mass-media, quan-do non sulle reazioni di qualche diri-gente di partito, mirante talvolta al-l’auto-esaltazione. (In questo campo,si registra tuttavia un’eccezione diffi-cile da spiegare. L’MPS, il partito co-munista, per intenderci, ha avuto un
solo eletto in Gran Consiglio, mentregli studenti gliene avevano assegnatiben 8: ma forse questo fatto non ne-cessita di una spiegazione). Agli stu-denti della SME erano poi poste an-che alcune domande circa le loro in-tenzioni per il futuro: si può ritenerepositivo che l’80% preveda di parte-cipare al voto e molti ancora pensinodi assumere informazioni circa i can-didati; per contro l’adesione a unpartito e meno ancora l’ipotesi dicandidarsi mi sembrano domandecosì lontane dalla possibile esperienzaadolescenziale da non giustificarel’opportunità di averle poste.
E la partecipazione?Da quanto ho fin qui riassunto, ri-sulta chiaro che la ricerca non havoluto cercare dati sul secondo deiprincipi elencati all’inizio: in che mi-sura la partecipazione degli allievi(e lo stesso vale per i genitori) rien-tra fra le preoccupazioni delle dire-zioni? In che misura si compionosforzi per attuarla?La Legge della Scuola che ha parlatodi queste cose risale a più di ventianni fa. Non ritiene il DECS di dover-si informare un po’ anche sulla mi-sura in cui questo principio è statotradotto in azioni congruenti?
Giorgio Zappa
(1) Mario Donati, Jenny Marcionetti,Pau Origoni: “Civica e cittadinanzanella scuola ticinese”, DATI, maggio 2012
Il problema del come la scuola puòcontribuire all’educazione civica de-gli allievi e degli studenti è un temaricorrente e si può ben dire che nonha finora trovato una soluzione deltutto soddisfacente. L’ultima discussione in materia risalealmeno a dieci anni fa ed era statasollecitata da una iniziativa parla-mentare generica promossa da Gio-ventù Liberale Radicale, che intende-va potenziare l’insegnamento dellacivica e chiedeva per le scuole Me-die, le Scuole Superiori e le ScuoleProfessionali la reintroduzione diun’ora obbligatoria, con l’assegna-zione di una nota individuale. Non èqui il luogo per ripercorrere l’iter diquella iniziativa che, al di là dellabuona intenzione, non deve averavuto un grande appoggio dal Di-partimento ed ha finito per produrreeffetti limitati: l’aggiunta di un arti-colo di legge (il 23a) e un rapportodella Commissione Scolastica delGran Consiglio che proponeva, perottenere lo stesso scopo, tre proce-dure che si scostavano del tutto daquelle suggerite dall’iniziativa stessa. Il Gran Consiglio decise:I suggerimenti del rapporto (stesodall'on. Franco Celio, 2001) eranoquesti :• I temi civici devono essere trasver-sali a tutte le materie;• È opportuno incentivare la parteci-pazione attiva degli studenti alla vitadella scuola;• Sui temi civici e di educazione allacittadinanza, l’istituto è tenuto a or-ganizzare giornate tematiche, al difuori della griglia oraria.I tre principi sono del tutto condivisi-bili, ma nessuno andava nella dire-zione richiesta dall’iniziativa.
La verificaDopo l’esperienza di dieci anni, ècomprensibile che il DECS abbia av-vertito la necessità di una verifica,che è stata affidata al CIRSE (Centroinnovazione e ricerca sui sistemieducativi) una struttura del DFA (Di-partimento formazione e apprendi-mento) della SUPSI. Il rapporto diquesta verifica è stato consegnato ela preziosa rivista DATI ne ha pubbli-cato lo scorso maggio una sintesi(1),con l’intenzione dichiarata di “allar-gare il dibattito” sul tema. Apprendiamo che i dati per la verifi-ca sono stati raccolti per mezzo ditre questionari destinati rispettiva-mente alle direzioni (63 istituti), aidocenti (808 persone) e agli studentidell’ultimo anno (364 studenti).Alle direzioni erano chieste informa-zioni circa il terzo degli argomentiprevisti, quello delle giornate temati-che organizzate nell’Istituto. I risulta-ti danno conto di una certa rispon-denza, peraltro molto differenziata:nella SME sono state assunte inizia-tive (da una fino a 12 per istituto);nelle SMS pure, ma in misura mino-re (da due a cinque); nelle SP (danessuna fino a 3). Quel che piùconta (e in un certo senso limital'interesse del dato) è il fatto che itemi elencati sono molto variati enon tutti possono legittimamente ri-entrare nella categoria della forma-zione civica. Meno interessante mi sembra poi ildato fornito dal questionario dei do-centi: mirava a confermare, come èevidente, la questione della trasver-salità del tema fra le materie, ma lerisposte sono piuttosto scontate enon molto impegnative.
Reazioni degli studentiIl questionario somministrato aglistudenti, che mirava a verificare dauna parte certe conoscenze e dall’al-tra sentimenti e intenzioni per il fu-turo, presenta invece parecchi puntidi interesse. Trascuro di valutare le risposte alledomande di natura nozionistica, che
PegasoI n s e r t o d i c u l t u r a p o l i t i c a e d i p o l i t i c a c u l t u r a l e
PrincipiaSviluppo dei popoli, dirittie doveri, ambientePagina III
PersonaggiIl cardinale ginevrinoGaspard MermillodPagina IV
AmbienteLe sfide ecologicheper tutte le creaturePagina VI-VII
PegasoInserto mensile diPopolo e Libertà
no. 75 - 21 settembre
EconomiaChe colpa hanno le agenzie di rating?Pagina II
Primo piano
C’è ancora posto per l’educazione civica?

Economia
Che colpa hanno le agenzie di “rating”?Uno studio le accusa di aver scatenato la crisi del debito in Europa
Pegaso Venerdì 21 settembre 2012II
Le agenzie di “rating” mondialisono la principale causa della crisieconomica che ha colpito molti pae-si dell’Eurozona? A questa conclusio-ne giunge uno studio di due econo-misti (Manfred Gärtner e Björn Grie-sbach) pubblicato dall’Università diSan Gallo. Lo studio esamina i datidi 25 paesi, membri dell’OCSE, tra il2009 e il 2011, ricordando le conse-guenze nefaste che la riduzione diuna quotazione (rating) ha avuto peri Paesi interessati.Probabilmente l’esame è un po’superficiale, nel senso che analizzagli effetti delle quotazioni delleagenzie sul costo del debito deipaesi interessati, cioè un aumentodei tassi di interesse da pagare, manon tiene conto del come tale de-bito si è realizzato negli anni. Sap-piamo che in alcuni Paesi si è esa-gerato con gli investimenti, siapubblici, sia privati, provocando loscoppio di una bolla immobiliare euna repentina perdita di valore diquesti investimenti, finanziati ovvia-mente con debiti ipotecari. In altripaesi il motore principale della crisi èstata la spesa sociale, compresaquella della pubblica amministrazio-ne, che è andata fuori controllo, al-tri ancora hanno invece sofferto diun rallentamento generale della con-giuntura che ha provocato un calodelle esportazioni. Spesso questecause si sono accumulate generandoanche situazioni di panico che nonhanno certo giovato alla stabilità fi-nanziaria dei paesi interessati.Qualche dubbio eraperò già nato inpassato circa ilcomportamento diqueste agenzie, ilcui pacchetto azio-nario è in mano adalcune banche emultinazionali, chelo potrebbero usareper danneggiare iconcorrenti. Quel che è certo è cheuna quotazione al ribasso di un’a-zienda provoca generalmente uncrollo delle quotazioni delle azioniin borsa, fa aumentare il “rischioimpresa” e quindi il costo dei capi-tali che vengono presi in prestito.
Se il sistema viene applicato per unintero paese, la situazione si com-plica di parecchio. Il primo effettonegativo di una quotazione al ri-basso è l’aumento dei tassi di inte-resse da pagare sui prestiti pubbli-ci. Ma l’origine dell’aumento del
debito pubblico èdata dalla manca-ta copertura fi-nanziaria degli im-pegni assunti dal-lo Stato in que-stione. Il paese sitrova così in unaspirale dalla qualenon può uscirecon le sole pro-
prie forze. La quotazione dell’a-genzia amplifica la situazione eprovoca il famigerato “spread”,cioè la differenza degli interessi de-bitori rispetto al paese che gode diuna quotazione migliore. Nel casoa noi più vicino l’Italia rispetto alla
Germania. Questo esempio ci per-mette di vedere che quando que-sta situazione si verifica all’internodi una unione monetaria (l’Eurozo-na) è la stessa zona che viene mi-nacciata.Lo studio citato,basandosi anchesu dichiarazionida fonte europea(la vice-presidentedella Commissio-ne Viviane Re-ding) constatache, quando gliStati Uniti sonoconfrontati conproblemi di bilancio, alcune agen-zie di “rating” puntano i loroproiettori sull’Europa. Ora, dal mo-mento che le maggiori agenzie so-no americane è possibile vedere unnesso tra le due cose e dedurreche le agenzie stesse possono es-sere causa del degrado della situa-
zione in Europa. La tesi potrebbevenir confermata dal fatto che aun certo punto, all’inizio del mesed’agosto scorso, l’agenzia Moody’sha creato qualche difficoltà allaGermania, decretando che “si tro-va in prospettive negative”, a cau-sa del rischio che presentano l’Ita-lia e la Spagna. Una notazioneanaloga è data anche all’Olanda eal Lussemburgo. Da qui a pensareche tutta la zona euro è in perico-lo il passo è breve. Queste agenzie, per le loro qualifi-che, usano le lettere dell’alfabeto:AAA (la famosa tripla A) è la mi-gliore, ma vi aggiungono anche isegni + o -, nonché delle note co-me quella appena citata. SecondoMoody’s, quindi, il solo paese dellazona euro che gode della tripla Acon “prospettiva stabile” è la Fin-landia.A giustificazione delle loro tesi, gliautori dello studio constatano chedal 2008 (anno di inizio della crisigenerale) molti Paesi europei sonostati valutati in modo diverso rispet-to a paesi extra-europei, cioè più se-veramente. Essi ritengono perciò in-comprensibili certe classificazioni,che non possono essere spiegate dalsolo deterioramento della situazioneeconomica o finanziaria. I paesi eu-ropei sarebbero stati declassati mol-to di più di quanto si sarebbero me-ritati. Per questo le agenzie di “ra-ting” possono essere considerate imotori principali e il fattore scate-
nante della crisi deldebito in Europa.Probabilmente qual-cosa di vero in que-ste affermazioni c’è.È però impossibileprovare che l’opera-zione venga fatta inmodo intenzionale.L’allarme però è get-tato e si stanno stu-
diando provvedimenti per contrasta-re almeno gli effetti più pericolosidel “rating”. Un giudizio che quan-do si applica a un intero paese com-porta anche importanti connotazionipolitiche.
Ignazio Bonoli
CrolloÈ che una quotazione
al ribasso di un’aziendaprovoca generalmente un
crollo delle quotazioni delleazioni in borsa
ValutazioniGli autori dello studio
constatano che dal 2008 moltiPaesi europei sono stativalutati in modo diverso
rispetto a quelli extra-europei

Principia
Sviluppo dei popoli, dirittie doveri, ambienteDall’enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI
Venerdì 21 settembre 2012 Pegaso III
Il tema dello sviluppo è oggi fortemente collegato anche ai doveri che nascono dal rapporto dell’uomo conl’ambiente naturale. Questo è stato donato da Dio a tutti, e il suo uso rappresenta per noi una responsabilitàverso i poveri, le generazioni future e l’umanità intera. Se la natura, e per primo l’essere umano, vengonoconsiderati come frutto del caso o del determinismo evolutivo, la consapevolezza della responsabilità siattenua nelle coscienze. Nella natura il credente riconosce il meraviglioso risultato dell’intervento creativodi Dio, che l’uomo può responsabilmente utilizzare per soddisfare i suoi legittimi bisogni - materiali eimmateriali - nel rispetto degli intrinseci equilibri del creato stesso. Se tale visione viene meno, l’uomo finisceo per considerare la natura un tabù intoccabile o, al contrario, per abusarne. Ambedue questi atteggiamentinon sono conformi alla visione cristiana della natura, frutto della creazione di Dio. La natura è espressionedi un disegno di amore e di verità.
Essa ci precede e ci è donata da Dio come ambiente di vita. Ci parla del Creatore (cfr Rm 1,20) e del suoamore per l’umanità. È destinata ad essere “ricapitolata” in Cristo alla fine dei tempi (cfr E/I, 9-10; Co! 1, 29-20). Anch’essa, quindi, è una “vocazione”. La natura è a nostra disposizione non come “un mucchio di rifiutisparsi a caso”, bensì come un dono del Creatore che ne ha disegnato gli ordinamenti intrinseci, affinchél’uomo né tragga gli orientamenti doverosi “per custodirla e coltivarla” (Gt 2,15). Ma bisogna anchesottolineare che è contrario al vero sviluppo considerare la natura più importante della stessa personaumana. Questa posizione induce ad atteggiamenti neopagani o di nuovo panteismo: dalla sola natura, intesain senso puramente naturalistico, non può derivare la salvezza per l’uomo. Peraltro bisogna anche rifiutarela posizione contraria, che mira alla sua completa tecnicizzazione, perché l’ambiente naturale non è solomateria di cui disporre a nostro piacimento, ma opera mirabile del Creatore, recante in sé una “grammatica”che indica finalità e criteri per un utilizzo sapiente, non strumentale e arbitrario. Oggi molti danni allo sviluppoprovengono proprio da queste concezioni distorte.
Del 29 giugno 2009, capitolo quarto “Sviluppo dei popoli, diritti e doveri, ambiente, nr. 48”

Personaggi
Il cardinale ginevrino Mermillod, ispiratore della Rerum NovarumA 120 anni dalla morte del fondatore dell’Unione di FriburgoNato a Carouge il 22 settembre
1824, questo ginevrino diventatocardinale - il secondo nella storiasvizzera, tre secoli dopo il vallesa-no Matthieu Schi-ner - è figlio delpanettiere JacquesMermillod e di Per-nette Mégard, en-trambi provenientida famiglie di agri-coltori del villaggiodi Bardonnex, a po-chi chilometri daGinevra. Il giovane Gaspard Mermillod, chesi distingue per l’amore dei libri edella cultura, frequenta dapprimail seminario minore di Chambéry,mentre dal 1841 il collegio gesuitaSaint-Michel di Friburgo ed infine,nella stessa città, il seminario mag-giore.
Vescovo cattolico nella Roma protestanteOrdinato prete nel 1847, diventavicario della chiesa di Saint-Ger-main a Ginevra, all’epoca unicaparrocchia cattolica nella città diCalvino. Le sue doti retoriche e let-terarie emergonodurante i suoi viag-gi a Parigi e in altrediocesi francesi, de-stinate alla raccoltadi fondi per costrui-re una nuova chie-sa cattolica nellaRoma protestante.È proprio di questanuova chiesa, ovve-ro della basilica di Notre-Dame,che Gapard Mermillod diviene ret-tore dal 1857 al 1864, quando ènominato da Papa Pio IX vescovoausiliario di Ginevra.
Dal Concilio Vaticano I all’esilio in FranciaTuttavia, nel tormentato contestodel Kulturkampf, l’affidamento aMermillod della giurisdizione su Gi-nevra viene considerato, dal gover-no radicale del Cantone, come ilprimo passo verso la costituzionedi una nuova diocesi senza il be-nestare delle autorità statali. Que-
sta diffidenza si rafforza ulterior-mente di fronte al deciso appog-gio del vescovo ausiliare all’infalli-bilità papale durante il Concilio Va-
ticano I. Nel feb-braio 1873 Ga-spard Mermillod,nel frattempo no-minato vicario apo-stolico, viene quin-di espulso dallaSvizzera, ma con-tinua - più decisoche mai - a guida-re i suoi fedeli
svizzeri dalla località di frontiera diFerney (Francia). Nel periodo dell’esilio cresce, gior-no dopo giorno, la sua sensibilitàper la questione sociale, che lo ap-passiona sempre più.
Precursore del cattolicesimo socialeÈ soltanto dieci anni più tardi, ov-vero nel 1883, che Gaspard Mer-millod, nominato dal nuovo PapaLeone XIII vescovo titolare di Lo-sanna e Ginevra - con residenza aFriburgo - può fare finalmente ri-torno in Svizzera. Diventa un atto-
re maggiore nellastoria della dottri-na sociale dellaChiesa. Nella cittàsulla Sarine dà vi-ta nel 1884 - in-coraggiato dall’a-mico René de LaTour du Pin - all’e-sperienza dell’U-nione cattolica di
studi sociali ed economici, meglionota come “Unione di Friburgo”.Quest’esperienza di studi e dibatti-ti, ma anche di amicizia, riunisce iprotagonisti del cattolicesimo del-l’epoca, tra cui i francesi Albert deMun, Louis Milcent e Henri Lorin,gli austriaci Karl von Vogelsang eGustave Blome, il tedesco FranzKuefstein, e tanti altri. Le loro dis-cussioni ma soprattutto i loro lavo-ri sulla “questione sociale”, cheagita gli animi dell’epoca, contri-buiscono ed ispirano l’elaborazionedell’enciclica sociale Rerum nova-rum di Leone XIII (1891). Due anni
prima, nel 1889, il vescovo Mer-millod sostiene la fondazione del-l’università di Friburgo, da partedel consigliere di Stato GeorgesPython, ma specialmente della fa-coltà di teologia.
Secondo cardinale nella storia elveticaNel concistoro del 23 giugno 1890Mermillod è creato cardinale daLeone XIII - quale secondo eccle-siastico svizzero in diciannove se-coli di storia - ed è chiamato a Ro-ma. A Friburgo una brasserie fon-da per l’occasione, in onore delproprio vescovo diventato cardina-le, la famosa birra “Cardinal”. Ilcardinale Mermillod muore a Romail 23 febbraio 1892, all’età di 67anni.
Lorenzo Planzi
Pegaso Venerdì 21 settembre 2012IV
EspulsioneNel febbraio 1873 Gaspard Mermillod,
nel frattempo nominatovicario apostolico, vieneespulso dalla Svizzera
BirraA Friburgo una brasseriefonda per l’occasione, inonore del proprio vescovodiventato cardinale, lafamosa birra “Cardinal”

Cristianesimo
Le aperture del VaticanoIl popolo cristiano cattolico celebra il cinquantesimo del Concilio Vaticano IIIl Concilio di Firenze, che proprio nel
luglio del 1439, al termine di lunghe ri-flessioni e con il contributo di padriconciliari di notevole valore aveva so-lennemente proclamato il ristabili-mento della comunione fra la chiesagreca e la chiesa latina, può essereconsiderato un Concilio che presen-ta tutti i requisiti per essere ricono-sciuto come un vero Concilio ecu-menico, alla pari di quelli che lo ave-vano preceduto nel primo millennio,e le sue decisioni avrebbero dovutoessere tradotte in atto sia in Orienteche in Occidente. Di fatto, una so-lenne promulgazione della bollaconciliare nella chiesa di Santa Sofiadi Costantinopoli confermò la pienaadesione della chiesa greca alle con-clusioni del Concilio. E tuttavia, passata la generazione deiPadri che avevano partecipato al con-cilio, una interpretazione alquanto dis-torta si impose progressivamente sia inoriente che in occidente. In Oriente,dove si diffuse la falsa convinzione chele sue conclusioni fossero state sotto-scritte dagli orientali soltanto a causadell’urgenza di ricevere un aiuto daglioccidentali per la difesa di Costantino-poli, e in Occidente dove si imposeun’interpretazione secondo la qualel’Oriente non aveva sottoscritto le con-clusioni del Concilio su un piano di pa-rità ma si era semplicemente sotto-messo a Roma. La conseguenza fu che le decisioni delConcilio non trovarono applicazioneconcreta, e che nella memoria dellechiese il Concilio di Firenze venne gra-datamente oscurato, e anzi in orientevenne sempre più demonizzato comeuna soperchieria compiuta dai latininei confronti dei greci. L’impegnocon il quale il popolo cristiano catto-lico nelle sue diverse componenti econ diverse iniziative vuole celebrareil cinquantesimo del Vaticano si de-ve spiegare proprio alla luce di quan-to è successo al Concilio di Firenze.Che non accada che, passata la ge-nerazione di coloro che vi hannopartecipato o che sono stati testimo-ni della svolta epocale da esso deci-sa per la vita della chiesa, la sua me-moria venga gradatamente offusca-ta e che interpretazioni meno cor-rette abbiamo a sminuire il valore dei
nuovi orientamenti da esso offerti al-la chiesa cattolica. Perché se è vero che il Vaticano II èin piena continuità con la fede e lavita della “grande chiesa cattolica eapostolica” (per usare il linguaggiodei primi secoli), tuttavia è anchevero che esso ha risposto con le suedecisioni ad attese spasmodichepresenti nella comunità cristiana, percui molto spesso e con ragione lo si èaccostato al Concilio di Gerusalem-me, di cui parlano gli Atti degli Apo-stoli al capitolo 15. Come il conciliodi Gerusalemme ha consentito allachiesa apostolica di aprirsi all’acco-glienza dei pagani e di credenti pro-venienti da tutte le nazioni, ricono-scendo che la fede in Gesù Cristo e ilbattesimo erano sufficienti per l’ap-partenenza alla chiesa e per la salvez-za, così il concilio Vaticano" dopoduemila anni nel corso dei quali il cri-stianesimo si era sostanzialmenteidentificato con la cultura europea(incarnandosi nella filosofia greca, neldiritto romano, nelle tradizioni ger-maniche). Apriva infine la chiesa auna piena incarnazione nella vita enella cultura di tutti i popoli restituen-dole una autentica cattolicità e ren-dendola veramente universale. Piena continuità con il passato, con lafede apostolica trasmessaci attraversole diverse generazioni, e insieme nuo-vi decisivi orientamenti nei confrontidegli ebrei, dei cristiani non cattolici,dei credenti delle altre religioni, ma an-che all’interno della comunità cristianaper quanto concerne la liturgia, la cen-tralità della Scrittura, la collegialità e lasinodalità, il riconoscimento del valoree della centralità della persona umanae della sua coscienza. Le decisioni del Concilio vennero ac-cettate abbastanza pacificamente al-l’interno della comunità cattolica, maesse non vennero conosciute e medi-tate a sufficienza, come mostra lo stu-pore ogni volta che si tiene un corsosui documenti del Concilio nei con-fronti della straordinaria ricchezza del-le affermazioni in essi contenute. Pro-prio gli attuali tentativi di relativizzareil concilio o di svalutarlo come conciliopuramente pastorale (espressione chein realtà mostra come esso volesse ri-guardare tutta la vita e la missione del-
la chiesa, con un atteggiamento noncondannatorio, ma dialogante e be-nevolo dei confronti di tutti) posso-no costituire l’occasione provviden-ziale per riprendere in mano queidocumenti e per recepire in una ma-niera nuova e più consapevole ilConcilio da parte di tutta la comuni-tà cristiana. Anche l’incontro previsto per il 15
settembre a Roma (istituto MassimoaII'EUR. ore 10-18) e che già ha su-scitato tanto interesse si inserisce inquesta prospettiva, in piena sintoniacon il cammino che tutta la comuni-tà cristiana compie per rispondere,in continuità con il concilio, alle nuo-ve e grandi sfide del nostro tempo.
Monsignor Giovanni Ceretti
Venerdì 21 settembre 2012 Pegaso V
Giubileo
L’11 ottobre 1962, Papa Giovanni XXIII apriva a Roma il Concilio Vaticano Il,concluso tre anni più tardi, l’8 dicembre 1965. A cinquant’anni dall’eventosiamo invitati a riprendere contatto con i grandi orientamenti tracciati dalConcilio, consapevoli delle novità che ha portato, ma anche della percezioneinsufficiente che di tale avvenimento hanno avuto le nostre comunità. L’invi-to è a una ripresa di interesse e di approfondimento. Giovedì 11 ottobre 2012, nella chiesa della Trinità di Berna, i Vescovi svizzericelebreranno, insieme con le delegazioni di tutte le Diocesi, un’Eucarestia so-lenne durante la quale sarà letto un Appello alle comunità. Nel pomeriggio siterrà una prima riflessione su che cosa è stato il Concilio e su come lo si puòrimettere oggi in rapporto con la situazione della Chiesa e del mondo. La proposta dei Vescovi svizzeri è per una rilettura tematica dei grandi docu-menti del Concilio, sotto il motto “Scoprire la fede”.Per il primo anno (2012-2013) il motto sarà: “La fede che celebriamo”, coninvito a riflettere sulla costituzione liturgica “Sacrosantum Concilium”. Per il secondo anno (2013-2014) il motto sarà “La fede che ci unisce” e la ri-flessione si svolgerà attorno ai temi della Chiesa, della Bibbia e dell’Ecume-nismo. Il terzo Anno (2015) recherà il motto: “La fede che ci impegna” e si concen-trerà sulla costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo moderno, sulla li-bertà religiosa e sui rapporti tra le religioni. Il motto “Scoprire la fede” prende spunto anche dall’Anno della fede procla-mato da Papa Benedetto XVI, che pure inizia l’11 ottobre 2012, a cinquan-t’anni dall’inaugurazione del Concilio, e vedrà di nuovo riunito a Roma il Si-nodo dei vescovi attorno al tema: “La nuova evangelizzazione”.
www.sxc.hu



Politica
Pegaso Venerdì 21 settembre 2012VIII
www.sxc.hu
La vecchia novità del Partito cattolicoL’opinione di Franco Monaco, senatore del PdMi sono imbattuto di recente in un
testo di Mino Martinazzoli che suonacosì: “L’aggettivo cattolico non è unaggettivo del politico. È più importan-te, è un aggettivo dell’impolitico. Inpolitica il mondo cattolico non c’è. Inpolitica ci sono i cattolici che scelgonodi occuparsene, quelli che scelgono dinon occuparsene e ci sono quelli chese ne occupano in un modo e altri inun modo diverso. E si qualificano poli-ticamente così, non perché sono cat-tolici”. In forma concisa, il buon Mar-tinazzoli ci richiama distinzioni quantomai pertinenti e attuali in rapporto alreiterato annuncio-proposito di unnuovo protagonismo politico dei cat-tolici italiani. Distinzioni elementari etuttavia fondamentali, che non è inu-tile ribadire su una materia ove, perio-dicamente, in Italia, riaffiorano confu-sione ed equivoci. Innanzitutto, la distinzione tra religionee politica, la cura per le rispettive auto-nomie. L’opposto della reciproca stru-mentalizzazione che le mortifica en-
trambe: con la religione ridotta a in-strumentum regni e la politica a bracciosecolare di religioni ignare della libertà,della regola democratica, della laicitàdelle istituzioni intese, al modo dei pa-dri costituenti, come casa comune dicattolici e non, credenti e non credenti.Anche oggi si incappa in tali oppostederive, in forme più o meno sottili. In secondo luogo, quel monito ci sug-gerisce il carattere naturaliter plurali-stico delle opzioni e dei percorsi politi-ci dei cattolici. Così è sempre stato sto-ricamente, come testimonia la secola-re storia del movimento politico deicattolici (intransigenti e conciliatoristi,liberali e sociali, clericali e laici, conser-vatori e progressisti). Persino nel mez-zo secolo della relativa unità politico-partitica dentro la Democrazia Cristia-na, partito plurale, comprensivo di unaricca gamma di sensibilità e di culturepolitiche e sociali. Comunque un’ec-cezione l’unità, e non la regola, origi-nata da una democrazia difficile e cuiera inibita una fisiologica alternanza.
In terzo luogo, siamo richiamati allaconsapevolezza che il pieno dispiega-mento di tale pluralismo politico, di cuila gerarchia ecclesiastica italiana hapreso atto a metà anni novanta, rap-presenta un doppio guadagno: per laChiesa e la libertà e l’universalità dellasua missione evangelizzatrice; e per lademocrazia italiana, alla cui articola-zione pluralistica i cattolici di varioorientamento possono dare un lorocontributo, dall'interno a modo di fer-mento, nei partiti e negli schieramen-ti. Immettendovi la loro sensibilità per-sonalistica e comunitaria. Infine, e soprattutto, ci è suggerito dicustodire la distinzione, cara a JacquesMaritain e risuonata al Concilio Vati-cano II, tra le azioni che i cristiani com-piono “in quanto cristiani” e quelleche essi compiono “da cristiani” ma“in quanto cittadini”. Senza impegna-re la Chiesa come tale. Cioè coerenticon la loro coscienza cristiana, ma conautonoma responsabilità laicale e po-litica, facendo valere la qualità della lo-
ro proposta politica, suscettibile di es-sere apprezzata da cristiani e non.Senza pretese primogeniture. Francamente ho l’impressione che ta-luni tra quelli che si agitano, addirittu-ra prospettando qualcosa che somiglia un nuovo soggetto politico cattolico,non brillino per creatività e originalitàdi elaborazione politica e, per conver-so, muovano da un giudizio sbrigativoe ingeneroso verso altri cattolici che inpolitica ci stanno già, e non sono af-fatto irrilevanti e ai margini. Quasi chel’impegno politico dei cattolici sia unainvenzione di oggi. Di più: mi chiedodove stessero costoro quando altri,con umiltà ma attivamente, si sonoimpegnati in quell’esperienza politicainnovativa e originale che fu l’Ulivo diProdi, e nell’azione di contrasto alladevastazione morale e civile prodottadal ciclo berlusconiano.
Franco MonacoSenatore del Pd, già presidente del-
l’AC ambrosiana e di Città dell’uomo
Il numero estivo della rivista ge-novese IL GALLO (luglio-agosto2012, CP 1242, 16121 Genova) èdedicato al tema della dignità, inrelazione a due “problemi” attualicome il lavoro (che cambia e spes-so manca) e la vecchiaia (semprepiù attiva e lunga). I redattori del-la rivista ne offrono una analisi ori-ginale e profonda che merita qui lapresentazione, con l’invito a pro-curarsi l’interessante quaderno.
Percorso della ricercaOggi certo, almeno nel nostro mondooccidentale, c’è una maggior presa dicoscienza della dignità di ogni essereumano. Dalla metà del secolo scorso,con la Dichiarazione Universale dei Di-ritti Umani (1948) in reazione alle atro-cità commesse nella seconda guerramondiale, fino a oggi la sensibilità co-mune si è affinata, ma purtroppo sia-
mo ancora lontani, anche nel nostrooccidente, dal riconoscimento per tut-ti della sacralità della persona. Pensia-mo non solo a esempi orrendi che so-no negli occhi di tutti, ma anche alleinfinite quotidiane lesioni della dignitàche subiamo e a cui assistiamo nel no-stro ambiente e di cui, almeno, speria-mo di non essere complici. Kofi Annan, già segretario generaledell’ONU, aveva detto: “Credo che ilventunesimo secolo sarà definito dal-l’impegno che dedicherà alla dignità ealla sacralità di ogni vita umana”. Cisiamo quindi chiesti se nella nostra so-cietà occidentale la dignità dell’uomosia vissuta o soltanto proclamata e da-ta la complessità del tema che riguar-da tutti gli aspetti dell’esistenza abbia-mo voluto limitare l’esame a due si-tuazioni paradigmatiche che hanno alcentro una visione della vita umana: illavoro e la vecchiaia, che corrispondo-
no a due tipiche condizioni-stagionidella vita, verificando in concreto qua-li valori e aspettative coincidono o dif-feriscono nei vissuti personali. Il lavoro perché occupa tanta partedella nostra vita e perché può accre-scere, o al contrario mutilare, la digni-tà di chi lo esercita, anche se purtrop-po oggi spesso più che la qualità dellaprestazione e la soddisfazione profes-sionale conta quanto consente di gua-dagnare; la vecchiaia perché oggi l’au-mento della speranza di vita non assi-cura la qualità della vita stessa chespesso chiede risorse di cui non si dis-pone, rende difficile la convivenza, dis-solve l’autostima fino a indurre il desi-derio di morire. Premesso un tentativodi definizione per un concetto com-plesso, con una sua implicita evidenzanon geometricamente circoscrivibile,la nostra ricerca si articola in parti. Nel-la prima consideriamo alcuni riferi-
menti che ci sono parsi necessari nellaevoluzione storica, nel diritto contem-poraneo e nei documenti del magiste-ro della Chiesa romana; nella secondaparte illustriamo con realismo diversiaspetti del mondo del lavoro , con te-stimonianze vissute e qualche indica-zione di possibili cambiamenti; nellaterza ragioniamo sulla vecchiaia cer-cando, anche attraverso esperienze,come affrontarla il più possibile da vi-vi; nella quarta, con due riflessioni sto-riche filosofiche tra l’etica e la religio-ne, riproponiamo la domanda su qua-li passi muovere perché l’uomo, cre-dente o non credente, sia integral-mente uomo.Aggiungiamo la nostra speranza, e ilconseguente impegno, che la dignitàesista per tutti, anche quando nonesiste.
I Galli
Lavoro e vecchiaiaQuale dignità? La riflessione de “Il Gallo”

Storia
Venerdì 21 settembre 2012 Pegaso IX
Una città tra terra e cielo:Gerusalemme La settimana di storia religiosa di GazzadaSi è svolta a Gazzada (Varese) la or-
mai tradizionale settimana di storiareligiosa, organizzata a Villa Cagnola,sede della Fondazione ambrosianaPaolo VI, terza del ciclo dedicato alcristianesimo delle Chiese del medi-terraneo. La nutrita partecipazione distudiosi e ricercatori, diretta e coordi-nata dal prof. Cesare Alzati dell’uni-versità del Sacro Cuore di Milano, co-adiuvato dal segretario della Fonda-zione Luciano Vaccaro, ha permessodi affrontare il tema “Una città traTerra e Cielo, Gerusalemme, le reli-gioni - le Chiese”, soffermandosi sudiversi filoni di ricerca. Così l’aspettoarcheologico ha illustrato le vicendedell’origine della città di Davide, delleripetute conquiste e distruzioni, dellericostruzioni del tempio ebraico e poidelle basiliche cristiane, bizantine ecrociate, sul Golgota e attorno alSanto Sepolcro. Quindi la successionedelle comunità cristiane, a partire dal-la Chiesa di Sion di Giacomo, e le di-verse confessioni cristiane (bizantine,ortodosse, copte ecc.), poi l’istitu-zione del Patriarcato latino da partedei Crociati, mantenuto per secoli aRoma e poi ricostituito nell’Otto-cento; mentre i francescani, sulleorme del Fondatore, hanno pacifi-camente “riconquistato” e custodi-to i cosiddetti “Luoghi Santi”, met-tendosi al servizio dei pellegrini, nu-merosi fin dai primi secoli dell’eracristiana. Oggi tutte le confessioni,anche quelle sorte dopo la Riforma,oltre alle diverse Chiese nazionaliortodosse, sono presenti a Gerusa-lemme, una promessa di ecumeni-
smo, dopo dispute poco cristiane,auspicato e imposto dalla difficilesituazione dei cristiani in quella re-gione, contesa oggi dai seguaci del-le altre due religioni abramitiche. Lapanoramica storica non ha evitatole vicende religiose e politiche degliultimi secoli, con la fine dell’imperoturco e la creazione dello Stato diIsraele: Bruno Di Porto dell’universitàdi Pisa ha presentato il movimentosionista e i suoi riflessi religiosi, al-l’origine di Israele, mentre PaoloPieraccini, dell’università di Parigi,ha illustrato la condizione delle isti-
tuzioni religiose di Gerusalemme do-po la fine del Mandato britannico,con la tragica diminuzione dei cristia-ni, in gran parte arabi, a causa delleespulsioni e delle permanenti difficol-tà economiche. Il padre francescanoNarciso Klimas ha ripercorso la storiadel cosiddetto “status quo” ottoma-no che tutt’ora regola le diverse co-munità cristiane al Santo Sepolcro; in-fine il Patriarca di Gerusalemme,Fouad Twal, dopo avere ricordato ladifficile situazione attuale in Palesti-na, per il protrarsi del conflitto checolpisce gravemente anche i cristiani,
ha voluto aprire alla speranza, propo-nendo ”Gerusalemme, patria comu-ne per tutti i cristiani e cuore delmondo”. Una settimana quindi den-sa di informazioni, spesso di primamano e di recente scoperta, e riccaanche di conoscenze e nuove relazio-ni amichevoli: deplorevole quindi chei Ticinesi non sappiamo meglio profit-tare di quanto, e non solo con le set-timane di storia religiosa, offre la Fon-dazione ambrosiana Paolo VI, a pochichilometri dal valico di Stabio.
Alberto Lepori
Il P.L.G. si estende su quattro mo-derne nazioni che coprono il terri-torio dell’antica Palestina e dellaTerra Santa: Israele, Palestina, Gior-dania e Cipro. Il Patriarca è co-adiuvato da 5 Vicari Patriarcali,uno per ogni paese, più un quintoper la Comunità Cattolica diEspressione Ebraica. Il PLG ha unsuo seminario minore (50 allievi) e
maggiore (32 allievi) ben fiorenti aBeit Jala, e un clero diocesano,quasi totalmente autoctono di 89sacerdoti, 11 diaconi permanenti,31 sacerdoti religiosi impegnatinella pastorale. Le parrocchie sono68 (più diverse succursali e centripastorali), con 162’000 fedeli (instragrande maggioranza autoctoniarabi). Il PLG ha una rete di 44
scuole parrocchiali parificate, concirca 24’000 studenti e anche unanuova Università a Madaba. Le Cap-pellanie per gli immigranti sono 7. Nel PLG prestano servizio 549 reli-giosi e 1’063 religiose, con i quali ilPatriarcato ha un fruttuoso rappor-to di collaborazione pastorale nellagrande diversità delle loro numero-se opere: Luoghi Santi, università,
seminari, istituti biblici, scuole,ospedali, centri per pellegrini, cen-tri per disabili e per anziani, mo-nasteri contemplativi. Una menzio-ne speciale meritano i Minori Fran-cescani della Custodia di Terra San-ta, che da più di 6 secoli si occu-pano, oltre alle parrocchie, di mol-ti (quasi la metà) e importanti Luo-ghi Santi.
Il Patriarcato latino
www.sxc.hu

Recensioni
Pegaso Venerdì 21 settembre 2012X
Un’opera di notevolespessore letterarioIl terzo romanzo di Giuseppe CuroniciMartedì 5 giugno è stato presentato
a Milano alla Libreria Hoepli con l’in-tervento del prof. Giuseppe Lupo del-l’Università cattolica un nuovo roman-zo di Giuseppe Curonici, intitolato“L’incendio della montagna blu. Ilquadro perduto di Cézanne”, stampa-to, come i due precedenti, dalle Edi-zioni Interlinea di Novara. Si tratta di un’opera di notevole valoreletterario, in cui l’autore, oltre alla suaben nota esperienza e conoscenzadell’arte e alla sua visione psicologicadei personaggi, ci dà uno spaccatodella vita della moderna società civile,non dando tregua alla profonda visio-ne di un ambiente che ruota attornoalla storia qui narrata. In breve la trama. Un giovane galleri-sta, pieno di entusiasmo ma ingenuo,viene turlupinato da alcuni individuisenza scrupoli che lo inducono a sot-toscrivere una assicurazione per unquadro famoso di Cézanne, “Lamontagna blu”, nel quale il grandepittore francese ha rappresentato unpaesaggio a lui particolarmente caro,che lo riporta alla sua infanzia, nelquale vi sono tutte le caratteristiche
di colore e forma che poi farannoscuola nell’arte moderna successiva,anche per esempio su Picasso. Questiindividui gli raccontano una storia,secondo la quale il quadro, di cui esi-stono molte versioni, è stato vendutoper poco durante la crisi del 29, ed èfinito nelle stanze di una signora de-funta. E gli fanno sottoscrivere unacospicua assicurazione, complice unaagente di assicurazione. Con la scusadi portarlo ad un acquirente, uno diquesti individui, tale Balsamo, bendescritto dal Curonici come il classicoavventuriero, attraverso strade im-possibili in direzione di S. Moritz, in-cendia la macchina per distruggere ilquadro allo scopo di frodare l’assicu-razione. Ma la polizia subito sospettadi lui e indaga, coinvolgendo nelle in-dagini anche Firmat, l’ingenuo galle-rista. Dopo questo antefatto, la storiasi sviluppa su due piani: da una partevi è la pressione della giustizia, cheperò non riesce a coinvolgere Firmatche continua con un certo successo lasua attività di gallerista, sostenutodalla sincera amicizia di un architetto,che è un po’ la cattiva coscienza di
Firmar e di tutta la storia in mezzo atanti individui marginali: dall’altro visono due amori non corrisposti di Fir-mar per la bella segretaria Irene, per-sonaggio ben rappresentato con tut-te le sue peculiarità femminili, e dal-l’altra della stessa Irene per Flaminio,un giovane che poi va con un’altra ra-gazza. In fondo il vero protagonistadel libro è proprio il quadro di Cézan-ne, sul quale di tanto in tanto l’auto-re ritorna come in un sottofondo,quasi a mostrare, senza averne l’aria,la piccineria della società del nostrotempo di fronte ai valori autentici del-lo spirito umano. Il Curonici non dàtregua ai suoi personaggi, li psicana-lizza in modo direi quasi agnostico,anche se traspare tra le righe unacerta comprensione per le sventuredel protagonista Firmat. Non scendeperò mai alla caricatura, se mai si av-verte una certa pietà. Insomma, unromanzo che viene letto con parteci-pazione, e che rimarrà negli annalidella nostra letteratura come un belromanzo-verità.
Siro Ortelli
Un incontro con l’autore avrà luo-go giovedì 27 settembre, alle ore18.00 alla Biblioteca cantonale diLugano.
Il dialogo è finito?Tra le varie confessioni cristiane e quello con le altre religioniUn titolo garbatamente provocato-
rio, reso più incisivo dalla fotografia dicopertina, con l’incontro di Assisi del1986, nella quale compaiono insiemei più importanti rappresentanti dellereligioni e delle confessioni cristianepresenti nel mondo. Una foto che, asuo tempo, fece epoca. È questo il modo con cui il libro di Bru-netto Salvarani, “Il dialogo è finito?”(EDB Bologna 2011, euro 17,50) sce-glie di presentarsi ai lettori, su di un te-ma che, almeno fino a pochi anni orsono, era molto sentito e partecipato.Oggi però, ed è inutile nasconderselo,il dialogo è in crisi. È in crisi quello trale varie confessioni cristiane (e forse sista pagando quella eccessiva ondatadi ottimismo suscitato dall’abbracciotra Paolo VI e il patriarca Atenagora in
virtù del quale si ipotizzò un succes-sivo percorso facile, rapido, indolo-re, coronato da un sicuro successo),ed è parimenti in crisi anche quellocon le altre religioni, prima fra tuttel’Islam. Quest’ultima pare infatti de-stinata a divenire la religione ege-mone, dominante in un prossimo fu-turo, sia per la sua dinamicità (anchedemografica) come pure per unasorta di apatia spirituale della vec-chia Europa la quale pare, talvolta,essere “stanca di Cristo”. Ma, am-messo che ce l’abbia, si può parlaredi una religione dell’Europa? Il testo si sviluppa in molti capitoli,sempre ben collegati tra di loro e ar-ricchiti da interessanti indagini sociolo-giche, utilissime per inquadrare i suc-cessivi sviluppi del pensiero dell’auto-
re. Il risultato è che il lettore può assa-porare l’intero volume, riga dopo riga,pagina dopo pagina. Conosciamo tut-ti Brunetto Salvarani come grandeesperto della materia, e lo si confermada come sa giostrarsi in essa, senzamai perdere il filo del discorso e la suachiarezza espositiva tanto più prege-vole quando gli argomenti diventanodifficili. Egli evidenzia i pregi e non na-sconde i difetti, le lacune, le ambigui-tà nascosti tra le pieghe di un termineoramai inflazionato quale dialogo, pa-rola buona per tutte le occasioni e pertutte le circostanze e alla quale si puòattribuire il significato che più piace oche più conviene. Tanti sono i quesitiche via via vengono proposti alla ri-flessione del lettore. Dal classico “Dioè morto”, al conseguente “anche il
prossimo è morto?”, quale è la posi-zione dei cristiani nell’Europa e qualisono le posizioni delle varie forme dicristianità vissuta? Se e quanti erano idialoghi possibili e su quali basi un dia-logo deve fondarsi per essere credibi-le? E così via. Per sintetizzare il tutto inuna frase, direi che il libro è una mi-niera inesauribile di spunti di riflessio-ne e come tale va letto. Infatti, per ap-prezzarlo come merita, è necessariopoter disporre di un po’ di tempo dadedicargli quotidianamente, comeuna meditazione o comunque con re-golarità, per non perdere il filo con-duttore che lega i capitoli fra loro.
Enrico Gariano, da IL GALLO, Genova, aprile 2012

Riviste
Rivista delle rivisteAECM, Bollettino dell’Amicizia ebraico cristiana di Firenze, Casellapostale 282, 50123 Firenze.Nel numero 1-2 del 2012, una intervista all’archeologo ebreo Dan Bahat sulla lo-calizzazione del sepolcro di Cristo a Gerusalemme.
CARTABIANCA, Periodico di approfondimento interculturale, Missio-ne Betlemme-Immensee, Piazza Governo 4, 6500 Bellinzona.Il numero di giugno 2012 è dedicato a “la mia Africa”, con testi di Silvano Toppi,Enzo Ritter, Pietro Veglio, Domenico Patassini, Jean-Luc Farine, Luca e Silvana Buz-zi, ecc.
CHOISIR, rivista culturale dei gesuiti, rue Jacques-Dalphin 18, 1227Carouge - Ginevra.Sul numero 633 (settembre 2012) Albert Rouet, già arcivescovo di Poitiers, ri-chiama l’importanza dello “spirito del Concilio”, mentre uno statunitense fa l’e-logio della contestazione nella Chiesa cattolica e un economista critica l’econo-mia mondiale“ a due velocità”.
IL DIALOGO, bimestrale d’informazione e di opinione delle ACLI Sviz-zere, Via Balestra 19/21, 6900 Lugano.Il numero di settembre è dedicato al valore sociale dello sport. È presentato ilCongresso nazionale italiano delle ACLI, sul tema “Rigenerare comunità per co-struire il futuro”.
IL GALLO, quaderni mensili, casella postale 1242, 16100 Genova.Nel numero di settembre, i redattori si interrogano sul significato di “essere cri-stiano” e un ampio servizio informa sul dibattito in corso in USA per l’elezione delPresidente, e si discute di “traduzioni e interpretazioni” sulla formula della con-sacrazione eucaristica.
IL MARGINE, mensile dell’Associazione culturale Oscar Romero, C.P.359, 38100 Trento.Nel numero 5-2012 (maggio) tre redattori fanno un bilancio della situazionepolitica italiana (“Tutto vacilla”) e il milanese Giovanni Colombo si interrogasulla gestione finanziaria della diocesi del cardinale Scola: per il fondo per le fa-miglie in difficoltà, in tre anni sono stati raccolti 14 milioni di euro, e per la re-cente visita del Papa ne sono stati spesi 10. Nei primi anni novanta, l’8 per mil-le fruttava alla Chiesa italiana 410 milioni, mentre l’ultimo dato disponibile è diun miliardo e 100 milioni; grazie al marchingegno concordato con Craxi, laChiesa cattolica riceve l’85% del totale, anche se meno del 50% dei contribuen-ti la indica come beneficiaria. Non sarebbe il caso di ridiscuterne, mentre si cer-ca una soluzione per gli “esodati”? Nel numero 6-2012, Fulvio De Giorgi af-fronta il tema della “pienezza ecclesiale” dei divorziati risposati, auspicandouna “via veramente cattolica”, che possa condurre in casi particolari alla pienapartecipazione anche eucaristica.
NONVIOLENZA, trimestrale d’informazione su pace, non violenza, di-ritti umani e servizio civile, casella postale 1303, 6501 Bellinzona.Il numero 7 -2012 (giugno) si apre con la denuncia del “colonialismo violento del-le multinazionali svizzere”; diversi servizi documentano lo scandalo del commer-cio delle armi, aumentato anche da parte della Svizzera nel 2011 (+36%).
KESHET, bimestrale di vita e cultura ebraica, Galleria del Corso 4,20122 Milano. Nel numero 3-4 (novembre-dicembre 2011), Bruno Segre descrive l’evoluzionedel sionismo, dalla sua origine laica all’attuale fondamentalismo religioso e con-stata la difficoltà aumentata di realizzare l’unica auspicata soluzione di “due Sta-ti per due popoli”.
IL REGNO, quindicinale di attualità e documenti, Via Nosadella 6, Bo-logna.Nel numero del 15 luglio, il teologo Dianich, commentando il documento prepa-ratorio del Sinodo sull’evangelizzazione, ripropone la sua tesi di un ostacolo trala Chiesa cattolica e la cultura occidentale contemporanea, indicando quale so-luzione una riforma della Chiesa con la povertà evangelica, che: “è amore della
Venerdì 21 settembre 2012 Pegaso XI
Segnalazioni
MONTE VERITÀ, 29 settembre, ore 9-18, Convegno internazionale“LOSFELD, il terreno incolto e dimenticato da cui si ricomincia”. Diverserelazioni, organizza il Dr. Giorgio F. Alberti.
LUGANO, 6 ottobre, Biblioteca Salita dei Frati, ore 17, Inaugura-zione mostra “Nulla dies sine linea” di Fra Roberto. Apertura me-ve 14-18/ sa 9-12.
LUGANO, 5-7 ottobre, Palazzo dei congressi, forum internazionale“Generazioni nel cuore della pace”, tavole rotonde, degustazioni, proie-zioni, spettacoli, esposizioni a tema; organizza Associazione culture TicinoNetwort (www.generazioninelcuoredellapace.ch).
LUGANO, 11 ottobre, ore 10.15, Palazzo dei congressi, conferenzadi Pietro Veglio, già consigliere per la Banca Mondiale e presidente dellaFOSIT, su “Governare la globalizzazione”; organizza l’Associazione ticine-se Terza età.
BERNA, giovedì 11 ottobre, chiesa della SS. Trinità, celebrazioneindetta dai Vescovi svizzeri per i 50 anni dell’apertura del Concilio vatica-no II, con Appello alle comunità, e inizio del triennio di rilettura dei do-cumenti, col motto “Scoprire la fede” e dibattito sulla attuazione del Con-cilio nel mondo di oggi.
VERONA, 9-10 novembre, Biblioteca civica, “Chiesa e società a Vero-na. A cinquant’anni dal Concilio vaticano II”. Venerdì pomeriggio: Giovan-ni Miccoli, Chiesa e mondo, da Pio XII a Giovanni XXIII; Giovanni Vian, LeChiese locali venete di fronte al Concilio; Enrico Baruzzo, Laicato cattoli-co, rinnovamento conciliare e società veneta. Sabato mattina: Rino Cona,Il vescovo Carraro e la novità del Concilio vaticano II; Concilio e postcon-cilio: testimonianze e bilanci; Riflessioni conclusive di Ilvo Diamanti.
semplicità e austerità di vita, ma lo è anche nelle forme che qualificano il pro-prio atteggiamento di fronte agli uomini”.
RIVISTA DELLA DIOCESI DI LUGANO, Curia vescovile, 6901 Lugano.Nel numero di giugno, mons. Sandro Vitalini insegna (con un testo dedicato al-l’eutrapelia…) “ad avere uno sguardo ottimista e sereno sulla globalità della vi-ta, con particolare attenzione al divertimento, al giuoco, alle passeggiate, alla mu-sica, al canto, all’attività sportiva”.
IL TETTO, bimensile di religione, politica e cultura, Piazzetta Cariati 2,80132 Napoli.Il numero doppio di marzo-giugno 2012 dedica due articoli al pensiero e all’amici-zia di padre Ernesto Balducci, nel ventesimo della morte; viene ricordato, con unalunga recensione, il contributo di Giuseppe Dossetti al tema conciliare “Chiesa deipoveri per i poveri; la cronaca del XXXIII Incontro nazionale delle Comunità di Ba-se italiane riassume preoccupazioni e speranze per la Chiesa. Completano rifles-sioni e rilievi critici sulla politica del governo Monti.
VERS UN DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE, mensile della Dichiarazione diBerna, rue de Genève 52, 1004 Losanna.Il n. 222 (giugno 2012) denuncia lo sfruttamento del lavoro (in Macedonia,meno di 70 centesimi all’ora agli operai delle confezioni!) di cui usufruisconoi commercianti di uniformi ed abiti di lavoro; circa 2 milioni di svizzeri li por-tano (militari, poliziotti, conduttori di mezzi pubblici, operai dell’edilizia, me-dici e impiegati negli ospedali ecc.) e molti sono acquistati (e cioè sottopa-gati) con soldi pubblici.