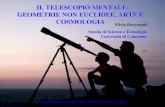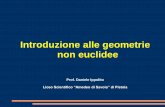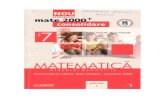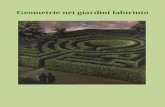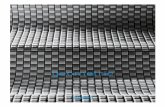08 Geometrie
-
Upload
dheannainsugradh -
Category
Documents
-
view
10 -
download
3
description
Transcript of 08 Geometrie

57
Metodologia Geometria e lettura storica
Geometria e lettura storica:il rilievo 3D come strumento per l’interpretazione e il confronto
Manuela Incerti
Già dal 1996 la Facoltà di Architettura di Ferrara ha voluto scegliere tra le possi-bili linee di ricerca la sperimentazione di nuove tecnologie per il rilievo avanzato. Risale a quell’anno la presenza del pri-mo modello di laser scanner 3D della Cyra: poco più di un prototipo sino a quel momento sostanzialmente mai testato nel rilievo architettonico. L’impegno pro-fuso dal Nub Lab (Laboratorio di Rilievo, Modellazione e di Prototipazione 3D) nel primo periodo della sua esistenza si è
in primis rivolto alla necessaria verifica delle capacità tecniche di questa nuova strumentazione. Nel tempo il prodotto, hardware e software, si è rinnovato e le sue potenzialità sono accresciute note-volmente: è stato possibile passare da piccoli, seppur molto prestigiosi, ambiti di rilievo (cuneo del Colosseo, abside del-le Terme di Caracalla), a nuovi contesti sempre diversi per caratteristiche logisti-che, ambientali, morfologiche, materiche e dimensionali, così come mostrano i casi studio illustrati nel presente volume1. Si tratta di rilievi che utilizzano metodi di acquisizione dati integrati: scanner 3D Cyrax e Minolta, stazione totale, GPS, fotografia digitale. L’apporto dei “metodi di rilievo diretto”, basati sull’uso dei tra-dizionali sistemi di misura quali squadri,
Vista dell’abbaziale di Pomposa e del suo campanile

58
MetodologiaGeometria e lettura storica
cordelle, aste metriche e fili a piombo è praticamente inesistente. Dai test di accuratezza sulla strumenta-zione impiegata si è oggi passati al con-fronto sul campo con l’ampio ventaglio di finalità che guida e determina l’agire del rilevatore. In ambiti rigorosamente specialistici, limitati e puntuali sono stati affrontati casi inerenti tra l’altro lo speci-fico disciplinare del restauro, della con-servazione, del consolidamento, della documentazione e catalogazione, della verifica tra stato di fatto/progetto, dell’ar-cheologia, delle perizie giudiziarie. La banca-dati di modelli 3D costituiti da nuvole di punti ammonta attualmente a diverse migliaia di milioni di punti interro-gabili da un operatore consapevole che rilevare non significa soltanto “misurare dimensionalmente”. La storia più recen-te della nostra disciplina ci ricorda che il rilevamento di un organismo architettoni-co “deve tendere alla rappresentazione mediante una trascrizione grafica, della conoscenza globale dell’opera, ottenuta attraverso indagini attente e ragionate della realtà costruttiva e che di questa colgano i valori formali e spaziali, dimen-sionali e percettivi, tecnologici e costrut-tivi.”2 Il rilievo dell’architettura è, oggi come ieri, un canale di conoscenza privilegiato ca-pace di condurre alla riscoperta dei pos-sibili significati, più o meno nascosti, di un’architettura. L’assenza di un contatto fisico, in senso stretto, tra l’operatore e il manufatto peculiare dell’uso della tec-nologia laser scanner, non può impedire tuttavia che tra loro s’instauri quel dialo-go profondo e ricorrente per la compren-sione dei valori più intimi dell’opera. Il primo passaggio obbligato è quello del-l’elaborazione grafica dei dati resa oggi
più agevole grazie alle potenzialità di due nuovi plug-in che integrano il softwa-re Cyclone: si tratta di Cloudworks basic e Cloudworks pro, prodotti in collabora-zione con Autodesk e Bentley. Mediante questi software è ora possibile ottenere delle sezioni piane dalla nuvola di punti 3D, e visualizzare il contenuto di un da-tabase tridimensionale direttamente da Autocad o Microstation lavorando con alcuni strumenti di Cyclone in ambiente CAD.È questa la procedura utilizzata per la realizzazione degli elaborati grafici, e per l’estrapolazione dei dati dimensio-nali, utili alla lettura delle caratteristiche geometrico-astronomiche dell’Abbazia di Pomposa. Le fasi di rilievo e di restituzio-ne dei dati sono descritte sinteticamen-te nel relativo caso studio del presente volume. L’obbiettivo della ricerca sul-
La navata principale verso l’abside.

59
Metodologia Geometria e lettura storica
l’abbaziale pomposiana ha naturalmen-te condizionato la procedura, la qualità del rilievo e la restituzione grafica finale. L’analisi archeoastronomica ha reso ne-cessaria una attenzione particolare nel-l’individuazione dei dati metrici di finestre e oculi (aperti o tompagnati), così come all’andamento di superfici orizzontali e verticali. Superfluo era invece il rilievo di dettaglio dei pur pregevoli particolari ar-chitettonici esistenti. Il risultato è dunque un elaborato molto accurato nella posi-zione delle sezioni murarie (compreso il fuori piombo), delle colonne, delle porte, delle finestre e degli oculi. Molto interes-sante, in questo contesto di ricerca, è anche il dato di riflettanza che consente di leggere la posizione nello spazio delle varie scene affrescate.Come sempre è stato necessario percor-rere la fase d’indagine cognitiva sull’og-getto attraverso la raccolta dei dati con-cernenti l’esecuzione, i committenti, lo specifico uso liturgico degli spazi, gli am-pliamenti, le trasformazioni, i consolida-menti, il significato dell’opera, l’ambiente culturale che animava la folta comunità monastica.3 Sulla base di queste prime indagini, è stata applicata alle piante ed alle sezioni bidimensionali la classica
analisi geometrico-astronomica,4 volta ad individuare le ragioni dell’allineamen-to sull’orizzonte locale e la presenza di eventi luminosi particolari in concomitan-za di date rilevanti del calendario liturgi-co ed astronomico.5 Per questo scopo sono stati utilizzati diversi programmi per il calcolo dei calendari e delle effemeridi. Alcuni software per il calcolo delle meri-diane,6 utili per velocizzare le operazioni di costruzione di un orologio solare con quadro orizzontale, sono stati impiegati per la visualizzazione delle iperboli gior-naliere e le linee orarie nelle epoche più rilevanti per la storia dell’edificio mona-stico. I file ottenuti, in estensione dwg, vengono sovrapposti alle planimetrie di-gitali per una corretta e dettagliata ana-lisi archeostronomica. A titolo di esem-pio, per rendere esplicita l’utilità dei dati acquisiti mediante l’uso dello scanner Cyrax, si riportano di seguito alcune del-le considerazioni svolte.Dalla lettura degli allineamenti tra le principali geometrie dell’abbaziale e le direzioni astronomiche più significative (nord-sud, est-ovest, levata e tramonto nelle date solstiziali) si evince che l’asse dell’edificio si discosta dall’equinoziale di 2° circa. Alcuni elementi architettonici
Pianta dell’abbaziale di Pomposa rilevata
con lo scanner 3D Cyrax ed elaborata con
Cloudworks.

60
MetodologiaGeometria e lettura storica
sembrano seguire perfettamente le dire-zioni cardinali: la parete del presbiterio (ricostruita negli anni ’30 sulla base di tracce materiali) ed il perimetro del primo tratto di pavimentazione.7 Sono stati riscontrati possibili effetti lumi-nosi degni d’interesse in diverse date del calendario liturgico ed astronomico. Il pri-mo riguarda la monofora oggi tompagna-ta presente sul muro sovrastante l’arco di trionfo e denominata 1E.8 Alla levata del Sole nei giorni intorno all’equinozio di primavera (tra il 21 e il 25 marzo) la mac-chia di luce proveniente da tale apertura sembrerebbe illuminare il volto del Cristo benedicente in controfacciata. Non è su-perfluo ricordare che il 24 marzo cadeva la festa dell’Arcangelo Gabriele, mentre il 25 marzo è celebrata l’Annunciazione
a Maria e che proprio sulla parete in cui si apre questa finestra sono rappresen-tate queste due figure.Qualche tempo dopo, nei primi giorni di aprile, la stessa apertura illumina il volto di Cristo Risorto nella mandorla (4 aprile 1351) raffigurato sempre nella stessa pa-rete. Anche in questo caso occorre pun-tualizzare che proprio in questo periodo, dato lo spostamento del primo plenilunio primaverile, era probabile la celebrazio-ne della Pasqua.9
Il 14 settembre, festa dell’Esaltazione della Croce e memoria della vittoria di Pasqua, lo stesso fascio di luce colpisce infine la croce della passione posiziona-ta alla destra della monofora settentrio-nale. Analizzando invece il sistema di apertu-re poste sulla facciata principale è stato possibile compiere altre interessanti ri-flessioni. Il 24 giugno, festa di san Gio-vanni Battista10, l’oculo di facciata clas-
Vista della controfacciata con l’affresco del Giudi-zio Universale
Il pavimento in mosaico del coro dei monaci

61
Metodologia Geometria e lettura storica
sificato come 1Ov genera un fascio di luce che illumina la porta di accesso al coro dei monaci intorno all’ora nona.11 Il 15 agosto, festa di santa Maria Assunta alla quale l’abbaziale era dedicata,12 la monofora settentrionale di facciata (2Ov) illumina il presbiterio intorno all’ora deci-ma e mezza, dunque nel tardo pomerig-gio alla celebrazione dei Vespri.Nell’intorno del Solstizio Estivo (21 giu-gno) invece sembrerebbe che le mono-fore della navata principale creassero un curioso disegno sul pavimento della chiesa. Intorno all’ora sesta, e dunque al
passare del mezzogiorno, le macchie di luce provenienti dalle aperture toccano simultaneamente l’asse della chiesa.13
Note:
1 Per le sperimentazioni sul rilevamento mediante scanner 3D condotte in questi anni all’interno del NUB LAB (Laboratorio di rilievo, modellazione e di prototipazione 3D- direttore M. Balzani) si veda: Frontiere del rilievo. Dalla matita alle scansioni 3D. A cura di R. Migliari, Gangemi editore, Roma 2001. 2 M. Docci, D. Maestri, Manuale di rilevamento ar-chitettonico e urbano, Laterza, Bari 1994, p. VI.3 Per una descrizione estesa di questi contenuti si veda l’articolo: M. Incerti, N. Zaltron, Procedure e metodiche sperimentali di rilievo mediante laser-scanners 3D finalizzate alla lettura delle caratte-ristiche geometrico-astronomiche dell’Abbazia di Pomposa, in Atti del III Convegno Associazione Italiana Archeoastronomia, Napoli 26-27 settembre 2003 (in corso di stampa).4 È noto come nella progettazione delle chiese non è insolito, come già nei templi antichi, orientare l’ab-side in modo che i religiosi o i fedeli possano vede-re il mattino, durante la celebrazione della prima messa, il sorgere del Sole richiamo simbolico alla Resurrezione di Cristo, Luce del mondo. Per tale
La monofora oggi tompagnata presente sul muro sovrastante l’arco di trionfo e denominata 1E.
Pianta dell’abbaziale di Pomposa riportante
i dati dell’analisi archeoastronomica.

62
MetodologiaGeometria e lettura storica
ragione il primo atto materiale, compiuto verosimil-mente dagli antichi costruttori, era quello di indi-viduare l’orientamento della fabbrica tracciandone l’asse principale sul terreno mediante pali e corde. L’orientamento prescelto per un edificio religioso, modesto o imponente che fosse, poteva coincidere con l’allineamento tra la posizione dell’osservatore ed il punto di levata (o di tramonto) del Sole nel giorno del Santo Patrono, della festa alla quale il tempio era dedicato, oppure di una particolare so-lennità liturgica. In alcuni casi era anche l’osser-vazione del sorgere o del tramontare del Sole nel giorno in cui si dava inizio ai lavori ad indicare la direzione dell’asse. Attraverso metodi gnomonici si poteva infine risalire all’equinoziale, cioè alla linea che unisce i punti di levata e di tramonto del Sole nel giorno degli Equinozi.L’allineamento dell’asse dei corpi di fabbrica non era in ogni modo l’unico accorgimento di carattere astronomico che i progettisti ed i costruttori pote-vano adottare in corso d’opera. Disponendo op-portunamente le componenti architettoniche di un sistema edilizio era possibile, in corrispondenza di festività e liturgie importanti, creare giochi di luci e di ombre spesso capaci di suscitare nei fedeli sen-timenti di stupore e di meraviglia.5 Tra le più recenti e significative ricerche dell’autri-ce sulle geometrie del tempo si veda: Le geometrie del tempo a Pienza, in Atti Convegno Internazio-nale AED, Il disegno della città opera aperta nel tempo, San Gimignano 28-29-30 giugno 2002; gli articoli pubblicati in Archingeo, mensile di attuali-tà e approfondimento Ambiente Territorio Edilizia, Urbanistica. Maggioli Editore, 2002-2003; Antiche geometrie solari nel Battistero di Parma. In Arte Cristiana, Rivista Internazionale di Storia dell’Ar-te e di Arti Liturgiche, LXXXIX, 805, luglio-agosto 2001; Architettura sacra medioevale ed Archeoa-stronomia. In L’Uomo antico e il Cosmo, Atti del III° Convegno Internazionale di Archeologia ad Astro-nomia. ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, Roma 15-16 maggio 2000 e la monografia Il disegno della luce nell’architettura cistercense. Allineamenti astrono-
mici nelle abbazie di Chiaravalle della Colomba, Fontevivo S. Martino dei Bocci in Valserena. Edi-zioni Certosa di Firenze, Firenze 1999. 6 Tra questi: “Calendario Perpetuo” di Giuseppe Tavernini, “G.Effem” (Versione 4/2001) di Gian-ni Ferrari, “Archisole” di Carlo Frison, “Merid98P” (Versione 06/01) di Gianni Ferrari.7 Singolarmente una delle direzioni della griglia geometrica del mosaico di recupero con disegno geometrico floreale tassellato possiede un azimut analogo alla levata del sole nel solstizio estivo (tra-monto solstizio invernale).8 Le dimensioni e la posizione delle aperture è sta-ta verificata interrogando direttamente la nuvola di punti.9 Il calcolo del cadere della Pasqua è stato verifica-to con il programma “Calendario Perpetuo” di Giu-seppe Tavernini, per il periodo storico a cui sono solitamente datati questi affreschi.10 In tale data si celebravano i battesimi e, dunque, il momento del “passaggio” con l’ingresso del cate-cumeno nel Popolo di Dio. E’ questa la ragione per cui a Giovanni Battista è spesso attribuito il signi-ficato di “porta”.11 Tale oculo, la cui autenticità non è trattata dagli storici dell’arte, è stato riaperto nel corso dei re-stauri seguiti dal Corsini nel 1928-30. 12 Janua coeli (porta del cielo), Felix coeli porta (felice porta del cielo, vergine “vestita di Sole, con la luna sotto i suoi piedi (Ap. 12,1). In proposito si ricorda che il 17 agosto si festeggiava Janus, dio della porta del Sole e della porta celeste (Janua coeli). Il 13 si festeggia Diana, la radice del cui nome, di-, si ritrova anche in deus (dio) ed esprime l’idea del brillare, del chiarore del cielo illuminato dal Sole. Sorella di Apollo, il Sole, Diana è assimi-lata alla Luna, riflesso dell’astro del giorno.13 Questo fenomeno era probabilmente ancora più scenografico sul pavimento precedente il mosaico attuale, quando il livello altimetrico era più basso di circa 30 centimetri. In tale condizione le macchie potrebbero infatti trovarsi perfettamente centrate sull’asse dell’edificio.