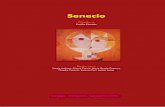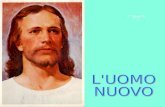01-Genesi
Transcript of 01-Genesi

Jfc PRIMO
LIBRO DEL PENTATEUCO
O S $ I A .
L A G E N E S I

PREFAZIONE
11 Pentateuco tutto, siccome è opera di unsolo autore Uose, così *& Ì'utto ™Sie™"*sol libro, ed è citato nel Nuovo Testamentocol titolo di libro di Mosè , ovvero col nome aiLegge. La divisione però di esso in cinque li-bri è molto giusta , e ad Esdra si atinbwc*comunemente. Il nome, che è dato nella nostraVolgata a questo primo libro viene dalla tra-dazione «te'iXX, i quali lo intitolarono Genesi,vale a dire Generazione , perchè m esso è de-scritta la creazione dit tutte le cose, e si rac-contano le generazioni de patriarci da A bra-mo in poi. Neti' Ebreo questo libro ( come gllaltri quattro ) prende il nome aprima pa-rola, da cui egli comincia, Beresith, ovveroBerescitb, Al principio. Tutta la Genesi si puòdistinguere Ì*&aMro P**à* *<&* 1**** la ma contiene ti retivi* del &«tr**ma»o d«Adamo fino ài diluvio, Genesi V IM* *«tonda abbracci* tutto il tempo , che corr e daNoè fino ad Abramo, dal- capo rii. fino alXll. La tersa descrive le a*iom di Àbramofino alla sua morte, capa XXr. Nella quartasi narrano i fatti à" Isacco, di Giacobbe e diGiuseppe fino alla morte di questo gran pa-triarca. Ella è opinione assai comune^ tra gliInterpreti, che la Genesi fu scritta da UosendV Arabia allora quando Iddio disgustato co-eli Ebrei per le loro mormorazioni, e petlalor miscredenza, li condannò a consumarequaranC anni nel girare attorno pellegrinando

per quel vasto 'dì&er'to. In tal luogo adunqueMosè diede principio ad istruire e formare iipopolo commesso dal Signore al suo governo ,rimettendogli davanti agli occhi le gran veritàdella Religione , sulle quali dovea poscia inal-zarsi tutto t edifizio della sua legislazione.Quindi è descritta la creazione dell universo,f origine del genere umano > la felicità del pri-mo uomo creato da Dio a sua immagine e so-miglianza ( felicità, di cui avrebber goduto isuoi discendenti, se egli non avesse disobbe»dito al suo Creatore ) ; la corruzione generaledegli uomini punita da Dio coli' universale di-luvio», da cui il solo Noè colla sua famiglia èsalvato nelf arca ; la confusion delle lingue, ela divisione della tèrra tra'figliuoli dì Noè, laseparazione di uno de' discendenti di Sem peressére il padre de* credenti, e lo stipite del po*•poi di Diot è finalmente la vita de' patriarchada A bramo fino a Giuseppe. Tali sono i gran»diosi oggetti che ci son messi davanti in que-'sto libro. L' autore di esso, il più grande in»siemet e il più antico di tutti gli storicit ci dàuna continuata notizia di tutti que s ecoli in-torno a' quali gli scrittori prof ani più antichiè più celebri non altro han potuto a noi traman-dare , se non mère favole, ovvero confuse ealterate tradizioni del vero. Quello però chesopra tutte le altre storie rende infinitamente-preziosa e venerabile quella di Mosè, egli ètche te essa si ha la storia della Religione daideiamo fino a quel tempot in cui, mediatore lostesso Mosè) fermò Dio la grande alleanzato' figliuoli d* Israele, e li fece suo popolo. Co-si £ uomo cristiano trova nella Genesi non so-lo là cognizione perfetta del vero Dio , e dei

45
suoi attributi ; ma di piai lumi necessarii perconoscere A-è stesso , e la naturale sua mise'ria, onde è condotto ad alzare la mente e ilcuore verso quel celeste Liberatore , la graziadi cui può non solamente scioglierlo dal pec-cato, ma ancor sostenerlo in mezzo alle tenta-zioni della vita presente ; vi trova i documentigravissimi di pietày e innumerabili esempli diogni virtù Ì7t que* santissimi uomini, la fedede' quali, degna dell' Evangelio, a cui pur ap-partenneroy è celebrata dagli scrittori santidel Nuovo Testamento, e dal medesimo GesùCristo : vi trova finalmente i misteri dello stes-so Cristo, e della sua sposa la Chiesa, figura*ti e predetti ne" fatti più illustri, e negli avve-nimenti , e negli stessi personaggi più rag"guarde.voli, de' quali in questa divina storia ra-gioitasi. Imperocché, come notò s. Agostino, Dique' santi, i quali furono anteriori di tempo allanat ivi tà del Signore, non solo le parole, ma an-che la vita, e i maritaggi, e i figliuoli, e le gestafurono profezia di questo tempo, in cui nellaf*de delia passione di Cristo è adunata di tutte1? gent i la Chiesa ; onde giustamente affermas. Ireneo, che ogni lettera di Mosè è parola diCristo : Literae Mosis verba sunt Chrisli.

1 kLIBRO DELLA GENESI,
CAPO PRIMO.
Della creazione del mondo. Distinzione^ e orna-to delle cose create* Formazione dell'uomo, acui Dio sottopone tutto quello ché àvea creato»
i, (i) in principiocreavit Deus coelum etlerram.
i. A.lprincipiocreòDio il cielo e la lerra.
(i) Ps. 32. 6. i35.5. Ecc/. 18. i.Act. \k> *4«17. 24.
Vers. i. Al princìpio creo Dio te. Con*queste parole Mosèfa io primo luogo conoscere, che il mondo non è eterno , maha avuto un principio, togliendo cosi di mezzo le false idee de-gli antichi filosofi: ««condola conoscere Palliare stesso del mon-do e della natura : ed è cosa da notar»!, ebe in tutta la «oriadella creazione \ la stessa vóce adopera Mo s è a significare ilCreatore del mondo. Questa voce esprime la potenza di Dio ,colla quale non solo creò il tut to , ma il tutto ancora conserva egoverna: questa voce è nel numero plurale, onde letteralmentesi t radurrebbe: A principio gli dii creo. Lo che non solamentead Origine ,a s. Girolamo e a s .Ep i f an io , ma anche a qualcheantico Rabiuo parve argomento della unità di essenza, e dellaplura l i tà delle persone , che è in Dio. La parola originale, chenoi espoughiaruo con quella creo , questa parola benché nonsempre significhi trarre dal nulla, ha nondimeno questa signifi-cazione principalmente; e io questo luogo evidentissimamenteesprime la creazione dal nulla : verità confermata eziandìo dallaScrittura (Maoh, n. cap. vii) oltre il consenso degli antichi, emoderni Interpreti.
11 cielo , e la terra, S. Agostino per queste due cose intesetutta la materia creata dal nulla : della qual mater ia doveva poiformarsi il cielo e la terra, e tutte le cose, che nel!' uno e nel 1*altra compiendomi; «ode il comedi cielo, come quello di te r rasono qui messi anticipatamente j Z» i, de Gcnt coni. Hfunich.

2. Terra autem eratinanis et vacua, et *e*nebrae erant super fa*ciem abyssi : et spiri'tus Dei ferebatur su-per aquas.
3, Dixìtque Deusi(\)Fiat lux. Et facta estlux.
2. E la terra era in-forme e vota, e le te-nebre erario Sopra lafaccia dell' abisso : e lospirito di Dio si moveasopra le acque.
3. E Dio disse : Siafatta la luce . E la lucefu fatta.
(O Helr. 11.3.cap. vii..Simile a quésta è la sposizione dì s. Gregorio Nisseno.Alcuni moderni Spositori ,Pererio ec. hanno credito che sottoil nome di cielo s' intendano i corpi celesti, e sotto il nomq diterra il globo stesso terrestre coi!' acqua , col fuoco, e coli'uria, ond' «circondato lò stesso globo. Forse è più naturale esemplice il dire, ebe Mosè racconta qui ingenerale la creazione dell 'universo, di cui le parti principali sono il cielo e laterra.per venire dipoi alla descrizione particolare di ciascuna par-te. Mosè tutto inteso a risvegliare nell'uomo l'idea del suo Crea-tore, e il sentimento della bontà, colla quale questi avea crea*te tante cose per lui, non parla della creazione degli Angeli, iquali, secondo il parere de' più antichi Padri greci e latini fu-rono primogeniti traile opere di Dio (Basii. Nazianz Hieron.«e ). e più probabilmente creati nei primi momenti del primogiorno.
* Creo Dio il cielo e forse gli angeli insiem con esso, poichénon dicesi informe e vuoto come la terra, sebbene non accora or-nato degli astri.
Vers. 2. La terra era informe e vola. Era una massa privadi tutti quegli ornamenti, ond' ella fu poscia abbellita, animali ,piante, erbe ec.JPWi Hai. xxxi t. 11. Jerein, »v. a3. Le acquasono comprese insieme colla terra.
È le tenebre erano sopra la faccia dell* abiuo: e lo spiri-to ec. Da no passo di Giobbe xxxvm g. sembra chiaro, che que*stè tenebre non erano una semplice privazione di luce , tua unaspecie di caligine, che investiva tutta la mole delle acque, e leingombrava. Dov'eri tu, (diceOio a GiobbeJ quond1 io involge-va nella caligine il mare, come un bambino nelle suefaicfìLo spirito che si movea sopra le acque, egli è lo Spirito Santo ?Spirito vivificante , il quale infondeva nelle acque la virtù diprodurre i rettili, i volatili , i pesci, eg.
* Lo spirilo dì Dio era portalo, aleggiava: cosi, secondo al-cuni, l'Ebreo.
Veri. 3. E Dio disse ec. -Fino a nove volte osservano gl'In-terpreti, che è ripetuta questa pai'oh io questo racconto della

4. Et vidìt Deus tu-• em , quod esset bona-,etd'wisit lucem a tene*oris.
5. Jppellavìtqiie hi-ceni diem , et lenebrasfioclem. F ac tum que estvespere et mane diesunus.
4» E Dio vide, che Jaluce era buona : e divi-se la l uce dal le tenebre.
5. K la luce n o m i n ògiornee le t eneb re noi-Lo. E della sera e de!lam a t t i n a s i compiè il pri-mo giorno.
creazione de l le cose , indueendo cosi Mosè la parola di Dio f osia il Verbo di Dio ) come p r i n c i p i o dell ' essere di t u t t e le co-se , p e r c h è queste cose tutte per lui furori falle.. Joan. i. Ved iq u e l l o che ci è de t to in ( j u e l luo^o.
Sia fuLla la luce. Ques ta m a n i e r a di p a r l a r e , la quale ton-v c i i i r non può, se non a l l ' u n i c o Essere « n i . i p o t c n U - , f . , c rU-bru-to a l t a m e n t e anche da uu relore pacano . S. ILis i l io , e s. Grego-r io IN ' i i z i anzeuo credono, che ques ta luce fosse una q u a l i t à senza
dono, che fosse un corpo l u m i n o s o , d' onde ne fu poi t r a t t o ilsole , e le stelle. L' Apos to lo 11. Cór. iv. G. a p p l i c a questo fa t -to , e queste parole ad un'al t ra maniera di creazione, va le a di-re a l l a sp i r i tua le rigenerazione de' fedeli per Cristo , d icendo:iddio il quale disse che dalle'lenebre splendesse la. luce, egli
stesso rifulse nt? no s tri cuori, ec.Vers. 4- E Dio vide, ec. Mosè rappresenta Dio a somiglianza
ti i un a r te f ice , il qua le fatta che ha un 'opera , la con templa , e«e a p p r o v a la bon tà , o sia 1' u t i l i t à . Tre cose ( dice s. Agosti-no ) grandemente importanti a saperti doveano estere a noiintimale : chi fosse il facitore : per f/nnl mezzo le cose tuttefibbia fatte: il perche le abbia f a t t e . Dio disse: Sia la luce :e la luce fu. E Dio vide , che la. luce erri buona. Non havvine autore più eccellente di Dioì ne arte più efficace della pa-rola di Dio, ne causa migliore, che i' essere fatte delU cojebuone da lui, che e il buono.
E divise la luce dalle tenebre. Le tenebre ( le qua l i oramainon sono, se non una p r i v a z i o n de l ia luce ) vo l le Dio , che suc-cedessero a l l a l u c e , e ques t a v i c e n d e v o l m e n t e a que l l e .
V e r s . 5. h la luce nomino ec. La no t te precede il giorno :onde da una sera a l i ' a l t r a con tano i l p iorno gli Ebrei e la ch i e -sa. 11 mondo a d u n q u e avea a v u t t » dodici ore di d u r a z i o n e , f i l -lorcLè Dio creò la luce.
n _ . -^- » -

&.Dixit quofjueDeus*,fiat firmamentam inmedio aquarum \ et di-viclat aquas ab aquis.
7. Et fecit Deus fir~mamentum , divisitqueaqaas , quae erant subfirmamento ab his, (ijquae erant super fir-mamentum, Et factamest ita,
8. Vocavitque Deusfirmamentnrn coelunt.Et j"actum est vespereet. mane dies secun-dus.
g. Dixit vero Deus :Congregentur aquae ,quae sub coelo sunt, in
6. Disse ancora Dio :Sia fatto il firmamentonel mezzo alle acque :e sepali acque da acque.
7. E fece Dio il fir-mamento, e separò leacque , che eran sottoil firmamento da quel-le che erano sopra ilfirmamento. E fu faltocosi.
8. E al firmamentodiede Dio il nome dicielo. E della sera edella mattina si compièil secondo giorno.
9. Disse ancora Dio :Si radunino le acque ,che sono sotto il cielo .
(i) P,y. i35. 5 , 118. 4. Jer. io. 12.6. 16.
Vers.6. Sia fallo il firmamento ce. La parola ebrea rendu -la nella Volgata con quel lo di firmamento, secondo s. Girolamo,e i pii» dotti Rabbini , significa etfxtmione , dilatazione, onde,r iunendo il senso della Volgata eoo quel lo del lesto or ig ina le ,il f irmamento sarà queli' ampia stabil volta , iutorno a l la q uale«i rivolgono i corpi celesti. Questa nel le Scr i t ture è soventerappresentata come un vastissimo padiglione , che tutta cuopree cinge la terra. Ps, io3. 2. Isaì. s». 22. xt.ii. 5. Firmamento dun-que è in questo luogo tu t to quello immensa spazio, che è traile,stelle , e noi. Che nelle superiori parti di esso vi sieno delle a-cque, è ripetuto tante volte nel le Scr i t ture , che sarebbe temerario ( per non dir di pe»«io ) ch iunque ard isse di negarlo. Vt-t l i P f . n3. 4-, io3 .3 , Dan. m. 20. Ps. 148.6
Vers, 8. E ... diede .. . il nome di cielo. La voce ebrea si-gnifica luogo , tìoi>e sono le acque*
Vers. g. Si adunino le acque in un sol luogo te. Dio aveadiviso le acque in due parti , come abbiarn veduto , lasciandonesopra la terra quel la porzione, ch'era necessaria a'suoi disegni:or questa egli comanda che si r iunisca in uà sol luo^o, onde !a

locum unum : et appa-reat arida. Et factumest ita.
io. Et vocavit Deusarìdam(i)ìterramì con*gregationesque aqua'rum appellavit maria.Et vidìt Deum , quodesset bonum,
n. Ei aiti Germinetterra herbam virentem^
in un sol luogo: e l'ari-da apparisca. £ così fufatto.
10. E ali' arida diedeDio il nome di terra , ele raunale delle acquele chiamò mari. E Diovide,che ciò bene stava.
11. E disse : La ter-ra germini erba verd<*g-
( i ) Job, 38. i. Ps. 62. 7. 88. 12. 100. 6.
terra rimasa a l i ' a s c i u t t o d i v e n t i v i s i b i l e . Ai con i ando di Dio i lmare lascia scoperte tu t t e quel le par t i de l l a terra, che Dio vol-le ebe fossero evacua t e , e va a r i u n i r s i in un sol luogo. Impe-rocché t u t t i i mar i ne l l a immensa ampiezza loro fanno un solmare, med ian te la c o m u n i c a z i o n e de l l ' uno coll'allro. Il mar Ca-spio, che solo potrebbe fare 'eccezione , dee aver comunicazioneocculta col l'Oceano, o col Ponto Eussino , la qual cosa rendesimanifesta dal vedere, come detto mare, r icevendo molli e gran-di fiumi, notì rigonfia perciò, nè inonda.
E 1' drìda apparisca. Conveniva perciò aprirede 'vast i seni,thè contenessero tutte il mare .alzare intorno ad e«*ft lesive ,e'dare .il pendìo a ' f i umi , perchè andassero a scaricarti «fil ma-re. Tutto questo in un momento fu fatto; ma tutto questo con-t iene i n f i n i t i miracoli delia onnipotenza e japierita del Creato-re. Imperocché, per tacere degli a l t r i , chi ha dato alle acquedel m a r e que l l a salsedine sì oppor tuna a preservar le dalla cor-ruzione; la quale corruzione avebbe portata la morte e la di-s t ruz ione a t u t t e le pa r t i della terra ? Chi allo stesso fine or-dini», che le acque del mare, mediante il (lusso e riflusso , inperpe tua ag i taz ione si mantenessero? Chi fissò ad esse que' ter-m i n i , che elle non ardiscono di trapassare g iammai? Vedi Jobxxxvin. » £ . , Proc. v j n . a y . 28. , ec.
la vece di arida 1' Ebreo propriamente dice asciugata , co-me q u e l l a che usciva di sotto le acque.
* L? arida. L' arido elemento.Vers. i i. La terra germini erba r,c. Fin qui la terra era sta-
la infeconda, e tale polca r imaners i , se Dio avesse voluto t-o.ii.Lezione i m p o r t a n t e pt-r gl i u o m i n i , aff inchè si avvezzino a r i-g u a r d a r e la sub b e n e d i z i o n e . d i Dio nume unica sortole di lui-

et facientem semen, etlignum pomiferumfa-ciens jructiim juxtagenus suum-, cujus se-men in semetìpso sitsuper terram. Et fa-ctum est ita.
12. Et pro tulit terra"herbam virentem , etfacientem semen juxtagenus suum \ tignum-que fac.iens fructum: etliabens unumquodquesementem secundumspeciem suam. Et viditDeus, quod esset bo-num.
giante, e che faccia ilseme, e piante fruttife-re , che diano il f rul losecondo la specie loro ,che in sé stesse con-tengono la lor semen-za sopra la terra. E co-si fu fa i to. '
12. E la terra pro-dusse l ' e rba verdeg-giante, e che fa il semesecondo la sua specie ;e le p i an t e , che d a n n ofru l lo , e delle quali o-gnuna ha la propria se-menza secondo la suaspecie. E vide Dio, checiò hene slava.
ti i beni conceduti all 'uomo. E ciò era tanto più necessario, per-chè dovea poi ven i r e no tempo, in cu i questa stessa t e r r a , laquale «li sua na tu ra non ha n i t r o che s t e r i l i t à , dovea da ' c iechi«omini adorars i , come una d i v i n i t à benefica, e come cspioo pro-dut l r ice di que.' ben i , de' qual i per sola bontà di Dio fu arric-chita.
Che faccia il seme, ec. Così Dio dà una specie d'immortalitàali' erbe , e alle p ian te , ponendo in esse i'i principio, code ri-prodursi , e, propagarsi ali' infinito.
Secando la specie loro. L' erbe e le piante, secondo questocomando di Dio, conserveranno in perpetuo la loro natura , etutta la loro in f in i t a varietà ; benché mescolati; 1' une colle al-tre in una medesima terra,non perderanno,nè a l tereranno giam-mai le specifiche lor qual i tà . Vi voleva perciò una sapienza , laquale tut te conoscendo le particelle e gli atomi della ter ra , edell'acque, secondo queste regolasse la tess i tura degli s t rumen-ti della nu t r i z ione e della vegetazione, onde dal medesimo suo-lo spuntassero , e si nutr issero erbe sì d i f ferent i nel colore, nelsapore , nella qual i tà delle foglie, ec.Lo stesso dicasi del le p ian-te. Ma qual dovizia, qual magnificenza di don! prepara Dio ali'uomo non solo per suo sostentamento , ma anche per sua de-lizia col crear tam' erbe e piaau fru t t i fere per lui ."' li Griso-

13.Et factam est ve-spere et mane die ter-tius.
\f\J)ìxitaulemDeus:•Fiant luminaria in fir-mamento coeli,et divi-dant diem , ac noctem,et sint (i) in jìgna ettempora et dies et an-nos.
13; E della séra edella mat t ina si compièil terzo giorno.
i4» E disse Dio : Sie-no falli i Jumina r i nelfirmamento del cielo, edist inguanoli di , e lanotte; e segnino le sta-gioni, igìorni e glianni.
(i) Ps. ioó. 7.
storno , e s. Ambrosio harm' osservato , che Dìo creole piantep r ima del soie e del le stel le , aff inchè la formazione delle stes-se p ian te non potesse a t t r ibu i r s i a l l ' i n f luenza del sole, o deglias t r i .
Vers. 14. e i5. / luminari nel firmamento del cielo ec Sem-bra v e r i s i m i l e , che in questa parola generale i luminari sienacomprese le s te l le , e ancile i piacel i ,• ma si descr ive più par-t i co la rmente la creazione del sole e de l l a i u n a , perchè e P unoe 1' al tra servono in tante guise a' bisogni del l 'uomo. Dio poneil sole nel f i rmanenlo del cielo in q u e l l a d i s t anza dalla terra ,che conveniva al bene degli uomini ; t a lmen te che nè p e r l atroppa vicinanza di lui ja terra fosse abbruciata, nè per la lon-tananza restaste sema il necessario calore. Questo immenso glo-bo di luce e di fuoco è per un milione di volte più grandedella terra.- e con tutta l'immensa quanti tà di materia, ch' egligetta da tanti secoli, non si vede in l u i d i m i n u z i o n e di sorteal-cuna, paragonando le più ant iche colle più recenti osservazio-ni: lo che è t an to più m i r a b i l e , quan to che sappiamo , oh' eglinon è un corpo solido e denso , ma come un abisso di luce.La luce , che di per sé è oscura, d i f l e t t endo a noi la luce delsole, si fa luminosa ella stessa. 11 cangiamento delle sue fasi sìammirab i le e sì ben regolato , e il volgersi , che ella fa a t to rnoalla terra, che ella ba per suo centro, dimostrano come per late r r a el la è fa t ta : quando ella è crescente, cont inua e a l lunga ilgiorno: previene il giorno, quando ella è scema, e quando è pie-na, lo raddoppia, facendo nella notte le veci del sole. Notisi cheil sole e la luna sono qui chiamati i due grandi luminari , quan-tunque e la luna sia minore assai de l le stelle ne l la luce e nellamassa, e alcune delle stelle uguag lino, e anche sorpassino il so-ie in grandezza: ma re la t ivamente a l l a loro s i tuazione , e a' loro«nletu sopra la terra gius tamente laScrittura dà tra tutt i i corpicelesti il principato al sole e alla luna.

16. Ut laceant in fir-mamento coeli, et il/M'minent terram. Etfa-ctum est ila.
iG.FecitgueDeusdtioluminaria magna: lu-minare majus, ut prae"esset diei : et luminareminus,ut praeesset no-eti : et stellas.
17. Et posuit eas infirmamento coeli, ut lu-cerent super terram»
18. Et praeessentdiei,ac noeti , et dividerentluffe m, ac tenebras. Etvidit Deus , quod essetbonum.
19. Et f actum est ve*spere et mane diesquartus.
16. E risplendano «eifirmamento del cielo, ei l l u m i n i n o la terra. Ecosì fu fatto.
io. È fece Dio due lu-minari grandi: il lumi-nar maggiore , che pre-sedesse al giorno ; e ill umina r minore , chepresedesse alla notte: ele slelie.
17. E le collocò nelfirmamento del cielo,affinchè rischiarasser laterra.
18. E presedesseroaldì, e alla notte , e divi-desser la luce dalle te-nebre. E vide Dio , checiò bene slava.
19. E della sera edella mattina si compièin quarto giorno.
Segnino le stagioni, i giorni, ec.lì sole e ja lana c'insegnanoa dis t inguere il di dal la notte, e insegnano a dividere il tempoin settimane, in mesi, io anni, osservando il loro corso.Forse a n -cora volle qui M o s è accennare , come il corso del sole e della}una dovea servire di poi a sognare i tempi e i giorni destinatiin modo speciale al culto di Dio.
Vers. 16. E le (telte.Quesie sono come tanti soli, ricche dellapropria loro luce: le più piccole SODO |>iu g r a n d i assai delia ter-ra, la quale è meno che un punto r iguardo a l l e maggior i : e l lesono anche innumerabili . Lo spirito umano si perde in conside-rando la sterminata mole di tali corpi, la distanza loro quasi in-f ini ta dalia terra, l 'inesausta luce, l 'ordine, e il concerto de'Jormovimenti , e domanda, a qual fine mai tanta magnificenza , elauta profusione? Dio solo , che conta il numero delle stelle, e

20.Di.rzV etiamDeus'.Prodticantacjuae repti-le anìmae viventis , etvolatile super terramsub firmamento coeli.
21. Creavilque Deuscete grandia>et omnemanimam viventem , at-que motabilem , quamproduxerant aquae inspecies suas , et omnevotatile secundnm ge-nus suum.Et vidìtDetis:quod esset bonum.
20. Disse ancora Dio:Producano Je acque irellili animati e viven-ti, e i volatili sopra laterra sotto il firma-mento del cielo.
21.E creò Dio i gran-di pesci, e tulli gli *»-nirnali v i v e n t i , e aven-ti molo: prodotti dalleacque secondo la lorospecie, e tulli i volati-li secondo il genere lo-ro. E vide Dio , che ciòbene slava.
ciascheduna di esse chiama nel suo proprio nome (P$. io3. ?..),Dio solo conosce tutt i i f i n i delle opere sue ; ma noi dobbiamoe conoscerlo per esse , e benedirlo.
Vers. 20. Producano l'acque i renili animati e viventi. Ret-tili si chiamano nella Sc r i t t u ra i pesci, perchè , generalmenteparlando , sono privi di piedi, e si strascinano sulle acque. Quial comando di Dio un popolo immenso di natanti riempie il ma-re: ques t i sono di specie inf in i te : i più piccoli non sono menoammirabi l i pella prodigiosa loro fecondità, e pella somma loroagilità e destrezza, che i grandi pella lor mole e pella loro forza.La manie ra , onde si mant iene in un elemento , dove nu l la na-sce , questa immensa popolazione, non dee recar mei.o di tnara-\iglia : i grossi d ivorano i piccoli , ma questi e mol t ip l lcano intanto numero , e son t an to lesti a l la fuga, e san cosi bene pertempo rifuggirsi ne'luoghi, dove per la bassezza dell' acque nonpossono andare i grandi , che e quest i t rovano a sufficienza persostentarsi , e quegl i a dispetto della crudel tà e voracità de' loronemici conservano la loro specie , senza cha appariste diminu-zioni". Tu t t i questi miracoli della provvidenza sono accennati daDavitkle, Pi. io3. a5. Quel m are grande, vastissimo^dove so-no rettili senza numero, animali minuti insieme co* grandi.
E i volatili sopra la terra. L'Ebreo e il votatile voli soprala terra ; ma nessuna varietà è per questo tra 1' originale, e laVolgata, ove in quello si supplifca P articolo, il quale, secondoil genio della l i ngua , di leggieri si omette, ed e suppl i to si n r l l 'Arabo , e sì ancor uè' LXX ; oude 4cvra uadurai; e; il velatile ,

2 2. Benc'ìix iti/uè eis,dicens : Crescite. 6 f mul-ti pi ic ami ni , et repletQacjna^ r.iaris : avesquemulùplicenlur superterram.
23. Etfactum est ve-spere ti 1 mane diesquintus.
2 4. D ixit quocjueDeus:Producattsrra animamv'wentem Ì77.gQ7isre suo;jumenta , et replilia, etbestias tarrae secun-dum species suas. Fa-ctumque est ita,
22. E li benedisse'di-cerdo: Crescete, e rnol-i i p l i c a t e j e popolate leacque del mare: e mol-l ip l i ch i r io gli uccelli so-pra la ter ra .
23. E della sera ecleiia ma l l ina si com-piè il qu in to giorno,
24. Disse ancora Dio:Produca la l e r r a anima-li v i v e n t i secondo la lo-ro specie ; a n i m a l i do-mestici, e rett i l i , e be-slie sa lva t i che della ter-ra secondo la loro spe-cie. E fa fat to così
che voli (opra la terra. Cosi a n i m a l i si d i f f e ren t i , i pesci e iv o l a t i l i , hanno comune l 'o r ig ino d a l l e acque de l mare per v i r t ù«li questa onnipoten te parola. La n a t u r a di q u e s t i è ancor piùnota all 'uomo,che quel la de 'pesci , e in essa i n f i n i t e sono le ma -r av i^ l i e , a l l e qua l i , perchè o r d i n a r i e e c o n t i n u e , assi poco si ri •i le t te , e con estrema i n g r a t i t u d i n e 1" nomo resta i n s e n s i b i l e gtanto numero di creature, ond'egli t an ta r i t r a e u t i l i t à e d i l e t t o ,e le qua l i ez iand i » son fat te per i s t r u i r l o . La b rev i t à , ch« io mison proposto , non mi permet te di s t endermi sopra ta l i cosequam' io amerei; ina non mancano au tor i e l i b r i da potere sod-d i s f a r s i in questa materia .
* Producano le acque i retili. I na t an t i .Vers .aa, E li benedisse dicendo, ec. Con questa benedizione
Dio <là a 'pesci e a g l i uccel l i la v i r t ù di r i p r o d u r s i ne ' loro p a r t in«r la conse rvaz ione de l l a loro specie.- con ques ta p rome t t e i l ivegl iare a l l a loro conservazione , e di p r o v v e d e r e al 1 o r o man te -triine.nlQ: Due patterò I t i si vendono dite denari; s ìin solo dìetsi non è dimenticato da Dio. Mai l . x. ?.().
Vers. ?4' Produca la terra ec. il m a r e e l ' a r i a e r ano «ià po-polati J i un immenso n u m e r o di c r e a t u r e ; v i e n e ora Dio a dare«le»l i a b i t a t o r i a l l a t e r ra .
diurnali domestici. Tale i: i l senso del l ' o r i g i n a l e ; e rum èd u b b i o , c h e lo stesso vogl ia s i gn i f i c a r s i uella Vogala colla paro-^

26. Et fecit Deus he-suas terrae juxta spe-cies suas , etjumenta ,et omne reptile terra ein genere suo. Et viditDeus, quod esset bo-num.
25, Et alt: Faciamusliominem ad ( i } imagi-nrim et similitudinemnostram ; et praesitpi-scibus maris, et volati'Lìbus eoe li, et bestiis ,universaeque terrae ,omnique reptili , quodmovetur in terra.
26. E fece Dio le be-slie salvatichedella ter-ra secondo la loro spe-cie, e gli animali dome-stici , e tulli i rettilidelia terra secondo laloro specie. E vide Dio,che ciò bene slava.
26. E disse: Faccia-mo l'uomo a nostra im-magine e somiglianza;ed ei preseda a' pescidal mare,e a'volatilidelcielo, e alle bestie , e alutta la terra e a luttii rellili , che si muovo-no sopra la terra.
Ci) Infr. 5. i. g. 6. i. Co& 11. 7, Coloss,3. io.
la jumenta;\zle a dire tutti quegli animali.cbeservono all'uomo,e a lui obbediscono, e Io aiutano nelle fatiche, gli somministra-no,onde sostentarsi , e vestirsi, e supplire agli al tr i bisogni dellavita. E certamente non altro, ebe la parola e l'ordine del Crea-tore potè r ende re doci l i e obbedienti ali ' uomo questi animali ,dc 'quali a l c u n i lo superano grandemente nel la forza, mentre al-tri ve n' li 3 non così robus t i , i qua l i 1' uomo non può in veruumodo addomest icare g iammai , nè r i da rg l i al suo servizio ( Job.xxxix. 5 q, io. 11. ) ; perchè Dio ha voluto , che a tal paragonericonoscesse 1'uomo a chi egli sia debitore de l la subordinazione,che most rano a lu i gì i a l t r i an ima l i , e del l 'ut i le , ch'è! ne ricava.
E i re IL! i.\ alt a dire t u t t i quegli an imal i , i qual i si strascina-no sopra la t e r r a , perchè o sono affatto senza piedi , o gli hannotanto corti, che poco, o nul la si alzano sopra la terra.Tutto que-sto s ' intende da noi co' terraini generali , di serpenti, e d'insetti.
Vers. 9.5. E Dio vide, ec. Quest'approvazione di Dio è lo stes-so , che la sua benedizione , e ha i medesimi effetti riguardo atut to l ' i n f i n i t o popolo di an ima l i terrestri.
Vers. 26. Facciamo V uomo. Ma qui si cnmbia linguaggio i eDio, il quale finora ha fatte tante e sì grandi cose colla semplicesua parola , si d i spone adopererò egli stesso, per cosi dire , di

a?- Et creavit DeusJiomìnem ad ìmagìnemsu arniti) ad imagìnernDei creavil illum : (2)masculum, etfoeminamcreavit eos.
27 . E Dio creò 1' uo-mo a sua somiglianza :a somiglianza di Diolo creolo creò maschio,e femmina.
(1) Sap. 2» 23. Eccl. 17. i.(2) Mtìj/^. 19. 4-
sua roano. Sembra (dice «aa Gregorio Nissenoj che Dio a guisadi pittore rappresent i a sé stesso l'idea, ch'è! vuole espnmere,eat tentamente consulti l 'originale e le t to per suo modello, men-tre Alce: facciamo P nomo. Egli avea creato i l mondo per Pnomo ; vuole adesso crear l'uomo per .sé: v u o l e adunque crear-lo dotato di senso e di ragione , e capace perciò d' in tendere ilsuo creatore, e ammirar le opere di l u i , e per esse ringraziarloe lodarlo. Tutta la Chiesa in queste parole : Facciamo . . . anostra ec. ha riconosciuto sempre le d i v i n e Persone suss is tent iio una perfe t t i ss ima un i t à .
4 nostra immagine e somiglianza, li» stessa cosa significanoqueste due parole immagine e somiglianza; ma unite insiemedenotano una immagine perfet ta quanto mai fare si possa. Vedicap. v. 3.: onde potrebbe t r adur s i a nostra immagine umilissi-ma. Or 1' uomo è i m m a g i n e di Dio secondo la a n i m a incorporea,immortale , dotata d1 in te l le t to e di volontà e di l ibero arbitr io,e capace di sapienza, di v i r t ù , di grazia e di beat i tudine , cioè divedere, e godere Dio. L'uomo adunque è immagin di Dio secoq-«1o quegli attributi, |che da lui si comunicano alle creature in-telligenti. E questa immagine, o somiglianza coq Dio è talmentenaturale ali' uomo, ch'ei non può perderla senza perdere la suanatura. Ben potè questa immagiue oscurarsi, e deformars i per lopeccato;'ma cancellarsi, o togliersi non potè mai. Vedi Angiut.Retract\ lib, 11. cap. 24, Nel corpo stesso dell 'uomo riluce qual-che cosa di straordinario e di grande. La sua figura è fatta permirare il cielo, a differenza degli al tr i animaii,che son tu t t i pie-gati verso la terrjuEgli ha due manioche sono s t rument i pr imari idi sua ragioue e di sua libertà:nella sua faccia, e principalmen-te ne'snoi occhi trasparisce uà non so che di spiri tuale(per cosìdire), e di divino.
Ei presedà a1 pesci ec. L'autorirà e il dominio sopra tutti glianimali è dato ali' uomo, come un d i s t i n t i vo e una prerogat ivadella sua dignilà.Egli,secondo l'espressione di *• Basii io,aacqueali' impero, ma questo impero fu limitato assai, e r is t re t to , al-lorché egli si avvili « si degradò col peccato. Tutto obbedì e&erYi ali' uomo fino a Un lo ciie i' uomo fu obbediente a DÌO.

ìi8. Benedixitque il'iis Deus , et alt : (i)Crescite., et muldplìca-mini, et replete terram,et subjicite eam: et do'min amini piscibus ma*ris, et volalilìbus coeli,et universis animanti-IjuS) quae moventur su-per terram.
sB.E benedisseli Dioe disse:Crescetes e mol-tiplicate : e riempile laterra, e assoggettatela :e abbiate dominio so-pra i pesci del mare : ei volatili deH'aria,e tut-ti gli animali , che simuovono soprala terra.
(i)/»/r.8. 17.9.1.
Una immagine di questo assoluto dominio l'ha Dio fatta vederein que'Santi sì dell' aotico, thè del nuovo Testamento, i qualiebbero docili al loro cornando e i muti animali, e le bestie piùferoci E'comuo sentimento de' padri, che gli animali, che souoadesso contrar i i ali' uomo , non lo erano nello stato dell' iuuo-cenza.
* Ed ei presieda. L' Ebr. in plurale dominio.Vers. 27. Crto V nomo a tua somiglianza^ a somiglianza ce.
Ripetizione,la quale nella bocca di Dio denota ed e&alta semprepiù la grandezza di questa sua creatura, affinchè questa dal suoFattore medesimo impari a fare una giusta stima de' doui, ondeegli la ricolmò, e ad averne tut tala gratitudine.
Lo creo maschio , e femmina. Dio creò 1' uno dopo 1' altro idue sessi, come vedremo nel capo seguente : imperocché qui s iriferisce in compendio quello che in detto luogo più ampiamen-te è descritto.
Vers 28. Benedisseli. . . Crescete^ e moltipllcate^ ec. Dio pro-mette «11* uomo e alla donna la fecondità, la quale, supposta au-che 1* unione de' sessi, è sempre un dono del Creatore , e uneffetto di questa benedizione. Non si ha qui adunque (checchédicano gli empi, e gli eretici) un comando, ma un' approvazionedel mat r imonio , per mezzo del quale la specie umana si conser-vi , e si propaghi. Fedi Augittt. de cìv. lib, xxi. e. 22. Notisi ,che le slesse parole sono dette a' pesci e agli uccelli nel vers.?.?.. , a' quali nessun dirà , che sia perciò stato dato un comando.
E assoggettatela. Occupatela come di vostro dominio, e col-tivatela.
Abbiate rfomim'o sopra i pesci .. . volatili ec- Non v'ha dub-bio, che queste parole unii diano ali' uomo potestà sopra tu t t igli animali per farl i servire a* proprii usi e bisogni, e per cibar-&ene ancora quando che fosse.
* ^>iogge»a(«ia.Faicvela sorella.

29. Dixitque Deu.y :Ecce dedi vubis omnemhe roam afferentem se-men super terram , etuniversa Ugna, quaeìiabent in semetipsisseme ?i te m generis sui ,(i) ut sint vobis in e-scam.
So. El cunctis ani-mantihus terrae, omni-que volucri coeti, etuniversis^ quae moven-tur in terra , et in qui-bus èst anima vwsns ,ut habeant ad vescen-dum. Et faclum est ita.
o i.( 2 ) FiditqueDeuscunctaì tjuaefecerat: et
29. E disse Dio : Eoco ch'io v'ho da to tu l -te l'erbe, che fanno se-«ne sopra la lena.e tul-te le piante , che hannoin sé stesse semenzadella loro specie , per-chè a voi servano dicibo.
3o.E a tutti gli ani-r*»ali della terra,ea lul-ti gli uccell i dell 'aria, ea quan t i si m u o v o n osopra Ja terra an ima l iv iven t i , aff inchè abbia-no da mangiare. E cosìfu fallo.
3i. E Dio vide tut tele cose , che avea fatte, -
(i)/«/r.9.3.(^2) Eccl. 69. 21. Mare. 7. ^7.
Vers. 29, É<:co, che io v'ho dito mile l'erbe ec. QuantunqueDio abbia fatto i' uomo padrone della vita di tu t t i gli animaliper trame i vantaggi, ch' essi possono somminis t ra rg l i ; contut-tociù concedendo adesso a lui'per suo cibo l'erbe" e le f ru t ta , ci dàtutto il motivo di credere, che dalle còrni drg'i animai! si asten-nero gli uomini fino a quel tempo, in cui l 'us>.j di esse fu espres-samente conceduto, come vedremo, Tale è il sentimento comunede* padri e degl' Interpreti.
Vers. 3o. E a tutti gli animali . . .uccelli ec. L'uomo è quiistruito a non fare gran caso di que' ben*, ebe la Provvidenza bafatti comuni anche a' piìi piccoli e negletti animal i , a non affan-narsi di soverchio per timore di restar privo di quel sostenta-mento, che Dio ha preparato io abbondanza anche per quel i i.Mirate i volai ili deW aria che non seminano, nè mtelono , ?/«chiudono ne1 granai le biaderò il Padre vostro celeste li paste.Non siete voi da più di loro? Mati. vi. 26.
Ver». 3i. Ed erano buone assai Dio aveva approvata ciascunaparte dell'universo da sé crea ta ; ma t u t t o insieme il complesso,la concatenazione, per eoàljJ.ire, C l'ordina merita una parti tola-

erant valete bona&tfa-cium est vespere et ma-ne dies sextus.
ed erano buone assai. Edella sera e della mat-tina si formò il sestogiorno.
CAPO II.
1)io, avendo compiuto in sei giorni il suo lavoro jriposa il settimo giorno , e lo benedice . Pone/ uomo nel paradiso ornato di varie piantefruttifere, e di correnti. Forma dalla costadell* uomo Èva per suo aiuto ; e istituisce ilmatrimonio.
i. Igitur per fedìsunt cotli, et terra, etoninis ornatus eorum,
i. ComplevitqueDeasdie septimo opus suum,quod fecerat; et (i) re-
1. 1 urono adunquecompiut i i c ie l i , e la1 e i ra , e tul io i' o rna toloro.
2. E Dio ebbe com-piuta il settimo giornol'opera, ch'egli avea fat-
(i) Exod, 20. 11. 3i. ij.Deut. 6. 14. Hebr.4-4-re approvazione, e più speciale. Erano buone assai. Così si de-guasse 1' uomo dì dar talvolta un 'occh ia ta alle in f in i t e maravi-glie fa t te per lui da Ojo, affi n di eccitare la & u a riconoscenza eil suo amore.
Vers. i. E tulio l'ornato Joro.Tutte le creature, ebe abbellì'scono e riempiono i cieli e la terra.
* Tutto 1' ornato loro. L' Ebr. il loro esercito; le loro schie-re: la lor m i l i z i a .
Vers. 2. Ripotò il settimo giorno.Scrive s, Agostino seni.277.Che Dio riposasse da tutte le opere sue, non altrimenti sideeintendere , se non che vcrun' altra natura non fu di poi for-mata da Z«i, sensa però ch? ei lasciasse di reggete , e di con-servare tjucllc che avea già fatte. Dio sempre immobile e iru-oau labile in sé stesso produce tutt i i cangiamenti, eli» succedono

fjuievit die septìmo aiuniverso opere , quodpatrarat.
3. Et benedixit dieideprìmo^ et sancùficavitillum: quia in ipse ces-saverat ab omni operesuo, quod creavit Deusut fa ceret.
l^.lstae sunt genera-tiones coelió, et terrae,quando creata sunt indie , quo fecit DominusDeus coelum , et ter-ram.
ò.Et omne virgultumagri,antequam orireturin terra , omnemqueìterbam regionis.prius-quam germinarci: nonenim pluerat DominusDeus super terram \ et
la : e riposò il setlimogiorno da tutte IH ope-re , che avea com più le.
5. E benedisse il set-timo giorno, e lo santi-tìcò:perchè in esso aveariposato da tulle le o-pore, cheDio avea crea-te e fatte.
4 Tale fu la originede! cielo , e della terra ,quando 1' uno, e l 'altrafu creala nel giorno,incui il Signore Dio feceil cielo, e la terra.
6. E tulle le piantede' campi , prima chenascessero sulla terra ,e . lu l te l 'erbe della Ur-rà, prima che (da essa)spuntassero : imperoc-ché il Signore non avea
nella natura; opera perpetuamente, e a tutte le operazioni con»corre delle sue creature. Sopra questo misterioso riposo di Diovedi Heb, iv, 3. ec. e le aouotazioui.
V»rs . 3. E benedille il settimo giorno, e lo santifico. Questamaniera di parlare sembra assai favorevole alla opinione di qi>e-{•V Interpret i ant ichi e moderni , i quoli hanno credulo, ,:be iloda quel tempo rimanesse il sabato assegnato da l'io a) suo cuhoin memoria del benefìcio della creazione, e ebe come lale fu os-servalo e ooorHto da' Gglioli di Adamo.
Vers. 4- e 5. Fece il cielo , e la urrà, e tutte le piante de1
campi, prima che ec. Rafferma la desciizione, ebe ci ha datadella creazione del cielo e della terra ; e aggiunge, che, r i g u a r d o«Ile piante e all'erbe della campagna, elle ancora furono iriirue-«liatameute prodotte da Dio, e ebe nessuno dee figurarsele comeuscite fuori dalla terra ; mentre questa non avea ancor 1' uomo,che la coltivasse, uè pioggia dal cielo *r* caduta ad irr igarla efecondarla. Muse va iocouiru a uu errore fucile ad insinuarsi uè 1-

homo non erat, qui ope-raretur terram.
G.Sedfons ascende-baie terra irrigati s uni-versarti superficiem ter-me*
mandalo pioggia soprala terra ; e uomo nonera, che la coltivasse.
6. Ma saliva dalla (er-ra una fonte ad innaff ia-re la superficie dellaterra.
le ment i degli uomini, ed è di riguardare la terra come principiodelie creature ond'ella è ripiena. 1 filosofi del l 'Egi t to a l l 'umidocalore del la terra a t t r ibu i rono stoltamente la prima origine dellecose terres t r i .
Vers. 6 Ma saliva dalla {.erra una fonte ad innaffiarti ec.La voce ebrea invece dì fonte potrebbe t r a d u r s i vapore; ondever rebbe ad in tenders i , come i l sottile umore a t t ra t to per forzadel sole d a l j a terra e dal mare, e addensato dal f reddo dellanotte, sc iogl iendos i q u i n d i iq rug iada ,dovea servi re a mantenere1' u m i d o sopra la terra . I l Caldeo in cambio di vapore mette nu-vola; la quale è un aggregato-di addensat i vapor i . Questa sposi-zio ne però cerabra, che mal convenga con quello che dice&i nelver»o precedente , ed anche coli' i n t enz ione di M osé , il quale( come abbiam detto ) da voluto farci sapere, ebe Dio era statol ' i m m e d i a t o fattore delle piante e dell' erbe, ond' era. allor ve-sti ta la t e r ra , senza che al la produzione di esse potesse concor-rere o la terra stessa, che mancava di umore, ovver l'opera del 1*uomo , il quale non fu creato , se non dopo di esse, Per la qualcose var i i dotti In terpret i ,anche Cattolici , intendono r i pe tu t a neltesto or ig ina le al pr incipio di questo verse t to la negazione po-sta nel precedente , onde si dovrebbe t r adur re in tal guisa : ILSignore non avea maridato pioggia sopra la terra , e uomonon vi era, che la coltivasse (non) saliva dalla terra vapore,che innaffiasse, ec .Ques t ' In t e rp re t i provano molto bene , chemol te vo l t e nell7 ebreo si ornmette in un membret to seguentela oegativ.1 posta in quello che è i n n a n z i : la quale perciò deeallor so t t i n t ende r s i , Questa versione fa un ott imo senso*, men-tre così Mosè v iene io queste u l t i m e parole ad escludere anchele rug iade , togliendo i vapori; i qual i alzatisi dalla terra , ad-dens.nisi pel freddo notturno,scendessero ad umenta re la super -J i c i o del la medesima terra. Imperocché sappiamo, che in moltiluogh i , dove rade sono le pioggie, suppliscono al biioguo dellacampagna le ragade e le guazze abbondanti,

7- Formavit igiturDominus Deus homi-nem de timo terrete , etìnspiravìt in faciem e-jus spìraculum vitae :et (i) factas est homoin animam vìventem.
7- II Signore, Dio a-dunque formò 1* uomodi fango della terra , egì' ispirò in faccia unsoffio di vila : e 1' uomofu fatto anima vivente.
(i) i. Cor. 16. 45.
Veri, 7. Dio adunque formò ce. Torna Mosè a spiegare più«Stintamente la creazione dell ' uomo. Egli ci r a p p r e s e n t a Diocreatore , il quale colle proprie sue mani forma di umida terra,e di polvere una statua, la quale, benché ancor p r i v a di molo,e di v i ta , poria già nel la sua figura, e soprattutto nel!' appl ica-zione del grande Artefice, sicuro ind iz io di dover essere qualchecosa d< grande e di sublime. Imperocché questa statua ( d i ceTer iu l l i ano) è formata non dalla imperiosa parola, ma dal-la stessa benefica mano del Creatore.
E gì1 ispirò in faccia ec. Sembra evidente da queste paro-le, che Dio comunica a l i ' uomo, per così dire, una porzione delsuo stesso essere, facendogl i parte del suo proprio spiri to-, on-de 1' i m m o r t a l i t à de l lo s p i r i t o umano, i nd i ca t a da Mosè in mol-ti a l t r i I n o i > h i , v iene a d i m o s t r a r s i in queste slesse parole. Que-sta veri tà , che P a n i m a i n f u s a da Dio nel l ' uomo sia di un' ori-gine tut ta divina, e per«;iò imma te r i a l e e immor ta le , ques ta ve-rità non potè essere di poi ta lmente offuscata da l l e t enebre delGen t i l e s imo , ebe non si t rovi r i p e t u t a e ce lebra ta presso i fi-losofi e i poeti pagani. L' Apostolo del le Genti cito di un an-tico poeta q u e l l e parole : Di Itti eziandio siamo progenie. At-ti xvn. 28.
E V uomo fu fatto anima vivente. Il soffio di Dio , o sia 1'anima , che Dio un,i al corpo del i ' uomo , fu per lu i il princi-pio di sentire, di rag iona te , e di v ivere . Questa un ione di duesostanze tra loro si d iverse , materiale l 'una, I' a l t r a sp i r i tua le ,questa u n i o n e è una del le maggiori merav ig l ie , che sieno ne l l anatnta. Dio solo potè e f f e t tua r l a colla sua onnipotenza ; e 1' uo-mo può ben s e n t i r l a , ma non comprenderla,
* Formò 2' nomo di fango della terra. L' Ebr . formo 1' uo-mo di polvere della terra.l LXX. presa della polvere del ia terra.
* L1 nomo fu fatto in anima vivente: d i v e n n e an ima to e vì-vente : ebbe anima e vi ta . I l Caldeo porta.' d ivenne ip i r i to ra-gionatore.

8. Pian Laverai autemDominus Deus par adi-sum, volu.plaii$ a prin~ci piò', in quo posuit ho-minem, cjuem formale-rat.
y.ProduxiìfjueDomi-Jius Deus de liumo om-ne lìgnum pfi'crum vi-su , et ad vescendum
8.0r il Signore aveapiantalo da principioun paradiso di delizie ;dove collocò 1' uomo ,che avea formalo.
9. E il Signor Dioavea prodotto dalia ter-ra ogni sorta di piantebelle a vedersi, e di f rut-
Vers. 8. Or il Signore avea piantato . . . un paradiso (o sìaun orto) di delizie, ec, L'Ebreo può anche £ rad» rsi: avea pian-tato un paradiso in Eden a levante, o sia dalla parie di le-vante, e cosi l ' intesero i LXX. Eden è il nome propr io dal luo-go, dove Dio avea p i a n t a t o il pa rad i so : e questo luogo era ver-ro 1 ' o r i e n t e , o si p renda questa d e t e r m i n a z i o n e in senso gene-rale, e asso lu tamente , ovvero r i spe t to al luogo, dove Mosè scri-veva questa storia. La t r a d u z i o n e però d e l l a nostra Volgatala-chè diversa , sta beniss imo cof tf ls to o r i g ina l e . Quella parola daprincipio d iede occasione agl i Ebrei , c i t a t i da s. Girolamo , dicredere, ebe il paradiso t e r res t re fosse stalo creato pr ima de)-la terra/ ma la maggior parte de' padri , e dell ' Interpret i ant.'-cbi e moderni lo credono formato nel terzo giorno, e alcuni po-chi subito dopo la creazione del primo uomo-, perchè in fattiMosè ci dice, che per faroe abitazione dell'uomo avea Dio pian-tato questo paradiso.
Vers. 9. E Dio avea prodotto eo, Vuol dire, che Dio avear i u n i t o m questo luogo tu t ta la magni f icenza e vaghezza dellepiante, sparse da lu i nella creazione per t u t t a la terra.
L> albero eziandio della vita. Vale a dire una p i a n t a , i cuif r u t t i gustati di tanto in tanto avrebbero servito a conservare lav i t a , e a tener sempre lon tana la mol te ; i f r u t t i delle a l t rep ian te doveano se rv i r e al l 'uomo di n u t r i m e n t o ; i f r u t t i di que-sta s e rv ivano a mantenere 1' uomo in una p e r p e t u a giovinezza,
U albero della fcienza del bene , e del mais. Così fu no-minata da Dio questa seconda pianta , quand' egii mostrandolaal p r i m o uomo g l i p ro ib ì di g u s t a r del f r u t t o di essa: e la ra-,gion di tal nome si è la de te rmina tone fa t ta da Dio d i ' conse r -vare, ed accrescere la g ius t i z i a , e in felicità de l l ' uomo , ove ,
de' f r u t t i di quella pianta ; e di pun i r lo di morte , ove disob-bedieute ne avesse mangia to . Q«est' albero ailu nque dovea f<irseiHire alì' uomo la dii lVrenia, che passa tra 1' obbedienza , e la

suave : lìgnum etiamvitae in medio par ad i-*/, lignumque scientìaeòoni et mali.
io. Et fiuvius egre-diebatur de loco volup-
lo dolce a m a n g i a r e , eT albero eziandio dellavita in mezzo a) para-diso , e P albero del lascienza del bene e delmale.
i o. E da queslo luo-go di delizie scaturiva
disobbedienza a Dio ; tra la fe l ic i tà promessa ali ' obbedienza, el ' in fe l i c i t à , nel la quale p rec ip i tò l ' uomo disobbediente.Questoalbero in effetto ci privò di t u t t i i beni , e ci sommerse in uàabisso di mali, e ci fece per una t r i s ta sper ienza conoscitori delbene e del male. Dio non avendo espressa la precisa speciee qua l i t à di queste due piante, son perciò varte ed i n u t i l i tu t teìe congetture deli' umana curiosità. A noi dee bastar di sapere,che 1' una e l ' a l t r a pianta era buona di sua na tura : che la v i r t ì idella p r ima destinata a serbar l 'uomo immorta le , era un effettodella libera volontà del Creatore; ebe la proibiz ione di man-giare de'fiulti della seconda fu una r i s e rva del supremo Padro-ne , che volle ( come notò il Crisostomo ) serbare intero il suodominio sopra dell' uomo , e fargli sentire, come di t an t i beni ,onde si vedea c i rcondalo , egli tra non il signore, ma un sem-plice u s u f r u t t u a r i o , hom. \6.in Gen.
* Avea prodotto dalla terra. Da quella terra , cioè dalla ter-ra del Paradiso.
Vers. io.fi da questo luogo .. , scaturiva ec. In piìi luoghidella Scri t tura si fa menzione del paese di Eden , lieti, xxxvn.za., iv. /?«g. XYUI. 11. xix. 12. i3. xvi. 6. 9.4. Ezech. xxvu '28.Da questi luoghi ventiliamo a conoscere, che lo stesso paese do-vea esssere vicino ali' Armenia , e al le sorgent i dell' Eufrale edel Tigri; qu indi è, che presso a' monti dell' Armenia han col-locato il paradiso terrestre va r i i autor i moderni , dove h a n n ocerta loro origine que'due f i u m i , N o i seguiremo questa opinione,rome quella che sembraci atta assai megl io d' ogni al t ra ad eva-cuare le difficoltà, che in sì a r d u a mater ia s ' incontreranno.
Scaturiva un fiume ,. , il quale di là si divide ec. Dal cen-tro del paradiso sgorgava una sorgente, la quale spa r t ivas i inquattro bei canali ad innaff iare ( per quanto sembra ) i quat trola t i del paradiso. Questi quattro canali , scorrendo dipoi pellevicine terre, crescevano in quat t ro gran f i u m i , che sono il Ti-gri, l 'Eufrate , e i) Pbison, e il Gehon. Cosi stava certamente lacosa, a l lorché Dio collocò l'uomo nel paradiso, e cosi dovea es-»ere aì tempi ancor di Mosè , e forse anche molli secoli appres-

talis ad irrigandumparadisum , qui indedivi di tur in quatuorcapita.
i i . Nomen (i) uniPhison\ipse est qui cir-cuii omnem terramile-vilath, ubi nascitur au-rum.
un fiume ad innaff iare Hparadiso , il qual (fiu-me ) dì là si divide inquattro capi.
il. Uno dicesi Phi-son; ed è quello 3 chegira a t torno il paese diHevìlath, dove nasce 1'oro.
(i) Eccl 24.35.
so redi Kccl xxiv. 35. 36. 3j. Ma non è possibile a noi , nènecessario a l i ' avve ramen to della storia di Mosè, il mos t ra re a-desso ueli' Armenia quattro fhimi nascenti , da una stessa sor-
di paese qua t t ro fiumi s imi l i ai descrit t i da Mosè, i quali pote-rono nascere un di da uno stesso fonte , benché ciò non sia alpresente. Che il Tigri el 'Eufrate avessero un dì comune l'origi-ne , il t roviam ripetuto in molti au to r i profani assai posterioria Mosè : tua egli è certo, che in d i f fe ren t i luoghi nascono ades-so que'fiumi , lo che ci dà luogo di poter dire, che anche deglialtri due (che noi crediamo essere il Fasi, e 1' Arasse ) cangia»giata sia la sorgente» Simili strabalzameli di f iumi , e di laghi,cagionati da' diluvii, da' tremuoti, e dalle vicende del tempo ,leggoosi ne l le storie, e nelle relazioni antiche, e moderne. Eforse Dio co l lo slesso cangiamento operato nell' origine di que-sti f i u m i vo l l e abol i re la memoria di Un luogo , in cui l'uomoavea stranamente abusato de' 6Uoi benefizii.
Vers. i i . Uno dicesi Phison. Questo abbiam detto essere ilFasi, il quale nasce u t - l i 'Armen ia , e si scarics» nel Ponto Eus-sino. Egli è il fiume più grande s famoso che abbia la Colchice,paese celebre una volta pel suo gran commercio. Vedi Plin.Ub.vi.cap. 5,
Egli gira per tutto il paese di Hevilath, dove nasce 1* oro,Nel rapo x. vedremo un Hevilcth figliuolo di Ghus , e un al-tro Hev i l a th figliuolo di Jectan. Ma o sia da uno dkquest i due,o da un terzo a noi ignoto, che abbia preso il suo nome il pae-se bagnato dal Fasi, questo paese era vicino al i* Armenia, e al*le sorgenti dell' Eufrate e del Tigri : la Colchide era in gran-dissima rinomanza per la qualità e là bontà dell'oro , onde ar»ricchivanla i suoi fiumi e torrenti , Ne abbiamo una prova nel'la favola del vello d' oro, Tedi Plin lib. zS.cap. 3.

12, Et auriim terraeillius optimum eó't: ibiinvenìlur bdellium } etlapis onychinus.
13. Et nomen fluviisecundiGehondpse est,fjuicircumit omnem ter-ram AEthiopiae.
14- Nomen vero flu-minis terdi Tigris-.ìpsevadit coìitra Assyrios.
12. E 1' oro di quelpaese è ottimo: ivi tro-vasi il bdeliio, e la pie-tra oniche.
13.-E il nome del se-condo fiume è Gehon :ed è quello che gira pertutta la terra d'Etiopia.
14. 11 nome poi delterzo fiume è Tigri,che scórre verso gli As-
Vers. i?.. Vi si trova il bdeliio. La voce ebrea debolah èpochissimo conosciuta. L'Arabo, il Siro, e molt i a l t r i Interpre-ti credono, che s ignif ichi la perla : e benché non si peschinoin oggi perle nel Fasi, ciò non farebbe dif f icol tà ; perchè può«ssere accaduto , ebe o sìeno state esaurite , o non se ne facciaricerca.1 oltre di che se ne pescano nei mari v ic ini ; lo che servea spiegare 1 ' espressione di Mosè. Ma tenendosi alla versionedella Volgata, il bdeliio è una specie di gomma odorosa, di cuiP/m. lib. xn. cap. g.
Ver». i3, Jl nome del seconde fiume e Gehon. L'Arasse na-sce nell' Armenia sul monte Ararat , in distanza di 6000 passidall'Eufrate, èva a scaricarsi nel mare Caspio. 11 nome di Gehonconviene benissimo a questo fiume , come quello che denota 17
impetuosità della sua corrente; la quale impetuosità fu dimo-strata da Virgilio , che scrisse lib. vin. JEtieid.
Il ponteDa dosso si scotea P armento Arasse.
Ed e quello che gira attorno alla terrei d^Etiopia. Ovvero,come ha Vf^t eo: attorno alla terra di Chus.Quesie parole fan-no una grave difficoltà. Non possiam negare, che o rd ina r i amen tenelle Scr i t ture la terra di Chns sia l'Etiopia , e tale è anchel ' interpretazione de'LXX, e di S.Girolamo. Contuttociò il cele-bre Bochart ha dimostrato , c h e fa d' uopo riconoscere nelleScri t ture più d' un paese, ebe abbia portato il nome di Chus ,per essere stato abitato e popolato da' discendenti di Chus fi-gliuolo di Cliam. Tale direm che fosse questo paese bagnatodall' Arasse, conforme scrive Mosè. E non è forse improbabile ,ebe questo nome di Chus siasi con qualche al terazione conser-vato nel nome degli Sciti, i qual i , secondo varii antichi storici,abitaron da prima preso 1' Arasse. Imperocché Chus secondo 1*inflessione del dialetto caldeo, dicesi Cbut, onde poi i Cuthi ov-vero $•!! Sciti. Fedi il Calmet.

"Fluvius autem quartusipse est 'Euphrates.
16. Tulli ergo Domi-nus Deus hominem, etposuit eum in paradisovoluptatis , ut operare-tur et custodirei illum.
16. Praecepitque eidicens: Ex omni lignoparadisi comede.
17. De ligno autemscientiae boni et maline comedas : in quo-
siri i . E il quarto fiumeegli è 1' Eufrale.
i5. 11 Signore Dioadunque prese 1' uomo,e lo collocò nel paradi-so di delizie,affinchè locoltivasse e lo custo-disse.
16: E gli fè comando,dicendorJVlangia di tut-te le pian le del paradiso.
17.Ma del fruito dell'albero della scienza delbene e dèi male non
Vers. 14. Il Tigri, che scorre verso gli Assiri!. L'Assiria ,osia il paese di Assur , per consenso de' più a n t i c h i s c r i t t o r i , eradi là dal Tigr i ; e ciò c r e d i a m o che a b b i a v o l u t o s i g n i f i c a r e Mo-sè. La sorbente di questo fiume è n e l l a g r a n d e Aru ieu i a . VediPlin. lib. v i i . cap. ?..
Il (juaria fiume egli è P E ufrate. Per t e s t i m o n i a n z a di Stra-bene e di Plinio, ques to fiume (i l q u a l e n e l l e S c r i t t u r e è de t tosemplicemente Ìl fiume, ovvero il gran f i u m e ) nasce sul monte
• Abo, o sia Aba nel!' Armenia ;Vers.15. li-Signore Dio adunque prese l'uomo, e lo collocò
nel paradiso ce. L 'uomo a d u n q u e fu creato fuora del paradiso,aftinché riconoscesse come un favore e benefizio di Dio , e noncome una cosa d o v u t a 'a l la sua na tu ra , la sorte d' avere un al-bergo cosi felice.
dffinche lo coltivasse e lo custodisse. Dio non vuole , che1' uomo, benché p r o v v e d u t o di t u t t o , e f o r n i t o d' ogni sorta d idelizie, passi i l suo tempo i n una mol le oz ios i t à . Egl i dee occu-parsi ne l la c u l t u r a del paradiso per conse rva rne 1' a m e n i t à , egua rda r lo dagl i oltraggi deg l i a n i m a l i : ma la sua occupaz ionesarà senza affanno e s tanchezza; sarà un onesto esercizio , nonun faticoso l avo ro Sarà egli uno strano pensamento ('dice s.Agostino) il credere, che 1* uomo collocalo nel paradiso do-vesse esercitare l'agricoltura non con travaglio di servo, maper onesto piacere dell' animo ? Vedi anche il Crisostomo ,hom. 14. in Gen.
Vers. 17. Non mangiarne: imperocché in qualnnqite giornoin ne mangiei-ai) in.iubiiatamente morrai. Dio ( come uo iò s.Bds i l iu di Selcucia) affile, per cos'i d i re , ali' albero queslo co-

cumque enim die come-deris ex eo, morie mo-rieris.
18. Dixit quoqueDo-minus Deus : "Non estbonum , esse liominemsolum*, faciam us ei ad'jutorum simile sibi.
19. Formatis igitur,Dominus Deus, de hu~mo cunctis animantibusterras, et universis vo-latilibus coeli, adduxitea ad Adamjitvideret,quid voc&ret ea : omneenim , quod vocavit A-
mangiarne : imperoc"chè in qualunque gior"no tu ne mange ra i , in-dub i t a t amen te morrai.
18. Disse ancora Dio:Non è bene, che l'uomosia solo: facciamogli uàa iu to , che a lui rasso-migli.
19. Avendo adunqueil Signore Dio formatidalia terra tulli gli ani*mali terrestr i , e lutt igf i uccelli d e l l ' a r i a , licondusse atlAdamo,per-chè ei vedesse il nomeda darsi ad essi:e ognun
mandamento; Egli esige dal l ' uomo obbedienza , e quanto siagrande e im por laute questa v i r i l i , e come da sé sola bast i a te-ner 1* uomo unito con Dio , gliel fa conoscere con prescrivergl idi attenersi da una cosa non mala , dice s. Agost ino , de peccai.mer,, et rem. cap. ai . Aggiunge la t e r r ib i l minaccia: i» indubi-tatamente morrai : ch' è quanto dire diverrai soggetto allamorte, diverrai mortale, come hanno alcune versioni : tu nonavrai più d i r i t to a' ( rut t i del l 'a lbero del la v i ta , e non avra i piùalcun mezzo o a iu to per tener l on t ana la morte: ogni passo , o-gni momento ti torrà una parte delle tue forze, e ti meneràverso il sepolcro. La morie adunque è pena del peccato. Per unuomo entro nel mondo il peccato., e pel peccato la morte, ecos'i ancora a^ tutti gli nomini si slese la morte, (perchè,) tuttiin lui (in Adamn) peccarono. Rom. v. 12. Concil. Trid. sess. 6.
Sap. i, 1 3 n. «3. 9.4.Vers. 18. Non è bene che l'uomo sia solo. Mese viene adesso
per una maniera di r ecap i to l az ione ad esporre più diffusamentequel lo che avea solamente accennato nel capo i. vers.27.lmpe-rocchè n iuno dee d u b i t a r e , che Èva fosse creata come Adamo,nel sesto giorno, dicendo ivi Mosè: li creò maschio e femmina,
Facciamogli un aiuto , che a lui rassomigli. Diamogl i unacompagna simile a l u i per la condizione di sua na tu ra , capaceperciò di concorrere col l 'uomo al l 'esecuzione de' miei disegni,e di uni rs i con esso lui a lodarmi , e rendermi grazie de' bene-fizii fat t i da me a tulle le c r ea tu re .

dam animae viventis ,ipsum est nomen ejus.
20. Appellavitque A"dam nominihus suiscuncta ammantici, etuniversa volatilia coe-Li , et omnes bestiasterrae: Adae vera noninveniebatur adjutorsimills ejus.
21. Immlslt ergoDo*mlnusDeus soporem inA dam ; cumque obdor-miss et, tulit unam de
de'nomi, che diede Ada-mo agli animali viven-ii,è il vero nomedi essi.
20. E Adamo imposenomiconvenienli a tut-ti gli animali , e a tut-ti i volatili dell' aria , ea tutte le bestie dellaterra : ma non si tro-vava per Adamo un a-iuto, che a lui somi-gliasse,
21. Mandò adunqueil Signore Dio ad Ada-mo un profondo son-no;e mentre egli era ad-
Vers. 19. Li condusse ad Adamo ec. Pr ima di dare aliinomi»l 'a iuto, che gli mancava, Dio fa passare, come in r ivis ta , d inan -zi a l u i t u t t i gli an imal i : affinchè e i; 1 i col l ume datogl i dal Si-gnore d i s t i n g u a , a che poss.i essergli u t i le ciascuno di essi , ecome padrone di t u t t i , imponga loro iì nome che piìi con-
, Ognun de* nomi che diede Adamo ... e il vero nome di etti.E nome conveniente, adattato al la natura di ciascuno degli ani-mali; lo che dimostra la profonda sapienza data da Dio al primouomo. Ma da queste parole viene ancora ad inferirsi, ebe i nomidati da Adamo agli animali eransi conservat i fino a Mosè nel lin-guaggio , in cui questi parlava ; Io che proverebbe , ebe il lin-guaggio de) pr imo uomo fu 1' Ebreo. 11 celebre Bochart ha di*mostrato eoa molte etimologie la grande conformità , che passatraila na tura degli an imal i , e i nomi , che questi hanno nellalingua ebrea; e possiamo bea credere, che ciò si diraostrarebbaanche meglio, se maggiori cognizioni aver potessimo de l l a me*destina lingua. Vedi Giuseppe Antiq. i. cap. i. Comunementegl 'Interpreti , dopo s. Agostino (lib. g. de Gen, ad Ut. cap. 12.),credono, che i pesci non dovettero comparire dinanzi adAdaraocogli a l t r i animali ; e il testo medesimo sembra favorevole aquesta opinion»?.
Vers. 20. Ma non si trovava per Adamo ec. Adamo, benchévedesse negli animali molti traiti della sapienza i n f i n i t a delCreatore, non trovò perù in alcuno di es*i nul la di s imi le alledoli iaieriim ed esteriori, oad' egli era adorno.

costis ejus , et replevitcameni pro ea.
22.Et aedi fie avi tD o-minus Deus costavi ,e) nam lulerat deAdam,in mulierem : et addu-xit eam ad A darri.
23. Dixitque Adam:( \Y Hoc nunc os ex os-sibus meis , et caro decarne mea : haec vaca-bitur vir ago , quoniamde viro sumpta est.
24. (2) Quamobremrelinquet homo patremsuum, et matremì et ad-
dormenUlo, gli tolseuna delle sue cestole ,e mise in. luogo di essadella carne.
22. E della cestola ,che avea tolto da Ada-mo, ne fabbricò il Si-gnore Dio una donna :e me nolla ad Adamo.
20. E Adamo disse '.Questo adesso osso del-le mie ossa, e carne del-la mìa carne , ella dall'uomo av i a il nome, pe-rocché è stala t rai ladall'uomo,
24. Per la qual cosa1' UOH50 lascerà il padresuo, e la madre , e sia-
(1) i . Cor. n i. 9.(2) Matili, i g. 5. Mare. io. 7. Ephes.5. 3i.
Yers. 21. Uà profanilo sonno. Tale i il s i g n i f i c a l o de l l a voceorig-naìe , io luogo de l l i qua le i LXX. t r a d u c o n o estati. Adamodunque in questo sonno manda teg l i da Dio fu rapi to fuor di ssstesso, e coU'animo libero e sciolto da'sensi non solo v ide quel -lo che Dio fece sopra di l u i , ma riè intese ancora tut to il mis i fi-re: Egli in questo punto entrando nel santuario di Dio, ebbeV intelligenza delle ultime cose, dice s. Agostino.
Gli tolse unii delle sue coitole ec. Chi avrebbe immaginatonel Creatore una ai s t raord inar ia invenzione per formare nnadonna? Ma quanto cosi d iv iene sensibile la relazione t r a i l a fijjn-ra ,e la cosa figurata!Dorme Adamo (dice s. Agostino) affinchèÈva sia formata; muore Cristo, affinchè sia formata laChie-sa; a Cristo morto e traforato il costalo , affinchè ne fgor-ghino i Sacramenti, de1 quali tifarmi la Chiesa, Sent . 3o,8.
* Mando , infuse ; un profondo sonno. UD' estasi. Ebr. e iLXX.
Vr«s. a3. Questo adesso oìso delle mie ossa ec Adamo riscos-so dalla sua estasi, mentre Dio presenta a lui In sua compagna ,riconosce iu essa un' immagine degna di &«, e come un a l t ro t«stesso.

haerebit uxori suae :( i ) et erant duo in car-ne una.
26. "Erat autem uter-que nudus>Adam scili»cef, et uxor ejus\ et nonerubescebanL
(O i.Cor.6. 15.
rà unito alla sua moglie,e i due saranno solunacarne.
26. E 1' uno e l'altra,Adamo cioè, ela suamoglie , erano ignudi ;e non ne aveano ver-gogna.
Vers. a4' Lascerà V nomo il padre suo te. Queste parole so-no r ifer i te da Gesù Cristo, Matt. xix. 5. come parole di Dio a di-mostrare i' indissolubi l i tà dei matrimonio: lo che dimostra, cheper istinto dello spirito di Dio furo n proferite da Adamo. Ellesono state, e saranno per tulli i secoli la legge immutabile del-l 'unione legittima dell' uomo e della donna , anche dopo che ,sollevatesi nel cuor dell' uomo le inquiete passioni, hanno reu-duta difficile, e penosaali 'uomo non più innocente una tal legge,Vedi i. Cor. vii. 3. L' Apostolo ci ha anche insegnato a ricono-scere nell'unione di Adamo con Èva il mistero di Cristo, e dellasua Chiesa. Gai. v. a3. a/j. ec.
Vers. 25.Erano ignudi , e non ne avevano vergogna. Nonera ancora nell 'uomo avvenu to que l lo strano cangiamento, perragione del quale la carne desidera contro lo spirito, e lo spiritocontro la carne. Nessun contrasto essendovi tra l'uomo interioree l'esteriore, non eravi onde arrossire della nudità. Ma sentiamoqui Agostino, che espone il felice stato dell' uomo innocente. Uuomo vive a nel paradiso, come egli volea, mentre quello eglivolea, ch'era stato da Dio ordinalo. Viuea godendo dì Dio fdella bontà del quale egli era buono. Vìvea senza bisogno, eaaea potestà di vivere sempre così. Avea comodo il cibo pernon patire lafams; avea 1* albero della vita, perche non ve»nisse a discioglierlo la vecchiezza. Nessun ombra di corru-zione nel corpo, per cui foste data «' sensi di lui alcuna mo-lestia. Nessuna malattia al dì dentro, nessuna offesa si teme-va al di fuora. Sanità perfetta nella carne, tranquillità asso-'luta neti' anima. Come nel paradiso non era nè caldo , nefreddo; così in colui, che vi abitava, non era alterato il buonvolere ne da cupidità, nè da timore.Nessuna malinconia,nes-sttna vana allegrezza. Un ver o perpetuo gaudio scendeva inlui da Dio , verso di cui portavasi /' ardente carità di cuorepuro, di buona coscienza, e di fede non fìnta' Vegliavano diconcordia la mente e il corpo: osservavasi senza fatica il co-mandamento: noi gravava nè 1' ozio, nè la stanchezza; ne ca-deva sopra di luì il sonno, se non volontario,

CAPO-HI.
Per frode del serpente i progenitori trasgredì's cono il comandamento di Dio, Promessa delMessia. Data a ciascuno di essi la sua pena^sono cacciati dal paradiso.
i. i3ed et serpenserat callidior cune ti a»nimantìbus terraeyuaefecerat Dominus Deus.Qui dlxit ad mulie-rem: Cur praecepit vo-bis Deus, ut non come*deretis de omni lignoparadisi?
M .a il serpente
era il più astuto di tut-ti gli animali della ter-ra fatti dal Signore Dio.Questi disse alla don-na: Per qual motivo eo-mandovvi Iddio , chenon di tutte le piantadel paradiso mangiastei frutti?
Vers, i. flfft il serpente era il pih astuto cc.Mosè non ha par -late» fio qui «Iella caduta degli Angeli ribelli; nia egli la suppo-ne in questo racconto: imperocché in questo serpente non puònon riconoscersi «n {strumento del diavoloni quale invidioso delbene fatto da Dìo ali' uomo, si serve di tal mezzo per i ndu r r e inostri progenitori a violare il comando di Dio.Dovea essere pro-vata la fedeltà di Adamo e di Èva:da questa prova dovea dipen-dere la inalterabil fermezza di quel loro felicissimo stato . Dioadunque permette ebe il nemico dell'uman genere rivolga la suamalizia a tentarli per procurare la loro rovina.Ma qual via pren-derà egli j»er insinuarsi con essiPÉgli ha bisogno di un istruaieu»to.«'«tenore ; e Dio gli permette di valersi del serpente, la cuiscaltrezza ed astuzia sembra aver qualche cosa di s imi le alla ma-lizia, ond* egli è ripieno.
Per qual motivo r.omandovvi Iddìo se. II demonio adunquemovendo la lingua e la bocca del serpente , trovando la donnaappartata da Adamo, le domanda , perchè mai abbia voluto Dio,che non fosse loro permesso indist intamente l'uso di t u t t i » f ru t -ti del paradiso. 11 testo originale porta: Veramente vi ha egliordinato Dio, che non di tutte le piante, del paradiso ec. !S7ellequali parole il tentatore mette in dubbio il comando, o almenola interpretazione data allo stesso comando da 4$aa10 e ^a Èva.

a. Cui respondit mu-tier: De fruttu ligno-rum , quae sunt in pa-radiso , vescimur.
S.Defructu vero l'i-gni, quod est in medioparadisi^ prctecepit no-bis Deus , ne comede*remus , et ne tangere-mus illud) ne forte mo-ri amur»
2. Cui rispose la don-nn:Del frullo delle pian-te, che sono nel paradi-so , noi ne mangiamo:
3. Ma del frullo dell'albero, che è nel mez-zo del paradiso , ci or-d inò il Signore di nonmangiare , e di nontoccare , affinchè per
disgrazia noi non ab-biamo a morire.
Possibile > clic Dio abbia eccettuato alcun albero del paradiso,vietandone 1' uso a voi , mentre tutti e gli alberi e i f rut t i soabuoni? Avete ben inleso le sue parole? 11 senso della volgato, edu' LXX. sarà lo slesso, quando si traslati: Perche mai Dio a-vrebbe ordinato a voi, che non di tutte le piante del paradisomangiaste i fruiti? Lo ebe fa una negazione s imi le ali' Ebreo.
* Ma il serpente. Ma quel serpente , con al lusione al padredella bugia, che di queli' animale si valse a t rad i r i' uomo.
Vers. a. e 3. Del frutto delle piante, che sono nel paradisonoi ne mangiamo: ma del frutto ce. Èva cade già in grand* er-rore, mettendosi a ragionare con uno, phc comincia del metterein dubbio il comando, ch'ella sa essere stato intimato al consor-te: e per esse intimato ancbe a lei. Ella non potè far a meno diessere sorpresa ali* udire la incognita voce di un animale: e viriconobbe un prodigio, e dovette comprendere , che una supc-riore in te l l igenza movesse la l i n g u a di lui : ma in cambio di te-mere di qualche inganno, come il discorso stesso ne dava occasio-ne , credè di potere soddisfarsi , e vedere fin dove andasse nontal novità. Ella dunque va raccontando, che Dio ha vietato lorodi mangiare del frullo di quel tal albero, ed ancor dì toccarlo,perchè 1' una cosa è compresa nell'altra. Cosi Èva dà a vedere,che ha presente il comando di Dio ;onde, secondo la riflessionedi s. Agostino , più evidente ed inescusabi l si rende la sua tra-sgressione.
^Affinchè per disgrazia noi non abbiamo a morire. Questamaniera di parlare non indica veruna dubbiezza,come apparisceda molti altri luoghi delle Scri t ture , P s. •>.. 12. hai. xxvu. "A.Matth. xv. 3 Mare. vui. 3. Èva adunque noti solamente ha pre-sente il precetto, ina anche la pena stabilita da Dio »lla viola-zione del precetto.

4« Dixit autem ser-pe fi s ad mulierem: (i)Nequaquam morte mo-riemini.
5. S ci i enim Deus ,quod in quocumque diacomederetis ex eo.ape-rientur oculi vestri i eteritis sicut Dii , scien-tes bonum, et malum.
6. Vidit igitur mulier,quod bonum esset li*gnum advescendum^etpulcrum oculis&spectu-que delectabìle^ et tulitde frac tu illius , et (2)comedil; deditque virosuo, qui comedil*
4. Ma il serpente dis-se alla donna: Assola-tornente voi non mor-rete.
ó.Imperocchèsa Dio,che in qualunque tem-po ne mangerete, si a-pr i ranno i vostri occhi:e sarete come Dei, co-noscitori del bane,edelmale.
6. Vide adunque ladonna, che ilfrutlo del-l'albero era buono amangiarsi, e bello a ve-dere , e appetitoso al-l'aspetto: e colse il frut-to, e mangiollo ; fi nediede a suo marito , iìquale nè mangiò.<£uaic ut uiaiigi
(1) st.Cor. n. 3.(2) Ecct. 26. 62. i. Timoth. 2. 14.
Vers. 4 Voi non morrete. Il maligno ardisce di dire tutto 11
opposto di quello che ha detto Dio. Uua simil proposizione nonavrebbe potuto ritrovare credenza appresso la donna , dice s.Agostino, te nello tpirìto di lei non fot se entralo già 1' amoretfella propria libertà, e una certa superba presunzione di sefletta.
Ver». 5. Sa Dio, che ... /i apriranno gli occhi vostri, ce.Una delle due, dice il tentatore, o il precetto non è vero, e voimale intendeste; o questo precetto è in vostro danno, e parte dainvidia del vostro bene. Imperocché Dio sa come dal f ru t to diquesta pianta verrebbe a voi una scienza infinita,ch* vi uguagle-rebbe a Dio stesso per la cognizione del bene e dei male, deivero e del falso , di quel la che è ut i le , o dannoso.
Vers6. Vide adunque la donna. .. e colse ec. Èva avea pro-babilmente altre volte veduto quel f ru t to ; ma ella avea altr iocchi, che non ha adesso. Ella è adesso collosguardo e col cuoretutta intesa al pomo desiderato; ne considera la bontà e dai 1'esterna bellezza} ch' ella divora cogli occli, argoaiti#la, e qua»!

*].~Èt aperti sunt ocu-li amborum\cumqu& co-gnovissent, se essenu-dost consueruntfolia fi-cus, etfecerunt sibi pe-rizomata.
7. E si apersero gliocchi ad ambedue: «davendo conosciuto, cheerano ignudi cucironodelle foglie di fico, e seuè fecero della cinture.
già gusta l'eccellente sapore; finalmente ella consuma il suopeccato; e coglie il pomo , lo mangia, e induce il mar i to a man-giarne. Tutta questa descrizione è sommamente patet ica, e de-gna dello spiri to di Dio , il quale ha voluto dare io un esempiosi grande, una gran lezione a tutti i secoli , e a tut te le genera-zioni future ,delle ar t i che tiene il demonio per indurre gli uo-mini alla prevaricazione della legge ; della maniera , onde Diopermette , che i falli seguenti sieno giusta pena de' pr imi ; delbisogno che avranno tutti gli uomini di vegliare costantementeper non entrare in tentazione , imperocché non saranno eglinoornai più nè senza peccato, nè l iberi dalle passioni, come Adamoed Èva, nè collocati come quegli in un paradiso, ma in un luogod i tentazione, e di combattimento.
La Scrit tura avendo raccontato per qual i vie il nemico sedus-se la donna, non dice altro r iguardo all'uomo,se non che quel lagli porse il frutto, e che ei ne mangiò. Egli (dice 1' Apostolo i.Tìmot. 11.14.) non fu sedotto ctm* Èva ; donde intendiamoche , sebbene egli non credesse al serpente , non ebbe coraggiodi resistere ali' esempio, e alle lusinghe della compagna; da cui•i lasciò pervertire ; egli che , essendo più saggio e più perfettodi lei, dovea essere sua scorta e suo consiglio. Forse non cono-scendo ancora per prova la severità di Dio, credette Adamo, ebepotesse essere scusabi le il fal lo di non abbandonare la compa-gna della sua vita anche nel la soscietà della colpa, dice s. Ago-stino de civ. lib.\iv. cap. i3 .Ma l 'aperta v io laz ion del comandonon sarebbe avvenuta (osserva l'istesso s. Dottore), se non fossepreceduta in tcr iormente la segreta compiacenza di sé medesimo,e la superbia , per cui volle sottrarsi al cornando di Dio, ed es-sere uguale a lui. Vedi Aug.de civ, lìb.xiv. cap. i3. in Ps. 70.,et semi. v. ne verb. Ap,
* // quale ne mangiò. L'orig. , e i LXX. ne mangiò con lei.Vers. 7. E si apersero gli occhi ad ambedue. Il serpente lo
av«a promesso (veri. 5.) ; e si avvera adesso, ma in un senso in-finitamente diverso da quello, in cui volle il tentatore far pren-dere quelle parole: si apriranno gli occhi vostri. Si apersero iloro occhi, e videro il gran fallo commesso , l 'orrenda loro disub-bidienza in tanta faci l i tà di osservare il comnndo, la ingrat i tudi-ne mostruosa a'bwaefiii! del Cfcalore; videro 1' innocenza per-

8. Et eam audissetvocem Domini Dei de*ambulando in paretài*so ad auram post me-ridiem, abscondit se A'dam.et uxor ejus afa*eie Domini Dei in me'dio Ugni paradisi.
8. E «vendo udita lavoce del Signore Dio ,che camminava nel pa-radiso nel tempo , chelevasi il vento dopo ilmezz,odi,si nascoseAda-mo , e la sua moglie al-la vista d«l Signore inmezzo agli alberi delparadiso.
duta, e con questa la loro felicità; videro i mali, ne* quali si eranprecipitati , il predominio delle passioni, la morte, i dolori , lemalattie, le miserie della vita infinite; videro finalmente percolmo della loro afflizione il loro reato , e i mali da ciò provenuti trasmettersi a tutta la loro infelice posterità.
E avendo conosciuto cha erano ignudi, ec. Aug. de Gen. adUt, lib. 11. 82.scrive.- L* uomo provò allora, qual fosse quellagrazia, di cui era rivestito quando nella sua nudità nientesoffriva (V indecente. Privato della grazia e della giustizia ori-ginale , sperimentò i primi f ru t t i di quella dura legge, cheornai regnava pelle sue membra, e contrariava la legge deliasp i r i t i» , e ne ebbe dolore e vergogna; e non avendo rimedioper togliere il male, cercò di nasconderlo agli occhi propriied altrui. Trovasi in Egitto una specie di fico, chiamato ficod' Adamo, le foglie del quale sono graudissìme,
* Cucirono. L' Ebr. aggiustarono: attaccarono insieme dellefoglie di fico.
Vers. 8. E avendo udito la voce del Signore Dìo, ec.Egliè molto credibile , che fino a tanto, che durò io stato dell'innocenza, Dio si facesse vedere a'nostri progenitori sotto unafigura adattata alla loro capacità , e che il tempo di tali vi-site fosse quello che qui si descrive; vale a dire quando de-clinando il iole dal mezzo dì, l'aura dolce e leggera , ebe silevava , invitava a goder eoo piacere maggiore Io spettacolodella natura. Queste visite doveano ancora essere preceduteda un certo romoreggiamento, che ndivast nel paradiso, e av-vertiva Adamo ed Èva di correre a presentarsi al Signore: ratquesta volta Adamo ed Èva, agitati da' rimorsi della loro co-scienza , fuggono la presenza di Dio, come si fuggirebbe unarrabbiato nemico, e corrono ad intanerai io un folto boschet-to. S. Girolamo vuole, che si nascondessero sotto 1* alberostesso della scienza del bene e del male, e pare così ancorapensaste «. Agostino,- onde allora converrebbe tradurre: ti na-tcotero nel metto {de? rami} delV albero del paradìio.

9. yocavitque Domi-nus Deus Adatti^ et di'xit ei: Ubi e-s?
10. Qui aiti Vocemtua/n audivii in para-diso', et timui eo , quodnudus essem^etabscon-di me.
11. Cui di xit'. Quisenim indicavit ubi,quod nudus esses^ nisiquod ex ligno, de quopraeceperam libi , necomederes 5 comedistfi
9. E il Signore Diochiamò Adanuo 3 e dis-segli: Dove sei tu?
10. E quegli rispose:Ho udito la tua vocenel paradiso:ed bo avu-to ribrezi&Oj perchè eraignudo; e mi sono a-scoso.
11. A cui disse Dio:Ma e chi ti fece cono-scere ^ che eri ignudo,se non 1' aver tu man-gialo del frutto,del qua-le io aveva a te coman-dato di non mangiare?
Vers. g. Dove sei iu?È'lo stesso come se dicesse: Adamo,per qual motivo ti fuggi da me? Credi tu di poterti nascon-dere agli occhi miei? Infelice, se tu senti il peso enorme deimali, ebe ti sei tirato addoslo, credi tu di poter trovare con-fiolaziooe e conforto coli' andar sempre più lungi da tue?
Ver», io. Perche era ignudo, te. Dio eoo la sua chiamataavea voluto dar motivo ad Adamo di confessargli il suo granfallo; Adamo perù torce altrove il discorso, e adduce per ra-gione di non essersi presentato subito, la vergogna, che aveadella sua nudità, come se od egìi non fosse stato ugualmentenudo ne'dì precedenti , o vi fosse riparo per nascondersi inalcun modo agli occhi di Dio, L'esempio del primo uomopeccatore è imitalo pur troppo da'suoi figliuoli, i quali nes-suna cosa temono tanto, come la vista e la confessione della\erita, da cui sono condannati; onde cercano per ogni parte«cuse e pretesti per nascondere e diminuire i proprii peccati.
Vers. il. £ e hi ti fece conotcere ch'eri ignudo, ce. Que-ste parole evidentemente dimostrano, come la concupiscenza èeffetto del peccato, e come dalla cupidità procede il disordinedelia immaginazione e dei sensi. Dio dice ad Adamo : Se tucon sei più quello di prima, se il tuo stato è oggi diverso ,come apparisce dal vedere, che quello » che già non ti davaalcuna noia, ti fa oggi vergogna; e donde tal nìulatioce?Àvre-sti tu perduto la veste dell' innocenza e deila gìu&tisu eoa<liì>obb<;dire al mio comandamento?

i a. Dixitqus AdamiMulier, quam dedistimihi sociam^ dedit mi-hi de tigno t et comedi,
13. Et dixit Domi-nus Deus ad mulie-rem: Quare hoc fecistfìQuae respondit : Ser-pens decepit me, etcomedi.
14- Et ait DominusDeus ad serpentem :Quia fecisti hoc, male'dictus es inter omniaanimantìa, et bestiasterrae : super pectustuum gradieris, et ter-ram comedes cunctisdiebus vitae tuae.
12. E Adamo disse :La donna datami da teper compagna , mi hadato del frutto, e l'ho iomangiato.
13. E il Signore Diodisse alla donna : Per-chè facesti tal cosa? Edella rispose: II serpentemi ha sedotta, ed io homangiato.
1,4. E il Signore Diodisse al serpente; Per-chè tu hai fatto quesio,maledetto tu tra tut-ti gli animali, e le be-stie della terrattu cam-minerai sul tuo ventree mangerai terra pertut l'i giorni di tua vita.
Ver», la. La donna datami da te per compagna , ec. Final-mente Adamo confessa il suo peccato ; ma io confessa da reo ,non da penitente-, rigetta la colpa sulla consorte, e quasi sulmedesimo Dio, che gliela die per compagna ; come se 1' affetto,ch' egli doveva a lei, render giammai potesse scusabile in alcunmodo una si orribile ingiustizia e disobbedienza contro delCreatore.
* Datami da te per compagna. L' Ebr. che tu bai messa conme. DaH' indegna sensa apparisce come uu peccato fa strada amolti.
Ver*. i3.Il serpente mi ha sedotta. La pazienza di Dio udì'accollare le false e frivola scuse d'Adamo,dà animo alia donna ditentare almeno di rendere men grave il suo reato, allegando lasua ignoranza , e la sua semplicità, per cui non potè ella imma-ginarsi, ebe traile creature di Dio, dimoranti nel paradiso , vifosse cbi eoa tanta perfidia si adoperasse per ingannarla e tra-dirla. Ma cbi può menar buona una tal difesa? Andava egli ascol-tato il serpente piuttosto che Dio?
Vera. 14- E il Signore Dio ditte al ferpente: Perche tu , ec,H demonio era tuttavia in <juel serpente , ebe gli ave.i servito di

16. Inimìcitias po-nam inter te , et malie'rem, et semen tuum> et$emen illius. Ipsa con-terei caput tUTim, et tuinsidìaberis calcaneoejus»
io. Porrò inimiciziatra te, e la donna, e trail seme tuo , e il semedi lei. Ella schiaccerà latua testa, e tu tenderaiinsidie ai calcagno dilei.
organo e di strumento a ordire le sue trame : qu ind i la maledi-zione di Dio è concepita in tali termini , che , quantunque el lacada e si avver i anche in certo modo nel serpente materiale ,va però più specialmente a ferire il serpente invis ib i le .
Malaletto tei tu tra tutti gli animali, ec Di tutt i gli anima-li nessuno è avuto in orrore dall'uomo, cerne il serpente, di qua-lunque specie egli s ia : quindi per antica maniera di proverbiosi disse: odiare una persona più che uo serpente. Ma più ancoradi ogni serpente, sarà odioso ali' uomo lo spir i to maligno , il cuistudio continuo si è di andare ^attorno in cerca dell' anime perdivorarle.
Camminerai sul tuo ventre e mangerai ec. Ciò dimostra lavil condizione del serpente , il quale strascinandosi perpetua-mente sopra la terra , di sordido e immondo cibo si pasce. Mapiù letteralmente, per così dire, lo spirilo di malizia è avvilito edepresso dopo aver meritata la maledizione di Dio. Egli volleinnalzars i , e porre il suo trono «opra le stelle ; ma la sua super-bia fu umi l ia ta e depressa sino all'inferno; egli cercò per invidiadel ben dell ' uomo di corrompere l'opera di Dio, e di rendere1' uomo imi ta tore della sua disobbedienza per averlo compagnoancor nella dannazione; ma Dio dice al serpente, che un tale ar-dimento sarà pun i to col l ' ignominia e coll 'obbrobrio , a cui saràridotto lo stesso spirito. Egli, benché di natura sì nobile ed ele-vata, sembrerà divenuto la stessa corruzione, e la stessa impuri-tà; onde a l t ro nome quas i più non avrà , che quello di spiritoimmondo ; perchè i suoi consigli , le sue suggestioni non avranper oggetto, se non i p iù sordidi e vi l i piaceri , ed egli non sicompiacerà, e non avrà per amici, se non coloro, i quali seguen-do i suoi de t tami s' immergeranno nella terra e nel fango Que-eta espressione mangiar la polvere, come i serpenti, si trovanelle Scritture Vedi Mieli, vi i . in.
* Camminerai sul tuo ventre. Ti strascinerai col tuo ventre.Vers. 15. Ella schiaccerà la tua testa , e In ac. L' Ebreo in.
vece di Ella legge Egli ovvero Esso, riferendolo al seme; e la.comune lezione de'LXX. è simile all'Ébrea.beuchè qualche edi-zione s iavi , in cui si t rovi in lezione della Volgata. Alcuni padriLatini lesserò, come 1' Ebreo ; ma generalmente tatti i Mss., e i

16. Mulieri quoquedixit\ Multìplicabo ae-rumna? tuas et conce-ptus tuos: in dolore pa-ries fiilos, et suo viripotè s tate eris , (i) etipse dominabitur lui.
(i) i. Cor. 14. 54.
io. E alla donna an-cor disse : Io moltipli-cherò i tuoi affanni ele lue gravidanze ; condolore partorirai i fi-gliuoli, e sarai sotto lapotestà del marito , edei ti dominerà.
PP.concordano colla Volgata, la quale dà un ottimo scaso,e ebepuò combinar benissimo coli' Ebreo, come diremo.
Dio parlando sempre all'uno , e ali' altro serpente , dice nel«primo «enso, che antipatìa, e nimistà perpetua averà la donna, e
* i figliuoli di lei coi serpente ; che la donna stessa, e la sua po-sterità schiaccerà quando che sia a lui la testa, ed egli valendosidi sua astuzia cercherà di arr ivare a mordere di nascosto il cal-cagno di lei. Cosi va la cosa tra M serpente materiale , e la don-na, e i figli di lei, dopo che per quello che avvenne nel paradisoebbe fine la pace, che l'uomo avea col serpente, e con tutti glianimali. Ma in.un altro senso inf in i tamente più sublime e im-portante per noi, ed avolo in mira principalmente dallo SpiritoSanto, allo spirituale serpente, al demonio sono dirette questeparole, e lui esultante per la vittoria riportata sopra del l 'uomoè anuuDiìata da Dio la vittoria, che riporterà di lui una donna,Ja quale per mezzo del figliuolo, che darà alla luce , schiacceràdel superbo la testa. Questa donna è Maria, come il seme di leie il Cristo, il Verbo di Dio fatto carne nel seno di questa Vergi-ne. L'opposizione di questa Vergine, e del figliuolo di lei collospirito immondo e superbo, e co'fìgliuoli di lui , cioè cogli em-pii, non può esser più grande. Siccome da una don uà ebbe prin-cipio la rovina dell' uman genere, e il regno di Satana ; cos'i daquesta Vergine avrà principio la riparazione degli uomini, e ladistruzione del peccato , per cui trionfava il demonio. Ecco laprima evidente promessa fatta da Dio agli uomini del Messia ,cioè di un Salvatore, il quale verrà a liberargli dalla schiavitùdei peccato e del demonio, a riconciliarli con Dio , e a meritareper essi la salute, e la vita eterna .Ed è cosa degna di molta con-siderazione, come nell'atto stesso, che Dio fa giudizio dell' uo-mo prevaricatore, vien publicata da lui, a consolazione dell' uo-mo, e della sua discendenza , questa grandiosa promessa di un«uovo Adamo, che dee venire a riparare con redenzione copiosa

17. Adae vero dixit:Quia audisti vocem «-xoris tuae, et comedistide ligno) ex quo prae-ceperam libi, ne come"deres , male dicta terrain opere tuo: in labori"bus comedes ex ea cun-ctis diebus vitae tuae.
17. E ad Adamo dis-se : Perchè hai ascolta-ta la voce della tua con-sorte , e bai mangialodel frutto, del quale ioti avea comandato dìnon mangiare,nialedet-la la terra per quelloche tu hai fatto: da leitrarrai con grandi fati-che il nudr imento pertutti i giorni della tuavita.
si avveri quel dell' Apostolo, clic- se pel delitto di un solo mol-ti perirono, molto più la grazia, e la liberalità di Dio e stalaridondante in molli mercé di un uomo , cioè di Gesti Cristo,Da questo punto adunque sino alla fine de' secoli Gesìi Cristo .fu sempre, e sarà 1* unico oggetto di speranza per l'uomo ; oudenella fede di lui venturo ebbero salute quanti della salute fece'ro acquisto prima di' egli nascesse e patisse, come nella fede dilui morto, pe' peccati nostri, e risuscitato per nostra giustifica-zione ottengono, ed otterranno salute tutti gli eletti.
E tu tender ai insidie al calcagno di lei. L'Ebreo: e tu tpcz*zerdi, ovver morderai il calcagno di lei. Ove queste parole in-lendansi del la Vergine , s ign i f icheranno i t e n t a t i v i , che farà ildemonio, benché inut i lmente , per abbattere la feJe di lei, e pervincerla , come avea vinto la pr ima donna. Ma r iportandole alseme della donna , cioè a Cris to ,el leno h a n n o un senso di moltamaggior importanza- imperocché verranno a spiegare , per qualmezzo il figliuol della Vergine schiaccerà la testa al demonio;questo mezzo sarà totalmente nuovo ed inaud i to II figliuolo del-Li Donna combat terà col demonio con colla sua possanza , mane l l a i n f e rmi t à della carne. Il calcagno signif ica 1 ' umani tà diCristo; il demonio per mezzo de' su«>ì ministri metterà a morteil Cristo, e la morte di lui sarà la salute dell ' uomo, e la scou-fìlta del diavolo.
Vers. 1.6. Moltipllcherà i tuoi affanni e le tue gravidanze.Vale a dire gli aifaiini e le miserie, che vati congiunte colie gra-vidanze.
Con dolore partorirai. Gl ' incomodi delle g rav idanze , ! dolo-ri del parto sono insieme il gastigo del peccato della donna , eil mezzo , oude Diu vuole punii varia , aifiue dì perdonarle* L&

18. Spinas et tribù-los germìnabit libi, etcomedes herbam ter-rete*
i g. In sudore vultusluì vtsceris pane,donecrevertaris in terrami ,de qua sumptus es ,quia pulvìs es, et inpulverem reverteris.
i8.EHa produrrà perte spine e triboli , emangerai 1' erba dellaterra.
iQ.Mediante il sudo*re della tua faccia man-gerai il tuo pane , finoa tanto che tu ritornialla terra, dalla qualesei stalo tratto: peroc-ché tu sei polvere3 e inpolvere tornerai.
donna sedotta prevarico; nondimeno ella ti salverà per Vetìn-cazione de* figliuoli, se $ì ter?à nella, fede, e nella cariici , enella santità con modestia, i. Ttm.ll. «4 15.
Sarai sotto la potestà del marito ec. Di qui avea imparalo1> Apostolo ciò che insegnava continuamente intorno alla subor-dinazione della donna. Cosi i. Tim. IL 11. i a. La donna impa-ri in filenzio con tutta la dipendenza; non permeilo alla don-na dì fare da maestra ; ma che stia cheta. E o t t imamente s.Agost. de Gen. ad Ut. lib. II. cap. 3y, Non lei nalii^a , ma lacolpa della donna merito di avere per signore il marito: laqual cosa quando non sia mantenuta, si corromperà vie putla natura, e anderà crescendo la colpa.
* Ei ti dominerà. Sari tuo signore,Vers. 17. e 18, Per quello che tu hai fatto, Dall' Ebreo , e
dalle antiche versioni apparisce , che tale dev'essere il senso diqueste parole della Volgata: In opere Ino: Maledetta ta terraec. lo cambio dell' uom peccatore, Dio maledice la terra, e dalcangiamento grande, che in questa succede, vuol che egli argo-menti la degradazione somma, a cui egli si è ridotto co) suo pec-cato. Dal paradiso di delizie, dov' era ogni abbondanza dì f ru i t i ,Adamo è mandato esule in una terra, dalla quale dovrà trarre agrande stento il pane per sostentarsi. I triboli, e }« spine, e lecattive erbe, e le piante inu t i l i germaglieranno in abbondanzasu questa terra; tutto quello che servirà al sostentamento del-l'uomo, avrà bisogno di faticosa cultura.
Mangerai V erba della terra. In vece di erba il testo origi-nale ha una voce , la quale oltre il frumento comprende ognisorta di granella, di legumi, e di erbaggi da mangiare.
Yers. jy. Mediante il sudore della tua faccia mangerai ce.Uà precetto generale egli è questo per tu t t i i figliuoli d'Adamo,

20. Et vQcavìtAdamnomen uxoris suaejle-va, eo quod mater es*set cunctorum viven-tium.
21. Fecit quoque Do-minus Deus Adae, etuxori ejus tunicas pel"liceas » et indu.it eos ì
ao.E Adamo pose al-la sua moglie il nomedi Èva, perchè ella eraper esser Ja madre ditutti i viventi*
21. E fece ancora ilSignore Dio ad Adamo,e alla sua moglie delletonache di pel le , dellequali li rivesti.
L'ozio, P infingardaggiae, l ' inutilità della vita si oppongono aquesta sentenza di Dio In qualunque stato, o condizione l'uomosi t rovi , 1'occupazione, e la fatica proporzionata, e convenien-te al medesimo stato è di precetto del Signore. L* Apostolo neera Unto persuaso , che non ha difficoltà di dire che Chi non.lavora, non dee mangiare II. Thessal, HI. io. I filosofi , e i le-gistratori Gent i l i conobbero anch'essi questa verità, e ae incul-carono 1' osservanza.
Perche tu tei polvere , e in polvere ritornerai, Tale è lasentenza di Dio contro Adamo, e cori tre tutta la sua posterità io-fetta e corrotta dal suo peccato. L'uomo era stato fa^to zrmjior-tale; volle essere un D,ì& non perde l'essere d'uomo , ma per-de l'ètsere d'immortale, e per la superbia della disobbedienza,questa pena fu contralta dalla natura, bug. seni. 260. L'uomoa d u n q u e per lo peccato è condannato a morire, ma non a morireper sempre; a l t r iment i a qual pro Dio lascerebb'egli a lui noco-ra per qualche tempo la vita?Dio pertanto convertendo io rime-dio, e ia uti le dell 'uomo lo stesso castigo, co l l ' i n t imarg l i la mor-te lo invita a prepararsi a questo passaggio per mezzo del la pe-nitenza, affine di conseguire il r innovel lamento del la g ius t iz ia , ela salute mediante la fede in l u i , che dee schiacciare la testadel nemico serpente, ed è già fin d' adesso fallo da Dio giusti-zìa, e santificazione, e redenzione per 1' uomo.
Vers. 20,11 nome d' Èva. Hevah in ebreo è lo stesso, che vi*ta. Un antico padri! notò, che Adamo nell' imporre questo nomealla moglie ebbe in vista quella donna, e quel seme di lei, dacui doveva essere schiacciato il capo al serpente, e f e n d u t a agli,uomini la vita spirituale perduta per la disobbedienza d 'ÈvaQuella donna figliuola di Èva divenendo madre d 'un figliuolo,il quale darà la vita a quell i ch' ebbero la morto da Èva, que l ladonna meritsrà con giustizia iì nome di madre de'viventi./i'fn/>/i

22.Et alt: ecceAdamquasi unus ex nobis fa-eius est, scìens bonumet malum : nunc ergone forte mittat manumsuam , et sumat etiamde ligno vitae, et come-dal, et vivat in aeter-num.
26. Et emisit eumDominus Deus de pa-radiso voluptaùs , utoptraretur terram , dequa sumptas est.
»4' Ejecitque Adam\et collocavit ante para-disum voluptaùs Che-
22. E disse:Ecco,cheAdamo è diventato co»me uno di noi, conosci-tore del bene,e del ma-le: ora adunque, che asorte non istenda eglila mano sua , e colgadell' albero della vita; ene mangi, e viva in e-terno.
25. E il Signore Diolo discacciò dal paradi-so di delizie, affinchè la-vorasse la terra: da cuiera stato tratto.
24. E discacciatoneAdamo, collocò davantial paradiso di delizie un
"Vers. 7.1. Fece ancora . . . delle tonache ili pelle , ec. Non èc»sa nuova nelle Scritture il dire,che Dio abbia fatto quello ch'egli ordinicene da altri si facesse Cosi qui o Dio ordinò ad Adamoed Èva di uccidere degli an imal i per coprirsi delle loro pell i , o«li stessi animal i feceuceidere per minis tero di qualche Angelo.Ecco sopra un tal fatto la riflessione di Oricene, hom, 6 i n L e v i t .Di tali tonache dovea rivestirsi il peccatore, le quali fosseroindizio e della morie, nella quale era incorso pel primo pec-cato , e della tua fragilità proveniente dalla corruzione deltacarne. ,
Yers 22. È diventalo come uno di noi ec. Non v' ha dubbio ,che per le parole uno dì noi s* intendano le tre divine Persone.Queste sono parole di Dio, il quale non insulla alla sciaguradi Adamo: ma s,li altri avverte di non insuperbirsi, come eglifece Aug. lib. 11. de Gen. 3g.
Ora adunque, che a sorte non ìstenda fglì la mano ec. Ilsenso, che rimane interrotto , è supplito da quel che si ha nelverso seguente. Affinchè Adamo non ardisca forse di stendere lamano ali' albero della vita, perciò Dio lo manda fuori del paradiso.
Vers. a4- Collocò davanti al paradiso . ., tiu Cherubino, ov-- . _ - j~» y>z.^....*,:„,• „„„,„ ...irta l'F.hreo: ma siccome ima sola è

rubim , et flammeumgladìum^tgue versati-lem ad custodiendamviam Ugni vitae.
Gherubìnocon una spa-da,che gettava fiamme,e faceva ruota a custo-dire la strada , che me-nava all'albero dellavila.
CA.PO iv.\£damo genera di Èva Caino e Abete. L1 empio.
Caino uccide il fratello Abete ; e punito daDio, mena vita di vagabondo-, e genera Enoc.Adamo parimente genera Seth , di cui fu fi-gliuolo Enos.
i. jtjLdam vero co-gnovit uxorem suamMelami quae concepì^et peperit Caint dicens:P os sedi ho mine m perDeum.
i. JLj Adamo conob-be la sua moglie Èva 3la quale concepì, e par-lori Caino, dicendo: Hofatto acquisto di un uo-mo per dono di Dio.
la spada, così molti credono , che Adamo non vedesse, ebe uàCherubino.
* E discacciatone Adamo. E ripudiato Adamo.A custodire la strada, ec. Uà queste parole sembra potersi
intendere, che il luogo assegnato per suo esilio ad Adamo, dopoche fu uscito dal paradiso, era v ic ino , e quasi in vista di quel1 tiogo di delizie , arììachè avess' egli mai sempre di oauzi agli oc-chi l ' immagine della perduta felicità ; e questa vista servisse aììudrire in lui sent iment i di penitenza , e la grati tudine versoDio , il quale concedendogli la vita popol i suo peccato gli som-ministrava il mezzo Ji meritare le sue misericordie.
Vers. i. Adamo conobbe le sue mogli. Da questo luogo i Pa-dri uè inferiscono, che Adamo ed Èva si mantennero vergini tut-to il te'npo che dimorarono nel paradiso terrestre.
Ho fatto ac finis io d' un uomo ec. Caino significa acquisto ,ponessi) Èva riconosce da Dio la sua fecondità, e iusegua alle al-ti^ ;1 anne a render uè grazie.

a. E di poi partorì ilfratello di Jui, Abele. EAbele fu pastore di pe-core , e Caino agricol-tore.
3. Ed avvenne, cheda li a lungo tempo of-ferse Caino doni ei Si*gnore de' frulli dellaterra.
4. Abel ancora offer-se de* primogeniti delsuo gregge , e de* piùgrassi tra essi: e il Si-gnore volse lo sguardoad Abele, e a' §uoidoni;
a. "Rursumque pepe*rìt fratrem ejus , Abel.Fuit autem Abelpastorovium , et Cain agri-cola.
3. f* actum est autempost muhos dies, ut of*ferrei Cain de fructibus terrae munera Dò-mino.
4. (i) Abel quoqueobtulit de primogenitisgregis suis , et de adi-pibus eorum: et res pe*xìt Dominus ad Abel tet ad munera ejus.
(i) Tlebr. 11. 4»
Vers. a. Partorì Abtle dì luì fratello, /f&e?esignifira vanità;col qual nome la madre , memore della sentenza di morte pro-punziala contro di lei, e coctro de' suoi figliuoli, volle forse in-dicare la condizione delfnuovo suo stato , in coi, secondo la pa-iola del Savio, lutto e verità; perchè e gli uomini, e le cose de-gli «omini passano come ombra. Notisi ebe Mosè non parla dellefigliuole di Èva, e nenamen di tutti i figliuoli, ma solamente diquelli ch e sono necessari per condurre la genealogia da Adamoa Noè , e da questo ad Abramo e al Messia: nè la consuetudineportava di rammentare le donne.
Vers, 3. Di lì a lungo tempo. L' Ebreo alla fine de*giorni,della qual espressione 11 senso migliore «embra essere alla fineàelV anno ; cioè dopo la ricolta : imperocché non è verisimile ,:ebe quello, ebe fu poi prescritto da Dio nella legge, di offerirede'frulti della terra alla fine dell'anno, ci osservasse sotto quellaebe chiamasi legge di natura. La ragione non meno, che gl'in-segnamenti di Adamo facean conoscere a* figliuoli, ebe tut to eradono del Creatore. A lui perciò facevano offerta di una partede'beni raccolti dalia terra, granella, frutti, miele, ec, tutto ciòprobabilmente si consumava nel fuoco.
* Frutti della terra. Comuni, non scelti: non i migliòri.Vers. 4- E de'più gratti tra etsi. Il Siriaco, illustrando quello
ebe è alquanto oscuro oelPEbreo, tradusse; ojftrsc il prìmoge-

5, Ad Cain vero% etad munera illius nonrespexìl'' iratusqus estCain vehementer , etconcidit vultus ejus.
6. Dixitgue Dominusad eum: Quare iratuses? et cur concidit fa-cies tua?
7.Nonne sibeneege-ris, recipìesi sin autemmale., statim in foribuspeccatum aderlt ? Sedsub te erit appetitusejus] et ut dominaberisìllìUò'.
5. Ma non diede unosguardo a Crino, nè aidoni di lui : e Caino sìaccese di grande sde-gno , e portava il voltodimesso.
6. E il Signoee dissea lui: Per qual motivosei adirato ? e perchèporti la faccia in seno?
7. Non è egli vero ,che se farai bene, ben»averai: e se farai male,sarà tosto alla tua por-ta il peccato? Ma 1' ap-petito dì esso sarà sot-to di te; e tu gii co-manderai.
ni ti de1* tuoi montoni, e t più gratti: sopra di che nota il Cri-sostomo, che Abele dell1 ottimo offerteli meglio. Gli Ebrei in-segnano , che i sacrifizii di Abele erano tutti olocausti , mentrenon era ancora permesso di cibarsi delle carni,nè per conseguen-za di offerire sacrifizio, in cui qualche parte dell'animale si ri-serbasse per 1'uomo. Da molti autori profani impariamo, che1' uso di sacrificare gli stessi animali non fu il più antico, e co-mune presso le nazioni, Je quali' da prima si contentavano di of-ferire il latte e la lana: lo che sembra non possa avere originealtronde, se non dall' astenersi, che fecero i primi uomini, daliecara! delie bestie.
// Signore volse lo sguardo ad Abele, ed a*suoi doni. La fe-de ela pietà sincera d'Abele fu quella che rendette a Dio accet-ti i suoi doni, Hebr. xi-4- Per la fede offerse a Die ostia mìglio-re Abele, che Caino, per la quale fu lodato come giusto , ap-provati ila Dia i doni di lui, 1 Padri comunemente credono ,che il segno dato da Dio del grandimento, con cui accettava l'of-ferta di Abele a differenza di quella di Caino, si fu il consumarecon un fuoco mandato dal cielo il suo sacrifizio. Un* antica tra-duzione approvata da s. Girolamo, dove noi abbiamo: Dio rivol-se lo sguardo a'doni ec. portava: Dio mise il fuocolne* doni, ec.Simile segno d'approvazione vedesi altre volte ne'uostsi librisanti , come Levit, ix. a4- *» Parai, xxi. 26.

8. Dìxitque Cain ad'Abelfratrem suumi E>grediamurforas. Cum-que essset in agro^con-3urrexitCain adversusJratrem suum A bel, et(i) interfecit eum.
8. E Caino disse adAbele suo fratello : An-diamo fuora. E quandofurono alla campagna ,Caino investì il suo fra-tello Abele: e lo uccise.
(i) Sap. io. 3. Matth. 23. 35. i, Joan. 3.12. Judae ii.
Ver» 7. Se farai &ene, lene avtraì. Si può ben credere , cheCalao veggendo la predilezione di Dio verso Àbele, temesse, chequesti non venisse a sé preferito ne' diritti di primogenito.
Se male, sarà tosto alla tua, porta il •peccato. Se tu pecchicontro il fratello , invidiando la sua sorte, il tuo peccato avraiperpetuamente alla porta delia tua casa; ed egli non tilascieràiene avere .• la tua cattiva coscienza sarà il tuo carnefice di gior-no e di uotte.
Ma l'appetito di esso sarà sotto di le, e tu gli comanderai.Lv appetito del peccato, o sia la concupiscenza non ti dominerà,se tu non vorrai; tu potrai resistere , reprimerla, e superarla.Nella sposizione di questo versetto, che è certamente uno de'piuoscuri, ho seguita l'interpretazione comune de'padri,e degli In-terpreti cattolici ; la quale è ancora la più naturale, e meglio siaccorda col testo originale.
* Sarà tosto alla tua parta il peccato. Qui , come spessoue'sacri libri, è posto il peccato per la pena al peccato dovuta.
Vers. 8. E io uccise. S. Giovanni ep. i. in. i a, Caino ,... am-mazzò il fratello: e perche lo ammazzo ? perche le opere dilui erano cattive, e quelle del tuo fratello giuste. Ma ogni elo-
gio sorpassa quello datogli da Gesù Cristo medesimo , il qualenon contento di dargli il titolo di gi'zuzo per eccellenza, lo contòti primo di quel gran numero di giusti, i quali dal principio delmondo iasioo ali* venuta del Messia, ebbero quaggiù in premiodella loro giustizia il martino ; onde s. Cipriano esortando i Ti-bari tani a dar volentieri la vita per Cristo , scrive ep. 6. lib. 4>Imitiamo,ifratellì carissimi,il giusto Abelc, il quale da prin-cipio al martirio) quando egli il primo fu ucciso per la gin-ttitia.. Quindi fu egli degno di essere una bella figura di GesùCristo medesimo perseguitato , e messo a morte dalla sinagogapeli1 invidia cooceputa contro di lui da' principi de* sacerdoti ,« <!«•>' grandi del popolo. La morte di Abele avvenne 1* anno i3ocibila creazione , contando egli 159 anni di vita. Benché la Scrit-tura non parli de'iigliuoli di Àbele, credesi nondimeno, che egli

9. Et alt Dominus adCairn Ubi est Abelfra*ter tuus ? Qui respon*dit : Nescio r num cu*stos fratris mei sumego?
lo.Dixityue ad eum:Quid fecisti ? vox san-guinis fratris lui cla-mai ad me de terra,
11. Nunc igitur ma*ledictus eris super ter-Tam, quae aperuit ossuum , et suscepit san*g ulne m fratris tui demanu tua.
9. E il Signore dissea Caino : Dov' è Abeletuo fratello? Ed ei ri-spose : Noi so : son ioforse il guardiano dimio fratello?
10. E il Signore glidisse: Che hai tu fatto?la voce del sangne dit uo fratello grida a medalla terra.
11.Or tu adunque sa-rai maledetto sopra laterra, la quale ha aper-ta la sua bocca, ed haricevuto il sangue deltuo fratello della tuamano.
avesse moglie , e famiglia: e i «acrifixii, che egli offeriva, sembra-no indicare, che eyli avesse casa a parte non uieu, che Caino.
* E Caino disse ad Abele suo fratello: Andiamo fuora,Ebr. Caino parlò ad Abele , e quando ei furono alla campagna.
Vers. 9. Dov' e Abele ? . . . fon io forse il guardiano dì miofratello? Dio colla interrogazione, che fa a Caino, porge ali* ini-quo fratricida occasione di riconoscere e confessare il suo pecca-to, e chiederne misericordia; ma egli colma la misura di sua ini-qui tà coli'arrogante risposta, e col seguitare a coprire il suopeccato.
Vers. io. Che hai tu fatto? la voce del sangue di ino fra-tello ec. Tutte queste parole di Dio hanno una forza ed unaveemenza somma ad esprimere 1' atrocità del peccato commessoda Caino. El le riguardano ancora ogni omicidio in generale, per-chè la rel igione insegna agli uomini di considerarsi l'uno 1' altrocoinè fratel l i .
Vers. 11. Sarai maledetto topra la terra. Tu porterai il pesode l la mia maledizione, in qualunque parie della terra tu rivolgai lun i passi ; perchè tu la stessa terra hai imbrat tata del sanguedi tuo fratello. L* Ebreo legge : maledetto tu dalla terra o siariguardo atta terra; come «e dicesse la terra stessa ingrata al-U ina fatiche dare a vedere , che tu lei uà uomo maledetto ,

ia.Cs/w operalus fue*ris eam, non dabit tibifructus suosi vagus etprofugus erls super ter*rum.
i S.toixitque Cain adDominum : Major estiniquità^ mea : quamut veniam merear.
14» Ecce ejicis mehodie a facie terrae , eta facie tua abscondaret ero vagus et profu-gus in terrai omnis igi-tur, qui incenerii me ,occidet me.
19. Dopo che tn 1' a-vrni lavorala, non daràe te i suoi frulli: lu sa-rai vagabondo e fug-giasco sopra la t e r ra .
13. £ Caino disse alSignore: E' si grande ilmio peccato, eli' io nonposso meritar perdono.
14. Ecco che luoghimi discacci da questalerra , ed io mi nascon-derò dalla tua faccia ,e sarò vagabondo efuggiasco per la terra :chiunque pertanto rnitroverà 3 darammi lamorte.
odioso & Dio, e io certo modo alla terra medesima pel tuo granmisfatto.
* Ha ricevuto. Ha bevuto. 11 janguc del tuo fratello dallatua mano. Sparso dalla tua mano.
Vers. 13. E $\ grande il mio peccato ce. Sentimento di Teradisperazione sommamente ingiurioso a Dio , la cui misericordianon ha coniine.
Vers. i4* Da quei La terra: dalla patria, dalla società do' mieigenitori e parenti.
Mi nasconderò dalla tua faccia. Dio degnandosi in que'pri-ini tempi di apparire sovente agli uomini , e di t ta t tare amore-volmente con essi, Caino dice, che egli beo lungi dal l 'anabirc uàsimil favore, non potendo soffrire la presenza di lui,ebe egli ri-prarda come nemico, cercherà di nascondersi ( se posibile fia )a' tuoi sguardi'
Chiunque mi troverà darammi 1 a moris. Veggonsi in Cainotutt i i terrori della mala coscienza. Ma è da notarsi, come nonTira di Dio, nè la morte dell' anima egli teme, ma gli nomini, ela perdita della vita presente,
* Chiunque pertanto mi troverà, M' ioj;onlre.rè.

15. Dixìtque ei Do*minus'Nequaquam itafieli sed omnis qui oc-ciderit Cain^septuplumpunietur « PosuitqaeDominus Cain signum^ut non interficeret eum.omnis , qui invenisseteum,
16. Egressusque Cainn facie Domini, habita-vit profugus in terraad orienlalenì: plataniEden.
17. Cognovit autemCain uxorem suam,
• quae concepii, et pepe-rii Henoch : et aedifi,"cavit cwitatem , voca-
I vitque nomen ejus exnomine filii sui Jffenoc.
io. E i! Signore glidisse : Non sarà così:ma chiunque uccideràCaino,avrà gastigo set-te volte maggiore. E ilSignore mise sopraCaì-no un segno, affinchènessuno di quelli , cheJo incontrassero, lo uc-cidessero.
i6.E andatoseneCai-no dalla faccia del Si-gnore fuggitivo per laterra, abitò nel paeseche è ali' oriente di E-den.
17. E Caino conobbela sua moglie, la qualeconcepì, e partorì H«ì-noch i ed egli fabbricòuna città ; a cui diednil nome di Henoc dalnome del suo figliuolo .
Vres. 15. Avrà, gastigo sette volte maggiore. Dio vuole , cheCaino rimanga in vita per esempio agli a l t r i uomini de l l 'odiosuo contro gli omicidi. Chiunque pertanto ardisse di metter ma«no addosso a Caiuo, protesta il Signore,che avrà pena sette volte,cioè grandemente maggiore di quella dello stesso Caino.
11 Signore mise sopra Caino un segno ec- La maggior parte<le' padri credono, che questo segno fosse un tremore continuoed universale delle membra, accompagnato da un' aria di voltotruce ed orribile, la quale facea consscere 1' agitazione di sua
~ coscienza.Vers. 16. * Fuggitivo per la terra, abito nel paese , che e
. .ali' oriente di Eden. Ebr. Abitò nella terra di Nod ali' oriente' di Eden: Abi t i ) vagabondo nel la terra «11' oriente <li Eden.
V< Vers. i']. Fabbrico una citta ec. Queste senta dubbio è la''ciua più aulica,che (uastj al momÌ9,forst CAÌB.O prese il partita

18. Porro Henòc ge.nuit Irad, et Irad ge-nuli Maviael, et Ma-viaelgenuitMathusaeltet Mathusael genuitLamecb.
i g Qui accepit duasuxoresjiomen uni A da,et nomen alteri Sella.
20. Genuitque A daJabel, qui fuit paterhabitantium in tento-rìis, atque posterum.
91. Et nomen fratrisejus Jubal : ipse fuit
18. Or Henocìi gene»ró Irad , e Irad generòMaviael, e Maviaal ge-nerò Malhusael, e Mal-husael generò Lamech.
15. Il quale presedue mogli, una che eb-be nome Ada, un' altrache ebbe nome Sella.
20. E Ada partorì Ja-bel , che fu il padre dique' che abitano sottole tende, e de* pastori.
21. Ed ebbe un fra-tello per nome* Jubal :
dì edificarla per prevedere alla sua sicurezza nel timore , ebeavea continuamente di essere ucciso.Ma qui non posso far a me-nò di riportare la bella riflessione di s. Agostino de cii>. l ib. xv. 8,Da que*duè progenitori dell'umana stirpe, Caino, clic appar-teneva alla città degli uomini, fu il primo a nascere ; Abele^che apparteneva alla citta di Dio, venne di poi. Con} in tuttoil genere umano prima nasce il cittadino di questo secolo , edi poi quello che e pellegrino nel secolo,e alla città dt Dìo ap'partiene , essendo predestinato per grazia, per grazia eletto ,per la grazia pellegrino quaggiù, per la grazia cittadino las-sù. , . Stet scritto adunque di Caino, ch? egli edifico una città:Abele poi » come pellegrino, non ne edificò , perche la cittàde* Santi e colastù, benché qui ella sijaccia dt? cittadini. Vediquello ebe di AJjrarno scrive 1' Apostolo, ffebr xi. 8 g. io.
Vers. 19. Prete due mogli. Lamecb adunque fu il primo, cheardisse di da%e questo pessimo esetnpio;ond'egli è chiamato uo-mo maledetto da Tertul l iano, adultero da Niccolo I, ed è ugual-mente condannato da s. Girolamo. La poligamia , ebe vedremopraticata da'santissimi Patriarci)! Abramo, e Giacobbe, e e. ebbeper ragione una speciale dispensazione di Dio.
Vers. 20. Jabel, che fu il padre ec. Vale a dire, egli promossegrandemente la vita pastorale,e molte cose inventò r iguardo allacura de* greggi , alia quale fu addetto unicamente egli, « i suoidiscendenti.

pater canentium citha-ra et organo.
22. Sella quoque ge-ììuit Tubale ain,qui fuitmallealor, etfaber incnncta opera aeris etferri. Soror vero Tu»balcain Noema*
^.Dixitque Lamechuxoribus suis , Adae ,et Sellas : Andile vo-cem meamt uxores La-mech , auscultate ser-monem meumtquonìamoccidi virum in vulnusmeum , et adolescente*lum in livorem meum.
ed egli fu il padre deisonatori di cetra e di'organo.
22. Sella partorì arMebe Tubalcain , che la-vorò di martello , e fotartefice di ogni sorta dilavori di rame e di fer-ro. Sorella poi di Tu*balcain fu Noema.
23. E disse LamecNalle sue mogli, Ada , eSella: Ascoltate la miaivoce, o donne di La-mech, ponete mente al-le mie parole: io uccisiun uomo con ferita fat-tagli da me , e un gio-vinetto co' miei colpi.
Vers. ai. Patir» detonaturi di cetra o <P organo. Sotto nome*di cetra si comprendono probabilmente tutti gli stromenti dafcorda, e sotto nome d' organo , ovvero flauto , *' intendono glis t rument i a flato. Abbiamo qui notata da Mo»è l'invf nzionedellea r t i necessarie ed u t i l i alla vi ta , in lempo molto anteriore a quel-lo , in cui secondo gli autori p ro fan i fu rono i n v e n t a t e le stessearti. Da ciò vergiamo, che i Fenici! e i Greci ebbero assai tard»cjtiesti ritrovamenti, i quali erano già antichi neJl'Assiria, e nellevicine regioni, che furon1» abitate prima d' ogni altra.
Credesi, che IVoenrn inventasse 1' arte di filare la lan? , e ditesserla, e fosse conosciuta da'Greci sotto il nome di Nemanitn,che è la loro Minerva .
Vers.a3. Io uccisi un uomo ec Chi sia l 'uomo ucciso da La-mech non possiamo dirlo con sicurezza. Gli Ebrei, secondo unaloro s t radizione riferita da s. Girolamo, dicevano, che LamecT»avesse accidentalmente dato morte a Caino, e che di questo fat-to egli parli alle sue mogli, dicendo loro , che non temessero,perciò, che ne avvenisse a IHÌ alcun male, perchè se una sev«^?.>
no, o l t r e modo più grave sarebbe la pena d'i chi uccidesse La-inech ; conciossiachì?, come si suppone, Laaieck.aou avea volou-

f 24. Septuplum ultiodabitur de ^Cain -9 deLameck vero septua»gìes septies.
26. Cognovit quoqueadhuc Adam uxorem$uam: et peperit filium^vocavitque nomen ejusSeth, dicens i PosuitmìhiDeus semen aliudpro Abel quem acciditCaia.
24- Sarà falla ven-detta dell' omicidio diCaino sette volle ; diquel di Lamech settan-ta volte sette volte.
26. E Adamo ancoraconobbe nuovamentela sua moglie : ed ellapartorì un figliuolo } acui pose il nome diSeth,dicendo: II Signore miha data nuova discen-denza in luogo di Abe-le ucciso da Caino.
tariamente, ma per meri disgrazia ucciso Caino, In questa sposizione però è da osservarsi, che l'uomo della prima parte del ver-setto si fa lo stesso col giovinetto della seconda parte , manieradi ripetizione usata sovente nelle Scritture. Ma chi crederà, cheun nomo, come Caino, possa chiamarsi giovinetto? Quindi sullafede della stessa tradizione ebrea si aggiunge, che Lamech aveaucciso e Caino, e un giovinetto, il q uale era stato col suo errorela causa del primo omicidio. Ma così sarebber due omicidi! , enon si potrebbe comprendere-, come potesse Lamech pretenderedi dovere, o poter essere privilegiato più di Caino. Se sopra unpasso sì difficile ardissi di esporre il mio sentimento, io cradurrelquesto versetto così; Io ho ucciso nn uomo per ferire me stesso,e «n giovinetto per impiagarmi: e»questa traduzione, che com-bina colla versione de' LXX, lega anche col versetto seguente ,il quale la illustra. Io , dice Lamech, ho ucciso un uomo permio danno, per mia sciagura, facendo più male a me, che a lui ,imperocché se grave fu il castigo dato a Caino, il castigo del miomisfatto sarà più atroce. Del rimanente a chi mi dimandasse, chieia 1' uomo , e il giovinetto , di cui parli Lamech , risponderci ,ch' io noi so.
* Un giovinetto nel mio livore. Uà giovinetto con un colpo" ,da me datogli.
Vers. 24. Sarà fatta vendetta dell* omicidio di Caino settevolle ec. Il Siro, l'Arabo, e molti padri interpretano in tal guisaqueste parole: Caino per avere ucciso Abele e stato punito settevolte; io per P omicidio da me commesso sarò punito settanta ^yoUe »eu« volte, cica con peoa 9pwu>a,itte.ute più grave, J

C A P O V .
26.S ed e.t Seth natusest filius, quem vocavìtE nos : iste coepit invo-care nomen Domìni.
26, E nacque andrea Seth un figliuolo ,ch* egli ch'i a m o E nos :questi principiò ad in-vocare il nome del Si-gnore.
CAPO V.
Genealogìa di Adamo, e de1 suoi posteri discesida Setkt ed anni della loro vita fino a Tioè.
i.. XJL ic estliber $e-nerationis Adam» Indie, qua creavit Deushominem , ad similiiu-dinemDeifecit illum(i);
2. Mas culumi etjoe*minam creavit eos , et
1. v^Juesta è la ge-nealogia di Adamo. Neidi in cui Dio creò 1* uo-mo, lo fece a somiglian-za di Dio.
2. Lo creò maschio .e femmina, e li bene
(i) Sap. I. 27. In/r. 9. 6. Sap. 2. 25. Eccl.-17-1-' ' . ' . • ' - - . - ' - " "" '
Vers. a5. A cui pose il acme di Setti. Anche qui la madre dail nome al figliuolo. Seth significa «no, ch'è posto> ovvero fon-damento , perchè questo figliuolo dovea essere io vece di Àbelefondamento della sua discendenza. Egli nacque Panno i3o di
Adamo , cap. v. 3.Vers. 26. Questi cominciò ad invocare il nome del Signore.
Vale a d i r e , egli cominciò ad is t i tu i re molti de' riti, e delle ce-rimonie del pubblico culto da rendersi al Signore. Egli non ful ' inventore della religione ,, la quale nacque coli' uomo, ma dicerte maniere di soddisfare a' doveri della religione ne' sacrili-z i i , nel le oblazioni , e uelle altre parti dell' esercizio pubblicodel la medesima religione.
Vers. i. Questa è la genealogia di Adamo, lo questa genea-logìa , lasciato Caino da patte colla sua posterità, spuo noveratii discendent i di Adamo per via di Setb fino a Noè. Seth è lo sti-pite del popolo eletto , e il progenitore de'maggiori del Mesiìà,il qnale è senipie 1' oggetto di questi libri di Mosè, come di tut-te le Scritture.

bqnedixit illis: et foca-vil nomen eorumAdami a die , quo creati sunt.
3. VixitautemAdamce n tum friginta annis:,et gemiti ad imaginemet similitudinem suamtvocavitque nomen ejusSetp.
4- Etfacti sunt dies(i) Adam , postquamgenuil Seth, octingentianni ; genuitque filioset fiHa$.
3.Et factam est omnetempus , quod vixit A-dam, anni nongenti tri»ginta, et mortuus est.
disse: e diede loro il no*me di Adam il di , incui furo n creati.
3. E Adamo vissecento trenta anni : egenerò , a sua immagi-ne e somiglianza , uàfiglio, a cui pose nomeSeth.
4» E visse Adamo,dopo avere generaloSeth, ottocento ann i ,e generò figliuoli e fi-gliuole.
5. E tutto il tempo ,che visse Adamo, fu. dinovecento trenta anni,e mori.
(i) Par. i. i.
\erti . Diede toro il nome di Adam. All'uomo,e alla donnada sé creati diede Dio il nome di Àdam; signif icante la loro crea-zione dalla terra, poiché Adatn vuol dir terra.Ebbero ambeduelo stesso nome per denotare, come doveano essere i due una solacarne,e una sola cosa mediante l'unione stabil i ta tra essi da Dio.
. Vers. 3. Generò a tua immagine e somiglianza ee. Generò«n figliuolo interamenre simile a «è nella Datura, simile sì quan-to al corpo, e si ancora quanto ali* anima.
* Cenerò a sita immagine e somigliata. Co) dirsi V uomo,guastata io «è l'imuin* e somiglianza originaria con Dio,generarfigli a sua somigliamo, s' insinua da quello io questi trasfonder-si il disordine della colpa.
Yers, 5, M tutto il tempo che vitse Adamo, fa di novecentotrenta anni, e morì. Questi anni della vita d'Adarao,come deglialtri patriarchi, sono certamente anni di dodici mesi; come è sta-to già evidentemente dimostrato da molti. Gredesi, che ad usa•i lunga yita abbia potuto contribuire la bontà de'temperamenti,la frugalità, la miglior qualità de'frutti della terra, che erano illoro ci bo, e i quali deteriorarono dopo il diluvio; ma checché »iadj tutto questo, egli è assai più ragionevole di attribuire questalunghezza di vita alla volontà di Dio, il quale così ordinò, afta-

6* Vixit quoque Sethcentum quinque annistet genuit Enos.
7. Vixitque Seth,postquam genuit Enos^octingentis septem an-nis , genuitque filios etfiiias.
S.Etfacti sunt omnesdies Seth nongentorumduodecim annorum, etmortuus est.
g. Vixit vero Enosnonaginta annis> et ge"nuit Cainan,
io. Post cujus ortumvixit octingenus quin»decim annis , et genuitfilios et fiiias»^11- Factique suntlìmnes dies Enos non-
6. E visse Selh cei*.to cinque anni, e gene,rò Enos.
7. E visse Seth, dopoaver generato Enos, ot-tocento sette anni , egenerò figliuoli e fi-gliuole.
8*E tuttala vila diSeth fu di novecentododici anni, e morì.
9. E visse Enos no-vanta anni , e generòCainan.
10. Dopo la nascitadel quale visse ottocen-to quindici anni, e ge-nerò figliuoli e figliuole,
11. E tutto il tempodella vita di Enos fu di
ebe più presto si propagasse il genere umano, eie arti e le scien-ze, e molto più il culto dfDio, e la tradizione e i principii dellareligione si tramandassero più agevolmente a'posteri più rìmothAdamo adunque con una sì lunga vita vide la moltiplicazione ela corruzione del genere umano:egli morì in tempo che Lamecb,padre di Noè avea cinquanta sette anni. Adamo passo la sua vitanella penitenza: e in mezzo alle proprie sciagure e alle afflizionierre gli trapassarono 1* anima nella perdita di un figliuolo inno-cente, e nella riprovazione del primogenito, e nella depravazio-ne orribile de* discendenti dello stesso primogenito, seppe eglialzare il suo cuore e le sue speranze fino a quell'unico Salvatorepromesso , che dovea nascere della sua stirpe, e meritò ebe laSapienza divina lo salvasse dal suo peccato,come si legge Sap,\.i, 2., e come ha creduto e crede la Chiesa con tal fermezza, ches, Agostino e s. Epifanie non han dubitato dì condannare d'ere-sìa gli Encratiti per avere negato, ebe Adamo ed Èva conseguis-te™ la salute. La Chiesa Greca fa commemorazione di Adamo edi Èva ai 19 di novembre,

genti quinque anni , etmortuus est.
12. V'ixit quoque Cai-n an septuaginta an ni s tet genuit Malaleel.
13. Et vixit Cainan ,postquam genuit Ma-laleel, octingentis qua-draginta annis, genuit*que fitios et filias.
i4- Et fac ti sunt o-mnes dies Cainan non~genti decem anni , etmortuus est.
15. Pixit autem Ma-laleel sexaginta quin-que annis j et genuitJared.
i 6. Et vixit Mala-leel, posquam genuitJared, octingentis tri-gìnta annis , et genuitfilios etfilias*
1*7. Et factisunt om-nes diesMalaleel octin-genti nonaginta quin-que anni, ei mortuusest.
18. Vixitque Jaredcentum sexaginta duo-bus annis, et genuitHenoc.
19. Et vixit Jared ,postquam genuitHenoc,octingentis annis\et ge-nuit filios etfilias.
novecento cinque anni;e morì.
12. Visse ancora Cai*nan settantanni, e ge-nerò Malalee).
13. E visse Cainan,dopo aver generalo Ma-laìeel, ottocento qua*ranta annij e generò fi-gliuoli e figliuole,
i4- E lutto il lempojche visse Cainan , funovecento dieci anni 3 emorì.
13. E visse Malaleelsessanta cinque a r fn i ,e generò Jared»
ì6. E visse Malaìeelidopo aver generalo Ja-red j ottocento » ren laanni , e generò figliuo-li e figliuole.
17. È tutta la vita diMalaleel fu di ottocen-to novanta cinque an-ni , e morì»
i8.E visse Jared cen-to sessanta due anni ,e generò Henocb.
tp. E visse Jared,do.po aver generalo He-noch , 800 a n n i , e ge-nero figliuoli e figliiiole.,

20è Et Jactl sunt o-mnes dies Jared non-genti sexaginta duo an-ni , et mortuus est.
zi. Porro Henoch vi-xit sexaginta quinqueannis,et genuit Mathu-salàm.
22. Et ambulavit He-noch cum Deo: et vixìt,postquam genuit Ma-thusalam> trecentis an»nis, et genuit filios etfilias.
a o. Et facti sunt o-mnes dies Henoch tre-centi sexaginta quin-que anni.
«4- (O Ambulavitquecum Deo , et non appa*ruit: quìa tulit eumDeus*
20. E tutta la vi la diJared fu di novecentosessantadue anni, e simori.
21. Ed Henoch vìssesessantacinque anni , egenerò Matbusala.
22. Ed Henoch cam-minò con Dio e visse ,dopo aver generato Ma-ihusala , trecento anni ;e generò figliuoli e fi-gliuole.
23. E tutta la vita dìHenoch fu di trecentosessanta cinque anni:
24. E camminò conDio , e disparve : per»chè il Signore lo rapì.
(i)Ecct. 44. 15. Hefa'u. 6.
Ver». 24. Cammino con Dio. Vale a dire , visse con tal pietàe tal sen t iment i di religione, che parve, avesse Dio sempre pre-sente, e con lui e dietro a lu i camminasse.Luogi dal lasciarsi se-dur re da'pessimi esempi degli alt nomini , egli fece aperta pro-feisione di temere Dio, e d' onora o in tut ta la sua vi ta .
Disparveyerche il Signore lo api Questa maniera di parla-re, la quale è adoperata qui da M è cer tamente non a caso, ede s imi l in ima a quel la , onde serve la sc r i t t u ra r iguardo adElia ,/io. »v. Rcg. n.iG. i 7., porgejut o il fondamento di credere ,che Lnoeb vive tu t to ra , e ebe egli fu trasportato da Dio fuor idel rribndo, come avvenne dipoi ad Eli», donde ambedue debbo-no poi ritornare a predicare alle nazioni la penitenza , e a com-battere contro 1» Anticristo, da cui saranno messi a morte. VediApocal. xi 3. 4. L'Apostolo Paolo illustra mirabilmente queste,luogo della Genesi, e conferma la comune interpretazione de'Pa-

zb.Vixit quoque Ma-thusala centum octogin-ta septem annis> et ge-nuit Lamech.
26. Et vixìt Mathu-$ ala, postquam genuitLamech, septingentisoctoginta duabus annis,et genuit filios et fi-lias.
27. Et facti sunt om-nes dies Mathusalanongenù sexaginta no-vem annidi mortuus est.
28. yixit autem La-mech centum octogintaduabus annis', et genuìifilium.
26. E visse Malhusa-la cento ottanta setteanni, e generò Lamech.
26. E visse Matbusa-la , dopo aver genera-to Lamech, settecentoottanta due anni, e ge-nerò figliuoli e figliuole.
27. E tutta la vila diMathusala fu di nove*cento sessanta rio ve an-ni, e morì.
28. E visse Lamechcento ottanta due anni,e generò un figliuolo.
dri, e degl* Interpreti cattolici: Per la fette Enochfu traspor-tato , perche non vedesse la morte , e non fu trovalo , perchetraslatollu Lidio: imperocché prima della trattazione, fu lo-dato, come accetto a Dio : or senza la fede è impossibile dipiacere a Dio. Una profezia di Eooeh è riferita da s.Giuda nellaaua lettera canonica vers. i^. 15.«e di essa abbiamo parlato incj(testo luogo La Scrittura non dice , dove sieno stati trasferiti<la Dio Enocb ed Elia. S i legge nell'F.cclesiastico.-Enotf/i fu tra-tferito nel par adito: ma oltre che queste parole nel paradisomancano nel testo greco, e i padri non le lessato , non potrem-mo neppure affermare eoo certezza quello che intendasi in quelJuogo pel paradiso : imperocché quanto al paradiso terrestresembra indubi ta to , ebe ei fosse coperto dal diluvio, come tuttele al t re part i del mondo. S. Girolamo spiega con queste paro-le: Enoch ed Elia trasportati co' loro corpi nel Cielo sotto ilgoverno e disposizioni di Dio,
* Cammini) con Dìo. LXX. piacque a Dio.\'ett.zn.La vita di Mainatala fu'di novecento sessanta no-
ve anni. Essendo egli nato 1' anno 687 , ed essendo vissuto 9'19anni . egli per conseguenza morì 1' anno del mondo i656, vale adire l'anno stesso del diluvio, e pochi di prima dello stesso diiu-vio , come notò s. Girolamo, e &li Ebrei.

29» Vocavitque no-men ejus Noe , dicens :Isteconsolabitur nos aboperibus et laboribusmanum nostrarum interra , cui maledixitDominus.
So.yixitqueLamech,postquam genuit Noe ,quingentìs nonagintaquinque annis , et ge-nuit filio*- et filius
31. JLt facti sunt om-nes dies Lamechj sept-ingenti septuaginta se-ptem anni , et mortuusest. Noe verojcum quin»gentorum esset anno-rum, genuit SemtCham%et Japheth.
29. E gli pose nomeNoè dicendo : Questisarà nostra consolazio-ne ne' travagli e nellefatiche delle nostre ma-ni in questa terra, cheè stala maledetta dalSignore.
30. E visse Làmech,dopo aver generaloNoè,cinquecento novanta-cinque a n n i , e generòfigliuoli e figliuole.
31. E tuttala vita diLaméch fu di settecen-to setlantasette anni ,e si mori. Ma Noè , es-sendo in età di cinque-cento anni, generò SemCham 3 e Japheth.
Vres. 20. Questi sa fa nostro, consolazione ec. Lamech conprofetico spirito previde a quali cose era destinalo da Dio il fi-gliuolo ; e perciò gli pose il nome di Noè, che qui s* ioterpretaconsalatore. Or iu più maniere Noè sarà la consolazione degliuomini. Primo, perchè egli sarà il ristoratore del genere umanosepolto sotto il diluvio : secondo, perchè nel meri to di sua virtùe in grazia del suo sacrifìzio dopo il diluvio Iddio benedirà lalena; alla qual cosa sembra che al ludano specialmente le paroledi Lamech: Questi s arà nostra consolazione ... sit qnestaterramaledetta da Dio : terzo , perchè da lui nascerà i) messia, ilquale, secondo la parola dell' Apostolo , è nostra pace.
Vers.3 i. Essendo in età di cinquecento anni, generò Sem ec.Egli osi astenne dal matr imonio fino a queli' età, o sino alloranon ebbe prole, o, se ne ebbe, i figliuoli di lui sedotti da'maliesempi degli altri , e abbandonatisi al vizio, meritarono di essererigettati dalla famiglia del giusto loro padre. Vedi s. Agost. decif, lib. xv. 20. Japheth fu il primogenito de'tre figliuoli di Noè,

CAPO VI.
I peccali degli uomini causa del diluvio. Noè ètrovato giusto, ed a lui è ordinata la fab bricadell' arca , nella quale si salvò egli, e tut te lespecie degli animali.
1. \~/ imque coepis-sent homines multipli-cari super terram , etfilìa v procreassenty
2. V~ident.es filii Deifilias hominum , quodessent pulcrae, accepe-runt sibi uxores ex o-mnibus, quas elogerai.
3. Dixitque Deus:yon permanebit spiri-tus meus in homine in
1. I--* avendo prin-cipiato gli uomini amoltiplicare sopra la(erra 3 e avendo avutodelle figliuole,
2. 1 figliuoli di Diovedendo la bellezza del-le figliuole degli uomi-ni, preser per loro mo<rgli quelle che più ditutte lor piacquero.
3. E il Signore disse:Non rimarrà il mio spi-.rito per sempre uè 11.'
Vers. i. e 2. Avtnfli) principialo gì i uomini a moltipllcare 1figlinoli di Dio vedendo te. Quello, che qui per una specie direcapitolazione viene a narrare M osé , cominciò ad accèdere, se-condo Teodoreto,intorno alla settima generazione, e circa'i tem-pi di Eooch. Da Noè adunque torna indietro Mosè a descriverela pessima condizione dell'età precedente al diluvio; e raccontaper primaria orìgine della corruzione degli uomini i ma t r imon i iiìontratti da' discendenti di Seth con le figliuole della stirpe diCaino: imperocché, secondo la comune interpretazione de'padrie degl'Interpreti callolic'i,figlinoli di Dio sono chiamati i f igl iuo-li di Seta, nella stirpe del quale erasi conservata la pietà e larelgione, come figliuoli e figliuole degli uomini sono chiamatiquegli e quelle della stirpe diCaino che imitarono il loro padre.
Vers. 3. Non rimarrà il mio spirito per sempre «<?.Spirìlo diDìo dicesi in quetto luogo l'anima e la vita data da Ini all'uomocol suo soffio divino. Din pertanto giustamente adirato centrodegtLuominidice, ebe eoa conserverà ancora ad essi la vita per

aeternum,quia caro est:eruntqne dies illius cen-tum viginti annorum.
4. Giganfes autem e-rant super terram indiebus illis : poste/namenim ingressi sunt filiiDei ad filias hominum,illaeque genuerunt, istisunt potentes a seculoviri famosi.
5. Videns autemDeus , quod multa ma-litia hominum esset interra , et (i) cuncta co-gitatio cordis intentaesset ad malum omnitempore,
uomo, perchè egli è car-ne : e i loro giorni sa-ranno cento vent i anni.
4- Ed erano in queltempo de1 giganti sopra3a terra: imperocché do-po che i figliuoli di Dio siaccostarono alle figliuo-le degli uomini, ed ellefecer figliuoli,ne venne-ro quelli possenti in an-tico, e famosi uomini.
5. Vedendo adunqueDio j come grande erala malizia d^gl i uominisopra la terra; e tulli ipensieri del loro cuoreerano intasi a mal farecon t inuamente ,
(i)//?/r, 8.21. Matth. 16.19.lungo trat to di tempo , perchè ei son divenuti tutti caroal«;*alea d i r e vivono, come se non fossero altro che carne, e non ad al-tro pensar dovessero, ebe a soddisfare la carne. Fissa perciò iltermine di sua pazienza a cento anni, dopo de' quali darà di ma-no al gastigo. Dio adunque de n iniziò agli uomini il d i l u v i o l'an-no 48o di Noè, vent i a n n i p r ima che egli avesse il primo de' tref i g l i u o l i ; perocché il d i luv io cominciò 1' anno 600 della vita diNoè. Vedi s. Agost. de civ. lib. xv. 24.
Vers. 4 Erano in quel tempo de'giganti ee.Quello che nellanostra volgata è t radot to colla voce gìganti,ìa a l t re antiche ver-sioni è tradotto nomini violenti , uomini impetuosi. Mosè de-scrìvendo la cagione del d i l u v i o racconta , che d a ' m a t r i m o n i ide l le f ig l iuo le di Dio co' f igl iuol i degli uomini ne nacque unaTazza di uomini di gran corpo e statura , e robusti , senza frenodi religione, pieni di ferocia, e di genio di mal fare. Questi (di-ce Mosè ) sono quegli uomini , de' quali tanta fu in quei tempiantichi la possanza e il g r ido , che si acquistarono colle loroprepotenze. Quanto agli uomini «di statura s t raordinar ia , ne ab-biamo de' document i in vari luoghi della Scrittura, Deiit. ni. ».Nam. xni. 33. 34. fedì ancora t. Agostino de civ. xv. z3.
Vers. 5, * Grande era la malizia. Ebr. Estrema,

G.Posnìtuìt eum.quodJiominemfecissetin ter-ra.Et taclus dolore cor-dis intrinseciiSi
7. Dele&o, Inquit, ho*minem, quem creavi , a/ade terrete, ab homineusque ad animantia , areptili usque ad volu-cres coeli'.paenìtet enimmefecisset eos,
8. Noe vero invenitgratiam coramDomino.
9. Hac sunt genera-tane s Noe-, (i) Noe virjus tu 9 , atque perfectusfuit in generatìonibussuis, cum Deo ambula-vii,
10. Et genuit tres fi'
6. Sì pent ì cT avprfallo 1' uomo . E presoda intimo dolor di cuo-re,
7. Sterminerò, disseegli 5 1' uomo da mecrealo dalla faccia dellaterra , dall' uomo finoagH animali , f i a ' r e i l i l ifino agli uccelli dell' a-ria; imperocché mi pen-lo d* averli f a l l i .
8. Ma Noèlrovò gra-zia dinanzi al Signore.
9. Questi sono i fi-gliuoli generali da Noè.Noè fu uomo giuslo, eperfetto ne' suoi lempì,camminò con Dio.
10. E generò Ire fi-
(i) Eccl. 44. 17.
Vers.6. Si pentì eli ove? fatto ly nomo ec. Dio , cui milo ècompre presente, ed il qnale non è soggetto nè a pentimento ,nè »r«M#re , si dice pentirsi e dolersi , allorché p e r l a ing iu-stizia e ingrati tudine degli uomini, risolte di toglier loro i do-cortfenti è le grazie , detle quali era stato liberale con essi. Si*mili espressioni nelle Scritlùr'e /le quali parlando agli uominiiron possono far uso, se tìón di nn linguaggio intelligibile a que-sti ) servono a dimostrare 1' enorme gravezza delle ingiurie lattea Dio, e l 'orrore che debbe avere l ' uomo giusto dellamostruosa senescenza degli uòmini verso del lor Creatore.
* E preso. E colpito da intimo 'doler di cuore.Vers. 7. Dati' uòmo sino agli animali , ec. Cosi 1' uomo è
ptratto anche collapmatiotte di tutte quelle cose, delle quali«gfi abusata io offesa del Signore.
^Vera, g. Noè fit nomo giusto «'perfetto we'jcr/oi tempi Grau-dissimo elogio d* un «oino il mantenersi fedele nella perfidia ecorruiiouc universale,

lios, Sem, Cham, et Ja-pheth.
11. Corrupta est au-tem terra coram Deo,et rtpleta est ìniquìtate.
12. Cumque vìdissetDeus terram esse cor-ruptam ( omnis guìppecaro corruperat viamsuam super terram)t
13. J)ìxit ad floe:Fi-nis unwersae carnisvenit coram me : reple-ta est terra iniquitate afacie eorum, et ego dis-perdam eos cum terra*
i4- 1?ac libi arcamde lignis laevigatis :mansianculas in arcafacies, et bitumine li'nies intrinsecus et ex-trinsecus.
gliuoli , Sem , Cam, eJapheth.
11. Ma la terra eracorrotta davanti a Dio,e ripiena d ' iniquità.
12. Ed avendo Dioveduto come la terraera corrotta ( perocchéogni nomo sulla terranella sua maniera divivere era corrotto),
13. Disse a Noè:La fi-ne di tutti gli uomini èimminente ne' miei de-creti; la terra per ope-ra loro è ripiena d' ini-quità , e io gli s termi-nerò insieme colla terra.
14. Fatti un' arca dilegnami piallati : tu fa-rai nell' arca dell» pie-,colè stanze , e la inver-nicerai dì bitume e dìdentro e di fuori.
Vers, 12. * Nella sua maniera di vivere. Nel snovivere.Vers. i4- Fatti un' arca di legnami piallati. S, Girolamo
crede, che l'ebreo significhi legnami inverniciati di bitume: madel bitume «i parla in appresso. Altri traducono legnami di ci-prestot e dicesi che nel!' Armenia e nell' Assiria, dove credestche abitasse Noè, non vi sia altro legname atto a farne una graanave, come 1' arca , fuori del cipresso.
Farai nelV arca delle piccate ftanze. L'aulico autore dellequestioni sopra la Genesi credette, che 1' arca fosse spartita ìuquattrocento di queste piccole stanze; altri ne mettono UD po*meno.
Le invernicerai dì bituma. I LXX., il Caldeo, il Siro, e famaggior parte degl'Interpreti convengono colla volgala, che Noèsi servi dell'asfalto , o sia bitume, in cambio di pece.

a5.E/ sic facies eam:Trecentorum cubìtorumerit longitudo arcae,quinquaginta cubìtorumla Mudo, et triginta cu-bitorum altitudo illius.
16. Fenestram in ar-ca facies , et in cubitoconsummabis summita-tem ejusi ostium autemarcae pones ex latere :deorsum coenacula, ettris te go facie s in ea.
#••
17. Ecce ego addu-eam aquas diluvii su-per terram^ut ìnterfi-ciam omnem carnemjn
15. E la farai in que»sto modo: La lunghez-za dell'arca sarà di tre-cento cubiti, la larghez-za di cinquanta cubiti ,1' altezza di t renta»
\6 . Farai nel!' arcauna finestra , e il tettodell'arca farai, che vadaalzandosi fino a un cu-bito: farai poi da un la-to la porta dell' arca: vifarai un piano di fondo,un secondo piano, e unterzo piano.
17. Ecco, che io man-derò sopra la terra leacque del di luvio aduccidere tu t t i gli ani-
Vers. i5. La lunghezza dell' arca sarà di trecento cubiti,la larghezza di cinquanta, e l'altezza di trenta. Poste quested imens ion i , ne viene, ohe la capaci tà in t e r io re dell ' arca era diquattrocento c i n q u a n t a mi la cubitU; e il cub i to è misura di impiede e mezzo. Per la qual cosa è stato già da uomin i dott issimievidentemente dimoslsato , che uu tale spazio è piuccliè suffi-ciente per contenere t u t t i gli an imal i , e tu t to quello che abbi-sognava oell'arca. Vedi tra gli altri Buteo, Fvilkinsio pressoti Polo Synop. Crii. Sac.ee.
Vers. j6. Farainell'arca un* finestra. Questa finestra do-vea occupare uri assai grande spazio nella lunghezza dell ' arca ,e forse girava intorno all'arca all'altezza di uà cubi to, e avea1 > $«a gelosia.
E il tetto dell'arca farai che ec. Vale a dire : il tetto dell*arca non sarà pieno , ma anderà sollevandosi sino al comignoloper l'altezza di un cubito.
Rifarai il -piano fondo, nn secondo piano, ec. Giuseppeebreo , e Filone dicono , che l'arca avea quattro piani : ma con-tano per un piano la carena. Nella carena alcuni mettono laprovvisione dell'acqua , perchè la figura dell'arca non avea bi-sogno di zavorra.

qua spiritus vitae estsubler coelum : urìwer'sa , c/uae in terra, sunt,cansummentur.
iQ.Ponam g uè foedusm<;um tecum : et ingre-dieris arcam tu, et filiiluì, uxor tua , et uxo-res filiorum tuorum te-ami.
19. El ex cunctis a-nimantibus uniuersaecarnis bina in duces inarcam, ut vivant tecum,masculini sexus ì et fae-ntini ni.
20.De volucribus jux-ta genus suum , et de
mal i , che Ijanno spìri-to di vila sollo del cie-lo : tulio quello che èsopra la terra,anderà inperdizione.
18. Ma io farò il miopalio con te, ed enlre*rai nell' arca tu } e ituoi figliuoli , la tuamoglie , e le mogli deituoi figliuoli.
19. E di lutti gli ani-mali d' ogni specie duene farai en l ra re nell 'ar-ca , maschio , e femmi-na.
20. Begli uccelli se-condo la loro specie ; e
Vers. 18. Entrerai nell'arca tu, e i tuoi figliuoli._, la, inamoglie ec. Dicendosi, ch'entreranno distintamenj^Veè, 6 i suoifigliuoli , la moglie di Noè, e le mogli de^jwwrfifigliuoli , viene;. s ignif icarsi , che gli u o m i n i stette^*1 nell 'arca separati dal lee! e U H e, e osservarono contineB*3, onde nel capo x. i , par landosirie' figliuoli , che ebbero i tre figliuoli di Noè, si dice che na-cquero dopo il di luvio. Qu ind i la separazione degl i u o m i n i dal-le lor mogli , usata ne l la Chiesa Giudaica , e ne l la Cr i s t i anane'.tempi di lutto e d' penitenza./^ec/ì ffieron. in cap.\n. Zac-ctiar. v, l i .
Vers. y.o. Entreranno leco. L' Ebreo? verranno a te, s' offe-r i ranno in certo modo a seguirti nel l* arca per proprio lorois t in to , ancorché s ieno bestie feroci. Così per volere d iv ino sipresentarono ad Adamo tut t i ^li an ima l i , cap. il. 19. Vedi s.Agostino lib. xv. de civ. 27. Notisi, che dicendo qui il Signore,che di tulli gli animali di ogni sorte due ne entreranno nell*arca , maschio , e femmina , e lo stesso dicendo degli uccel-li , g iument i , ec. dimostra a Noè la sua volontà di salvare diogni specie un maschio, e una femmina, riserbandosi a spiega-re più d is t in tamente il numero, ebe dovea mettersene neli^arca secondo la qual i tà di mondi , o immondi,yedieap.'seguen-le ve .2,

lumentis in genere suo,et ex omni reptili ter-rae secundum genussuum: bina de omnibusingredientur teeum, utpossint vivere.
21. Tolles igitur te*cum ex omnibus escìs,quae mandi possunt, etcomportabis apud te: eterant tam tibi, quam il-lis in cibum.
22. Fecit igitur Noeomnia, quae praecepe-rat illi Deus.
de'giumenti di ognispecie y e di tulli i ret-tili della terra secondola loro specie : due fil-t re ranno teco n e l l ' a r -ca affinchè possano con-servarsi.
21. Prenderai adun-que leco di tutte quellele cose , che possonomangiarsi , e le porte,rai in questa tua casa :e serviranno a te e aloro di cibo.
22. Fece adunqueNoè tutto quello chegii avea comandato ilSignore.
C A P O VII.
Entrato Noè co1 suoi nelf arca, le*acq uè per cen-to cinquanta giorni soperchiarono le cime ditutti i monti, e sommersero tutti gli animali.
i. JLJixìttjue Domi-nus ad eum : Ingrede-re tu : et omnis domus
i. Hi il Signore glidisse,: Entra nell 'arcatu , e tuttala tua fami-
Vers. »i. Di tulle quelle cote, che possono mangiarsi. L' E-breo-.d' ogni soria di cibo solito a mangiarsi: lo che verrebbea significare, ebe nell'arca facesse Dio portare da Noè cibo adat-tato a ogni specie d'animali , e etc i càrtrmuj per esempio vi«i ribassar di carni. Vedi Buteo de arca.
Vers. i. Entra nell'arca ; cioè preparati ad eutrarerei!'ar-eav^di veri. 4.
* Giano <tin({W>i & nie> Realmente giusto,

tua in arcani : te e.iim(i) vidi jus tum coramme in generaliane hac.
2. Ex omnibus ani-manti bus mundis lolleseptena et septena^ ma*sculum , et foeminam :de animantibus veroim mundis duo et duo,masculum , et foemi-nam.
3. Sed et de volati*libus coeli septena etseptena, masculum , etfoeminam : ut salvetursemen super faciem «-riwersae terrae.
4- Adhuc enim etpost dies septem egopluam super terratn
glia : imperocché io tsho riconosciuto giustodinanzi a me iti questaela.
2. Di tutti gli anima-li mondi ne prenderai asette a sette , maschio ,e femmina : e degli a-nimali immondi a duea due , maschio, e fem-mina.
5. E parimenle*degliuccelli dell' aria a sellea settej maschio, e fem-mina : affinchè se neconservi la razza soprala faccia della lerra.
4. Imperocché di quia sette giorni io farò ,che piova sopra la ter-
(i) llebr. ii. 7. 2. Petr. 2. 6.
Vers. 2. Di tutti gli animali mondi ne prenderai a selle asette. Ho creduto con s. Ambrogio, Crisostomo , Teodoreto , ecolla maggior parte degl'interpreti, che tale sia il senso dellanostra volgata , come dell' ebreo ; vale a dire, che di ogni spe -eie di animali mondi debbano entrare nell'arca sette capi, edegli animali impuri noa sola coppia per ogni specie. Or de-gli animali puri ire coppie voglionsi destinare alla conservazio-ne della specie , il settimo per sacrifizio, che offerse dì fattoNoè , terminato che fu il di luvio , cap. VIL. 20. Veggiamo daquesto luogo , che la distinzione tra gli animali moadi e im-mondi , ripetuta di po! nel Levitico , fu osservata anche sottola legge di natura, mentre Dio ordina qui a Noè di osservarequesta distinzione; Io che suppone, che a lui f.o*»e già nata.
Vers. ^.Di qui a t ette giorni te, Da'dieci del secondo mesefino a'diciassette. Noè eseguendo l'ordine di Dio (lai di dispojr*re o£ai cosa nell'arca, e v' introdusse gli ammali,

quadraginta diebus etquadraginta noctìbus tet delebo omnem sub'sfantiam^ quam feci desuperfìcie terrae.
6. Fecit ergo Noe om-nia , quae mandaveratei Dominus.
6. Eratque sexcen-torum annorum , quan-do diluvii aquae inun-da verunt super terra m.
7. Et (i) ingressu?est Noe , et filii ejus ,nxorejus-et uxores fi-liorum ejus cum eo inarcam propter aquasdiluvii.
8. De animantibusquoque mundis, et im-mundis , et de vulucri'bus , et ex omni, quodmovetur super terram ,
9. Duo et duo ingres-sa sunt ad Noe in ar-cam , mas^ulus , etfoe-m ina t sicut praecepe»rat Dominus Noe.
10. Cumque transis-$ent septem dies, ««quae diluvii inundave-runt super terram.
ra per quaranta giornie quaranta no l l i : esterminerò dalla super*fiele della terra tulli ivìventi falli da me.
6. Fece adunque Noètuttoquelloche gl i ave-va comandalo il Signo-re.
6. Ed egli era in etàdi seicento anni , allor-ché le acque del di luvioinondarono la terra .
7. Ed entrò Noè ,e isuoi figliuoli, e la mo-glie di lu ì , e le moglide'suoi figliuoli con luinelP arca a motivo del-le acque del diluvio.
8. E degli animaliancora mondi , ed im-mondi 5 e degli uccelli ,e^di tutto quello che so-pra la terra si muove.
g. Entrarono con Noèin coppia-nell' arca ma-schio, e femmina, con-forme il Signore aveaordinato a Noè
io. E passati i sellegiorni , le acque del di-luvio inondarono la ter-ra.
(i) Matlh. 24» 3?. Luc' 17- Petr' 3- 20-
Yers, 9. * Entrarono con JVoè, L'orig. spontanei vennero,

il. Anno vexcente-si/no vitae Noe, mensesecundo , septimodeci-mo die mensis , rapiisunt omnes fontes a-
li. L' anno secente-simo della vita di Noè ,il secondo mese a' di-ciassette del mese , sisquarciarono tutte le
Vers. i l . Iranno secentesimo della, vita di Noe.Noe adunqueera nell ' anno secentesimo, di sua età, quando cominciò il di-luvio. Egli a d u n q u e d a l l ' a n n o 5oo ( o pit tosto 480 , come di-cemmo d i s o p r a ) fino a l i 'anno 600 della sua vita credette , eannunzio agli uomiui il d i l u v i o , benché la sua predicazione( come la ch iama s. Pietro ep. i. IM. 20 ) fosse schernita dagli,e rapi i , e t u t to questo tempo la pazienza divina aspettò i. pec-catori i n v i t a n d o g l i a penitenza, come dice lo stesso Apostolo..
Il secondo mese. Vale a dire dell' anno civile , il qual annocominciava verso l 'equinozio d'autunno: imperocché,non essendoancora stabilito 1' anno sacro, crediamo che Mosè non abbia po-tuto parlare se non dell'anno civile* Cosi il principio del di-luvio , cha fu a' diciassette del mese secondo, viene a caderenel novembre,
Si squarciarono tutte le sorgenti del grande abisso , e siaprirono le cateratte del Cielo Due cagioni del d i luv io si as-segnano qui da Mosè. Primo la acque del grande abisso; quel-le .acque , dalle qual i al principio del mondo era coperta la,terra ; e le quali secondo l'ordine di Dio si r i t irarono ne' vastiseni già preparati a riceverle , traboccarono da tutte le parti«opra la terra. la secondo luogo, quella immensa quantità «Ta-cque, alla quale Dio aveva dato luogo «opta del firmamento.Noi non cerchiamo altra prova d' uu fatto sì grande e rniraco.loso, fuor i della parola di Dio. Può essere, che la filosofìa tro-vi delle difficoltà e difficoltà anche grandi per intendere e spìe-gare questo fat to: ma il fatto non lascierà di esser vero e io-dubi ta to , benché la corta nostra ragione non possa arrivare acomprendere il modo , onde siaawenuto. La d iv ina autor i tà diMosè, così ben provata da tu t to quelle che per ministero di luioperò il Signore , è sufficientissimo a farci chinar la testa inossequio della fede dovuta alla parola di lu i , che è parola diDio. Ma lo stesso Dio ha voluto , ebe la memoria di questof a t t o s i conservasse nel la tradizione de'popoli, e non solo deipopoli del mondo ant ico, ma anche di quel l i del nuovo , dovecertamente non ne fu tolto il modello dalle nostre Scritture. Lastoria naturale , e la fisica confermano la t radizione ; onde noipotremo concludere con le parole d' uno de* più violent i ne-mici della religione , che a dubitare del diluvio vi vuole un'e-strema ignoranza, od uri* estrema os(inastone, ogni volta chesi rifletta alla concorde testimonianza della fisica^e dell'ista*

&y$si magnae,etcalerà-ctae coeli apertae sunt.
12. Et facta est più*vìa super terra/n qua-draginta diebus >et qua-draginta noctibus.
13. In articulo dieiillius ingressus estNoe,et Sem, et Cham , etJapheth, filii ejus, uyorillius, et, tres uxores fi-Horam ejus cum eis inarcam.
14. Ipsi* et omne a-nimal secundum genussuum, universaque ju~menta in genere suo,et omne , quod movelursuper terram in gene-re suo, cunctumquevolatile secumdum ge-nus suum , universae
.sorgenti del grandeabisso, e si aprirono lecateratte del cielo.
12. E piovve sopra laterra per quaranta gior-ni , e quaranta notti,
13. In quello stessodi entrò Noè, e Sem,eCham, e Japhelh suoi fi-gliuoli , la moglie dilu i , e le mogli de9 suoifigliuoli con essi nellaarca.
i4- Eglino , e tuttigli animali secondo laloro specie, e tulli igiumenti secondo i lorogeneri , e tutto quelloche sopra terra si muo-ve secondo la sua spe»eie, e lutti i volatili se*condo la loro specie, e
ria, e alla voce universale del 'genere umano, Il'dilavio ani-versale adunque nulla ha di contrario alla ragione; ma egli è uàvero miracolo superiore alla ragione in molte sue circostanze:egli fu .opera di Dio, il quale volle eoa universale gastigo punirela uni vertale corruzione degli uomini, e lasciare a' secoli poste-riori una terribile immagine della severità di sua giustizia affinedi ritirarli dall'empietà. Veggasi nel giornale Ecclesiastico ali'anno 1762, mese di novembre, e dicembre, la spiegazione fisico-teologica del diluviò, e de'suoi effetti, opera dell'abate LeBrun, degna di esser letta, perocché salvando, anzi ponendo perfondamento , le due cagioni del diluvio toccate da M»sè, esponecon. molla semplicità e chiarezza questo grande avvenimento eoatutto quello che ne seguì.
Vers. 13. In quello stette (fi. Ovvero , come altri traducono ,nel principio di quel giorno, vale a dire del diciassettesimo deif3es<-, secondo.

aves t omnesque volu-cres,
io. Ingressa suntad Noe in arcam binaet bina ex omni carne,in qua erat spiritus vi-tae.
t6. Et quae ingres-sa sunt, masculus , et/vernina ex omni car-ne introierunt , sicutpraeceperat ei Deus :et inclusit eum Domi-nus deforis.
17. Factumque estdiluvium quadragintadiebus super terram ;et multiplicatae sunt a-quae i et elevaverunt ar-cam in sublime a terra.
48. ìPenemén&r e-nim inundaverunt ì etomnia repLeverunt insuperficie terrae: porroarca ferebatur superaquas» *•
19. Et aqaae prae-valuerunt nimis super
lutti gli uccelli , 6tutto quello che portaali.
16. Entrarono da Noènel!' arca a due a dueper ogni specie di ani-*ma l i , che respirano, edhanno vita,
16. E quei, che v' en-trarono , entraron diogni specie maschio , efemmina , conforme a-yea a lui ordinato il Si-gnore ; e ve lo chiuseper di fuori il Signore.
17.E venne il diluvioper quaranta giorni so-pra la terra, e le acqueface va n cresciuta*, e fè*cer salire 1' arca moltoin allo da terra.
r8, Imperocché la i-nonda^ìone delle acquefu grande : ed èlle co*privano ogni cosa sullasuperficie della terra »ma 1* arca galleggiavasopra le acque.
19. E le acque in-grossarono formisura
Vers. 16. E ve lo chiute per di fuori il Signore. \\ Signore aforse per minis tero d' uà Angelo, fece inve rn i c i a r per di fuorocol bitume tutto all'intorno la porta dell 'arca. Siccome in tul i -questo gran fatto spira per ogni parte l'ira di Dio coutro gli era^pii, cosi spicca del pari la carità, e la bontà di Dio verso del giuisto, e verso la sua famiglia, e verso gii animal i stessi cornute^a l la cura di Noè.

terrama operlique suntomnes montes excelsisub universo coelo.
20. Quìndecim cubi-tis altior fuit aqua su-per montes, quos ape-ruerat.
at. (i) Consumpta-que est omnis caro ,quae movebatur superterram, volucrum, ani*mantium , bestìarum ,omniumque reptilium ,quae reptant super ter"rarn^i universi homi"n<ì$.
»2. Etcunctat in qui-bus spiraculum vitaeest in terra , mortuasunt.
23. Et delevit om-nem substantiam> quaeerat super terram, abnomine usque ad pe-cus, tam repùle , quamvolucres coeii) et deletasunt de terra ; re man»sit autem s olii s JVipe,et qui cum eo erant inarca.
sopra la terra : e r ima-ser coperti tutti i mon-ti sollo il cielo tulioguanto,
20. Quindici cubi l isi alzò 1' acqua sopra imonli, che ayea rico.perii.
21. E ogni carne, ebeha moto sopra la terra,restò consunta , gli uc-celli, gli animali, le fie-re , e tntli i reitilij chestrisciano sulla terra :tutti gli uomini,
22. E tutto quelloche respira , ed ha vitasopra la terra, peri.
23.E fu perduto ognicorpo vivente , che erasopra la terra , dall' uo-mo fino alle bestie, tan-to i rettili , che gli uc-celli dell' aria , lutto fusterminato dalla (erra :e rimase solo Noè , equei che eran con lui,nell'arca.
( i j Sap. io, 4 Ecel.Sy. 28. i. Petr. 3. 20,
Veri. 20. Quìndici cubiti ti alzò V acqua sopra i monti. Cnt\nessun gigante, uessun animale polè salvarsi sojua alcun monte

24» Qbtinueruntqueaquae terram centumquinquaginta diebus.
24. E le acque signo-reggiarono la terra percento cinquanta giorni.
C A P O VIIL
Scemate a poco a poco le acque del diluvio, do*po aver messo fuori il corvo, e la colombaJSoèesce fuori con tutti quelli cH eran nel? arca :e alzato un altare , offerisce a Dìo olocaustiin rendimento di grazie : onde placato Diopromette , che non sarà mai più il diluvio.
i. f\ecordatus au-tem Deus Noe , cunclo-rumque animanùum ,et omnium jumento-rum j quae erant cumeo in arca.adduxit spi-ritum super terram , etimminvtae snn,t&iu&e*
a. Et clausi sunt fon»ies abyssi et catara-ctae coeli : et prohibi-
i. iVJLa il Signorericoridandosi di Noè , edi tulli gli animali , edi tulli i g iumenti chtrerano con esso nell 'arvea, mandò il vento so-pra la lerra , e le acque(Uffìtpttìroai).
a. E furo» chiuse? lesorgenti del gra/ide,abisso , e le cataratte.
' Vers. «4- Per cento cinquanta giorni, la questi cento cin-quanta giorni si computano anche i quaran ta giorni della piog-gia. Vedi Perer.
Vers. i. Mando il vento sopra la terra. Questo vento ga-gliardo non tanto per sua propria efficacia , quanto per divinavirtù dovea parte consumare le acque, e alzarle in vapori, parterespingerle ne' gran seni ond' erano state tratte.
* Le acque diminuirono. Calarono.Vers. ?.. E furono vietate le pioggie dal cielo- Dio trattenne
ogni pioggia per sette mesi, e più, cioè da'diciassette del sett imomese , in cui le acque cominciarono a scemare -, fino a'ventisettedel mese secondo del seguente anno, vers. i4>
* Mietale te ptoggt'e, Trattenute,

tae sunt pluvìae de eoe-lo.. 3. "Reversaeque suntaquae de terra euntes ,et redeuntes \ et, coepe-runt minui post cen-tum quinquaginta dies.
4- Requìevitque arcamense septìmo, vigesi-mo septimo die mensissup&r montes Arme-niae.
5. At vero aquae i-kant t et decrescebantusque ad decimum men-semi decimo enim men-se^ prima die mensis,apparuerunt cacuminamontium.
6. Cumque transis-seni quadraginta dies,aperiensNoefenestramarcae , quam fecerat,dimisit corvumi
Bel cielo; e forono vie*tate le pioggia dal cielo*
•3. E le acque andan*do , e venendo si parti-vano dalla terra: e prin-cipiarono a scemare do-po cento cinquantagiorni.
4. E 11 arca si posò ilsettimo mese a' venti-sette del mese sopra imonti d' Armenia,
6. E le acque andava-no scemando sino al de-cimo mese: perocché ildecimo mese , il primogiorno del mese, si sco-prirono le velle deimonti.
6. E passati quarantagiorni, Noe, aper ta la fi-nestra , che avea fallaali' arca, mandò fuori ilcorvo:
- Vel'». 4- Sopra i monti cP-Armtnìa.U Ebreo legge.- topra lemontagna di Amrat: II Caldeo: sopra i monti Cordn, chiama-ti Gordidi, da altri rferittori. S. Girolamo scrive , che il monteÀrarat è una parte del monte Tauro. Che l'arca si posasse suimonti dell'Armenia, vien riferito anche da varii scrittori profanicitati da Giuseppe e da Eusebio, e lo stesso fatto è confermatodàlia tradizione di quel paese, conservata fino al di d'oggi, intor-no alla quale vedi s. Éasilio di Seleucia , orai, iv.de arca.
1 * A* ventisette del mese. Ebr. a? diciassette.• Vera.5, // decimo mese. Non dal cominciamento del diluvio ,
ma dal priocipio del iccentesimo anno dalla venuta di Noè, co*cne apparisce dal ver s, 13. e 14., e dal capo precedette vefVu.

•7. Qui egrediebatur,et non revertebatur ,doneù siccarentur a*quae super terra/n.
8. Emisit quoque co»lumbam post eum , utvideret si jam cessas*seni aquae super fa-ciem terrae.
g. Quae cum non in-venisset, ubi requie»scerei pes ejus , rever»<sa est ad eum in ar'eam: aquae enim erantsuper universum ter"fam : extenditque ma'num , et aperehensamintulit in arcam.
io. Exspectatls au*lem ultra septem die-bus aliis, rursum di-
7. Il quale usci , enon tornò fino e tantoche le acque fosser sec-cate sulla terra.
8. Mandò ancora do-po di lui la colomba ,per vedere se fossero fi-nite le acque sopra lafaccia della terra.
9. La quale non a-vendo trovalo , ove fer-mare il suo piede, tor-nò a lui nell' arca : pe-rocché per tutta la ter-ra eran le acque ; ed e-gli stcìe la mano, e pre-sala la mise dentro 1* ar-ca.
10. E avendo a s pe 1-tato sette altri giorni,mandò di nuovo la co
Vers. 7.11 quale usci e non tornò.NelP Ebreo manca la par-ticella negativa,- ma i LXX. , il Siro, e tut t i i padri hanno la le-zione della volgata ; e 1' Ebreo con varii dotti interpreti si puòbeo conciliare col Latino: imperocché queste parole il corvo li-sci andando e tornando posaon significare, che il corvo veggen-de' cadaveri sopra i monti, amando di farne pasto , non tornavaa Mosè dentro I' arca; ma perchè a cagione del gran fango nonpotea nemmen posare sopra la terra , andava a riposarsi sul tettodell' arca.
Fino a tantoché Vacque fattero seccate. Questa maniera diparlare non significa, che il corvo tornasse poi, quando le acquefurono seccate, ma solamente, che per tutto quel tempo primadell'asciugamento delle acque, egli mai non tornò dentro l'arca;onde Noè non poter per tal mezzo sapere, in quale stato fosse laterra; e di fatto non vi tornò egli mai più, nemmeno dopo. E' danotarsi questa espressione, che trovasi anche in altri luoghi delleScritture, Vedi Matlh, i. verj, ult,.J?t, 109,2. ce.

misti cotumlam ex ar-ca.
11. At illa venit adeum ad vesperam, por-tans ramum olivete vi-rentibus foliìs in oresuo.lntellexit ergo Noe,quod cessassent aquaeSuper terram.
12. Exspectavitquenihilominus septem a-lios dies : et emisit co-lumbam , quae non estreversa ultra ad eum., 13. Igitur sexcente-simo primo anno , pri'mo mense, prima diemensis\imminutae suntaquae super terram: etaperìens Noe tectumarcae aspexit viditque
tomba fuori dell'arca*
i l » Ma ella tornò aluì alla sera , portandain bocca un ramo di u-livo con verdi foglie. In-tese adunque Noè , co-me le acque erano ces-sate sopra la terra.
i 2. E aspettò nondi-meno sette altri giorni,e rimandò la colomba ,la quale più non tornoa lui.
13. V anno adunquesecentesimo primo diNoè , il primo mese , ildi primo del mese, le ac-que lasciaron la terra :e Noè avendo scoper-'chiato il tetto dell'arca
Vers. l i . Torno a luì alla sera, ec. Ella, dice il Crisostomo,passo il giorno a mangiare ; la se ta poi, fuggendo il freddo not-turno, se ne tornò a trovare sua compagnia. II ramoscello d'olivoche ella portava , potè benissimo serbare la sua verdura ancheun interno anno sotto dell'acque, affermando Plinio che il lauroe 1' olivo vivono e frut t i f icano anche nel mar Rosso: Vedi ancheTeophrast. hitt.plani, lìb, 4 8. Il ri torno adunque della co-lomba, e molto più il ramoscello d'olivo fece intendere, ebe nonsolo i monti più a l t i , ma anche le colline, dqve bei) riesce i'olivo, erano asciutte.A!Vers. l3. Mirò ,e vide che la superfìcie della terra ec. Unatal vista quanto dovea consolare Noè , e qual impeto dovea sve-gliare i u lui di uscire fuori dell 'arca! ma egli si sta in pazienzaaspettando P ordine di Dio: qual vir tù e qual fede! La terra erasenz'acque; ma v'erano ancora la belletta e il fango che non per-mette vano di camminarvi.
* Le acque scemarono tutta terra,. Lasciarono la urrà.

quod essiccata essetsuperficies terrae.
14. Mense secundo ,septimo et trigesimodie mensis tarefacta estterra.
15. Locutus est aiirlem. Deus ad Noe, di'cens :
16. Egredere de ar-ea, tu, et uxor tua., filiifui, et uxores filiorumluorum tecum.
17. Cuncta anima n-ùa , quae sunt apud teex omni carne, tam involatilibus, quam in be-sliìSi et universis re-ptiliòus, quae reptantsuper terram : educ te-cum, et ingredìmìni su*per terram : ( i ) Cresci-te., et multiplic amini su?peream.
1.8. JEgressus est er-go Noe, et filii ejus , u-xor illius, et uxores fi-tiorum ejus cum, eo.
19. Sed et omnia a-ninìantia, jumenta, etreptilia, quae reptantsuper terram, secun-dum genus suum, e-gressa sunt de arca.
mirò, e vide, che la su-perficie della terra eraasciutta.
i4- Il secondo mese ,a'ventisette del mese,la terra rimase arida.
15. E Dio parlò aNoè, dicendo:
16. Esci dall'arca tu,e la tua moglie, i tuoifigliuoli e le mogli de'tuoi figliuoli con te.
17. Conduci leco fuo-ri tulli gli animali, chesono insieme cori te, diogni genere , tanto vo-latili , che bestie, e ret-tili, che strisciano sullaterra , e scendete sullaterra : Crescete e mol-li plìcà te.
18. E uscì Noè, e conesso i figliuoli dì lui , ela sua moglie, e le mo-gli, de' suoi figliuoli.
19. E tutti ancoraglianimali, e le bestie e irettili, che striscianosulla terra, secondo ialoro specie , uscironodell'arca.
(i) Sap. 1. 9.7. 9.8. Infra, g. i. -.

20. Aedificavit autemNoe altare Domino : ettollens de cunctis pe~coribus, et volucribusmundis jobtulit 1iolocau~sta super altare.
21. Odoratusque estDominus odorem sua-vitatis, et aìt: "Nequa-quam ultra maledicamterrae propter homines:(i) sensus enim, etco-guado humani cordisin malum prona suntab adolescenza sua:non igitur ultra percu-tiam omnem animamuiveìitem, sicut feci»; i 22. Cunctis diebu^éerrae sementìs etmes*$ìs, frigus et aestu$\aestas et hiems, notietdies non requiescent.
20. E Noè edificò unaliare al Signore : eprendendo di tulle lebestie, e uccelli mondi,gli offerì in olocaustosopra l'aliare.
21. E II Signore gra-dì il soave odore, e dis-se: Io non maledirò maipiù la terra per le colpedegli uomini: perocchéla mente , e i pensieridegli uomini sono incli-nati al male fin dall' a-dolescenza: io adunquenon manderò più flagel-lo sopra tulli i vivenlì,come ho fallo.
22. Per tulli i giornidella terra non manche-rà giammai la semenzae la messe, il freddo e ilcalore , l'estate e il ver-no, la nolte e il giorno.
(i) Sap. 6. 5. Maith. 15. 19.
Ver*, ai. Il Signore gratti il soave odore. S. Gio. Crisosto-mo: La virtù del giusto cambiò in dolce fragranza il fumo, eii sito delle,arfe vìttime.
Io non Maledirò mai più la terra ec. Dio promette Ai nonpunire mai più con simil fustigo universale 1' umana malìzia, eChe avrà cornpassio.ne dell' infermità degli uomini, e della pro-J>«nsione loro al male ; propensione nata con essi per difetto del-la corrotta natura.NVedesi qui notata la colpa originale e la con-cupiscenza cte mscono coli' uomo, e sono il principio di tuttii peccati.
Vers. 32. ffon mancherà giammai la semema, ec. Le vicis-situdini delle fatiche di seminare e raccogliere, le vicissitudini

C A P O IX.
Dio benedice Noè, e i figli ; e assegna loro percibo tutti gli animali insieme co"1 pesci, proi-bendo pero il sangue. Il patto tra Dio e gliuomini del non mandar più, le acque del dilu-vio è confermato coli' iride. Cliam , ch' aveaschernito Noè nella sua ebbrezza, è maledet-to nel figlio Chanaan. ; Sem, e lapheth sonbenedetti.
j. fjenedixltqueDeusNoe, et filiis ejus. Etdijcit ad eos : ( i ) Cre-scite et multi pii camini)et replete terram.
2. Et terror vester,ac tremor sit super cun-cta animatici terrae, etsuper omnes volucres
1. L> Dio benedisseNoè , e i suoi figliuoli.;E disse loro : CresQete ^e moltipllcate , e riem-pile la terra.
2. E temano, e tre-mino dinanzi a voi tut-ti gli animali della ter-ra , e lutti gli uccelli
fij Supra t. 22. 28. 8. 17.
dell'anno, l'estate e il verno, finalmente le vicissitudini de'tem-porali, il freddo e il caldo, l'alternativa delle notti e de'giorni,promette Dio, che saranno costanti sino alla fine del mondo.
Vers. j . * Crescete e molliplicale ec. Può equivalere al fu-turo : crescerete e moltipllcherete e riempirete la terra. CosiCap. I. v. 28.
Vers. 2. E temano e tremino dinanzi a voi ec. Effetto di que-sta legge posta da Dio si è, che le bestie più forti e robuste del-l'uomo lo rispettino, nè ardiscano mai di offenderlo, se non forse
'offese da lui, o strette dalla fame. Plinio racconta, che l'elefantes'impaurisce al solo vedere le pedate di «n uomo ; e che le tigriappena veduto un cacciatore trasportano altrove i teneri loro par-ti , come se un istinto interiore avvertisse le bestie, che l'uomoè il loro antico signore. Cosi Dio ha voluto conservare all'uomo"na porzione di quest'assoluto dominio, che egli avea concedutoa Adamo innocente.

coeli cum universis ,quae moventur superterrami omnes que* pi-sces maris manui ve-strae traditi sunt.
3. Et omne quod mo-ve tur, et vivit, (i) eri/vobis in cibumi quasiciera virentia tradidivobis omnia;
4. (2) Excepto, quodcarnem cum sancitinenon comedetis.
dell'aria, e quanto simuove sopra la terra :tutti i pesci del maresono soggettati al vo-stro potere.
3. E tutto quello cheha moto e vita, sarà vo-stro cibo : tutte questecose io do a voi, comei verdi legumi ;
4. Eccetto che voinon mangerete carnecol sangue.
(i) Supr. i. (i) Lev. 17. 14-
Vers. 3. Tutto quello che ha moto e vita farà vostro cibo ,Dio permette l'uso delle carni degli animali. Il Crisostomo, Teo-•doreto, e molti interpreti moderni credono, che avanti il diluvio
4*E>n fosse proibito assolutamente 1' uso delle carni ; ma che gliuoinini più religiosi, come i discendenti di Seth, se ne astenesse-ro, perchè Dio (cap. i. ver s. 29.) avea assegnato per cibo ali uo-4o non le carni, ma i legumi. Vedi detto luogo. Questa permis-sione di Dio secondo s. Girolamo, restringessi a quegli animali,che sono mondi, imperocché egli crede, che la distinzione di ani-mali mondi e immondi ( la quale abbiamo detto di sopra essersi
' " osservata riguardo a' sacrifuii ) avesse già luogo anche per 1 usode' cibi.
* Verdi erbaggi. Legumi. . ,Vers. L Non mangerete caricai sangue. In virtù di questa
legge, rinnovata poi nel Levitico vn. «6- X V H . ' I I . 14- fu proibitodi mangiare il sangue o rappreso nelle membra degli animali oda essi separato» La ragione di tal proibizione si è, primo, d iti-
, fonder negli «omini maggior avversione dallo spargimento del5 «angue umano, Oers. 5.: secondo, perchè Dio volle che il sangue,
che è quasi la vita dell'animale, a lui solo fos|Se offerto m sacrih-zio in cambio della vita dell'uom peccatore. Vedi Levil. xvn. ».Questa legge fu rinnovata di poi dagli Apostoli nel concilio di
^Gerusalemme (Atti xv. 29.) e fu osservata in molte Chiese anche*per mòtti secoli. Ma siccome non per altro era stata introdotta, seiona fine di facilitare a«li Ebrei tenacissimi delle lor costuman-te 1' ingresso nella Chiesa dì Gesù Cristo ; quindi e che linoda' tempi di s. Agostino cominciò questa legge a non essere pm

6. Sanguinem enimanimarum vestrarumrequiram demanucun-ctarum bestiarum : etde manu nominis, demanu viri^ et fratris e~jus, requiram animamhominis.
6. (i) Quicumque ef-fuderìt humanum san-guinem, fundetur san-guis illius-, ad imagi*nem (juippe Dei factasest homo.
7. ( 2} Vos autem cre-scite, et mulùplicami'
o. Imperocché io fa-rò vendetta del sanguevostro sopra qualsisiadelle bestie: e farò ven-detta della uccisione diun uomo sopra 1* uomosopra T uomo fratellodi lui.
6. Chiunque spargeràil sangue dell' uomo, ilsangue di lui sarà spar-so : perocché 1* uomo èfatto ad im in a gin di Dio.
7. Ma voi crescetelemoltiplicate, e dilatate-
(i) Matth. 26. Sa. Apoc. 13. ao,(*) Supra, i. 28. 8. ij.
osservata in molti luoghi, e a poco a poco cessò interamente, at-tenendosi i Cristiani a quella parola di Gesù Cristo: Non quel-lo che entra j?er Im bocca imbratta P uomo, Vedi Augustilib. xxxn. corat Faust. cap, f 3. •-..*
Vers. 5. Io faro vendetta del sangue vostro sopra qualsisiadelle bestie. Dimostra, che la ragione della precedente proibizio-ne si è di allontanare quel più gli uomini dallo spargere il san-gue umano. Io punirò le bestie istesse che avranno commesso unsimil delitto, affinchè l'uomo apprenda , quanto debba rispettareil sangue dell'altro uomo. Vedi Exod. xxi. 28.
Faro vendetta ... sopra P uomo, sopra V uomo fratello di lui.Questa repetizione aggrava il delitto dell'omicidio, rappresen-tandone l'iniquità : farò vendetta sopra dell'uomo della uccision?fatta da lui di un uomo, di un uomo che è suo prossimo e suofratello.
Vers. 6. Chiunque spargerà il sangue dell1 uomo, il sanguedi lui sarà sparso. Vale a dire, è giusto che sia messo a mortechiunque ad un uomo avrà data la morte. Alcuni Vogliono quistabilita la legge, che dicesi del taglione, in virtù della qnalepermettevasi di vendicare il sangue col sangue, la morte collamorte: il qual diritto dopo la fondazione della società passò v&fteramcnte ne' rettori e magistrati delle medesime società.

ni," et ingrediminì su-per terram, et impleteeam.
8. Haec quoque dixitDeus ad Noe, et ad fi'Kos ejus cum eoi
g. Ecce ego statuampactum meum vobis-cumt et cum semine ve-stro post vos \
10. Et ad omnem a-nimam vìventem^ quaeeStvobiscum tam in vo+foribus, quam in ju-mentis, et pecudibusterras cunctis> quae e-gressa sunt de arca*et universis bestiis ter-rete.
11. (i) Statuam pa-ctum meum vobiscum^M nequaquam ultra in-terficietur omnis caroaquis diluvii, neque erit"deinceps diluvium dis-$ìpans terram.
12. Dixitque Deus:Hoc signum foederis,
vi sopra la terra, e riem-pitela.
8»J)isse ancora Dio aNoè , e a* suoi figliuolicon lui :
9. Ecco che io ferme-rò il mio patto con voi,e con la discendenzavostra dopo di voi :
i o, E coti tulli gli a-nimalì viventi, che so-no con voi tanto vola-tili , come giumen-ti , e bestie della terracon tutti quelli che so-no usciti dall'arca, econ tutte le bestie del-la terra.
11. Fermerò il miopatto con voi, e nonsaranno mai più uccisicolle acque del diluviotutti gli animali, nè di-luvio verrà in appressoa disertare la terra.v 12. E disse Dio : Ec-co il segno del patto,
<Vfc-54 9-
Ver», io. E con lutti gli animali viventi cha fono fon voi ec.Con queste parole Dio s'impegna a conservare sopra la terra tut-t>p le specie degli animali, a provvederle di cibo, e di nutrimen-ti^-e. ji perpetuarne la fecondità. Così Gesù Cristo ci assicura nelino Vatìgelo, che neppur uno de' più piccoli volatili è dimenti-cato da Dio.
Vers. n.* Uccisi, Fatti morire,

quod do inter me % etvoS) et ad omnem ani-mam viventem , quaeest vobiscum in gene-ratlones sempiternas .
1 3. Arcum meumpo-nam in nubibus, et eritsignum foederis interme , et inter terram.
1 4 •( i ) Cumque obdu-xero nubibus coelum ,apparebit arcus meusin nubibusi
16. Et recordaborfoederis mei vobiscum ,
Ci) Ecd. 43. 13.
ch' io fo Ira voi, e me ,e con tulli gli animaliviventi, che sono convoi per generazioni e-terne.
13. Porrò il mio arco-baleno nelle nuvole, esarà il segno del pattotra me, e la terra.
i4» E quando io a-vrò coperto il cielo dinuvole, comparirà il mioarco nelle nuvole :
15. E mi ricorderòdel patto , che ho eoa
Vers. 13. Porrò il mio arcobaleno nelle nuvole. La manieradi parlare di Dio, e quello che egli vuol che significhi in appres-so agli uomini l'arcobaleno, sembra, dimostri assai chiaro, c|iequesto non erasi veduto giammai prima del diluvio : benché nonsia da dubitare, che per tutto quel tempo non mancaron le piog-ge : imperocché, lasciando le altre riflessioni da parte, nissun po-trà comprendere, come le nuvole, o sìa i vapori esalati continua-mente dalle acque della terra, e accresciuti in infinito per lospazio di due mila anni si potessero sostenere nell'atmosfera wn*,za mai sciogliersi in pioggia. L'iride adunque mancò prima deldiluvio, non perchè mancassero le pioggie \ ma perchè le acquesuperiori, delle quali abbiamo parlato al cap. vii. 11., impediva-no , che potesse aver luogo questo fenomeno. Tolte questa acquesuperiori", le quali si versarono sopra la terra, e non ritornaronopiù ali* antica loro sede, potè allora vedersi l'iride, ed essere unsegno nuovo e infallibile, che il diluvio non sarebbe mai più.Vedi la spiegazione, dì cui sopra, vn. 11.
E sarà il segno del patto tra me e la terra. Il Caldeo poria :del patto tra il mio Verbo, e la terra ; accennando, come il Fi-gliuolo di Dio è stato il mediatore di tutte le alleanze tra Dio egli uomini; perchè tutte hanno avuto per oggetto e fine la gran-de e divina alleanza , che egli dovea contrarre con noi nella *fwincarnazione.
* Porro, L'ebr. e i LXX. io pongo : io metto.

et cum omni anima vi"venie, quae carnem ve-getai : et non erune ul-tra aquae diluvii addelendum universamcarnem.
16. Eritgue arcus innubibus, et videbo il-lum , et recorda bor foe-deris 6* empitemi, quodpàctum est interi) eum tet omnem animam vi-ventem universàe car-nis, quae est super ter-tam.
17. Dixitque Deusad Noe : Hoc erit si-gnum foederis, quod
jconstìtuì inter me, et^nnem carnem superterram.* 18, Erant ergo filiiJVbe, qui egressi suntde arca, Sem) Cham etJapheth: porro Cham i-pse estpater Chanaan.
\$, Tres isti Jilii
voi, e con ogni animavivente , che informacarne: e non verran piùle acque del diluvio asterminare tutti i vi-venti.
16. E 1* arcobalenosarà nelle nuvole,e ioinveggendolo mi ricorde-rò del patto sempiternofermato tra Dio , e tut-te le anime viventi diogni carne, che è soprala terra.
17. E disse Dio a Noè:Questo è il segno delpatto, che io ho ferma-to tra me, e tutti gli a-nimali, che sono in ter-ra.
18. Erano adunque itre figliuoli di Noè, cheuscirono dall'arca, Sem,Cham, e Japheth : eCham è il padre di Cha-
jiaan.ip. Questi sono i tre
Vers. 16. Io in reggendolo mi ricorderò del patto sempiter-no ec, Eg$ « anche giusto per conseguenza r che gli uomini si ri-cordino anch'essi, in reggendo l'iride, del terribile universale ca-stigo, col quale Dio puoi i peccati del mondo, e gratie rendano aIpi della misericordia usata con essi.
^^Vers. io. E da questi sì sparse il genere umano sopra tuttafil terra. Woe adunque non ebbe altro, che tre figliuoli, e daquesti, dopo lo sterminio di tutti gli altri uomini nel diluvio, furipopolata la terra. Canaan nacque dopo il diluvio.

sunt Noe: et ab his dis-seminatum est omnegenus hominum superuniversam terram.
20. Coepitcfue Noevir agricola exercereterram, etplantavit vi-neam.
21. Bibensquevinuminebriatus est, et nu-datus in tabernaculosuo.
22. Quod cum vidis-set Cham* pater Cha-naan, verenda scilicetpatris sui esse nuda-ta, nuntiavit duobusfratribus suisforas.
23. At vero Seni, etJapheth pallium impo-suerunt humeris suisfet incedentes retror*sum operuerunt veren-da patris sui.faciesqueeorum aversae erant,et patris virilia nonviderunt.
24' Evigilans autemNoe ex vino, cum di-
figliuoli di Noè, e daquesti si sparse tutto ilgenere umano sopratutta la terra.
20. E Noè , che eraagricoltore, principiòa lavorare la terra , epiantare una vigna.
21. E avendo bevutodel vino si inebriò, e sispogliò de' suoi panninel suo padiglione.
22. E avendo vedutoCbam padre di Ghana-an la nudità del padresuo, andò a dirlo a'duesuoi fratelli.
23. Ma Seni, e la*pheth, messosi un mari*tello sopra le loro spal^le, e camminando al-l'indietro coprirono lanudità del padre, tenen-do le facce rivolte all'op-posta parte , e non vi-dero la sua nudità.
24. E svegliatosi Noèdalla sua ebbrezza, a-
* Sopra tutta ira terra. Per tutta la terra.Vers. 20. c a i . E piantare una vigna: e avendo bevuto del
vino ec. Fino a quell'ora gli uomini si erano contentati di man-giare 1' uve prodotte naturalmente dalla vite senza coltivarla , e-senza estrarne il liquore. Noè fu il primo a pensare all'una, eall'altra cosa; e non sapendo ancora la forza del vino cadde perinesperienza nell' ebrietà, la quale da tutti i Padri è scusata dapeccato, e fu figura di grandissimo mistero , come diremo.

dìcisset , quae fece-rat ei filius suas mi-*n or,
20. Aiti MLaledictusChanaan, séfvus ser-vorunt erit 'fratribussuis.
26. Dìxitque: Bene-dictus Dominus DeusSem\ sii Chanaan ser-vus ejus.
27. DilatetDeus Ja*
vendo inteso quel cheavea fatto a luì il suo fi-gliuolo minore,
26. Disse: MaledettoGhanaan , ei sarà servode' servi a' suoi fratelli.
26. E disse: Benedet-to il Signore Dio diSem ; Ghanaan sia suoservo.
27. Dio amplifichi Ja-
Vers. a/J- -W suo figliuolo minore. Oham : il quale venghiamoad intendere, die era il più giovine de'tre figliuoli di Noè; e ciòè senza paragone più naturale, che il dire, che debba intendersiil nipote Ghanaan, di cui la Scrittura non ha parlato , se nou in-cidentemente di sopra al vers. 18.
Vers. a5. Maledetto Chanaan. Noè non maledice il figliuoloCham, ma sì il nipote Chanaaa ; perchè in primo luogo non vol-^fc gettare la sua maledizione sopra un figliuolo , a cui Dio aveaIKta la sua benedizione poco prima: in secondo luogo veniva adesser punito forse più sensibilmeute il padre colla punizione delfigliuolo: in terzo luogo ottimamente Noè rivolge con profeticospirito la sua maledizione contro di Chanaan, perchè i posteri dìlui, i Ghananei, furono quelli, sopra-de'quali per la loro empietàvenne a verificarsi visibilmente questa maledizione , allorché fu-
" rono sterminati, o ridotti in dura schiavitù da'discéndenti diSeM, o sia dagli Ebrei. Così la maledizione di Noè non è tantouna maledizione, quanto una profezia.
Servo déservi. Significa servo 3|*fimo, e dellaspiù abietta con-dizione, m
Vers. 26. Benedetto il Signore Dio di Seni. Dall' altra partePfoè veggendo col medesimo spirito i benefizii e le grazie, chet)io avrebbe a larga mano diffuse sopra Sem, e sopra i suoi po-stesi, si fl|plge con tenera gratitudine a benedire e ringraziareper esse iì Signore. La massima delle prerogative di Sera doveaessere il culto del vero Dio conservato da'suoi discendenti, e ilìÉÌ?*a * e*ie 4ov^a nascer da questi.
igjjjfers. 27. Dio amplifichi JapJieth, ec. li Signore darà a Ja-ptieth un* amplissima posterità ; ma il Signore abiterà nelle ten-de di Sena , e Chanaan sarà suo schiavo. Tale è il senso di questoverso secondo il CàMeo; e questo senso è seguitato da Teodore-to, dal Lirano, daJl'Àbulense, e da altri interpreti, Noè in questo

pheth) et ìiabilet in la-bernaculis Sem; sitfjueChanaan servus ejus,
28. Vìxit autem Noeposi diluvium trecentistjuinc/uagi7ìta annis.
pheth , o abili iie'padi-elioni di Seni , e Cba-
- *uaan sia suo servo. w
28. E visse Noè dopoil diluvio* trecento cin-quanta a»ai.
versetto conclude la sua benedizione , predicando a Japhclli unanumerosissima discendenza (Japheih è il padre de'Gentili )j nidiritorna a Sein, e ripete l'altissimo privilegio di lui d'avere Dioabitante nelle sue tende, non solo per ragione del culto di Dioconservato we' suoi posteri, ma molto più per ragione di colui,nel quale abitar dovea corporalmente la Divinila, Colos. 11.9.per ragione del Messia, cioè del Verbo di Dio, il quale fatto cai-ne pose suo padiglione (cosi il Crisostomo Jo. i. 14- ) e abitotra' discendenti di Seni : dopo di giù Noè ripete la sua maledizio-ne contro di Chanaan: tpnto era egli certo dell'avveramento disua predizione. Questa sposizione H fa qui vedere una chiara pri-lezias dell'incarnazione di Cristo.
Non debbo però tacere, che molti Padri riferiscono quelle pa-role, e abiti ne*padiglioni di Sem, non a Dio, ma a Japheth; eintendono queste parole della vocazione de'Gentili, i quali en-treranno nelle tende di Seni, quando si uniranno alla Chiesa diGesii Cristo figliuolo di Sem secondo la carne. ^
* Amplifichi. Propaghi.Verjf, 48. falsse iVoè dopo ìJLdiliivio trecento cinquanta anni.
Abramo essendo nato Panno divento novantadue dopo il diluvio,ne segue perciò, che egli visse con Noè cinquamtar òlto anni. Lalunga vita de'primi padri nell'ordine della divina previdenza fa,il mezzo di far passare la religione e il eulto di-Dio a tutti i io*~"t\ro posteti. Noe (dice l'Apostolo) avvertito da Dio dì cose, cheancora non si vedeano, con pio timore ando preparando l'ar-ca per salvare la sua famiglia^ per la quale (arca) condannòil mondo , e divento erede della giustizia , che vien dalla fede.Hebr. xi. 7. Per questa giustizia fu egli degno di essere una vivafigura del Giusto per eccellenza , del vero Riparatore e Salvato-re del genere umano, che dalla stirpe di lui dovea nascere , e<£essere con migliori titoli il consolatorc, e la speranza djJ mondo-:
La incredulità degli nomini, e il disprezzo, che questi fòdero del-la predicazione di Noè, che egli invitava a penitenza, dimostrano,in qual maniera sarà ricevuto il Messia dal suo popolo \ o lo stt-i-minio di quelli per mezzo delle acque del diluvio presagisce lapiena de'mali, e delle orrende sciagure, onde sarà repentinameivte oppresso il popolo Ebreo per aver rigettato il suo Cristo. Pe*di Mailh, xxiv. 3^. Noè, che riunisce nell'arca, e salva sopra Jcacque la sua famiglia, rappresenta viàbilmente il òahdlore degi'i

«9- Et impleti suntI omnes dies ejus non-
gentorum quinquagin*ta annorum: et mor-tuus est, *
29» E tutta intera lasua vita fu di novecen-to cinquanta anni, e simori.
C A P O X.
Genealogia de figli di Noè da1 quali vennero lediverse nazioni dopo il diluvio, e nacquerotutti i mortali.
i, (i) flae suntgenerationes fiUorum"Sioe, &|0i, Cham, etJa»pheth: natiaue sunt ejusfilii post diluvium.
x a. Filii Japhcth Co-rner, ctMagog, et Ma-
i. v^uesti sono i di-scendenti de'figliuoli diNoè , di Sera , di Charn,e di Japheth: e questi ifigliuoli nati ad essi do-po il diluvio.
e. Figliuoli dì Ja-pheth sono Gomer , e
(i) i. Par. i. 5,
uomini, il quale riunisce colla sua Chiesa ( fuori di cui non e sa-lute ) la sua famiglia per santificarla, mondandola con la la-vanda d? acqua mediante la parola di vita- Ephes, v. 26. Lastessa ebbrezza di Noè con ciò ci» ne avvenne^ci dipinge al vivol'estremo amore di Grato verso la Chiesa ; amore, che lo ridussea spogliarsi di tutta la sua gloria, e ad esporsi alle ignominie , e«gli scherni dei suoi nemici, e a «offrire il più obbrobrioso sup-plizio, nessun caso facendo della confusione : sostenne la croce,dispreizando la confusione. Ma due de'figliuoli di Noè rispetta-no, ed onorano la dignità del padre nella sua umiliazione,,e Ge-sù Cristo in virtù delle stesse sue^imiliazioni sarà adorato qual
tùjìj*0 ad P°SS?° Gentile figurato in^fapheth, e dall' ebreo fedele^§Jlitatpre diSérà, e la maledizione, e l'ira starà sino al fine eo-^pra gli empi discendenti di Cham, «opra i Giudei increduli, tra-
ditori , ed uccisori-del Cristo.Vers. 2. Figiijbli di Japhelh èc. Presso alcuni scrittori Cri-
stiani si trova scrìtto, che Noè per ordine di Dio assegnò a S%m

dai, et Javan^ et Thu-balt et Mosoch, et Thi-ras.
3. Porro filii Corner,Ascenez, etRiphath, etThogorma.
4- Filii autem JavanìElisa, et Tharsis, Cet~tliimì etDodanim.
Magog , e Macia i , e Ja-van , e Thubal, e Ma-soch, e Thiras.
3. E i figliuoli di Go-mer, Asctnez, e Ri-phalh, e TJ|ogorma.
4. E i figliuoli di Ja«van , Elisa , e Tharsis ,e Getthinij e Dpdanim.
l'Oriente, l'Africa a Cam, e tutta l'Europa coli'isole, e le partìsettentrionali dell' Asia a Japheth, e che di questo spartimentone lasciò scrittura nelle mani di Sem. Questa divisione, dellaquale brameremmo di avere documenti più certi, e più antichi,può combinare con quella che è qui raccontata da Mosè. Da'fi-gliuoli di Japheth qui nominati, ^oè Corner, Magog, ec., dopola dispersione avvenuta a causa della edificazione di Babel disce-sero altrettante nazioni: ma il determinare, quale da ciaschedunodi essi avesse 1' origine , è cosa sommamente difficile, e sopra laquale per lo piìi non possiamo avere, se non deboli congetture.
Corner. Da Gomer molti credono derivati i Cimbri, o siaGermani.
Magog. Questi è creduto padre degli Sciti, de'Geti, e Mas-sageti.
Mudai. Per sentimento comune, da lui ebbero nome e ori-gine i Medi.
Javan. Da lui i Jonii, e forse tutti i Greci,Thubal. Da lui gli Spagnuoli, detti in antico Iberi: cosi s.
Girolamo.Mosoch. Da lui i Moscoviti, e secondo altri, i popoli di Cap-
padocia.Thiras.'T?et. comun pareri^ padre de'Traci.
Vers. 3. Ascenez. Nell'Ebreo Ascenaz. Egli popolò l'Asia, ov-«vero secondo altri una provincia della Frigia minore, chiamataAscenia,
Riphat. Da lui i popoli della Paflagonia, ovvero quelli del-la Bitinia. V
Thogorma. Da lui molti pretendono esser venuti i popolidella Turcomania, e i Turchi nominati da Plinio.
Vers. 4- Kìisa. Da lui forse ebbe nome l'Elide nel Peloponneso.Tkarsis.Ua lui quelli di Tarso, e gì i al tri popoli dellaCilic^Cetlhim. Non v' ha dubbio , che nella Scrittura la terra «H
flelthim è la Macedonia, la quale da questo figliuolo di Ja\an do-•* ette aver nome, onde fu anche detta Maceli»-.'
Duilftfiim. Da lui molti derivano i Dodonci, nelJ'Epiro»

6. Ab his divisaesunt insulae gentiumin regionibus suis, u-nusquisque secundumUnquam suam , et fa-milias suas in nationi*bus suis.
6.FUU autem ChamChus, et Mesraimì etPhuth ,et Chanaan.
7. Filii Chus Sala 5et llevila, et Sabatha,et Regma, et Sabata*cha. Filii Regma Sa-ba> et Dadan.
5. Questi si diviserole ìsole delle nazioni ,e le diverse regioni,ognuno secondo il pro-prio linguaggio , e lesue famiglie , e la suanazione.
6. E i figliuoli diCha m sono Ghus, e Me-sraim , Phuth, e Cha-naan.
7. I figliuoli di ChusSaba, ed Hevila , e Sa»batha , e Regina , e Sa-ba lacha. 1 figliuoli diRegina Saba } e Dadan.
Vera. 5. Le ìsole delle nazioni. Col nome J'isole delle nazio-ni s'intendon non solamente le vere isole, ma anche i paesi sepa-rati dal continente della Palestina, a'quali paesi gli Ebrei nonpotevano andare, se non per mare. Cosi le Spagne, le Gallie ,l'Italia, la Grecia, l'Asia minore presso gli Ebrei dicevansi isoledelle nazioni.
Yers. 6. Chus. Cham , come dicemmo , ebbe 1' Africa per sua; parte, e Nemrod, uno de'suoi discendenti, usurpò molti paesi ap-
partenenti a' figliuoli di Sem, come vedremo. I discendenti diChus popolarono una parte dell'Arabia, che è perciò detta nelJcScritture la terra di Chus. Questo nome però si dà talora ancheali' Etiopia : onde conviene ricorioscere più paesi di tal nome.
Mesraim. Da lui i popoli dell'Egitto , il quale anche ia og-gi è detto Mesra dagli Arabi e da' Turchi.
Phuth. Da lui i Man titani e quei della Libia. Nella Mauri-tania havvi il fiume Phuth.
Cariaart. Da lui i Cananei, il paese de'quali fu poi «fello laterra d'Israele, e dopo il ritornò dalla cattività di Babilonia ebbe il nome di Giudea.
J., "Vera. 7. Saba. Da lui (secondo s. Girolamo) i Sabei famosiYpe' fóro incensi nell'Arabia.
ffevila. Da lui, secondo alcuni, i Cavelei rammentati <laPlinio, abitanti ne^'Arabia verso il golfo Persico,
Stfbathci. Da lui i Sabatci3 anch'essi udì' Arabia.

8. Porro Chus ge/tuitNemrodi ipse coèpit es*se polens in terra.
9. Et erat robustusvencitor coram Domino;ob hoc exìvit prover-biimi: Quasi Nemrodrobustus v enator coramDomino.
10. Fuit autem prin-cipium regni ejus Ba-by ton , et Arach, et A-chad, et Chalanne, interra Sennaar.
8. Chus poi generòNemrod: questi comin-ciò ad essere potentesopra la terra.
9. Ed egli era caccia-tore robusto dinanzi alSignore; d'onde nacqueil proverbio:ComeNem-rod cacciatore robustodinanzi al Signore.
10. E il principio delsuo regno fu Babilonia,e Arach, e Achad , eChalanne nella terra diSennaar»
Regma. Una città di Regama sul golfo Persico è rammenta-ta da Tolomeo.
Sabalacha. Questi, secondo Bochart, passato dall' Arabianella Caramania , vi lasciò qualche memoria del suo nome.
Saba. Nella Caramania è la città, e j.1 fiume Sabis.Dadan. Da lui credesi che avesse nome la città detta in og-
gi Daden, o dì Adeo, e il paese vicino detto Dadena sul lito delmar Persico.
Vers. 8. Comincio ad essere potente sopra la terra. Secondoi LXX. egli era un gigante, vale a dire, che Nemrod era famososì per la mole e robustezza del corpo, sì ancora per 1' audacia ela crudeltà. 11 nome di Nemrod può essergli stato dato per lasua empietà. NemEod vale ribelle;*
Vers. g. Cacciatore robusto Dinanzi al Signore. Cacciatorenon di fiere, ma di uomini, i quali egli riduceva in ischiavitìi.Quella giunta dinanzi al Signore significa , secondo la fraseebrea , che veracemente e singolarmente questo nome si adat-tava a Nemrod.
* Cacciatore robusto dinanzi al Signore. Vedi l'osservazioneal Cap. VII. verso i.
Vers. io. Il principio del suo regno fil Babilonia, Nemroddopo la dispersione di Babel si fermò nel paese , dove erasi co-uiiuciata la fabbrica della famosa torre , e fondò Babilonia, e le 'tre città qui nominate nella terra di Sennaar; che così chiam.i-vasì il paese di Babilonia : ed è ciò notalo afliri di distinguerequesta Babilonia da quella di Egitto , tlt'lta in o^-i il Cairo.

11. De terra illa e-gressus est Assur, etaedificavit Niniven 3 etplateas civitatis , etCitale,
12. Resen quoque in'ter Niniven et Chale \haec est civitasmagna.
15. AtveroMesraimgenuit Ludim, et Ana-mim , et Laabim, etRephtuim,
i4. EtPhetrusim, etChasluim : de quibus e-gressi suntPhilisthiim,etCaphtorìm,
11. Da quella terrausci Assur , ed edificòNinive, e le piazze del-la città , e Chale,
12. Ed anche Resentra Ninive e Chale :questa è una cittàgrande.
13. Mesraim poi ge-nerò Ludim , e Ana-mim , e Laabim, e Ne-phtuim,
14- E Phetrusim, eChasluim: da'quali ven-nero i Filistei, e i Ca-phtorimi.
Vers. 11. Da quella terra uscì 4ffur.\ssur figliuolo di Semtcostretto da Nemrod ad abbandonare il paese di Sennaar, che'era di sua ragione , ritirassi nel paese, a cui diede il suo nome ,onde l'Assiria, di cui la capitale è Ninive.
E le piazze della città. L'Ebreo ha Rohoboth^ e lo stesso iLXX, e lo stesso nome è ritenuto nella nostra Volgata, cap. xxxvi.37. i.Paralip. 1.48.
Yers. 12. Questa e una dita grande. Parla certamente di Ni-nive rammentata in primo luogo al principio del verso precedente.
Vers. 13. Ludim. I suoi discendenti doveano abitare verso l'E-gitto. fedi Ezuch. xxx. 5. :..-.'
Ànamim. Bochart «rede ; che egli desse nome a' popoli cheabitavano vicino al celebre tempio di Giove Ammone.
Laabim. Da lui i Libj dell'Africa, o quelli d'Egitto.Nephluim. Da lui alcuni vogliono discesi i Numidi.
Vers. 14 Phetrusim. Da lui diconsi derivati quelli della Tebai-de detta Patras nelle Scritture, e secondo alcuni gli ArabiPetrei,
Chasluim. I Parafrasti Caldei, 1' Arabo, ed altri mettono isuoi discendenti nell' Egitto inferiore.
•f' Fil^fteì.^Sono notissimi per le guerre continue che ebberofon essi gli Ebrea, perchè eglino avean occupata una parte dellaCananea. Vedi Sophon. n. 5.
7 Caphtorirni. Ciedonsi gli abitanti dell' isola di Candia , i. celebri Cretesi.

15. Chanaan autemgenuit Sidonem primo-genìtum suum, He-thaeum,
io. Jebusaeum, etAmorrhoeum, G erge*saeum,
17. Hevaeum, et A-racaeum, Sinaeum,
18. Et Aradium, Sa*maraeum , et Ama*thaeum : et post haecdisseminati sunt popu-li Chananaeorum.
19. Factique sunttermini Chanaan ve»niendbus a Sidone Ge*raram usque Gazamìdonec ingrediaris So-domam^et Gomorrham,et Adamam, et Seboimusque Lesa.
zo.Hìsurttfilii Chamìncognationibus, etUn~guisì et generationìbus,terrisqùe, et gentìbussuis.
31. De Seni quoquenati sunt>patre omnium
15. Cbanaan poi ge-nerò Sidone suo primo-genito , d'onde gli He-tei,
15. Gli lebusei, e gliAmorrei, i Gergesei,
17. Gli Hevei, egliAracei, e i Sinei ,
18. E gli Aradei, tSamarei, e gli Amatei:e da questi venne la se-menza del popolo de*Cananei.
19. E i confinì diChanaan sono andandotu da Sidone a Gerarafino a Gaza , e fino chetu giunga a Sodoma, aGomorra, e Adamam ,e Seboim fino a Lesa.
20. Questi sono i fi-gliuoli di Cham distin-ti secondo la loro ori-gine , e i linguaggi, ele generazioni, e i pae-si , e le loro nazioni.
21. E anche Seni, pa-dre di tutti i figliuoli di
Vers. 15., 16., 17. e 18. Sidone suo primogenito. Il quale fon-dò Sidone famosa città della Fenicia, e fu padre di quel popolo.
Gli Elheii gli lebusei ce. Abbiamo qui undici popoli disce-ti da undici figliuoli di Chanaan.
Vers. 21. Di tutti i figliuoli di Heber. Figliuoli di Heber somi popoli abitanti di là dall'Eufrate, come diremo al vers. a/I'

fiUorum Hebert fratreJapheth majore.
22. (i) filii Seni,Aelamì et Assur^etAr-phaxad , et Lud, etAram.
25. Filii Aram , Usìet Hul, et Gether, etMes.
24. At vero Arpha-xad genuit Sale, de quoortus est Heber.
Heber, fratello maggio-re di lapheth, ebbe fi-gliuoli.
22. Figliuoli di Sem,Elam , e Assur, e Ar-phaxad, e Lud, e A-ram.
23. I figliuoli di A-ram, Us, e Hul,e CJeiher,e Mes.
24. Ma Arphaxad ge-nerò Sale, da cui ven-ne Heber.
(ij i. Par. i. 17.
Fratello maggiore di lapheth. L'Ebreo può benissimo tra-dii rsi fratello di lap hel h il maggiore, o sia il primogenito. Co-sì i LXX., e cojnunemente gl'Interpreti ; e dall'altro lato sembrafuori di dubbio, che lapheth fu il primogenito di Noè. Qui Mosèprincipia a descrivere la discendenza di Seni, e in essa si esten-de più che in quella degli altri fratelli, perchè da Sem venivanogli Ebrei, pe* quali egli scriveva.
Vers. 22. Elam. Da lui gli Elamiti vicini alla Media, e de'qua-li la capitale fu Elimaide.
Assiir. Di lui vedi vers. \\.Arphaxad. Il nome di cui dicesi che portassero una vol-
ta i Caldei.Luti. I suoi discendenti abitarono la Lidia nell' Asia minore.Aram. Il paese di Aram nelle Scritture comprende la Me-
sopotamis e la Siria: gli Aram ei, o Arimei spjjjp rammentati da'piìiantichi scrittori.
Vers. 23. Us. Gli antichi credo/no fondata, da lui Damasco , eche egli desse il nome al paese circonvicino, chiamato Us da-gli Ebrei.
HuL I discendenti di lui sono collocati nell'Armenia.Gelher. S. Girolamo vuole, che questi sia padre degli Acar-
nani, e de'popoli della Caria; quelli nell'Epiro, questi nell'Asia
Mes. Ne'Paralìpomenì lib. i. cap. i. 17. egli è detto Mesech.'Da lui credesi dato il nome al monte Masio nella Mesopotamia.
Vers. 34. Sale. Da lui i popoli della provincia di Susa, dove*era un^ città detta Scia sul fiume Eleo,

26. Natique suntHe-ber filii duo: nomen uniPhaleg, eo quod in die-bus ejus divisa sit ter-ra -- et nomen fratrisejus Jectan.
26. Qui Jeclan ge-nuit Elmodad, et Sa-leph, etAsarmoihJare,
27. Et Aduram, etUzal, et Decla,
28. Et Ebal, et Abi-mael, Saba,
29. Et Ophir, et Jle-vila , et Jobab : omnesisti filii Jectan.
30. Et facta est ha-litatio eorum de Mes*
26. E ad Heber nac-quero due figliuoli : u-no si chiamà Phaleg ,perchè a suo tempo fudivisa la terra : e ilfratello di lui ebbe no-me Jectan.
26. Questo Jectangenerò Elmodad , e Sa-leph , e Asarmoth Jare,
27. E Aduram , e U-zal, e Decla ,
28. Ed Ebal, e Abi-mael, Saba,
29. E Ophir, ed He-vila, e Jobab : tuttiquesti figliuoli di Je-ctan.
30. E questi abitaronnei paese , che si trova
Da cui venne HéK$r. Da lui Vogliono alcuni, cne venisse ilnome di Ebreo, il qual nome fu por dato ad Àbramo: ma sembrapiù giusto il sentimento di s. Girolamo, del Crisostomo, e dimolti altri, i quali dicono che il nome di Ebreo dato ad Abramosignificava, com'egli era originario del paese di là dall'Eufrate.I popoli situati oltre di questo fiume erano detti/?g7iaoZi di di /à,figliuoli di Eber: i LXX. in vece di àbramo Ebreo, tradusseroÀbramo passeggero, Gen. xiv. 13,
Vera. ?.5. Si chiamo Phaleg. Questa divisione della terra, osia degli uomini, e delle loro lingue, per sentimento di s. Giro-lamo, e di molti Interpreti, avvenne qualche tempo dopo la na-scita di Phaleg : ma il padre Heber illuminato da Dio previde ladivisione, e l'annùnzio in certo modo, dando questo nome al su»proprio figliuolo. Phaieg può aver dato il nome alla città diPhalga sul!' Kufrate.
Jeclan. Giuseppe Ebreo assegna a Jectan, e a'snoi figliuoli ipaesi dal fiume Cophene fino all'Indie, e alle regioni confinantide' Seri.
Vers. 3o. Da Messa fino a Sephar. Intorno alla vera situazio-ne di questiluoghi si disputa tra gli eruditi.

sa pergentibus usqueSephar^ montem orien-talem.
31. Isti filii Sem se-cundum cognationes ,et linguasy et regionesin gejitibus suis.
32.Hae familiaeNoejuxta populos, et natio-nes suas. Ab his divi-sae sunt gentes in ter-ra post diluvium.
andando da Messa finoa Sephar , monte , cheè ali' oriente.
31. Questi sono i fi-gliuoli di Sem secondole loro famiglie , e lin-guaggi, e paesi e nazio-ni proprie.
32. Queste sono le fa-miglie di Noè secondoi loro popoli, e nazio-ni. Da queste uscironle diverse nazioni dopoil diluvio.
C A P O X I .
Nella fabbrica della torre di B abelle resta con-fusa la superbia, e il linguaggio degli empii.Genealogia di Sem fino ad A bramo.
1. ( i ) j / / v z £ autemterra labiiunius^etser-ìtionum eorumdem.
2. Cumque proficisce-rentur de oriente, in-
1. V^r la terra aveauna sola favella , e unostesso linguaggio.
2. E partendosi dall'oriente, gli uomini Irò-
(i) Sap. io. 5.
Vers. 31. Secondo le loro famìglie e linguaggi. Anche questo« detto per, anticipazione ; conciossiaehè fino alla dispersione laferra ebbe un solo linguaggio ( come dicesi nel vers. i. del càp.eegwente), yale a dire il linguaggio, che ebbe Adamo , che era ol'Ebreo, jod altro molto simile all'Ebreo.
Vers. 3ft* * Da queste uscirono. Si staccarono.Ve**; 2; E partendosi dall'oriente, gli uomini trovarono ec. I
figliuoli di Noè ti suppone, che abitarono presso alle montagne

venerimi campum interra Sennaar, et ha-bitaverunt in eo.
3. Dixitque alter adproximum suum1. Ve-nite, faciamus lateres,et coquamus eos igni.Habueruntf/ue Laterespro saxis , et bitumenpro coementoi
4« Et dixeruntì Te-nite, faciamus nobiscivitatem , et turrim,cujus culmen perdngatad coelum : et celebre*mus nomen nostrum,antequam dividamurinuniversas terras.
varono una campagnanella terra di Sennaar,e ivi abitarono.
3. E dissero tra diloro : Andiamo , faccia-mo de' mattoni, e licucciamo col fuoco. Esi valsero di mattoni incambio di sassi, e di bi-tume in vece di cal-cina:
4. E dissero: Venite,facciamoci una città , euna torre , di cui la ci-ma arrivi fino al cielo;e illustriamo il nostronome prima di andardivisi per tutta quantala terra.
dell'Armenia, Di là a molti anni, moltipllcatisi assai, si avanzaro-no a cercare migliori terreni, e si posarono nella campagna dìSennaar, paese sommamente fertile e abbondante di ogni cosa.Ma propagatisi ben presto oltre misura , si videro costretti a se-pararsi per cercare nuove abitazioni. Allora fo, che venne loro inpensiero di fabbricare la famosa torre, di cui parla Mosè.
\ers. 3. Si valsero di mattoni ... e di bitume ce. II paese hagrande scarsezza di pietre, e il bitume vi abbonda, ed è celebratoda tutti gli antichi scrittori. Non con altri materiali, che mattonie bitume, furono fatte le grandiose fabbriche alzate in Babiloniada Semiramide e da Nabuccodonosor.
Vers. 4- E una torre, di cui la cima ec. S. Girolamo in Isai.cap. xiv. dice, che questa torre dovette essere ^ta quattro milapassi, che fan quattro miglia italiane. Da questo fatto potè averorigine la favola de' giganti, i quali secondo i poeti vollero farguerra al cielo.
Illustriamo il nostro nome. Quegl'Interpreti, i quali hanvoluto scusare i*lì autori di tal impresa, fanno contro la comunedottrina de'Padri, e contro il fatto di Dio medesimo, che punì imedesimi autori. Peccarono adunque di vanità e di superbia; e ilCrisostomo dice, che ad essi sono simili coloro, i quali intrjipren-

6. Descendit autemDominus, ut videret ci'vitatem^ etturrimjjuamaedificabantfiLUAdanii
6. Et dixit : Ecce,unus est populus, etunum labium omnibus^coeperantgue hoc face*re, nec desistent a co-gitationibus suis, do-nec eas opere com-pleant.
7. Vgftite igitur^ de-scendamuS) et confun-damus ibi linguam eo-rum , ut non audiat u-nusquisque vocem pro-ximi sui.
6. Ma il Signore di-scese a vedere la città ela torre,che fabbricavanoi figliuoli d'Adamo,
6. E disse : Ecco chequesto è uri sol popolo,ed hanno tutti la stessalingua : ed han princi-piato a fare tal cosa , enon desisteranno da'lo-ro disegni, fino a che gliabbian di fatto condot-ti a termine.
7. Venite adunque ,scendiamo, e confondia-mo il loro linguaggio ,sicché 1' uno non capi-sca il parlare dell'altro.
.• dono grandi edilìzi! per vanagloria. Non vuole pero negarsi, dieforse non pochi furono quelli, particolarmente della famiglia diSeni, i quali o non prestarono la mano a quell'opera, o noi fece-ro col fine che aveano gli altri.
Vers. 5. Ma il Signore,discese a vedere ec. Maniera di parla-re tutta umana , ma di grand' enfasi a spiegare la Provvidenza,che veglia sopra tutti gli andamenti degli uomini.
I figliuoli di Adamo. Vale a dire uomini mortali, che altronon sono che terra e polvere, e ai alzano fino al cielo col loroardimento.
"Vers. 7, Venite adunque, scendiamo ec. Prima Dio disceseper osservate; ora dicesi, ché scende a punire. Alcuni Padri daquesta manierjLdi parlare in plurale credono qui accennata la
.frinita delle pitsone divine. Grandissimo fu il miracolo fatto daDio di cambiare repentinamente 1' unico linguaggio di tutti gliuomini .instante lingue diverse , quanti erano i capi di famiglia:iiiaperoceìi.è ciò sembra indicarsi da Mosè, quando dire x. 5. Qne-
' sii'^.ì/jj^s^p le isole delle nazioni... ognuno secondo il pro-prio liiijrùtàggio , e le sue famiglie e la sua nazione. Or secon-do il testo ebreo e la Volgata , si contano settanta capi di fami-gliaj^seeondo i LXX. se ne contano sino a settantadue. SiccomeperSlfoolti de' discendenti di No<; rammentati al capo precedente

8. Atque ita divistieos Dominus ex illofoco in universas ter-ras , et cessaverunt ae-dificare civitatem.
9. Etidcirco vocatumest nomen ejus Babel,quia ibi confusum estlabium universae ter-rae , et inde dispersiteos Dominus super fa-ciem cunctarum regio-num.
10. Hae sunt gene-rationes Sem : ( i ) Senierat centum annorum,quando genuit Arpha»xad, biennio post dilu-vium.
n. Vixitque Seni,postquam genuit Ar-
(i) i. Par- i. 17.
8. E per lai modo glidisperse il Signore daquel luogo per tutti ipaesi, e lasciarono daparte la fabbrica dellacittà.
9. E quindi a questafu dato il nome di Ba-bel , perchè ivi fu con-fuso il linguaggio ditutta la terra , e di là ilSignore li disperse pertutte quante le regioni.
10. Questa è la ge-nealogia di Sem : Seniavea cento anni, quan-do generò Arphaxad,dueanni dopo il diluvio.
11. E visse Sem , do-po aver generato Ar-
( i ) i. Par. i. 17.
non erano nati al tempo della confusione delle lingue, quindi è,che non resta necessario di supporre, che in tanto numero fosse-ro i linguaggi che nacquero allora, e gli eruditi riducono ad unpiccolo numero le lingue matrici, delle quali sono tanti dialettitutte le altre ; come per esempio, dialetto dell' Ebreo credonsi ilCaldeo, il Siriaco, il Cananeo, il Cartaginese, l'Arabo, l'Armeno,l'Etiopico, e il Persiano. -V '
Vers. S.* E per tal modo lì disperse il Signore. Con quantopoco Dio sa confondere il nostro orgoglio ! E se ciò avvenne l'an-no 34o dopo il diluvio , secondo un' antica opinione , l'istessoNoè sopravvissuto dieci anni, fu testimone di una nuova strcpi-tosa umiliazione dell' intero genere umano.
"Vers. io. Questa e la genealogia ni Sern. Torna. Mosè a de-scrivere i discendenti di Sem per la famiglia di Aiphaxad. Jìnoad Abramo, v"

pJiaxadì quingentis an-nis : et genuit filios etfilius.
12. Porro Arpnaxadìlvixit triginta quinque
anniS) et genuit Sale.13. Vixitque Arpha-
xad, postquam gentiliSale, trecentis tribusannis : et genuit filiosetfilias.
14. S ale quoque vìxittrìginta annis , et ge»nuitJìej^er.
15. Ìn.xitque Sale,postquam genuit He-bér> quadrijigends tri-bus annis : et genuitfilios etfilias.
16. Vixit autem He-^'bèr trìginta quatuor
annis, etgenuitPlialeg.17. "Et vixit Heber,
postquam genuit Pfaa-leg, qùadringentis tri-ginta annis , et genuitfilios etfilias.
18. Vixit quoquePhaleg trìginta annis,$t genuit ijj&u., i$.(^ì)lMxitquePha-leg, pmtqnam genuitKéii^f-t ducentis novem
, 4tn&ì»$ : et genuit filios^é&$ias.
phaxad, cinquecentoanni : e generò figliuo-li e figliuole.
12. Arphaxad poi vis-se trentacinque anni,e generò Sale.
13.E visse Arphaxad,dopo aver generato Sa-le , trecento tre anni :e generò figliuoli e fi-gliuole.
i4-Sale poi visse tren-t'anni, e generò He-ber.
15. E visse Sale , do-po aver generalo He-ber , trecento tre anni:e generò figliuoli e fi-gliuole.
16. E visse Hebertrenta quattro anni ,e generò Phaleg.
17. E visse Heber,dopo aver generatoPhaleg, quattrocentotrent' anni, e generòfigliuoli e figliuole.
18. E visse Phalegtrent* anni, e generòReu.
19. E visse Phaleg,dopo aver generaloReu,dugento nove.an-ni t e generò figliuolie figliuple.
flOF«,'. ..19.

20» Vìxil autem Reatriginta duóbus annis,et genuit Sarug.
21. yixitquoque'Reu^postquam genuit Sarugiducentis seplem annis :et genuit filios et filiam.
22. Vixit vero Sarugtriginta annis\et genuit*$[achor*
23. Vixitque Sarug)postquam genuit Na-cJior, ducenti^ annis:et genuit filios etfilias.
24. Vìxìt autem JT«-chor viginti novem an-nis\ et genuìt Thare.
26. yixìiyae Nachor,postquam genuit Tha*re, centum decem, etnovem annis : et genuitJilios etfilias*
20.E visse Reu tren-tadue ann i , e generòSarug.
ai. E visse Reu, ^o-^po aver generato Sa-rug , dugenlo sette an-ni : e generò Jgliuoiie figliuole.
22, E visse Sarugtrent 'anni j e generòNachor.
23. E visse Sarug,dopo aver generatoNachor ,dugehto anni:e generò figliuoli e fi-gliuole.
24. E visse Nachorventinove anni, e ge-nerò Thare.
26. E visse Nachor ,dopo aver generatoThare, cento dicianno-ve annis e generò fi-gliuoli e figliuole.
Vers. ar>. Sftrug. Alcuni hanno créduto che a' tempi di Sarug«Yesse principio 1' idolatria. Dimenticato il vero Dio creatore deltùelo e della terra, gli uomini cominciarono a rendere il loro cui*t:o al sole i, alla luna, alle stelle ; indi agli uomiif^celebri pe* 1*invenzione delle arti, o per imprese guerriere; e finalmente aglianimali, ed anche alle piante, e a cose ancora più VÌK. EusebioPrctep. 1. i.cap. 6, pone l'origine della idolatria nell'Egitto;donde dice, che ella si sparse tra' Fenici e tra' Greci, Npn pu<>dubitarsi, che nella famiglia di Nachor e di Thare si adorasserogl'idoli. Vedi Josue xxiv. i. 14- S, Agostino de civ. lib, x. cap»tilt, scrive, che Abramo liberato per divina vocazione dalle super-?stizìoni de'Caldei, cominciò a seguire e adorare il vero Dio. ^|rfl

26. Vixitque Thareseptuaginta (i) annis,
rt.et genuit Abram, et^ffachor, et Aran.
27. Hae sunt autemgenerationes Thare :Thare genuit Abram,Nachor, et Aran. Por-ro Aron genuit Lot.
28. Mortuus que estAran ante Thare pa-trem suum in terra na-
'( tivitatis^j$uae , in UrCìialdaWrum»
29. Duxerunt autemAbrami, et Nachor uxo~res ; nomen uxoris A-oram, Sarai : et nomen
«uxoris Nachor, Melclia*filia Aran, patris Mei-chaet et patris Jeschae.
3o» TLrat autem SaraisteriliS) nec habebat li-beros.
26. E visse Thare set-iant'anni, e generò A-bram, e N a elio r, e Aran,
27. E questa è la ge-nealogìa di Thare ; Ta-re generò Abram, Na-chor, e Aran. Aran poigenerò Lot.- 28. E morì Aran pri-ma di Thare suo padrenella terra, doy' era na-to, in Ur de' Caldei.
29. E Abram , e Na-chor si ammogliarono :lamoglie di Abram aveanome Sarai: e la mogliedi Nachor ebbe nomeMelcha , figliuola di À-ran , padre di Melcha,e padre di Jesca.
5o- Ma Sarai era ste-rile^ non avea figliuoli,
(V) Jbs, a 4* 2. i. Par. i. 26.
Yers, ao. Generò Abram, e Ivitckof^ « Aran* Àbramo, be»-iphè posto ^Jllsfè *n primo luogo, era il terzogenito de' figliuo-li di Thare. €fpi Sena è sempre nominato il primo tra' figliuolidi Noè ,benché minore di Japheth, a cui si dà il terzo luogo.
Vers. 7/8. In Ur fJe' Caldei. Ur in ebreo significa fuoco, etmfcsto diede forse origine a' racconti degli Ebrei, i quali dicono,elle Àbramo gettato nelle fiamme da' Caldei, come adoratore delsolo Vero Dio , ne fu liberato per miracolo ; e quindi si ritiro colpadre ad Haran. Trovandosi rammentata la città di Hura nella*lesopotamia , molti credono , che ella sia quella città , di cui sijrjrrfa in questo luogo; e perciò pretendono , che l'antica Caldea«ompreudesse anche la Mesopotamia. Vedi Aui vu. 2. 4

31», (i) Tulli itaqueThare Abram fdiumsuum , et Lot filium A-ran , filium filii sui , etSarai nurum suam , u-xorem Abram filii sui,et eduxìt eos de UrChaldaeorum (2) ut i-rentin terramCìianaamveneruntfjue usque Ha-ran, et habitaverunt ibi.
32. Et facti juntdies Thare dwcentorum(}uÌ77«iue annorum , etmortuus est inHwaJi.
31. Thare adunqueprese seco Abram suofigliuolo , e Lui figliuo-lo di Aran , (cioè) ffefgliuolo di un suo figliuo-lo , e Sarai sua nuora,moglie di Abram suo fi-gliuolo . e la (fondasseA'ia da Ur de'Galdei perandar nella terra di Cha-naa n , e andarono finoad Harà n , ed ivi abita-rono.
32. E visse'Thare du-g$r»lo cinque anni , emorì iu Ilaran.
(i) Jos. 9.4 2- -N^* 9- r(•>.) Judith. 5, 7. A-ct. 7.
Vers. 3-i. Tlvare adunque prtsv seco j4bra<qjjfa. Questa par-tenza da Ur si suppone seguita dopo la prima Riamata di Dio ,di cui si parla negli Atti, cap. vii.
Andarono fino ad Harnn. Ella fu di poi detta Carré^ cit-tà famosa nelle storie , particolarmente per essere stato n«lle suevicinanze sconfitto da' Parti 1' esercitt) romano, sotto la condottadi Grasso. I Turchi hanno in venerazione quel luogo pel soggior-no fattovi da Abramo. Con Àbramo e con .Thare, credesi , cheanche Nachor , e il rimanente della famiglia passassero in Hilaa.fedi Aug. de civ, xvu 13,

C A P O XII.
^Àbramo obbedendo al comando di Dio, ricevutele promesse , abbandona la patria, e in com"pagnia di Lot va pellegrino nel paese di Cha-naan, e fa sacrificio al Signore in Sich&m , ea Bethel. Indi portandosi in Egitto per cagiondella fame, dà alla sua moglie il nome di so-rella ; ed essendo ella stata condotta via acasa di Faraone , è poscia renduta a lui in*latta.
1. (i) jLfixit autemDominus ad A bram :Egredere de terra tua,et de cognatione tua,et de domo patris tuìt
';frt venì in terram, quammonstrabo tibi*
2. Faciamque te Ingentem magnani, et be-
1. JLJ il Signore dis-se ad Abramo : Partidalla tua terra , e dallatua parentela , e dallacasa del padre tuo , evieni nella terra , cheio ti insegnerò.
2. E ti farò capo diuna nazione grande , e
(i} Act. 7. 3.
Yers. i. E il Signore disse ad Àbramo, ec> Questa è la se-conda vocazione riferita negli Atti cap. vii. 5. 6. e da questa sicontano i quattrocento treni* anni $ pellegrinaggio notati nel-l'Esodo cap. xii. 4<>. 41** e da Paolo <?«/. ni. ij.
E vieni nella terra che io ti insegnerò. Dio non determina£1 paese , in cujlvuol condurre Abramo ; ma gli ordina di lasciartutto, e dì andare, dovunque egli vorrà condurlo. Degnlssirnaperciò è la fede di questo Patriarca degli elogi di Paolo : Per Lafede quegli che e chiamalo Abraham, obbedii per andare al/«o#o, che dovea ricevere in eredita, e parù senza saper, dovettn^atse^ IJeb. xi. 8. Le promesse fattegli da Dio sono grandi,•UM! Jwro adempimento è lontano ; e un uomo di minor fede dilui non avrebbe saputo indursi a distaccarsi da tutto, ed esporsia un lungo e incerto pellegrinaggio, e a tutù i disastri, che l'ac-compagnano.

nedicam tibi, et magni-ficabo nomen tuum, e-riscjue benedictus*
3. Benedicam bene-dicentibus tibi, et ma-ledicam maledicenti-bus tibi, atque (i) INTE benedicentur uni-versae cognationes ter-Tae.
4- Egressus est ita-que (2) Abram, sicutpraeceperat ei Domi-nus , et ivit cum eo
li benedirò, e farò gran-de il tuo nome , e saraibenedetto.
3. Benedirò que' cheti benedicono , e male-dirò que* che ti maledi-cono , e IN TE saranbenedette tutte le na-zioni della terra.
4- Parti dunque Abra-mo , conforme gli aveaordinato il Signore , econ lui andò Lot: Abra»
(i) Infr. 18. 18. aa. 18. Gai 3. 8,(*) Jfeb. ii. 8.
Vers. a. Ti faro capo di una, nazione granile. Secondo lalettera Abramo fu capo e stipite della nazione ebrea, la qualesi moltiplicò a dismisura, e divenne un gran popolo uguale nelnumero alle arene del mare , come più volte è detto nelle Scrit-ture. Secondo un altro senso più importante, Abramo è padr<j£,rnon solo degli Ebrei, ma anche di tutti i Gentili fedeli-, e imita-tori della sua fède. Vedi Kom. iv. 7,
Tibenedirò ... et arai benedetto. La benedizione di Dio, elagloria, alla eguale egli promette d' innalzare Abramo, compren-dono senza dubbio anche là copia di tutte le felicità temporali,le quali volea Dio nel merito della fede di lui spargere a largamano sopra il suo popolo. Ma a tutta altra felicità aspirava ilcuore di Abramo : distaccato da tutti i beni della terra egli stet-te pellegrino nella terra promessa , come non sua, abitandonelle tende ... Imperocché aspettava puella citta ben fondata,della quale e architetto Dio , e fondatore. Heb. xi. g. La felici-tà, e la gloria di quella patria è promessa ad Abramo da Dio,quando gli promette di benedirlo, d'essere suotÉbotettore , e difar si, che egli sia come un esempio di quel che sia .per un uo-mo la benedizione di Dio : Ti benedirò ... e sarai benedetto ; ov-vero come porta F Ebreo, sarai benedizione, e'-IN TE sarannobenedette ec. IN TE, vale a dire, nel seme tuo, come si leggeGen. xu. 18., e questo seme egli è il Cristo, come espone l'Apo-stolo, Gai. ni. 16. In questo tuo figliuolo (dice Dio ad Abramo)saranno benedette tutte le genti, Je quali imitajad.o la tua fedecrederanno in lui, e da lui avranno salute.

Lot: septuaginta quin*que cmnorum erat A-bram, cum egrederetur(te Hor an,
5. Tuìitque Sarai u-xorem suam, et Lot fi-lium fratris sui, U7iiver-samque substantiam,quam possederant, etanimas, quas fecerantin Haran : et egressisunt ut irent in terramChanaan. Cnmcfue ve-nìssent in eam,
6. Pertransivit A" 'pram terram usque adlocum Sichem, usquead convattemittustrein\Chananaeus autem tuncerat in terra.
mo avea settantacinqueanni , quando uscì diHaran.
6. E prese seco Saraisua moglie , e Lot fi-gliuolo di suo fratello,e tutto quello che pos-sedevano, e le personeche aveano acquistatein Haran r e partironoper andare nella terradi Chauaan. E giunticolà,
6. Abramo passò permezzo al paese fino alluogo di Sichem , finoalla valle famosa : e iChananei erano allorain quella terra»
Vers, 4- Averi teltantactnque anni, ee+ Da questo l»u»go evi-dentemente conchiudesi, che Àbramo venne al mondo 1' annoi3o di Thare.
Yers. 5. E le persone, che aveano acquistate in Haran. 1servi, o comperati, o nati dalle loro schiave nel tempo del lorosoggiorno in Haran. Potevano essere già-nate a Lot le due figliuo-le. Gli antichi Ebrei per queste persone acquistate intendonogli uomini, i quali Àbramo avea convertiti al culto del vero Dio,e le donne convertite da Sarà, Co/i un antico interprete tradus-•e: e Impersoni}, che aveano rendale soggette alla legge inffaran. ,
Ye,rs. 6, Finoéal luogo di Sickern. È lo stesso ebe Sichar i»». Giovanni »v. a.
Fino atta, valle famosa.* Alcuni traducono 1' Ebreo sino alla•valle della mostra ; perchè Dio ad Abramo in questa valle feceTedére la vastità, e la bellezza della terra promessa.
. ;:'1£. * Chananei erano allora in quella terra. Queste paroleservono a dimostrare la gran fede di Abramo, il quale credette aDio, cEe jjli prometteva il dominio di una terra occupata da un»potènte nazione, e non t,euiè di dimostrar*! adoratore dei vero Di>

7» Apparuit autemDominus Abram, et di'xit ei: (i) Semi/ti tuodabo terram hanc. Quiaedificavit ibi altareDomino, qui apparue-rat ei.
8. Et inde trans gre*diens ad montem, quierat contra orientemEetliel, tetendit ibi ta-bernaculum suum, aboccidejite habens Be-thel, et ab oriente Hai:aedìficavit quoque ibialtare Domino, et invo-cavi nomen ejus.
9. Perrexitque A~ì)ram vadens, et ultraprogrediens ad meri-diem.
10. Facta est autemfames in terrai descen-
•i. E il Signore appar-ve ad Abramo, e glidisse : A' tuoi posteridarò questa terra. Edegli edificò in quei luo-go un altare al Signo-re, che eragli apparito.
8. E di lì passandoavanti verso il monte ,che era a oriente di Be-thel , vi tese il suo pa-diglione, avendo a occi-dente Bethel, e a le-vante Hai : ivi pure e- _,,dificò un altare al Si-gnore, ed invocò il suonome.
9. E tirò innanzi A-bramo camminando , eavanzandosi verso mez-zodì. t ^
10. Ma venÉ^ nelpaese la fame s è Abra-
frj Infr. 17. 15. 15. 18. 26, 4vZ>«tfc 34 4
in un paese di perfidissimi idolatri ; onde vi alzò un altare perofferirvi vittime di ringraziamento al suo Signore. Notisi, che IChananei erano tuttora in quel paese, quando ciò scriveva Mosè;ma siccome doveano esserne ben presto discacciati , quindi Masi?con ispirilo profetico li considerò, come se più non vi fossero.
Vers. 8. A oriente di Bethel. Bethel è probabilmente quellastessa, di cui si parla cap. xxviu. itj; onde que&ljpuome le fu da-to molto dappoi, e le è dato qui per anticipazione. Le due cittàdi Bethel e di Hai sono poco disianti l'una dall'altra, fì furon dipoi della tribù di Beniamin.
Edifica un altare ... e invoco ec. Ella è degù* d' ammira-jìbneja costanza d'Abramo nel professare altamente la «sta fe-de nel vero Dio, tenendosi lontano da'riti de"lr idolatri, econservatalo viva ne' suoi la pietà.

ditque Abram inAEgy-ptum, ut peregrinareturibi : praevaluerat enimfames in terra»
M. Cumque prope^esset, ut ingrederetur
AEgyptum, dixitSaraiuxori suae : Novi, quodpulchra sis mulier:
12. Et quod cum vi"derint te AEgyptìit di-cturi sunti Uxor ipsiusàsti etinterficient me,et te reservabunt.
i5« (i) Die ergo, ob-%ecro te, quod sororirte à sis : ut bene sitmila, propter te, et vi"vnt anima mea ob gra»li a m fui»
mo scese nell*Egittoperistarvi come passeg-gero : perocché la famedominava in quel paese.
11. £ stando per en-trar nel!' Egitto, dissea Sarai sua moglie : So,che tu sei bella donna:
12. E che quando gliEgiziani li avranno ve-duta , diranno : Ella èsua mogli? : e uccide-ranno me , e te serbe-ranno,^
i3.?Di grazia adun-que di', che tu sei miasorella : affinchè per teio sia ben accolto?, esalvi la mia vita per o-pera tua.
(i) Ififr. ao. ii.
Vers. io. Ma venne nel paese la fame. Dio esercita la virtùdi Abramo, costringendolo ad abbandonare un paese, di cuigli avea già più volte promesso di farlo padrone.
Per islarvi come passeggero. Non per fissarvi stanza, per-chè egli non esita nulla sulle divine promesse.
Vers. 13. Di grazia adunque dì\ che tu sei ntia sorella. Àbra-mo domanda a Sarà di tacere il non||j;)di sua sposa, e dire solo ,ch' ella Hjta assorella ; lo che era*vero perchè Sara era fi-gliuola dello stesso padrdMt Abramo, benché non della stes-sa madre, come^leggesi Q^jf xx. i 3.
Abramo, cui era ben noto il carattere della nazione, pres-ti di cui si rifuggiva per salvare e sé , e la famiglia dalla fa-Mie , prende il partito di non darsi a conoscere per marito,ina solamente per fratello di Sara , provvedendo cosi alla salu-te propria, e della sua gente, raccomandando alla cura dellw.previdenza la castità della moglie, di cui conosceva la virtù ,persuaso che Dio in tanta necessità 1' avrebbe protetta , e spe-

i 4- Cum itaque in-gressus esset AbramAEgyptum , videruntAEgyptii mulierem. ,quod esset pulchra ni-mis.
16. Et nuntìaveruntprincipes Pharaoni, etlaudaverunt eam apudillum, et sublata estmulier in domum Pha-raonis.
14. Entrato adunqueAbramo in Egitto , vi-dero gli Egiziani, chela donna era bella som*marnante.
15. E i signori nedieder nuova a Farao-ne , e la celebrarono di-nanzi a lui: e la donnafu trasportata in casadi Faraone.
ramlo in lui contra ogni speranza. Con questi principii s. Ago~^stino sostenne, e difese il fatto di Abramo contro un empiafilosofo , il quale avea ardito d'intaccare la virtù di quel san-tissimo patriarca.
Vers. 15. Ne dìeder nuova a Faraone, Questo era il comunnome de're dell'Egitto, al qual nome aggiungevano un altroparticolare, come Ramesse, Amenophi , ec. Questo nome si-gnificava coccodrillo secondo Bochart j e questo gran pesce era'uno degli Dei d'Egitto.
Fu trasportala in casa di Faraone. Dal versetto 19. ap-parisce , che P intenzione di Faraone fu di sposarla. Or, 'comenotò s.Girolamo, l'uso portava, che le donne destinate ad es-•ere spose de' re , fossero per lungo tratto di tempo preparatecolle unzioni, e profumi , come vediamo dal libro di Esther,che facevasi alle mogli de' re di Persia, In questo tempo furo-no fatti ad Abramo i buoni trattamenti descritti nel Versettoseguente , e frattanto Dio co' suoi gastir:hi cambiò il cuore diFaraone. Così Dio fa vedere, com' egli e custode del forestieroPsal. io4-, e salvata la vita ad Àbramo , salva ancorala casti-tà della moglie. Un antico scrittore riconta che Abramo inse-gnò al re d'Egitto 1' astronomia : Sr qual cosafinon è difficilea credersi , poiché sappiamo , quanto in quella scienza fosseroversati i Caldei, da' quali veniva Abramo. Riguardo alla quali-tà delle piaghe, colle quali Iddio punì il re, la Scrittura nul-la ci dà di certo : ma un isterico presso Eusebio, Praeparat.lib. ix, 1.3., scrive, che venne la peste sul re, sulla famigliareale, e sul popolo tutto, e che gì' indovini scopersero al re,che Sarai era moglie di Àbramo . Può. essere benissimo , cheFaraone afflitto con grave malore da Dio sospettasse del vero,e uè facesse iulervoyare Sara. o da lei risapesse quello che era,

16. Abram vero be-ne ftsi sunt propter il-lam^fuenmtque ei oves,et boves , et asini , etservi, et familiae , etasinae, et cameli.
17. Flagellavi au-tem Dominus Pharao-nem plagis maxìmìs ,et domum ejus^propterSarai uxorem Abram.
* 18. Vocavilque Pha-rao Abraìnì et dixit ei :
^Oi^énam est hoc, quodjecisti mihi? quare, nonindicasti, quod uxortota esset?
19. Quam ob causamdixis&y esse sororemtuanVfut tollerem eammihi in uxorem ? Nuncigitur ecce conjux tua,accipe eam, et vade.
ao. PraecepitffuePharao super Abramviris 1^: et deduxerunteum, etuxqrem illius4et omnia, quaehabebat.
16. E per rigtnrcfo alei fecero buon' acco-glienza ad Abramo : edegli ebbe pecore, e bo-vi , e asini, e servi, eserve , e asine , e cam-melli,.
17. Ma il Signore ca-stigo con piaghe gravis-sime Faraone , e la suacasa a causa di Saraimoglie di Àbramo.
18. E Faraone chia-mò Àbramo , e gli dis-se: Che m* hai tu fatto ?perchè non hai tu si-gnificalo, che ella è tuamoglie ?
19. Perchè mai dice-sti , ebe era tua sorella,perchè io me la piglias-si per moglie ? Or a-dunque eccoti la tuadonna , prendila , e vain pace.
30. E Faraone diedejy^cura di Abramo a uo-mini , i quali lo accom-pagnarono fuora collamoglie , e con tutto-quello che avea.
"Vera. 20. Diede la cura <T Abramo a uomini. Per metterlo ial coperto dagi' insulti degli Egizi.iai. .. |

C A P O XIIL
~Acromo , e Lot usciti dalt Egitto si separano acausa della lor grande opulenza : e avendoLot eletto di stare presso al Giordano > Abra%mo abita nel paese di Chanaan , dove sono alui ripetute le promesse di Dìo intorno allamoltiplicazione di sua stirpe, e intorno al do»minio di quella terra**.
1. ./JE scendit ergoAbram de AEgypto,ipse, et uxor ejus, etomnia, quae habebat,et Lot cum eo, ad au»stralem plagam.
2. Erat autem, divesvalde in possessioneauri et argenti.
3. Reversusyue estper iter, quo venerai, ameridie in B&thel us-que ad locum, ubi prius-fixerat tabernaculuminter B etnei, et Hai'.
4. In locoaltaris, (i)quod fecerat prius : etinvocavit ibi nomen Do-mini*
1. Usci adunque A-bramo di Egitto con Elsua moglie,, e con tuttoil suo , e insieme c/mlui Lot, andando versòil mezzodì.
2. Ed egli era moltoricco di oro e d'argen-
*°* %-3. E tornà^per la
strada , per cui era an*dato , da mezzodì versoBethel fino al luogo, do-ve prima avea piantatoil padiglione tra Bethel,e Hai :
4- Nel luo||o dovaavea già latto P altare ,e ivi infocò il nomedel Signore.
(i) Sctp. 12. 7.
Vers. i. Andando verso il mezzodì. Verso la parÈe meridio-nale della Cananea .
Vers. 4- E ivi invoco il nome del Signore. Rendè a Dio grazi»jte'favori a lui compartiti nell'Egitto.
* Dove uvea già fallo.. Eretto 1' altare.

6. Sed etLot^qnìe-rat, cum Abram, fue-runt gre&es ovuim^ etarmenta% et taberna-mia.
6. Nec poterat eoscapere terra, ut Tiabi-tarent simuli (i) eratquippe substantia eo-rum multa, et nequi-&ant habitare eommu-ìl*ter*~~ -# 7. Unde et facta estrìxa inter pas tores gre-gum j£bram> et Lot. Eo<Wfem tempore Ghana-naeus, et Pherezaeusliabitabantin terra illa.
8. Dlmt ergo Abramad Lot: Ne, quaeso, sitjurgium inter me, ettetet inter pas tores meos,et pastores tuos\ fra-tres enim sumus.
9. J£c$! universa ter»ra coram fè est: recede
6./Ma anche Lol,che era con Àbramo,avea greggi di pecore ,e armenti, e tende.
6. E la terra non po-tea capirli, abitando e-glino insieme : peroc-ché aveano molte facol-tà, e non potevano sta-re in un medeskno luo-go.
7. Per la qual cosane nacque anche rissatra' pastori de' greggid' Abramo , e quei diLot. E in quel tempoabitavano in quella ter-ra il Cananeo, e il Fè-rezeo.
8. Disse adunque A-bramo a Lot : Di grazianon nasca alterazionetra me , e te , e tra'mieipastori, e i tuoi pastori:perocché noi siam fra-telli.
<£ Ecco dinanzi a tetutta questa terra : al-
(tjlnfr. 36. fr
Y*f«» 7. Abitavano in quella terra il Cananee ee. AccennaWosè il pericola che vi era, che quelle genti feroci e idolatreprendessero occasione da quella discordia dispogliare e disper-gere ruttato e l'altro, o almeno ne restassero scandalizzate, o piùmal disposte verso la religione.
Vera. 8. IVetsiamfratelli. Strettamente congiunti disangue,C questi nella Scrittura si chiamano sovente fratelli.

a me, obsecro : si ad si-nistram ieris, ego dex-teram tenebo: sì tu dex-teram elegeris , ego adsinistram pergam.
10. Elevatìs itaqueLot oculis, vidit omnemcirca regionem Jorda-niS) quae universa ir-rigabatur , antequamsubv erteret DominusSodomam, et Gomor~rham, sicut paradisusDomini^ et sicut AEgy-ptus venientibus in Se-
11. Elegitque sibiZiOt regionem circa Jor-danem, et recessit aboriente : divisique suntalteruter afratresuo.
lontanati, li prego, dame : se tu andrai a si-nistra, io terrò a destra;se tu sceglierai a destra,10 andrò a sinistra.
10. Lot adunque al-zati gli occhi, vide tut-ta la regione intorno alGiordano, per doye sjiva a Segor, la quale eratutta i n affi a la , come ilparadiso del Signore, ecome l'Egitto prima che11 Signore smantellasseSodoma e Gomorra.
*:%,11. E Lot si elesse il
paese intorno al Gior-dano , e si ritirò dall'.o-rienle : e si separarono1* uno dall'altr^,
Vers. g. Se tu andrai a sinistra, io terrò fi destra ee. Leggeantichissima lodata da s. Agostino lib. xvi. de civ. cap> ao., cheil maggiore faccia la divisione, il minore elegga la porzione, chepiù gli piace.
Vers. io. Vide tutta la regione ... inctffiata, come il paradi-so ec. Tutta la Pentapoli avanti la sua distruzione, particolar-mente quella parte, la quale dal luogo, dove allora era Abramo,si atendea verso Segor, era inaftìata dalle acque del Giordano, efertile, come già il paradiso terrestre, e come ^Egitto. L'amenitàdel paese fu una grande attrattiva per Lot. '-
Vers. il. Sì ritiro daW oriente. Per nome di oriente s'intendequi il luogo, dove stava Abramo con Lot, primawche si separasse-ro tra Bethel, e Hai, il qual luogo disse già caj).'jai. 8., che eraall'oriente di Bethel, ed avea Bethel a occidente, a levante HaiDel rimanente, assolutamente parlando, Lot andando verso ilGiordano, andava verso l'oriente: e questo senso hanno alcunivoluto dare al testo ebreo: ma non è necessario di pensare a cor-reggere la Volgata, eolia quale concordano le altre versioni.

12. A^ram habitat) itin terra Chanaan r Lotvero moì^itu& est in op*pidis, quae erant circaJordanem, et habìtavitin Soctomìs,
13. Homines autemSodomitae pessimi e-r$nt, et peccatore^ co»rum Domino nimis-.
i4« Dixìtyiee Domi'nus ad Abram^ post-quam iUvìsus est ab eoHOtt: (i) Leva oculostuos^f vide a loco , ing&$ nunc es , ad aqui-
(\), Supr. 12. 7. Infr. 15.
ra. Abramo abito nef-la terra di Chanaan r eLot sta-va per le città ,che erana intorno alGiordano , e pose stan-za in Sodoma.
13. Ma gli uomini diSodoma erano pessimi re formisura peccatati di-nanzi a Dio.
i4« E il Signore dissead Abrama, dòpo cheLat fa separata da lui :Alza gH occhi tuoi, emira dal fuogo dove setora, a settentrione , as
18. 26. 4 Deut. 34. 4
* Lot sì eleffc il paese intorno aì Giordano. Mra per quan-to fertile q[B^l luogo e delizioso si fosse, Lot scelse assai male,
àmpegnandtì&ì a vivere in mezzo a popoli pessimi e abbominevolìal cospetto di Dio.
Yers. 12. Nella terra dì Chanaan i presa in istretto significa-to ; perocché altrimenti ancne Sodoma era nel paese di Chanaan.
Lot stava per le citta ec. Si può intendere, che egli avesse fsnoi greggi sparsi attorno di quelle città, e andava e veniva pervisitarli ; ma sua dimora ordinariamente faceva in Sodoma.
Vers. 13. Formisura peccatori dinanzi al Signore. Queste .espressioni formisura dinanzi al Signore, dimostrano l'orrendaperversità ^ quel popolo. Ezechfele ne parla così : Ecco qualfu F iniquità di Sodoma ... La superbia, i bagordi, il lusso, ela oziosità di /«', e delle suis figlie: e al povero, e al bisogno-so non estendevano la mano, cap. xvni. 48. Sopra le quali pa-role s. Girolamo: La superbia, i bagordi, i''abbondanza di tuttete é&fer f ozio, e-le delizie sono il peccalo di Sodoma, da cui\ nasce la dimenticanza di Dìo , per la quale i beni presenti si
«$*H tcngon^'come perpetui... onde il sapienlissimo Saldinone pre-go Z>tVc<wì; Ùammi il necessario, e quello che basta, affin-chè una volta ch* io sia. satollo , io non divenga bugiardo, <?dicti : Chi mi rivedrà i conti? ovvero divenuto bisognoso rubi ^ ,e spergiuri con offesa del nome del mio Dìo.

lonent et meridiem , adorientem et occidentem.
16, Omnem terrarii,(fuamconspicis, tibi da-bo, et semini tuo usquein sempiternum.
16. Faciamque se-men tmim sicut pulve-rem terrae: si quis pot-est hominum numera-re pulverem terrae, se-men c/uoque tutori nu-merare poterit.
17. Surge, et peram-bula terram in lon-gitudine et latitudinesua : quia tibi daturussum eam.
18. Movensigìtur ta-bernaculunt suum A-bram , 'venti, et habita-vit juxta convaìtemMambre , quae est inJlebron : aedijìcavitqueibi altare domina.
mezzodì, a levante, ealT occidente.
15. Tutta la terra,che tu vedi, la cfarò a te,è a' tuoi posteri lino ineterno.
16. E moltiplìcheró la,tua stirpe , come la pol-vere della terra : se .al-cuno degli uomini puòcontare i granelli dellapolvere della terra, po-trà anche contare i tuoiposteri. -t
17. Levati su, e scor-rila terra, quanfe* ette èlunga, e quanto è lar-ga : perocché a te io lardarò.
*8. àbramo adunquemosse il suo padiglione,e andò ad abitare pres-so la valle di Manìbre,,,che è in Hebron: ed iviedificò un altare al Si-gnore.
Vers. 15. Tutta la terra che tu vedi^ec. Un dotto interpreteafferma, che Dio, o uà Angelo per parte di Dio, p?i*e dinanzi agirocelli d' Abramo vaia immagine della terra promessa, e a parte »parte gli fece vedere tutto quello eli e ella conteneva di più pre-gevole. Cosi il demonio mostro a Cristo tutti i regni del mondo-,Jllcitlh. iv. 8. T^edi il Pererio. Abbiamo giù osservato, come que-ste promesse hanno mi senso infinitamente più nobile, e degnodella fè le di Àbramo T e di que' figliuoli, de' quali egli fu padre1 ,secondo la fede.
Fina in eterna. La promessa della terra di Clianaan era con-dizionata; vale a dire, purché i figliuoli carnali di Abramo-fosse-io fedeli a Dio, come egli se ne dichiarò, Le vit. top- a6.

C A P O XIV.
Vinti i cinque re, e saccheggiata Sodoma, iquattro re vincitori ntenano schiavo Lot collamaggior parte de* suoi ; ma Abramo insegue ,e ripiglia i prigionieri e la preda ; e lieto dellavittoria^ dà la decima a Melchisedecco , dalquale riceve la benedizione, e rende ogni co-sa al re di Sodoma.
\.J? actum est au~terì^ in illo tempore, utAmrapJielrexSennaar>et £rì.d&h rex Ponti, etChoaorlahomor rex E-lamitarumt et Thadalrex Gentium,
2. - Inirent bellumcontra Bara regem $o~
1. fj avvenne inquel tempo , che Amra-phel re di Sennaar, eArioch re di Ponto, eChodorlahomor re degliElamiti, e Thadal redelle Nazioni,
2. Mosser guerra aBara re de' Sodomiti, e
Vers. 18. Presso la valle di M'ambre ce. Questa valle era ap-piè del monte, su di cui risiedeva la città di Hebron, e nella val-le era un quercete, come apparisce dall'Ebreo.
Vers. i. Amraphel re di Sennaar. La maggior parte degli in-terpreti lo credono di Babilonia, e Giuseppe Ebreo scrive , chel'esercito era tutto di Assiri sotto il comando di quattro capitani.Certamente la monarchia degli Assiri è la più antica di tutte.
Arioch re di Ponto. Non del Ponto Eusino, ma di un paesepiù vicino , cBé portava lo stesso nome. L'Ebreo legge : re diE lassar: e gli Elassari sono' posti da Tolommeo nell'Arabia.
Chodortahomor re degli .Elamiti. Gli Elamiti sono i Per-siani : questo Chodorlahomor avea la parte principale in questaguerra, e gli altri erano in suo aiuto.
Thadal re delle Nazioni. Alcuni spiegano, re della Galileadelle Nazioni, il qual nome fu dato a questo paese a motivo delconcorso, che ivi si facea di varie genti per ragion del commercio,Altri vogliono, che Thadal si fosse formato il suo regno col darricetto a* vagabondi e fuggitivi di qualunque nazione, come fecedipoi anche Romolo, aprendo l'asilo per popolare Roma uasccnlc.

domcfrunt^ et contra Ber-sa regem Gomorrhae,et contra Sennaab re-gem Adamaeì et contraSemeber regem Seboimtcontraque regem Balae\ipsa est Segar.
3. Omnes hi conve-nerunt In vallem Silve-strem^ quae nunc estmare salis.
4. Duodecim enimannis servierant Cho-dorlahomor, et tertia*decimo anno recesse-runt ab eo.
6. Igitur (juartodèci-mo anno venit Chador-lahomor, et reges quierant cum eo : percus-Seruntque Raphaim inAstarotk - carnaim, etZuzim cum eis, et E-mim in Save Caria-thaim,
a Bersa re di Gomorra ,e a Sennaab re di Ada»ma , e a Semeber re diSeboini, e al re dì Baia;la quale è Segor.
3. Tutti questi si rau-narorio nella valle de*Boschi, che è adesso jUmar salato.
4- Imperocché per do-dici anni erano statisudditi di Ghodorlaho-mor , e il decimo tertiaanno se gli ribellarono.
6. Per la qual cos$ 1*anno, quartodecimo simosse Chodorlahomor,e i regi uniti a lui, esbaragliarono i Raphai-miad Astaroth-carnaim,e con essi gli Zuzimi, egli Emimi a Save Ca-riathaim,
Vers. 2, Baia, la quale e Segor. Ebbe poi il nome di Segor^come vedremo cap. xix. 22.
Vers. 3. Che e adesso il mar salato. Sotto il nome di sales'intende anche il nitro e il bitume ; e di tutto questo è pienoquello che chiamasi mare Morto, in cui fu cambiata dopo 1' in-cendio di Sodoma la bella valle piena di piante, che è qui no*minata la valle de' Boschi.
Vers. 5. Sbaragliarono i Raphaimi. Chodorlahomor co* snoire cominciaron la guerra contro al popolo detto de' Raphaimi,forse perchè questo era alleato de're della Pentapoli ; e lo stessopuò intendersi dell'altre tre nazioni, degli Zuzimi, degli Emimi,e de'Correi. In vece di Raphaimi i LXX. mettono giganti; e dalDeuteronomio ( cap. m. ), e da Giosuè ( cap. xa. xui. ) apparisce ,

6. El Chorraeos inmontibus Seir usque adcampestrìa Pharnn ,quae est in solitudine.
7. Reversicfue sunt,et venerimi ad JoJilemMisphat \ ipsa est Ca-des\ et percusseruntomnem regionem Ama-l&citarum, etAmorrhae-um, qui liabitctbat inAsasonthamar*
8. fèt egressi suntrex Sodomorum, et rexGomòrrhae, rextjue A'dàmae , et rex Seboim^necnon et rex Balae,
6. E i Correi su'mon-ti di Seir fino alle cam-pagne di Pharan , cheè nel deserto.
7. E ( i re ) tornandoindietro giunsero allafontana di Misphat, cheè fo stesso che Cades :e devastarono tutto ilpaese degli Amaleciti,e degli Amorrei, che a-bìtavano in Asasontha-mar.
8. Ma il re di Sodo-ma , e il re di Gomor-rha , e il re d'Adama , eil re di Seboìm , ed an-che il re di Baia, la qua-
che costoro erano gente di grande corporatura. La città di Asta-rotli - earnahn era svii torrente di Jabocr e probabilmente ebbenome da qualche simulacro della luna, che ivi era adorata ; pe-rocché A.starte è la lima.
E gli Emimi. Emim. vale terribile. FeJiDeitter, u. *o.S"ave Carìathaìm. Catta del paese dìMoab , Josne xm. i g.
Vers. 6. E i Charrei su' monti di Seir. I Cborrei discendevano»da Seir, il quale diede il suo nome a'monti che sono a levantedi Chanaan di là dal mare Morto. Vedi cap. xxxvi, 20.
Pharan è nome di un monte, e di una cittA. Fedì Niun*MH. i, Deuteron. xxxin. a,
Vers. *j, Alla fòritctna (ti Mispfiat, Pereria crede, che la fon-tana dì Mrsphat vag-li* lo stesso , che la fontana di Meriba, e chequesta avesse fi nome di fontana d«l giudizio (Mìsphat), e dì fon-tana di contraddizione. ( Meriba ); perchè ivi gli Ebrei mormora-rono contra Mosè ; ma Dio giudicò la lite in favore di lui, facen-do scaturire le acque dal vivo sasso. Nitm. xx. 13.
Il paese degli Amaleciti. Vale a dire il paese, che possede-rono dipoi gli Amaleciti nelP Arabia Petrea tra Gades ,, e il ma*Rosso. ,
Ascttontkamar vuol dire città (teìfo palme e f« poi dellaEngaddi.

quae est Segar : et di-rexerunt aciem contraeos in valle Silvestri i
g. Scilicet adversusChodorlahomor regemElamitarum , et Tha-dal regem Gentium , etAmraphel regem Sen-naar t et Arìoch regemPonti : quatuor regesadversus quinque.
10. fallisi autem SU'vestris habebat puteosmultas bituminis. Ita"que rex Sodomorumet Gomorrhae tergaverterunt, cecideruntibi-, et qui remanserant^fugerunt ad rnontem.
11. Tulerunt autemomnem substantiam So-domorum , et Gomor*rhae, et universa, quaead cibum pertiìient, etabierunt ;
12. NecJton etLot, etsub stantiam eju&,filium
le è Segor , si mossero •e nella valle de' Boschischierarono il loro eser»cito contro di quelli:
9. Vale a dire controChodorlahomor re degliElamiti, e Thadal redelle Genti, e Amra-phel re di Sermaar , eArioch re di Ponto,:quattro regi contro cin-que.
10. E la valle de' Bo-serhi avea molti pez,zi dibitume. Or i re di Sodo-ma e di Gomorrha vol-ta ron le spalle , e vi-fufatta la strage : e queiche salvaron la vita, fug-girono alla montagna.
11. E (i vincitori )presero tutte le ricchez-ze di Sodoma , e dì Go»morrba, e tutti i viveri,e se »' andarono.
12. E ( presero ) an-che con tutto que Ho che
Vers. io. La valla .„ ctvea molti pozzi di bitume. Questi poz-zi di bitume servirono poi nelle mani di Dio alla distruzione del-le infami città .
E vi fie fatta strage. Alcuni vorrebbero, che si traducesse,vi caddero dentro, cioè ne'pozzi del bitume; lo che sembra po-co probabile di persone, che ben avean notizia de'luoghi, e sape-rano che in que'pozzi trovavano sicuramente la morte. Notisi, co-llie Dio si serv» sovente del braccio d' uomini cattivi a punire al-tri cattivi.

fratris Abram, qui ha"bitabat in Sodomis.
13, Et ecce unus, quicvaserat, nuntìavit A-bram Hebraeo , quihabitabat in contraileMambre Amorrhaei,fratris Escol, et fratrisAner ; hi enim pepile-rant foedus cum A'bram.
14» Quod cum audis-set Abram, captum vi-delicet Lot fratremsuum,numeravit expe-ditos vernaculos suostrecentos decem et o-cto: et persecutus estusque Dan.
aveva , il figliuolo delfratello di Abramo Lot,che abitava in Sodoma.
15. Ed ecco uno de'fuggitivi ne portò lanuova ad Abramo E-breo, il quale abitavanella valle di MambreAmorrheo, fratèllo diEscol, e di Aner; peroc-ché questi avean fattolega con Abramo.
i4- Àbramo adunqueavendo udito, come erastato fatto prigionieroLot suo fratello , scelsetra* suoi servi trecentodiciotto uomini i più le-sti; e tenne dietro a'ne-mici fino a Dan.
Vers. i a, E presero anche ,.. Lot. Lot, il quale allettato dal-l'amenità del paese avea eletto di vivere tra genti scellerate, èpunito da Dio colla perdita delle sue ricchezze e della libertà.
Vers. 13. Ne porto la nuova ad Abramo Ebreo. Si è già det-to , che il nome di Ebreo gli fu dato per essere egli venuto dipaese oltre 1' Eufrate - quasi volesse dire uomo di la, cioè di làSàll'Eufrate.
Quctti avean fatto lega con àbramo. Queste paiole dan-no motivo di credere, che Mambre, Escol, e Aner , che doveauessere persone di conto, aiutarono Abramo colle loro ^enti. Ve-di vers. a4-
* Ed ecco uno de* fuggitivi ne porto la nuova : Ed unode' fuggitivi ne portò tosto la nuova.. Vera. 14. Trecento diciotto uomini Questo numero d'uomini
impiegati al servizio di casa , e alla cura de' greggi di Abramo dàuna grande idea di quel ch'egli fosse. Vedi cap. xxni. 6.
Fino a. Dan. Dan in questo luogo uon è la città di tal no-me , ma un rivo, o Un luogo vicino al Giordano, £# città di Danal tempo di Mosè «i chiamava Laris.

15. Et dwisis sociis,irruit super eos nocte :percussitque eos <, etpersecutus est eos us~que Hoba, quae est adlaevam Damasci*
16^ Reduxitque o-mnem substantiam, etLotfratrem suum cumsubstantia illius, m«.lìeres quoque, et popu»luni.
17. Egressus est an»tem rex Sodomorum inoccursum ejus, post-quam reversus est acaede Chodorlahomor,et regum, qui cum eoerant in valle Save ,quae est vallis regis.
18. (i) At vero Mei-chisedech rex Salem,profsrens panem et vi-num : erat enim sacer-dos Dei Altissimi:
16. E divìse le schie-re , gli assali di nottetempo : e gli sbaragliò,e gl'inseguì sino ad Ho-»ba, che è alla sinistradi Damasco.
16. E ricuperò tuttele ricchezze, e Lot suofratello con tutta la ro«ba di lui, ed anche ledonne, e il popolo.
±f^È andogli incon-tro nella valle di Save( che è la valle del re )il re di Sodoma, quand*ei tornava dalla rotta diChodorlahomor, e de'resuoi confederati.
18. Ma Melchisedecre di Salem, messo fuo-ra del pane e del vino;perocché egli era sacer-dote di Dio Altissimo :
fi} Hebr. 7. i.
Vcrs. 17. Nella, valle rii Save (che e la. valle del re). Questavalle, prima detta di Save, e dipoi valle del re, era dirimpetto aGerusalemme secondo Eusebió.
Vers. 18. Ma Melchisedech re d'i Salem ^ messo fuora del,pane e del umo, ce. Salem è Gernsalemme per comun parerede' Padri, e degl' Interpreti.
Messo fuora del pane e del vino. perocché era sacerdo-*te eo. Questa giunta, che Melchisedech era sacerdote, non essen-do certamente messa a caso, dimostra assai chiaramente controgli eretici, che il pane e il vino portato e messo fuora da Melchi-scdech dovea servire al sacrifico pacifico, che egli offerse in rea-

19, Btnedixit ei, etalt\ Bene dictus AbramDeo excelsa, qui crea*vit coelumt et terram :
20. Et benedictusDeusexcelsuS) quo pro*temente , hostes in ma-nibus tuìs sunt. Et de*dìt ei decimas ex o-mnibus.
'-•21.- Dixit autem rexSodomnrum ad Abram\Da mihi animas : cele-rà lolle tibi.
22. Qui respondit ehTLevo manum meam adDominum Deum excel-sum, possessorem eoe*li> et terrae,
19. Lo beneclisse, di-cendo: Benedetto Àbra-mo dall? altissimo Dio,che creò il cielo, e laterra :
20. E benedetto l'al-tissimo Dio , per la cuiprotezione sono statidati in poter tuo i ne-mici. E ( Àbramo ) die-de a lui le decime ditutte le cose.
21. Ei! re di Sodomadisse ad Abramo : Dam-mi gli uomini: tulio ilresto tienlo per te.
22. Quegli rispose alui : Alzo la mano miaal Signore Dio altissimo,padrone del cielo e del-la terra ,
dimenio dì grazie a Dìo per la vittoria dì Abramo : ed è stato an-che da altri osservato, che varii Ebrei, invece di quelle parolemise fuora del pane e del vino traducono 1' Ebreo offerse delpane e del vino: e Filone Ebreo dice, che Melchisedech offersesncrifìzio per la vittoria. Ma tutto il mistero di qnesto re sacer-dote , ammirabil figura di Cristo sacerdote secondo 1' ordine diMelchisedech, e re di pace, è spiegato divinamente da Paolo,H-ebr. TU.; onde è da vedersi quello ché ivi si è detto. Aggiunge-rò solamente, che varii antichissimi Padri, e dietro a questi Teo-doreto,ed Eusebio credono, che Melchisedech fosse un regolodella Chanasea, il quale per im miracolo della grazia si manten-ne santo e giusto tra gli empii.
Ver». 20. Diede a lui le decime dì tulle le cose. Vale a dired«lle spoglie de'nemici, non già anche delle robe ricuperate, tol-te da questi a're, e agli abitanti della Penlapoli.
Vers. za. Alto la mano mia. Antichissimo rito per prendereDio in testimonio di qualche cosa , alzar la mano verso il cielo :invocando colui che abita nel cielo.

a3. Quod a filo sub-te gminis usque ad cor-rigiam caligae non ac-ciplam ex omnibus ,quae tua sunt, ne di-casi Ego ditavi A brani:
24» Exceptis his ,quae comederunt jiwe-nes, et partibus viro-rum, qui venerunt me-cum , Aner, Escol,etMarnare : isti accipientpartes suas.
23. Che nè un filo diripieno, nè una correg-gia di scarpa io prende-rò di tutto quello che ètuo , perchè tu non di-ca: Ho fatto ricco A-bramo:
24. Eccettuato quelloche hanno mangiato igiovani, e le porzionidi questi uomini, cheson venuti meco, Aner,Escol, e Mambre : que-sti avranno ognuno lasua parte.
Vera, aa, * Alzo la mano mìa. Benìssimo ancora nel passato,akaì ec.
\ers. a3. Di lutto quello che e tuo. Vale a dire di quello che«ra tuo, e de' tuoi, e tuo voglio che sia tuttora, benché sia dive-nuto di mia ragione , come acquisto fatto in guerra giusta. Con.ragione i Padri celebrano la magnanimità e il distaccamento diAbramo.
* Di scarpa ovvero di borzacchino.Yers. 9.4. Eccettualo quello che hanno mangialo i giova-
ni , ec. Abramo eccettua que'commestibili che avesser consumatoi suoi soldati, i quali con una appellazione usata nella milizia«gli chiama giovani*
In secondo luogo Abramo eccettua la porzione che toccavaad Aner, a Escol, e a Mambre, i quali si vede che non imitaronola sua grandezza d'animo, e probabilmente si accordarono a civvolentieri i re della Pentacoli,

C A P O XV.
Ad Abramo, che non isperapiù successione^ Diopromette un figliuolo , e A bramo credendo alui è giustificato, e per caparra della terrapromessa offerisce il sacrificio prescrittoglidal Signore* È indicato a lui il futuro pelle*grinaggio della sua stirpe.
i. fi is itaque trans-actis , factus * est ser-mo Domini ad Abramper visionem, dicens :NolitimeretAbram\ egoprotector tuus sum , etmerces tua magna ni-mis.
a» Dixitque Abram :Donnine Deust auid da-bis mihi? ego vadantabsque lìberis : et fi-lius procuratoris domusmeae, iste DamascusElìezer.
i. tassale che furo-no queste cose, il Signo-re parlò in visione adAbramo , dicendo : Nontemere , o Abramo : iosono il tuo protettore ,e tua ricompensa gran-de oltremodo.
a. E Abramo disse :Signore Dio, che mi da-rai tu ? io me n' andròsenfca figliuoli: e il fi-gliuolo del mio maestrodi casa , questo Eiiezerdi Damasco.
Vera, ». E tua rìcompenfa grande oltrt modo. Dio solleva loèpìrìto di Abramo a faticare e combattere per un premio infini-tamente più grande che le vittorie e le ricchezze del mondo. Iostesso sarò tua mercede , dice Dio ad Abramo; ecco la sola mer-cede degna di me, e dell' amore cli'io ho per te.
V«r*. a, Signore Dìo, che mi darai tu? io me n' andrò ec.Fra tutte le maniere di esporre le prime parole della risposta diÀbramo questa mi sembra la più vera : Signóre Dio, bene stache voi vi degniate d'essere mìa mercede : imperocché di tutte lecose del mondo, che darete voi a me, che possa essermi di con-solazione? méntre quel figliuòlo ch' io aspettava, quel figliuolounico oggetto di mie brame ; quel figlinolo in cui debbono esser

3, Addiditque A-bram : Mihi autem nondedisti semen ; et eccevernaculus meus hae-res meus erit.
f\. Statimque sermoDomini factus est adeum , dicens : Non erithic haeres tuus ; sed<jui egre die tur de uterotuo, ipsum habebis hae-redem.
5. Edux i'tquè eumfo-ras, et alt illi: (i) Suspi-ce coelum , et numerastellas, si potes. Et di-xit ei : Sic erit sementuum.
6. Credidit ìbramDeo, etreputatum estfili ad justitiani. (2)
(i) Rorn. £. ,18.(a) Rom. 4. 3. G«foi. 3. 6. Ja$, *, *3.
3. E soggiunse Abra-mo : Ma a me (u nonhai dato figliuolo: ed ec-co clie questo schiavonato in mia casa sanimio erede.
4. E tosto il Signoregli parlò , e disse : Que-sti non sarà tuo erede ;ma quello che da'lcmbituoi uscirà, lui avraituo erede.
5. E lo condusse fuo-ra » e gli disse : Mira ilcielo , e conta , se puoi,le stelle. E così ( disse-gli ) sarà la tua discen-denza.
6. Abramo credette aDio , e fugli imputato agiustizia.
Peut. Vol I.
benedette tutte le genti, io noi vedo, e temo che per jnia colpaio ne sia privo, e che senz'esso io mi morrò, e ornai avrò per ere-de non un figliuolo naturale , ma un adottivo , il figliuolo delmio maestro di casa, Damasceno di patria. Il discorso d' Abramoè rotto, come ognuno vede, e patetico.
Vers. 4- * Che dilombi tuoi. Che da te uscirà.Vers. 5. Conia, se puoi, le stelle. Veramente di queste il nu-
mero non può aversi con tutte le diligenze usate dagli astrono-mi, scoprendosene nel cielo, mediante le ripetute osservazioni,sempre delle nuove, le quali per la sterminata distanza da noiscompariscono quasi, benché sien di fatto grandissime. Or allestelle è paragonata la discendenza di Abramo, non tanto la di-scendenza carnale , quanto la spirituale , di que7 figliuoli cioè ,de'quali sta scritto , che splenderanno come stelle per inlermi"nobili eternità. Dan. iv.

7- Wixitque ad eum:Ego Dvminus, qui edu-jci te de Ur Chaldaeo-rum, ut darem tibi ter-ram isiam, et posside-res eam.
8. At ille mt\ Domi-ne Deus j unde scire \possum quod possessu*rus sim eam. ?
9. Et respondens Do-minus: S urne i inquit,mihi vaccam triennem,et capram trimam, etarietem annorum trium,turturem quoque > et co-lumbam.
i o. Qui tollens uni-versa haec (i), divisit
7-E il Signore gli dis-se : Io sono il Signoreche ti trassi da Ur de*Chaldei, per dare a tequesto paese, e perchètu lo possegga.
8. Ma quegli disse :I Signore Dio, donde pos-
so io conoscere , ch' iosia per possederlo?
9. E il Signore rispo-se: Prendimi una vaccadi tre anni, e una capradi tre anni, e un arietedi tre anni , e una tor-tora , e una colomba.
10. Ed egli prese tut-te queste cose , le divi-
<i^ Jerem, 34. j8.
Vers. 6. Abramo credette n Dio^ e fugli imputato a giusti-'zìa. Abramo padre di nostra fede , come lo chiama 1' Apostolo,credette a Dio, e per questa fede non solo fu fatto giusto, ma ot-tenne eziandio di crescere nella giustizia; imperocché vuoisi os-servare , che quelle parole Àbramo credette , e fugli imputa-to , ec. si applicano non solo a questa particolare circostanza, per«•ui sono state scritte, ma a tutte le precedenti azioni-di Abramo,rominciando dalla prima chiamata di Dio in Ur de' Chaldei : ma«Ono state poste qui da Mosè , perchè in questa occasione spicci*tt»aravigliosament« la fede del gran patriarca. Abramo adunquegiustificato già per la sua fede, per la fede divenne ancora piùgiusto, e così egli fu padre della fede, e modello di giustificazio-ne. Sopra queste parole vedi V Apostolo Rom. iv. Gai. m., e s.•Giacomo cap. n. 28., e quello che abbiamo detto in questi luoghi.
Vers. 8. Signore Z)io, donde po$s'io conoscere, ec. Questa di-inanda non è indizio di verun dubbio intorno alla verità dellapromessa: ma Abramo affidato nella bontà del Signore domandacon umiltà qualche segno riguardo al modo, onde ciò debba•effettuarsi. La sua interrogazione è simile a quella della Vergine,£##. i 34.

ea per medium, et u-trastue partes contrase altrinsecus posuit:aves autem non divisti.
11. Descenderunt-epe volucres super ea"damerà, et abigebat easA brani.
12. Cumque sol oc-tumberet, sopor irruitsuper A brani, et ìior-ror magnus et tenebro-$us invasit eum.
13. Dictumque estad eum : Scito praeno-
se por mezzo, e le partipose T uria dirimpettoali' altra ; ma non divi-se i volatili.
11. E cala vano uccel-li sopra le bestie morte,e Abramo li cacciava.
12. E sul tramontaredel sole, Abramo fu pre-so da profondo sonno,e lo invase un orrorgrande, e oscurità.
i3.Efug!idetto:Tudèi fin d'adesso sapere,
••Veri. io. le divise p*r mentii Balla testa in già. Queste cose«mo fette da Abramo per ispirazione di Dio, il quale confermale sue promesse, istituendo il rito, di contrarre le alleanx rfqual rito si conservò dipoi presso gli Ebrei (f edi Jerem. xxxiv?8.), e f« adottato da molte nazioni. Secondo questo rito d ym«li animali «ella guisa descritta da Mosè, e collocate le parti diIssi V una dirimpetto ali' altra, passavano i contraenti pel mezzo ,onde venivano ad essere uniti tra loro mediante il comun«ci*.fizio. Ma ricordiamoci, che Abramo m premiala suafed^e-rito dì vedere, benché da lungi, il giorno di Cristo, Jo. v M e 1sacrifico di lui, col quale fu riunito 1' uomo con Dio, e stabilita"te na alleanza, questo sacrifico fu predetto, e mostrato ad
Abramo nel sacrificio degli animali divisi da lui m simbolo della
SUfl *MTnon Mi* i volatili. Questi non appartenevano al ritodell' alleanza ; ™» erano solamente per essere offerìji al bignore>
V«rs. 11. £ Abramo li cacciava. Abramo si stava nei mezzo
"trs.tr Itm, fu Pr«» da profondo sonno Qu.to son-no, o sia estasi, come hanno i LXX., gli fu mandato da Dio e lecose, che Dio rivelò a lui intorno a'suoi posteri m questo sonno,lo atterrirono, e gli fecero orrore grande, e afflizione.
* Profondo sonno. Per i LXX. estasi come Cap. «•««•££in appresso, terrore e oscurità. Il tramontare del sole e lo sparirdella luce simboleggia calamità.

scens, quod (i) pere-grinimi futurum sit se-me n tuum in terra nonsua, et subjicient eosservitoti, et affligentquadringenta annis\
14- Verumtamen gen-tem> cui servitori sunt,ego judicano : et posthaec egredientur cummagna substantia.
15. Tu autem ibisad patres tuos, in pa-ce sepultus in senectu-te bona.
16. Generatione au-tem quarta revertenturhuc: necdum enim com-pletae sunt iniquitatesAmorrhaeorum usquead praesens tempus.
che la tua stirpe saràpellegrina in una terranon sua, e li porrannoin ischiavitù, e gli stra-zieranno per quattro-cent' anni.
14- Ma io farò giudi-zio della nazione, dicui saranno stati servi:e dipoi se ne partiran-no con grandi ricchez-ze.
16. Ma tu andrai atrovare i padri tuoi, se-polto in pace in prospe-ra vecchiezza.
16. E alla quarta ge-nerazione ( i tuoi ) tor-neranno qua: imperoc-ché fino al tempo pre-sente non sono ancoracompiute le iniquità de-gli Amorrhei.
(i} Actor. n. 6.
Vers. 13. Per quatirocenìannì. Vedi l'Esodo cap. xn. 49- 41-* Li porranno. Li terranno in {schiavitù.
Vers. 15. Andrai a trovare i padri tuoi. S. Ambrogio lib. 2.de Abraham capt q. Noi, che ci ricordiamo, che la madre no-stra e quella, Gerusalemme, che e colassìi, qu?llì diciamo pa-dri, i quali nel merito precedettero e nelV ordine della vila;ivi trovavasi Abele vittima della pietà, ivi il pio e santo He-nockì ivi Noe i et trovar questi anderà Àbramo^ come quiaItti'sì promette.' Yers. 16. Alla quarta generazione. Nella linea di Giuda sicosterebbero in questa guisa le quattro generazioni d' uomininati nell' Egitto : Efron ( nipote di Giuda ) generò Arain , Aram
'generò Aminadab, Anjinadab generò Naasson, Naasson generòIpSalmon, il quale entròjiiella terra di promissione.

17. Cum ergo occu-fuisset sol, facta estcaligo tenebrosa, et ap-paruit clibanusfumanSiet lampas ignis trans-iens inter divisiones il-las.
18. In illo die (i) pe-ptgìt Dominus foeduscum Abraham dicens :Semini tuodabo terramhanc afluvio AEgyptiuse/uè adjluvium ma-gnum Euphratem.
19. Cinaeos, et Ce-nezaeoSt Cedmonaeos^
20. Et Hethaeos, etPherezaeos , Raphaimt]uoquet
17. Tramontato poiche fu il sole , si feceuna caligine tenebrosa,e apparve una fornacefumante , e una lampa-na ardente , che passa-va per mezzo agli ani«mali divisi.
18. In quel giorno ilSignore fermò 1' allean-za con Abramo, dicen-do : Ai tuo seme daròio questa terra dal fiu-me d'Egitto sino algran fiume Eufrate.
19. I Cinei, e i Ce-nezei, e i Cedmonei,
20. E gli Hethei, e iPherezei, e anche i Ra-phaimì,
(i) Supra, i a. 7. 13. 15. Infr. 26, Deut, 34- 4- #<#. 4. a i .a, Paralip, g. a6.
Non sono ancora compiute finifuitk degli /imorrnei. No-mina questi soli, come popolo principale, e piìi ragguardevole diChaan, e ancile perchè nella terra di quel popolo si trovavaallora Abramo .
Vers. 17. Una fornace fumante. Ecco un simbolo delle tri-bolazioni , e de' mali, sotto de' quali dovean gemere in Egitto iposteri d' Abramo.
E una lampana ardente , che passava per mezzo eo. Diodi cui è una immagine questa lampana ardenti, passando permezzo agli animali divisi, ratifica l'alleanza fermata con Abramo.
Vers. 18. Dal fiume <V Egitto sino al gran fiume ec. Il fiuto»d'Egitto è il Nilo: dal Nilo adunque fino all'Eufrate, prometteDio , che sì stenderà il dominio de'posteri d' Abramo. 1 peccatidi questi trattennero lungamente 1' adempimento pieno di talpromessa: ma ella fu verificata interamente lotto Davide, « Sa-iomone .
* Al tuo seme darò. Ho già dato. .Così l'Ebr.

zi. Et Amorrhaeòs,et ChananaeoS) et Ger-gesaeos, et Jebusaeos.
fil. E gli Amorrhei,e i Chananei e i G erge-sei, e i Jebusei.
C A P O XVI.
Agar è data in moglie ad Àbramo da Sarai suapadrona : ma ella dopo di essere dive?iutamadre disprezzava la padrona ; ed essendostata perciò gastigata , si fuggi / ma per co-mando di un Angelo tornò a soggettarsi a Sa*rai » e partorì Ismaele.
i * igitur Sarai uxorSbrani, non genueratlibero^ : sed ìiabensanciltamaegyptiam no-mine Agart
2. Dixit marito suo:Ecce conclusa me Do-minus , ne parerem ;ingredere ad ancìllammeam, i forte saltem
i. i»-Ia Sarai, mo-glie di Abramo, non a-veva fatto figliuoli: maavendo una schiava egi-ziana per nome Agar,
2. Disse a suo marito;Ecco che il Signore miha fatto sterile, perchèio non partorisca j spo-sa la mia schiava , se a
Yers, a. Se a torte di lei avessi figliuoli, L'Ebreo: /or/' ioper mezzo di lei mi edificherò una casar Maniera di parlaremolto frequente nelle Scritture, Agaf diede nome alla città det*ta Agra nell' Arabia Petrea, e a' popoli detti Agareni, e dipoiSaraceni, dalla parola araba S araba, che vale rubare, far la-trocinii, ^
Essendosi egli prestato alle preghiere dì lei : S. Agostinoiib. xvi, de civ. cap. a 5. scrive. O «orno, che virilmente usa del-le donne : della moglie con temperanza., della schiava percondiscendenza, di nissuna con ismoderata ajffezionel E altro-ve non. ha difficoltà di uguagliare i matrimonii d'Abramo alla ca-stità di .Giovanni. In questo fatto Abramo fu certamente guidatodallo spirito del Signore ; onde egli non fu dipoi men caro a Diftjap||aver condisceso a' desiderii della moglie.

ex illa suscipìamfiMos.Cumque ille acquiesce.ret deprecanti,
5. Tulit Agar aegy-ptiam, ancillam suam,post annos decem quamhabi tare coeperant interra Chajiaan : et de-dit eam viro suo uxo-rem.
4. Qui ingressum estad eam. At illa conce"pìsse se videns despe-xit dominam suam.
5. Dixitq uè Sarai adA oram : Inique agiscontra mei ego dedianciìlan meam in sinumtuum: quae videns ,quod conceperitt despe*ctui me Habet: jiidìcetdominus inter me jet te.
6. Cui respondens d-bram : Ecce, alt, andi*la tua in manu tua est:utere ea, ut libet. Affli-gente igitur eam Sarai,fugam inìit.
sorte di lei almeno aves*si figliuoli. Ed essendo-si egli prestato alle pre-ghiere dì lei,
5. Ella prese Agar e-giziana, sua schiava,passati dieci anni, dac-ché avean principiaload abitare nella terra diGhanaan : e la diede almarito suo per moglie,
4. Ed egli coabitavacon essa. Ma ella vederi-do, che avea concepi-to , prese a farsi beffedella padrona.
5. E Sarai disse adAbramo : Tu mi fai in-giustizia : io ti ho datala mia schiava per tuaconsorte; ed ella veden-do , che ha concepito,mi beffa: il Signore siagiudice tra me $ e te;
6. Rispóse Àbfamo :Ecco che la tua schia-va è in tuo potere : facon lei, come meglio tipiace. vSiccome adunqueSarai la ga&tigava , ellase ne fuggi.
Yers. 4- * Prese a farsi beffe della padrona. Non è raro cheI« prosperità facciano insolentire i men virtiiosi e i più vili.
Vers. 5. Tu mi fai ingiustizia. £ara rifonde nella troppa bon-t't di Abramo verso di Agar la cagione de'mal i termini, che usa-va seco i a schiava. « -.

7. Cumque invenis-szt eam Angelus Do*mini juxta fontem a-quae in solitudineì quiest in via Sur in de-serto ,
8. Dixit ad illam :Agar, andila S'arai,unde venis ? et quo va-dis? Quae respondit:A facie Sarai dominaemeae egofugio.
g. Dixitf/ue ei Ange-lus Domini : Re ver ter ead dominam tuam, ethumiliare sub manu il-lius.
i o. Et rursum: Mul-tiplicans, inquit, multi-plicabo semen tuum,et non numerabiturprae multitudine.
11. Ac deinceps: Ec-ce , ait, concepisti, etparies filium-, vocabis-
7. E 1* Angelo del Si-gnore avendola trovalain luogo solitario pres-so una fontana di ac-qua , che è nella stradadi Sur nel deserto ,
8. Le disse: Agar ser-va di Sarai, donde vie-ni , e dove vai tu ? Edella rispose : Io fuggodagli occhi di Sarai miapadrona.
9. E 1' Angelo del Si-gnore le disse: Tornaalla tua padrona , e u-miliati sotto la manodi lei.
10. E soggiunse : Iomoltiplicherò : grande-mente la tua posterità,e non potrà numerarsiper la sua moltitudine.
11. E dipoi: Ecco,disse, tu hai concepito,e partorirai un figliuo-
Vers. 6. La tua schiava e in tuo potere. Vedesi in questo rac-conto il buon ordine regnare nella casa di Abramo. Sara disgu-stata ed offesa non ardisce dì punire Agar, ma se ne lamenta conAbramo. Abramo, senza disaminare per minuto la ragione dellequerele di Sar^^avendo riguardo alla debolezza del sesso, cono-scendo la prudìÉza della consorte, rimette a lei il pensiero diumiliare la schiava affine di mantenere la pace nella famiglia,Vedi Chrjsoslom, 38. ,- Vera. 7. * L'Angelo del Signore. E questa la prima volta che
espressamente si fa menzione del ministero degli Angeli in prodegli nomini.
* Ivi. La strada dì Sur. Agar egiziana dirigevasi al mo

que nomen ejus fs-mael, eo quod audierièDominus afflictio?iemtuam.
12. Hic eritferus ho»mo; manus ejus contraomnes , et manus omn-ium contra eum : ete regione unhersorumfratrum suorum figettabernacula.
13. Vocavit autemnomen Ti omini ^qui lo-(juebatur ad eam : TuDeus , qui vidisti me.Dixit enim : Profectohic vidi posteriora vi-dentis me.
i 4» ( i) Propterea ap-pellavit puteum illum
lo, e gli porrai nomeIsmaele , perchè il Si-gnore ti ha esaudita nel-la tua afflizione.
12. Egli sarà uom fe-roce: le mani di lui con-tro tutti, e le mani ditutti contro di lui ; eipianterà le tende suedirimpetto a quelle ditutti i suoi fratelli.
13. Ed ella invocò ilnome del Signore , chele parlava : Tu , Dio,che mi hai veduta. Im-perocché ella disse: Cer-to che io ho veduto iltergo di lui ; che mi haveduta.
i4« Per questo chia-mò quej pozzo il poz-
f i j /»/r,"»4=-6tj
Vera. la.'Z-e mani diluì contro tutti, e le mani dì tutti con-tro ec. Predizione verificata in tutti i tempi, e fino al giornod'oggi negli Arabi posteri d' Ismaele, feroci, amanti la guerra, ei ladronecci; senza stanza fissa, salvatichi, e vagabondi, dall'altrolato fedeli nelle promesse, e ospitali, tenendo tutti gli uominiper fratelli, e persuasi che i beni di questa terra son tutti comuni.
Pianterà le sue terre dirimpetto a quelle dì lutti i suoi eo.Gì' Ismaeliti circondano la Giudea, l'Idumea, il Paese di Moab ,e degli Ammoniti.
* Uom feroce. Ebr. Onagro : Asino sal valico.Vers. 13. Ho veduto il 1 ergo ec. L'Angelo, che rappresenta-
va Dio nel corpo, che avea assunto, non fece vedere ad Agar lasua faccia, ma il tergo. Vedi 11 Esodo xxxiu. 38. Quindi 1' anti-chissima tradizione presso gli scrittori profani, che gli Dei nonmostravano mai agli nomini la loro faccia.
Ho veduto il tergo di ini, che mi ha veduta. Che ha get-tato lo sguardo sopra di me per consolarmi, e darmi consiglio,»

puteum viventis, et vi-dentis me. Ipse est in-ter Cades, et Baraci.
15. Peperitque AgarAbrae filium : qui vo~cavit nomen ejus Is-mael.
16. Octoginta et sexannorum eratAbramìquando peperà ei AgarIsmaelem.
zò di lui, che vive, e miha veduta. Egli è traCades, e Barad.
15. E Agar partorìad Abramo un figliuo-lo: il quale gli pose no-me Ismaele.
16. Ottanta sei anniavea Abramo,« quandoAgar partorì a luiIsmaele.
* C A P O XVH.
Le promesse son pur ripetute ad Abramo ; e aluì, e a Sarai sono cangiati i nomi. La cir-concisione è comandata come segno delt al-leanza. Promessa di un figliuola di Sara.Prosperità d? Ismaele. Àbramo eseguisce ilprecetto della circoncisione.
pi. Jt ostquam vero
nonaginta et novem an-norum esse coeperat,apparuit ei Dominus tdixitque ad eum: Rgo
f Deus omnipotens*. am-bula coram me, et estoperfectum À
i. JLtjLa quando egliera entrato nel nonàge-situo nono anno, gl|$p-parve il Signore > e gli4
disse ; Io il Dio onnipo-tente : cammina allapresenza mia, e sii per-fetto.
Vers. 14 Tra Cades, e Barad. Cades, o Cadesbarnc era nel-P Arabia Petrea circa venti miglia lontano da Hebrtm. Di Baradnon sì ha certa notizia.
Vers. i. Io il Dio onnipotente. Potrebbe tradursi l'Ebreo: ioil Z?i'o, che sono pienezza, ovvero la stessa pienezza! camminaa^f presenza mia, e siipwfetlo: affine di renderti capace de'Jie-

2. Ponamque foedusmeum inter me , et te,et muldpUcabo te vehe-menter nimis.
5. Cecìdit Abrampronus in faciem.
4» Dixiique ei Deus:Ego sum, et pactummeum tecum , (i) eris-cjue pater multarumgentium.
5. Nec ultra vocabi-tur nomen tuum A"brami sed appellaberisAbraham', quia patremmultarum gentium con-Stitui te.
6. Faciamque te cre-scere vehementipsime,etponam te in^ejitibuS)regesque ex £§re~dientur.
2. E io fermerò lamìa alleanza tra me , ète, e li moltipllcherògrandemente oltre mo-do.
3. Si gettò Abramoboccone per terra.
4- E dissegli Dio : Iosono, e il patto mio (sa-rà ) con te , e sarai pa-dre di molte genti.
5. E non sarai piùchiamalo col nome diAbramo; ma sarai dettoAbrahamo : perocché ioti ho destinato padre dimolte genti.
6. E ti farò crescereformisura, e ti farò pa-dre di popoli, e da leusciranno de' regi.
ni, ch'io ti preparo, e ti ho promesso, cammina come servo fede-le alla mia presenza, obbedisci a'miei comandi, e fa di essere ir-reprensibile, e senza macchia.
Vers. 4- Io sono. Di Dio solo con verità si dice, che egli è, per-chè egli è eterno, immutabile. Egli adunque /con questa paroladimostra ad Abramo, come1 il-patto, e l'alleanza, che egli ferma-va coti lui, era immutabile.
Vers. 5. Non sarai più chiamato col nome di ee. Abram si-gnifica padre eccelso : Abraham ( contratto di Ab-ram-ham-mon) padre eccelso di moltitudine.
Vers. 6. Ti farò padre di popoli, e nasceranno ec. Abrahn-mo secondo questa promessa di Dio fu certamente padre di po-poli immensi, gl'Israeliti, gl'Idumei; gli Arabi; ed egli ha avutojiella sua discendenza un numero graHÌÌ|ÌS£Ìmo ti' re'^i. Nessun\io-

7- Et statuarii pa-ctum meum inter me, ette , et inter semen triumfiQSt te iti generationi-bus tuis foedere sempi-terno'. utsimDeus tuusyet seminis tuipost te.
8. Dabocfue libi, etsemini tuo terram pere-grÌ7tationis tuae, omn-em terram ChanaaTitn possessionem aeter-nam, eroe/uè Deus eo-rum.
9. Dixìt iterum J)eusad Abraham: (i) Et
7. E io fermerò il miopaltò fra me , e te : ecol seme tuo dopo di tenelle tue generazionicon sempiterna allean-za : ond' io sia Dio tuo,e del seme tuo dopo dite. *
8. E darò a te, e alseme tuo la terra, dovetu sei pellegrino, tuttala terra di Chanaan ineterno dominio, e io sa-rò lor Dio,
9. E di nuovo disseDio ad Abramo : Tu a-
(ij Actor. 7. 8.
mo riguardo a tutto questo potè mettersi in paragone con Abra-liamo, dacché mondo è mondo. Ma vanno elleno a terminarsi quile grandiose promesse di Dio? E l'alleanza sempiterna (vers. 7.)di Dio con Abrahamo che sarebb'ella divenuta, se ella avessedovuto aver suo effetto nella sola discendenza carnale di questo
^ gran patriarca? Con ragione perciò 1'Apostolo ci fa osservare,. che i figliuoli di Abrahamo secondo lo spirito sono l'oggetto di
r este promesse ; che a queste han diritto i Gentili imitatoriIla fede di quel patriarca, a cui queste promesse furono fatte
prima eh' egli ricevesse l'ordine della circoncisione, affinchè cosi. egli fosse padre di lutti i credenti incirconcisi ( vale a dire
*1§I.Gentili), e padr* de1 circoncisi, di quegli, i quali seguonole vestigia delfajede, che fu in Abrahamo padre nostro nonancor circoncjjjtf Rorn. iv. n. i. ix. 7. 8. Gai m. 14-, et seq. Inquesto senso i re, che «asceranno da Abrahamo , sono in primoluogo il Cristo re de' regi, e poi i principi della casa del Signore,
j;li apostoli delle Chiese, gloria di Cristo: la terra(, di cui Dio dàil possesso eterno al seme di Abrahamo fedele, ella è la terrade'vivi, riguardo alla quale non sono più pellegrini nè forestieriquelli che per la fede sono divenuti concittadini e/e' Santi, <ideli(t famiglia stessa di Dio. Ephes. n.
* * * Tifavo padre dii^plli popoli. Ti dilaterò.

tu ergo custodies pa-ctum meum , et sementuum post te in genera--tionibus suis.
io. Hoc est pactummeum, quod observa-bitis inter me, et vos,et semen tuum post te :circumcidetur ex vobisomne masculinum.
n. Et circumcidetiscarnem praeputiì vestri,ut sit in signum foede-ris inter me et vos. (i)
12. Infans ocio die-rum circumcidetur invobis, omne masculi-num in generationibusvestris : tam vernacu-lus\ quam emptidus cir-cumcidetur t et quicum-que non fuerit de stir-pe vestra,
dunque osserverai ilmio patto ? e dopo di teij. tuo seme nelle suegenerazioni.
10. Questo è il miopatto, che osserveretetra me e voi 5 tu, e ilseme tuo dopo di te :tutti i vostri maschi sa»ran circoncisi.
11. E voi circoncide-rete la vostra carne insegno dell' alleanza trame e voi.
12. Tutti i bambinimaschi di otto giornisaranno circoncisi tradi voi da una genera-zione all'altra : il servo,o sia nato , o 1' abbiatecomperato da qualun-que uomo non della vo-stra stirpe, sarà circon*ciso.
(ij Lev. la. 3. Lue. a. ai . Rorn. 4- * t.
Vers. i o. Questo e il mio patto. Cioè a dire il segno del mio''-/ -patto con voi sarà la circoncisione. La circoncisione adunque fu "<ordinata da Dio a rammemorare P alleanza fatta da lui coi suopopolo, divenuto perciò un popolo specialmeaSfé dedicato e con-secrato al Signore , e distinto da tutti gli altri popoli per mez-zo di questo segno. Questo segno medesimo fu una figura del-l'indelebil carattere che i Cristiani ricevono nel santo Battesimo,per cui sono ascritti e adottati nella Chiesa di Dio, e acquistanocliritto^a'beui della medesima Chiesa.
Vers. 11. * In segno. Affinchè ciò sia segno.\?crs. i a. Tutti i bambini ... di otto giorni ec. Non potea farsi
prima questa cercmoiiia , perchè j^n fosse cagioni di morte ai

13. Eritque pactitmmeum in carne vestrain foedus aeternum.
i4- Masculus, cujuspraeputii caro circum-cisa non fuerit, delebi-tur anima illa de populosuo: quia pactum meumìsritum fecit.
T. S.Dìxit quoque Deusad ^Abraham: uxorem
i3. E questo segnodel mio patto sarà nellavostra carne per eternaalleanza.
14* Se un maschionon sarà stato circon-ciso , una tal anima sa-rà recisa dal ceto delpopol suo : perocché haviolato il mio patto.
io. E Dio disse anco-ra ad Abramo ; Non
bambino; ma potea differirsi' per giuste cause .. Vedi Josuecap. 5. 6.
Il serro o sìa nato in casa, o lo abbiate comperato ec. LaVolgata è un poc' oscura in questo luogo : onde ho procurato diesprimere il senso del testo originale, che dee essere anche ilsenso della stessa Volgata. Notisi, che un incirconciso potea vive-re nelle terre degli Ebrei., ma non in casa di un Ebreo : e se unoschiavo straniero avesse ricusato di ricevere la circoncisione, ilpadrone non potea costringerlo, ma dovea rivenderlo . VediMaini, de circumcis. lib, i. cap. 6., Vers. 14. Una lai anima sarà recisa dal celo del popol suo.Sarà rigettata dal corpo della Chiesa Giudaica, privala delle pre-rogative della famiglia di Abramo, ed esclusa dalle promessecontenute nella mia alleanza. Altri spiegano queste parole dellapena di morte, colla quale dovrà punirsi chiunque non fosse cir-conciso ; altri della morte dell' anima , cioè dell'eterna dannazio-ne,-nella quale incorresse chi trascurava questo rito, come quel-lo che era stato ordinato pel rimedio del peccato originale, se-
<£ «ondo s. Agostino, s. Gregorio, s. Tommaso , e altri : ma siccome~au questo punto è diversa l'opinione di molti altri Padri e Inter-preti, la prima e la seconda sposizione sembrano più accertate.Gli-Ebrei affermano che, se un figliuolo di Abramo, non circon-eiso nell'infanzia, arrivato all'anno decimoterzo non si facesse cir-concidere, restava soggetto alla pena intimata da questa legge.
Vers. 15. Non chiamerai più la tua moglie ec. Dopo avermutato il nome ad Abramo, Dio cangia anche quello della consor-te : tu non la chiamerai più mia signora, ma assolutamente lasignora : come quella che non di una sola famiglia sarà madre f
ma di tutte le genti per mezzo d*Isacco, e del Cristo che dee na»scere dal seme d'Isacco, e dA cui lo stesso Isacco sarà figura.

tuam non vocabis Sa-rai, sed Saram.
16. Et benedicane ei,et ex illa dabo tibi fi-lium , cui benedicturussum : eritcfue in natìo-nes, et reges populorumorientur ex eo.
17. Cecidit Abrahamin faciem suam, et ri-sii, dicens in corde suo:Putasne centenario na-scetur filius ? et Saranonagenaria pariet ?
chiamerai più la tuamoglie col nome di Sa-rai , ma sì di Sara.
16. E io la benedirò,e di lei darò a te un fi-gliuolo , a cui io daròbenedizione: ed ei saràcapo di nazioni,-e dalui usciranno regi dipopoli.
17. Abramo si gettòboccone per terra , e ri-se, dicendo in cuor suo:Possibile, che nasca unfigliuolo a un uomo dicento anni? e che Sarapartorisca a novanta ?
Vers. 1-6. La benedirò , e dì lei ti darò un figliuolo, ec. Nel-l'jEbreo tutto intero il versetto si riferisce a Sara: La benedirò,di lei ti darò un figliuolo, la benedirò; ella sarà madre di po-poli, e da lei usciranno de1 re . Grandioso elogio di Sarà, e in-fallibile prova della virtù di questa gran donna . Ella è degnaperciò di es&ere »aa bella figura della Chiesa di Cristo, e anchedi quella Vergine figliuola di Sara, dalla quale volle nascere ilCristo. , _ . , , .
Vers. l'i. E rise, dicendo ec. Rise per eccesso di allegrezza in-sieme, e di ammirazione ; imperocché lungi da noi di sospettarela minima diffidenza in questo grand' uomo dopo quello che iuproposito di questo fatto medesimo ci espone l'Apostolo: Abra-mo contro ogni speranza credette di divenir padre di molte £nazioni... e senza vacillar nella fede non considerò ne il suacorpo snervato, essendo già egli di circa cento anni, ne Vuteradi Sara , già senza vila; ne per diffidenza esitò sopra la pro**messa di Dio: ma robusta ebbe la fede, dando gloria a Dio;pienissimamente persuaso, che qualunque cosa abbia prornes.*sa Dio: egli e potente per farla; perlocche eziandio fugli (ciò)imputalo a giustizia. Rom. iv. 18. 22. Farmi, che queste paroledi Paolo, le quali evidentemente sono allusive al fatto, di cui siparla , non lascin luogo di dubitare della fermezza invariabiledella fede in Abrahamo , particolarmente ove riflettasi a quelleparole: e fugli imputato a giustizia.

18. Dixitf/ue adDeum : utìnam Ismaelvivat coram te.
19. Et alt Deus adAbraham 1(1) Sara u-xor tuct parìet tibi fi-lium^ocabisfjue nomenejus Isaac \ et cojisti-tuam p actum meum il-li in foedus sempiter-num, et semini ejus posteum.
20. Super Ismaelquoque exaudwi te. Ec-ce benedicam ei, et au-gebo, et multipUcaboeum. valde ; duodecimduces generabit, et fa-ciam illum in gentemmagnam.
21. P actum vero m&*um statuam ad Isaac ,quem parici tibi Sara
18. E disse a lui: Digrazia, vìva Ismaele di-nanzi a te,
io. E disse Dio adAbramo : Sara tua mo-glie ti partorirà un fi-gliuolo^ gliporrai nomeIsaac; e fermerò con luiil mio patto per un' al-leanza sempiterna, ecol seme di lui dopo diesso.
20. Ti ho anche esau-dito riguardo a Ismaele,e lo amplificherò, e mol-tiplicherò grandemen-te : ei genererà dodicicondottieri, e farollocrescere in una nazio-ne grande.
21. Ma il mio pattolo stabilirò con Isacco,cui partorirà a te Sara
(ij Infr. 18. io. et ai. a.
Vers. 18. Di grazia , viva Ismaele dinanzi a te. Vale a dire,Signore, dacché tanta è la tua bontà verso di me , che mi pro-metti uu tal figliuolo, e con esso tanta felicità, degnati di graziadi conservare in wta anche il mio Ismaele, e di benedirlo, affin-chè egli viva dinanzi a te, e ti sia accetto. La risposta di Dio: Tiho anche esaudito riguardo ad Ismaele ce. parmi , che nonpermetta di dare verun altro senso a queste parole .
Vers. 19. E gli porrai nome Isaac : che vuol dir riso.Vers. ao. Dodici condottieri. Gli Arabi erano divisi, come gli
Ebrei, in dodici tribù, e lo sono anche di presente ; i capi, o siacondottieri di esse sono predetti in questo luogo.
'* Farollo crescere in una nazione. Divenire una nazionegrami e.

tempore ista in anno al-ter o.
22. Cumque finitusesset sermo loc/uentiscum eo , ascendit Deusab Abraham.
23. Tuiit autem A"braham Ismael filiumsuum, et omnes vernacu-los domus suae-, univer-sosque , t/uos emerat,cunctos mares ex omni-bus viris domus suae :et circumcidit camenipraeputii eorum statimin ipsa die sicut prae-ceperat ei Deus.
24. Abraham nona"ginta et novem erat an-norumì quando circum-cidit carnem praeputiisui.
26. Et Ismael filiustredecim annos imple»
in questo tempo V an-no vegnente.
22. E finito che ebbedi parlare con lui, sitolse Dio dalla vista diAbramo.
23. Abramo adunqueprese Ismaele suo fi-gliuolo , e tutti i servinati nella sua casa : etutti quelli che aveacomperati, tutti quan-ti i maschi di sua casa,e li circoncise immedia-tamente lo stesso gior-no, conforme Dio gliavea ordinato.
24. Abramo avea no-vantanove anni , quan-do si circoncise.
26. E il figliuolo I*smaele avea compito
Vers. 21. * Ma il mio patto lo stabilirò con Isacco. Perquanto di glorioso ed ampio si prometta nel mondo a Ismaele, inconfronto degli spirituali vantaggi destinati al fratello, nulla daDio si valuta.
Vers. 22. Si tolse Dio ec. Il Siro traduce V Angelo di BJo . Emolti Interpreti credono , che per lo più in queste apparizionidee intendersi un Angelo rappresentante la persona di Dio.
Vers. 28. Immediatamente lo slesso giorno, È degna di osser-vazione la pronta obbedienza di Abramo. JL' udire il comando diDio, e l'eseguirlo fu quasi Io stesso. Ma è anche degna d' osserva-zione 1' obbedienza d'Ismaele , e di tutta quella numerosissimafamiglia in soggettarsi ad un rito molto penoso. Argomento del-l'autorità acquistata da Àbramo sopra dei suoi per una sperimen-tata virtù e saviezza.

verat tempore circumci-sionis suae.
26. Eadem die cìr-cumcisus est Abraham,et tsmael filius ejus»
2 7. Et omnes viri do-mus illius, tam verna-culi, quam empdtii, etalienigenae pariter cir*cumcisi sunt.
tredici anni al tempodella sua circoncisione.
26". Nello stesso gior-no fu circonciso Abra-mo , e Ismaele suo fi-gliuolo.
27. E tutti gli uomi-ni di quella casa, tantoquei che in essa erannati , come quei che e-rano stati comperati, egli stranieri furono cir-concisi ad un tempo.
C A P O XVIII.
Tre Angeli accolti da A bramo come ospiti pro*mettono un figliuolo di Sara ; e questa perciòavendo riso , ne è ripresa. Predizione dellarovina di Sodoma, per cui Abramo prega piùvolte.
i. ( i) Lpparuit au"tem ei Dominus in con-valle Mambre, sedentiin astio tabernaculi suiin ipso fervore dìeì.
(i^ fle&r. 13. ».
i. EJ il Signore ap-parve ad Abramo nellavalle dì Mambre , men-tr' ei sedeva ali' ingres-so del suo padiglionenel maggior caldo delgiorno.
Vers. i. E il Signore apparve ad Abramo nella valle ec. Itre personaggi che apparvero ad Abramo, rappresentavano il Si-gnore sèlle tre divine persone: ed erano Angeli in figura umana:iunperoccjbè a questo fatto principalmente alludendo 1' Apostolodice: Non vi dimenticato delV ospitalità, dappoiché per quatta

2. Cumque elevassetoculos , apparuerunt eitres viri stantes propeeum : quo s cum vidis*set.cucurrit in occursumeorum de ostio taberna*culi, et adoravit in ter-ram.
3. Et dixiti Domine^sì inveni gratiam in o»culis tuis , ne transeasservum tuum :
4. Sed afferam pau~x illum afjuae , et lava-te pedes vestros , et re»quiescite sub arbore.
6. Ponamcjue buccel-Iam panis, et conforta»
2. E avendo egli al*zati gli occhi, gli com-parvero tre uomini, chegli stavano dappresso ;e veduti che gli ebbe ,corse loro incontro dal-l'ingresso del padiglio-ne, e adorò fino a terra.
3. E disse : Signore ,se io ho trovato graziadinanzi a te , non la-sciar indietro il tuo ser-vo :
4. Ma io porterò unpo' di acqua , e lavate ivostri piedi , e riposa-tevi sotto quest'albero.
5. E vi presenterò unpezzo di pane, affinchè
alcuni diedero, tenta saperlo, ospizio agli Angeli. Heb. xm. 2.Vedi Augast. xvu def.ciy. cap, 29.
Yers. 2. Ceduti <?ke gli ebbe , ando ec. In tutto questo raccon-to abbiamo una viva pittura del rispetto e della carità di Abramoverso degli ospiti . , -
E adoro sino a terra. Vedi cap. xxm. 7. un' espressione si-mile a quella usata qui nella nostra Volgata. La voce latina ado-rare, e la greca de'LXX., che corrisponde a questa, significanoportar la mano alla bocca, baciarsi la mano, che era segno d'ado-razione presso gl'idolatri. Fedi Job. xxxi. 28. IH. Reg. xix. 18,
* Adoro fino in terra. Oppure : si prostro a terra.Vers. 3. Signore, se io ho trovato ec. Abramo talora parla a
tutti e tre ; talora a quello di mezzo , che faceva la prima figura,e pareva sovrastare agli altri.
Vers. 4- Porterò un po iV acqua ec. La lavanda de' piedi erala prima funzione dell' ospitalità. S. Agostino, e s. Girolamo, in-vece di quello che si ha nella Volgata: e lavate i vostri piedi,lesserò, e laverò i vostri piedi: ma certamente il senso è lo stesso.
Per questo siete venuti verso ec. A questo fine d' onorar lamia tenda, prendendo in essa ristoro; a questo fine senza altro visiete qua rivolti.

te cor vestrum*', posteatransibitisi idcirco enimdeclinasti^ ad servumvestrum. Qui dixerunt:Fac, ut locutus es.
6'. Festlnavit Abra-ham in tabernaculumad S oram, dixitque ehAccelera ; irla sata si-milae commisce, etfacsubclnericios panes.
fy Ipse vero ad ar-mentum cucurrit: et tu-Ut inde vituhtm tener-rimum^ et optimum, de-ditque puero, quifesti*navit, et coxit illum.
8. Tulit quoque buty-rum, et lac, et vitulum,
ristoriate le vostre for-ze , e poi ve n* andere-te? imperocché per que-sto siete venuti versoil vostro servo. E quellidissero : Fa , come haidetto.
6. Andò in fretta A-bramo da Sara, e le dis-se : Fa presto, impastatre sati di fior di fari-na, e fanne delle schiac-ciate da cuocer sotto lacenere.
7. Ed egli corse ali3
armento, e ne tolse unvitello il più tenero , egrasso, e lo diede ad unservo,il quale ben tostolo ebbe cotto.
8. Prese anche delburro ? e del latte , e il
"Vers. 5. * VI presenterò un pezzo di pane. Del cibaVers. 6. Impasta tre sali di fior di farina. II salo è misura
ebrea contenente il terzo di uii'epta; onde tre sati fanno un'epha,cioè piii di settanta libbre di farina. Sara in età di novaut' anni,Sarà nobilissima e ricchissima donna dee impastare ( certamentecolP aiuto delle sue serve } questa farina, farne il pane, e cuocer-lo. Questa semplicità degli auticki costumi notata nelle Scrittu-re si osserva anche negli scrittori profani, benché tutti posterioria Mosè. E questa semplicità serviva assaissimo a conservare nellemadri di famiglia il buon costume e 1' affezione alla casa, a ren-derle piìi attive , e anche ^ti miglior sanità. E questa semplicitàquanto è mai preferibile alwmollezza e alla inutilità, nella qua-le le donne comode de' nostri tempi consumano la maggior partedei tempo e della vita!
Delle schiacciate da cuocere tolto la cenere. 1 Saraceni » ej Mauri, simili agli Ebrei ne'costumi, anche oggidì cuocono il lo-ro pane o eotto i carboni, o cotto 1« ceneri, o nelle padelle.

quem coxerat, etposuitcoram eis: ipse vero sta-bat juxta eos sub ar-bore.
9. Cumque comedis-sent, dixerunt ad eum:Ubi est Sara uxor tua?Ille respondit : Ecce intabernaculo est.
10. Cui dixit-. (i) Re-vertens veniam ad tetempore isto, vita comi"te; et habebit filium Sa-ra uxor tua. Quo au-dito , Sara risii postostium tabernaculi.
(i) Sap. 17. IQ. Infr. ai. i. Rom. 9. 9.
vitello cotto , e ne im-bandì loro la mensa :ed egli se ne stava inpiè presso di loro sottol'albero*
g. E quelli mangiatoche ebbero, dissero alui: Dov'è Sara tua mo-glie? Egli rispose : Ellaè qui nel padiglione.
io.E alui disse (unodi quelli ) : Tornerònuovamente a te di que-sta stagione, vivendotu ; e Sara tua moglieavrà un figliuolo. Laqual cosa avendo uditaSarà di dentro alla por-ta del padiglione, rise.
Vers. 8. Prese conche del burro. Nell'oriente il burro si con-serva liquido, e la voce usata qui nell' originale dà idea d* unacosa che si bee. Questo burro ordinariamente dà grato odore.
Se ne stava in pie presso di loro ; vale a dire gli serviva atavola, come traduce il Caldeo. Vedi Jerem. in. 12. Nehem. xii. 44-
Vers. Q. Mangialo che ebbero. La maggior parte degl' inter-preti cori Teodoreto, e s. Tommaso affermano, che questi Angelinon mangiarono in realtà, ma parve che mangiassero ; e Abramocredette che avesser mangiato. Ma s. Agostino sostiene, che real-mente mangiarono , e che gli Angeli posson mangiare , e , chequando P Angiolo Rafaele disse a Tobia: Pareva a voi che iomangiassi e bevessi ; ma io mi servo di cibo e di bevanda in-visibile, ciò non vuol dire, che Ra&ele non mangiasse effettiva-mente, ma significa, che quelli, chelo vedeano mangiare, crede-vano che egli facesse per bisogno , quand' ei lo faceva solamenteper elezione. Vedi Tob. xir. i g.
Vers. io. Vivendo tu. Sembrami questa la migliore interpre-tazione di quelle parole della Volgata vita comile; e dell' Ebreosecondo il tempo della vita; l'Angelo dice ad Abramo, che l'au>

11, "Erant autem am-bo senes, provectaequeaetatis > etdesierantSa*rae fieri nwliebria.
12. Quae risii occul*te , dicens : Postc/uamconsenui, et (i) domi-nus meus vetulus est<voluptati, operam dabdì
15, Dixit autem Do-minus ad Abraham, :Quare risìt Sara, di-céilis : Num vere pari-tura sum anus ?
14- Numquìd Deoguidquam est difficile ?Juxta condictum rever-tar ad te hoc eodem tem-pore , vita comile, ethabebit Sara filium.
15. Negavit Sara, dì-cens : Non risi : timoreper territa. Dominus au-tem : NOÌI est, inquit,ita: sedrisistì.
11. Imperocché am«bedue erano vecchi, ed' eia avanzata , e Sa-ra non aveva più i cor-si ordinarii delle donne.
12. Creila rise in suosegreto dicendo : Dopoche io sono vecchia , eil mio signore è caden-te , ridiverrò io giovi-netta ?
13. Ma il Signoredisse ad Abramo : Per-chè mai ha riso Sara ,dicendo : Son io perpartorire da vecchia ?
i4- V'ha egli cosa dif-ficile a Dio ? Tornerò ate secondo la promessafatta in questa stagio-ne , vivendo tu , e Saraavrà un figliuolo.
15. Negò Sara, e pie-na di paura disse: Nonho riso . Ma il Signore:Non è così, disse : pe-rocché tu hai riso.
(ij i. Pet. 3, 6,
no seguente in quello stesso tempo tornerà a lui ; che ei sarà vi-vo, e avrà avuto un figliuolo di Sara.
Yers. i a. Rìse in suo segreto. Il Caldeo rìse déntro di se: ri-guardando come impossibile quello che avea sentito dire da quel-li che «Ha credeva uomini ; ella è perciò ripresa e biasimata dal-l'Angelo.
E il mio signore è cadente. A ragione l'umiltà, e il rispet-to di Sara yera> il marito è proposto come un beli' esempio alledonne Cristiane da e. Pietro, ep.-i. cap. in. 6.

16. Cum ergo surre-xissent inde viri, dire-scerunt oculos contraSodomam-. et Abrahamsimul gradiebatur, de-ducens eos.
17. Dixitque Domi-nus i Num celare pote-rò Abraham, quae ge-3turus sum ?
18. Cum futurus sitin gentem magnani,ac robustissimam , et( i ) BENEDICENDOsint in illo omnes na-liones terrae ?
i g. Scio enim, quodpraecepturus sit filiissuis , et domui suaepost <set utcustodiantviam D ominide tfaciantjudicium, etjustitiam jut adducat Dominuspropter Abraham omn-ia , quae locutus estad eum.
16. Essendosi adun-que alzati da quel luo-go quegli uomini, volse-ro gli sguardi verso So-doma : e Abramo anda-va con loro, accommia-tandoli.
17. E il Signore dis-se : P'otrò io tener na-scosto ad Abramo quelche sono per fare ?
18. Mentr'egli defcbeesser capo di una na-zione grande, e fortis-sima , e dovendo in luiavere BENEDIZIONEtutte le nazioni dellaterra?
19. Imperocché io so,che egli ordinerà a'suoìfigliuoli, e dopo di saalla sua famiglia, che se-guano le vie del Signo-re, e osservino la retti-tudine > e la giustizia ;affinchè il Signore pon-ga ad effetto tutto quel-lo che ha detto a lui.
(i) Supr* 12. 3. Inf. 22. 18.
Vers. 15. Non ho riso. Sara è anche più biasimevole per avervoluto coprire il suo fallo con una bugia.
Vers. 19. * So che ordinerà a'suoi figlinoli ec. Chi vuol per-tanto piacere a Dio e riportarne benedizioni, non lasci d'insinua-re ne'fìgli e nella famiglia tutta, che seguano le vie dj|l Signore,e osservino la rettitudine e la giustizia, *

20. Dixit itaque Do-minus : Clamor Sodo-morum, et Gomorrhaemuldplicatus est., etpec-catum eorum aggrava-tum est nimis.
»*• Descendam, etvìdea*?, utrum clamo-rem , qui venit ad me,opere compleverint-, annon est ita, ut sciam.
t;2. Convertermite/uèse inde, et abiei*unt So-
jdjomam: Abraham vero^jjii'huc staóatcoramDo-minOi
Z^T&tappropinquansait: Nunquid perdes ju-stum cum impio?
24. Sì fuerint cjuin-quaginta justi in civi~tate., peribunt simul* etnon parces loco illipropter quinc/uagintajustoS) si fuerint in eoj
20. Disse adunque ilSignore : II grido di So-doma e di Gomorrha ècresciuto, e i loro pec-cati si sono aggravatiformisura.
21. Andrò, e vedrò ,se le opere loro aggua-glino il grido, che ne ègiunto fino a me : o, secosi non è, per saperlo.
22. E si partìron dilà, e s' incamminaronoa Sodoma: ma Abramostava tuttora dinanzial Signore.
23. E avvicinandosidisse : Manderai tu inperdizione il giusto in-sieme coli'empio?
24' Se vi saranno cin-quanta giusti in quel-la città; periranno egli-no insieme ? e non per-donerai tu a quel luogoper amor di cinquantagiusti, quando vi sieno?,
Vers. 20. Il grido di Sodoma e di Gomorrha ec. Questo gri-do, come osserva s. Agostino, significala sfacciataggine e impu-denza , colla quale i cittadini di quelle città violavano pubblica-mente le leggi più sacrosante di natura. Sono nominate questedue città, come le principali e le più ingolfate ne'vizii.
Vers. ar. Andrò e vedrò, ec. Dio qui istruisce coloro , i qualisono destinati ad amministrar la giustizia, insegnando loro la cir-cospezione e la maturità che debbono osservare ne' loro giudizii.
Vers. as. E lìpartiron di tó, due de'tre Angeli, restando conAbramo il terzo che era quello, il quale, come abbiam detto, fa-ceva la prima figura, e portava là parola.

2 5. Ab sit a te, utrem hanc factas, et oc-cidas justum cum im-pià, jìatque justus sicutimpius : non est hoctuum ; qui judicas o-ìmiem terram, nequa-quam facies judiciuìJihoc.
26. Dixitque Domi-nus ad eum : Si inve-nero Sodomis quinqua-ginta justos in mediocivitatis, dimittam o-mni Loco propter eos.
27 .Respondensque A*braliam , alt : Quia se-mel coepi, loquar adDominum meum, cumsint pulvis, et cinis .
28. . Quid si mi-nus quinquaginta /#-$tis quinque fuerint? de-lebis propter quadra-ginta quinque univer-$am urbem ? Et ait :Non delebo , si invene-ro ibi quadraginta quin-que,
29. Rursumque locu-tus est ad eum\ Sin au-tem quadraginta ibi in-venti fuerint, quid fa-cies! Ait-.Non percudampropter quadraginta.
Pent, VoL I.
26, Lungi da te il fa-re tal cosa, e che tu uc-cida il giusto coli' em-pio, e il gius 1 o vada delpari coll'empio : questacosa non è da te; tuche giudichi tutta laterra non farai similgiudizio.
26. E il Signore dis-segli : Se io troverò itimezzo alla città di So-doma cinquanta giusti,io perdonerò a tutto illuogo per amore di essi,
27. E Abramo rispo-se , e disse : Dacché hocominciato una volta ,parlerò al Signore mio,benché & sia polvere ,e cenere.
38. E se vi sarannocinque giusti meno dicinquanta , dMrugge-rai tu la ^iltà, perchèsono solamente qua-rantacinque ? E queglidisse : Non la distrug-gerò ,se ve ne troveròquarantacinque.
20.E Abramo ripigliò,e disse a lui : E sé qua-ranta vi si troveranno,che farai tu ? Queglidisse : Non gastigheròper amor de* quaranta.
9

3o. Ne quaeso, in-x/uit, indigneriSt Domi"ne , si loquar. Quid siibi inventi fuerint tri'"ginta? Respondit: Nonfaciam , si invenero ibitrìgìnta.
5i. Quia semel) ait^eoepì, loquar ad Domi"num meum . Quid si
,,, ibi inventi fuerint vi-'; gintì? Ait: Non interfi-
*ciam propter viginti*v>
T' 32. Obsecro , inquit tne irascaris Domine,i9Ì loquar adhuc semel»Quid sì inventi fuerintibi decem? Et dixiti"Non delebo propter de-•cem,
35. Abiitffue Domi'nus postcjuam cessavitloqui ad Abraham, etille reversiis est in /o-cumsuum.
3o. Non adirarli, dis-se , o Signore, del mioparlare . Che sarà egliquando vi se ne trovi-no trenta ? Rispose :Non farò altro, se vene troverò trenta.
3 i. Dacché una voltaho principiato, disseegli, parlerò al mio Si-gnore. E se ve ne fos-ser trovati una venti*na ? Rispose: Per amorde' venti non manderòlo sterminio.
3^. Di grazia , diss'e-gìi , non adirarti, o Si-gnore , se io dirò anco-ra una parola. E se die-ci colà si trovassero?E quegli disse : Peramore de' dieci non ladistruggerò.
33. E andossene ilSignore quando .Abra-ma finì di parlare ; edegli tornosseue a casasua.
Yers. 85. E se clieci colà si trovassero? Abramo dopo questainterrogazione non va più avanti, ma si sta cheto, ammirando la«Temenza di Dio. Ei credeva, clic dieci giusti .potessero agevol-inente trovarsi in tanta moltitudine. Benché la sua sollecitudine-riguardasse principalmente il nipote Lot, contuttocib egli fa ve-'dere una carità universale verso gli abitanti di quelle infelicicittà;-carità, colla quale meritò la-liberazione del nipote.
Vers. 33. Andosscnc il Signore, quando ec. Spari dagli occhi*!' Abramo quell'Angelo, col quale egli parlava, andati gli altriiéue 9 Sodome, "

Lot avendo accolti in sua casa gli Angeli è mal-trattato da' Sodomiti : è Liberato colla moglie,e colle due figliuole dall incendio di Sodomaìe perde per istrada la moglie. Ubriacato com-mette incesto coII una e coli' altra figliuola ,donde nacquero i Moabiti, e gli Ammoniti.
i. (i) reneruntfjueduo Angeli Sodomamve spere, et sedente Lotin foribus civitatis. Quicum vidisset eos, sur-rexit, et hit obviam eis:adoravitque pronus interram.
2. Et dixit: Obsecro,Domini , declinate indomum pueri vestri, etmane te ibi: lavate pe*des vestros, et maneproficiscemini in viamvestram. Qui dixerunt-.Minime , sed in plateamajiebimus.
3. Compulit illos op-pido , ut dìverterent adeum: ìngressic/ue do-mum illius fecit convi"
1. Jtii i due Angeliarrivarono a Sodomasulla sera , e in tempoche Lot stava sedendoalla poria della città.Ed egli veduti questi,si alzò, e andò loro in-contro: e gli adorò pro-strato per terra.
2. E disse: Signori,di grazia venite alla ca-sa del vostro servo , ealbergatevi : vi lavere-te i vostri piedi, è allamattina ve n* andreteal vostro viaggio. Maquelli dissero: No, noistaremo nella piazza.
3. Ei però li costrin-se ad andarsene a casasua : ed entrati che fu-rono, fece loro il ban-
(i) Hebr. 13. 2.
^Vers. i. -j t" alzo, e ando loro incontro ec. Lot imita la carità•di Abramo verso de' forestieri. *

vium , et coxit azyma%et comederunt.
4. Prius autem quamirent cubitum, viri civi-tatis vallaverunt do-miitn> a puero usque adsenem> omnis populussimul.
6. Vocaveruntque Lot,et dixerunt eh Ubi suntviri, qui introierunt adtemete? educ illos huc,utcognoscamus eos.
6. Egrcssus ad eostiot post tergum occlu*dens oftium ait:
7. Nolite, quaeso,fra-tres mei, nolite malumhoc facere.
chetto, e cosse del pa-ne senza lievito , ed eimangiarono.
4. Ma prima ch essiandassero a dormire,gli uomini della cittàassediarono la casa, fan-ciulli, e vecchi, e tuttoil popolo insieme.
6. E chiamaron Lot,e gli dissero : Dove so-po quegli uomini, chesono entrati in casa tuasul far della notte? man-dagli qua fuora , affin-chè noi li conosciamo.
6. Usci Lot, chiu-dendo dietro a sé laporta, e disse loro:
7. Non vogliate digrazia, fratelli miei,non vogliate far que-sto male.
Vers. 3. Cotte del pane senza lievito, ec. L'Ebreo diceAJmazoth : i Greci avevano una specie d'impasto, ài farina d or*Zo. o di grano, eoa acqua e latte e olio, con vino dolce, ovverovino cotto," e questa pasta mangiavano cruda ; e chiamavasiim*-,0. Simile Impasto era usuato tra gli Ebrei ; ma eglino per lopiù lo facevan cuocere. Si può credere che tale fosse il pane da-to da Lot agli Angeli. ^ ••
* Fece lor? il banchetto. Gli preparò da bere: cosi nel-
VerT^ Tutto il popolo insieme. Vedesi una corruzione uni-versale ed inaudita. , , r•
Vew, 5. finche noi li conosciamo. Voghamo vedere que lo-restieri, e sapere chi essi sono. Sotto questo pretesto cuopronoquesti empiile scellerate loro intenzioni; e questo bastava a Lot(il quale feissimo li conosceva)'per intendere quel che voles-sero fare,

8. Habeo duasfilias,quae necdum cognove-runtvirimi', educam easad VOS) etabùtimini eis,sicut placuerit, dum-modo viris istis nihilmali faciatis ; quia in-gressi sunt sub umbraculminis mei.
9. At illi dixerunt\Recede illuc. JLtrursustIngressus es, inquiunt,ut advena\ numquidutjudices ? te ergo ipsummagis, quam hos, affli-gemus. (i) fimquefa-debant Lot vehemen-tissime : jamque propeerat, ut effringerentfores*
8. Ho due figliuoleancor vergini: le con-durrò a voi, e abusatedi esse , come vi pare,purché non facciate ve-run male a quegli uo-mini ; perocché son ve-nuti ali' ombra del miotetto.
9. Ma quelli dissero:Va in là. E aggiunse-ro: Tu sei entrato quacome forestiero ; la fa-rai tu da giudice ? Noiadunque faremo a tepeggio, che a quelli.E facevano strapazzograndissimo di Lot : ederano già vicini a rom-pere la porta.
(i) a. Petr. a. 8.
Vers. 8. Io ho due figliuole ec. La perturbazione <à? animo aduna si indegna richiesta, la sollecitudine di salvare ospiti sì ve-nerabili dall'oltraggio, l'impossibilità di opporsi per nissun mo-do agli attentati di coloro ; tutto questo potè diminuire in qual-che maniera la colpa di Lot nel fare una tale offerta : ma eglicertamente peccò ; nè egli era padrone di esporre le figliuole al-l'infamia e al peccato ; e l'ordine stesso della carità richiedeva,che egli, padre com'era , provvedesse ali'onor delle figliuole,prima che a quello degli ospiti. S. Agostino confessando il pecca-to di Lot dice tutto quello che ragionevolmejjte può dirsi periscusarlo, in queste poche parole: Lol per orrore degli altruipeccali turbato nelV animo non bada al suo proprio peccalo ;mentre volle sacrificare le figliuole alla libidine di quegliempii.
* Abusale di esse come vi piace. Fate di esse quel che vijpiace.
Vers. g. Va in la. Volevano farlo allontanare dalia porta peristoriarla ; e si vede, che riusc, loro di farlo. "

10. Et ecce miserimimanum viri, etbitrodu-xerunt ad se Lot, clau-seruntgue ostium.
11. Et eos , qui/oriserant (i), percusseruntcrediate a minimo us-que ad maximum, itaut ostium invenire nonpossent.
12. Dixerunt autemadLofr Habes h^cquem-pigan tiiorum, generum,aut filios , aut filias ?omnes , qui tui sunt,educ de urbe hac :
13. Delebimus enimlocum istum\ eo quodincreverit clamor eo-rum coram JD^ omino ,qui misit nos , ut per-damus illos.
i4« Egressus itaque-Lot, locutus est ad ge-neros suos, quiacceptu-ti erant jiiias ejus, etdixit\ Sur gite , egredi»
10. Quand'ecco que-gli steser la mano, emisero Lot in casa, echiuser la porta.
11. E colla cecità pu-nirono que* che eranfuori, dal più piccolofino al più grande, tal-mente che non poteva-no trovar la porta.
12. E dissero a Lot :Hai tu qui alcunode' tuoi, o genero, o fi-gliuoli , o figlie? tuttii tuoi menali via daquesta città ;
13. Imperocché noidistruggeremo questoluogo ; perchè il lorogrido si è alzato viepiù fino al Signore , ilquale ci ha mandati asterminarli.
14. Usci adunqueLot, e parlò a*suoi ge-nerijChe doveano pren-dere le sue figlie, e dis-se: Levatevi, partite
(i) Sap. 16. i g,
Yers. il. E colla cecità punirono ee. Vatablo : abbacinaronola vista a quelli ec. S. Agostino, e la maggior parte degl'inter-preti credono , che questa cecità consistesse nell' avere fatto si ,che quantunque vedessero le altre case, non vedessero, nè potes-sero trovare la porta della casa di Lot.
* Colla cecità. L' Ebr. in plur. colle cecità, accio sì com-prenda lo stalo misero cui furono ridotti, sconvolto vie più inessi 17 uso della ragione, che quello de' semi.

mìni de loco isto ; quiadelebitDomiJius civita-lem hanc. Et visus esteis quasi ludens ioqui.
15. Cumque essetma-ne , cogeòa?it eum An-geli , dicentes : Surge ;tolte uxorem tuam , etduas filias quas habes:ne et tu pariter pereasin scelere civitatis.
16. Dissimulante il-lo, apprehend erunt ma-num ejus , et manumuxoris , ac duarum fi*liarum ejus , eo quodparceret Dominus illi.
17. (i)Eduxeruntqueeum, et posuerunt ex-tra civitatem : ibìqueloculi sunt ad eum di-centes : Salva animamtuam i noli respicerepost tergum \ nec stesin omni circa regione :sed m moìite salvum tefacjie et tu simul pereas.
da questo luogo ; per-chè il Signore distrug-gerà questa città. Eparve loro, che parlassecome per burla.
16. E fattosi giorno,gli Angeli lo sollecita-vano, dicendo: Affretta-ti ; prendi la tua mo-glie , e le due figliuole,che hai : affinchè tu an-cor non perisca per lescelleratezze di questacittà.
16. E stando egli abada , lo preser per ma-no lui, e la sua moglie,e le sue due figliuole ,perchè il Signore a luivolea perdonarla.
17. E lo condusserovia, e lo miser fuori del-la città : e quivi parla»rono a lui, dicendo :Salva la tua vita : nonvoltarti indietro , e notiti fermare in tutto ilpaese circonvicino: masalvati al monte, affin-chè tu pure non perisca.
(ij Sap. io. 6.
Vers. «4- Che doveano prendere le sue figlie. L 'Ebreo, cheprendevano le sue figlie: e i LXX, che aveano prese le sue fi-
f lie; vale a dire , avevano fatti gli sponsali colle sue figlie, òliSfarei, e gli altri popoli del levante faeea n passare per lo più un
assai lungo intervallo Ira gli tjponsali e il malrimoaio.

18. Dixitque Lot adeos: Quaeso,D ornine mi,
19. Quia invertii ser-^vus tuus gratiam coramte , et magnificasti mi-sericordiam tuam,quamfecisti mecum , ut sal-vares animam meam,nec possum in montesalvari^ ne forte appre-ìiendat me malum , etmoriar.
ao. Est civitas haecjuxta, ad quam possumfugere, parva, et salva-hor in ea . Numquidnon modica est, et vi-vet anima mea ?
21. Dìxìtque ad eum:Ecce etiam in hoc su-scepi preces tuas , utnon subvertam urbem,pro qua locutus es.
18. E Lot disse loro:Di grazia , Signor mio,
.19. Dacché il tuo ser-vo ha trovato grazia di-nanzi a te , e bai fattoa me una misericordiagrande , ponendo in si-curo la mia vita, io nonposso salvarmi sul mon-te, perchè potrebbe for-se venir sciagura sopradi me, e tormi la vita.
20.E qui vicina quel-la città , alla quale pos-so fuggire ; ella è pie-cola , e ivi troverò salu-te . Non è ella piccoli-na , e ivi non sarà sicu-ra la mia vita ?
21. Ma quegli dissea lui : Ecco che anchein questo io ho esaudi-te le tue preghiere, on-de non distruggerò lacittà,in favor della qua-le tu hai parlato.
Vers. 17. * Non voltarti indietro. Riguarda il comandamentodel pari la moglie , e le figlie di Lot , ed è indiritto a provarecoli' obbedienza la costante detestazione dejle scelleraggini delpaese.
• Vers. 19. Non posso salvarmi sul monte, perche ec. Sembrache Lot pieno ancor di timore, d'agitazione e d'affanno per quel-lo che gli Angeli gli avevano predetto, camminando lentamente<? a stento , temesse che gli mancasse il tempo per arrivare a sal-vamento sul monte ; o che assolutamente non si sentisse forzaper giungervi La sua obbedienza non fu perfetta ; ma nondimenoegli merita lede, perchè per tal modo cerca di salvare la piccolacittà di Sego*,

22. (i) Festina, etSalvare ibi : quia nonpoterò facere quidquam,donec ingrediaris illuc.Idcirco vocatum est no-men urbis illius Segar.
23. Sol egressus estsuper terram , et Lotingressum est Segor.
24. (i) Igitur Domi-nus pluit super So-domam et Gomorrliamsulpliur et ignem a Do-mino de coelo:
22. Affrettati , e sal-vati colà: perocché ionon potrò far nulla, fi-no a tanto che tu vi siaentrato. Per questo fudato a quella cifctà ilnome di Segor.
23. Il sole si levò so-pra la terra , e Lot en-trò in Segor. .
24.11 Signore adun-que piovve dal Signo-re sopra Sodoma e Go-morrha zolfo e fuoco ,dal cielo:
(i) Sap. io. 6.(•>.) Deut. 29. 2 3. Isaì. 13. 19. Jerem. 5o. 4o
Oj.ee 11.8. Amos 4- 11. Lue. 17. 28. Judae 7.Ezech. 16. 49-
Vers. 22. Per questo fu dato a quella citta il nome di Segor,Prima chiamavasi Baley e di poi fu chiamata Segor, ebe vuol dirpiccola.
Vers. a4- H Signore piovve dal Signore ec. 1 Padri riconosco-no concordemente in queste parole una dichiarazione della di-stinzione delle persone, del Padre e del Figliuolo, e la divinitàdel Figliuolo, e la sua uguaglianza col Padre, e han paragonatoqueste stesse parole con quelle del Salmo roo. vers. i. Disse ilSignore al mio Signore, citate già da Gesìi Cristo istesso ; equelle del Salmo lao: Per questo ti unse , O Dio, il tuo Dio, ec.citate da s. Paolo a provare le medesime verità, Heb. i. 9. Senzai>adare perciò a quello che qui dicono alcuni moderni Ebrei, eanche alcuni moderni Cristiani troppo facili a seguire le dottri-ne di quelli, abbiam conservato nella versione la stessa prettafrase, come l'ha conservata la nostra Volgata, II Padre ha rimes-so interamente al Figliuolo dì far giudizio, Joan. v. 22. Il Fi-gliuolo riceve dal Padre insieme colla essenza anche tutta la po-testà. Il Figliuolo adunque, che è Signore, e Dio, colla potestàdatagli dal Padre, da cui riceve tutte le cose, piovve zolfo e fuocodal cielo sopra Sodoma e Gomorrha. Notisi, che quantunque nonsi parli qui, se non di Sodoma e di Gomorrha, egli è certo pero,che anche Adama e Seboim furono soggette allo stesso gastigo ,e la quinta città non fu risparmiata se non per le preghiere di Lo 1,

20. Et subvertit civi-tates has, et omnem
§ìrca regìonem, univer-os habitatores urbium.,
et cuncta terrete viren-da.
26. (i ) Respìdensqueuxor ejus post se, versaest in statuam salis.
26. E distrusse quel-le città, e tutto il pae-se all'intorno, tutti gliabitatori delle città, etutto il verde dellacampagna.
26. E la moglie diLot essendosi rivoltaindietro , fu cangiatain una statua di sale.
(i) Lue. 17. 3».
MEa perchè non riflettiamo noi sopra questo grande avveni-mento, nel. quale ha voluto Dio dare una gran lezione agli uomi-ni, facendo loro vedere un saggio di quella terribil giustizia, col-la quale punirà la sfrenatezza degli uomini nell' altra vita? Unaregione già amenissima e fertilissima diviene orrida a vedersi, espaventevole, dopo che il fuoco e lo zolfo cadente dal cielo nesterminò gli abitatori, ridusse in cenere gli edifizii, e la campagnastessa coperse di rovine e di orrori. Il bitume, di cui era pienoquel terreno , servì ad accrescer l'incendio , da cui non solo lepiante tutte, ma anche una parte della terra fu abbruciata. Crc-pata la stessa terra in più luoghi, e abbassatasi, le acque delGiordano vi si gettarono, e vi presero le qualità che si osservantutt'ora, la gravezza e densità capace di sostenere i corpi più gra-vi , l'oscuro e tetro colore, il fetore grande , per cui i pesci muo-iono, subito che entrano in quel lago, le rive sterili, 1' aria gravee malsana che regna attorno , 1' amarezza dell' acque, la pessimacondizione di que' pochi frutti che possono ancora nascervi, tuttoannunzia e annunzierà fino alla fine del mondo, che Dio è terri-bile ne' suoi giudizii sopra i figliuoli degli uomini : Sodoma eGomorrha, e le città confinanti ree nella stessa maniera d'im-purità ... furono fatte esempio soffrendo la pena del fuocoeterno, Judce 7.
Vers. 26. Essendosi rivolta indietro. Lo Spirito santo nellaSapienza cap. i. 7. chiama la moglie di Lot anima incredula:fosse per affezione verso ciò che ella lasciava, o fosse per accer-tarsi co' proprii occhi dell' avveramento della predizione degliAngeli,, a gran ragion attribuiscesi la sua colpa a mancanza di fe-de. Cosi ella viola il preciso comando fatto a lei non meno che almarito, ed è immediatamente punita, e diviene anch'essa ungrande esempio: esempio della severità , colla quale sarà punitochiunque dopo la chiamata di Dio si arresta tra via, o col cuorerivolgesi e coli' affetto a quelle cose, che egli dee abbandonare

27. Abraham autemconsurgtns mane , ubisteterat (i) prius cumDomino,
28. Intuitus est So-domam et Gomorrlìam,et universam terramre giojiis illius: viditqueascendentem favillartide terra quasi fornacisfumum.
29. Cum <gn?°}i sub-ver fere f Deus civitates
.regionis illius , recar*datus Abrahae, libera-vit Lot de subversioiieurbium, in quibus ha~bitaverat.
So. Ascenditque Lotde Segor , et mansit inmo7ite , duae quoque fi"lìae ejus cum eo ( ti-muerat enim manerem
27. Ma Abramo por-tatosi la mattina là ,dove prima era stalg-col Signore,
28. Volse Jo sguardoverso Sodoma e Go*morrha, e verso la ter-ra tutta di quella re-gione : e vide le favil-le, che si alzavano daterra , quasi il fumo diuna fornace.
29.Imperocché quan-do Dio atterrò le città ,di quella regione, ri-cordossi egli di Àbra-mo , e liberò Lot dallosterminio di quelle cit-tà , nelle quali questiavea dimorato.
3o. E Lot si par ti daSegor, e si stelle sulmonte, e con lui le suedue figliuole (perocchéegli non si teneva si-
(ij Supra 18. i..
per andar dietro al Signore:-Ricordatevi, dice Cristo, della mo-glie di Lot. Lue. xvn. 32.
In una statua dì sale. Di sale metallico , che resiste allapioggia , e per la sua saldezza è buono anche per gli edilizi]". Va-di Plìn. lib. xxxi. cap. 7, Non pare, che possa dubitarsi, che que-sta statua siasi conservata per molti secoli. Fedì Sap. x. 7. Giu-seppe lib. i. Anlin. cap. 12.
Vers. 27. Ma Àbramo portatosi la mattina ec. Àbramo an-sioso di saper epa ei che fosse del suo nipote, e delle città dellaPentapoli, si porta al luogo, dove il d> avanti a.vea parlato col-l 'Angelo, perchè di 1«Y poteva vedere tutta giurila pianura.
Yers. ?8. E >•/,/« le faville. LT.L.reo: e nVfV il finn*.

Segor ) : et mansit inspeluncaipse^ et duaejfilìae ejus cum eo.
3i. Dixìtfjue majorad minorem : Pater no-ster senex est, et nui-lus virorum remansìtin terra, qui possit in-
; gredi ad nos juxta mo-rem universae terrete*
Sileni, inebriemus, eum vino, dormiamus-
que cum. eo , ut serva-re possimus ex patreHQ^jtro semqn.&
33. Sederunt itaquepatri suo bibere vin uninocte illa^ Et ingressa
curo in Segor ): e abi-tò in una caverna egli,e le due figliuole conlui.
31. E la maggiore diesse disse alla minore:Nostro padre è vecchio,e non è rimasto uomoalcuno sopra la terra,che possa esser nostromarito, come si costu-ma in tutta la terra.
32. s Vieni , ubbria-chiamolo col vino , edormiamo con lui, af-finchè serbar possiamodiscendenza di nostropadre.
33. Diedero adunquequella notte del vino abere al padre loro. E la
Vers. 3o. Egli non fi teneva sìctiro in Segar. Anche in questacircostanza Lot dimostra una fede assai debole: l'Angelo gli aveadetto, ch' ei poteva restare in Segor ; la costernazione e l'abbat-timento di spirito, in cui si trovava, gli fanno dimenticare la pro-messa dell'Angelo, ed egli cangia l'abitazione.
Abito in una caverna. Tutte le montagne ali' intorno sonopiene di simili caverne molto spaziose.
Vers. 31. Non e rimasto uomo alcuno sopra la terra. Ellesapevano però, che degli uomini ne erano in Segor, dond' eranopartite; ma forse, veduto come Dio avea sterminato gli abitantidelle altre città, credettero che alla fine avverrebbe lo stttssr»anche di quelli di Segor non meno scellerati; o non volevano as-solutament& aver tali uomini per mariti. Ma benché possano for-se scusarsi dalla menzogna, non possono però scusarsi in vérunmodo da quello che fecero per aver prole, nè Lot può scusarsi;perocché egli ancora peccò ( dice s. Agostino ) non quanto portaìin inceno, ma quanto porta quella ubbriachezza » lib, xxu.t;o«t. Faust. cap. 44-

est major, dormivitquecum patre : at ille nonsensit, nec quando ac-cubuit filia> nec quan-do surrexit.
34- Altera quoquedie dixit major ad mi-nore m : Ecce dormiviheri cum patre meo :demus ei bibere vinumetiam hac nocte; et dor-mies cum eo, ut salve-mus semen de patrenostro.
55. Dederunt etiamet illa nocte patri suobibere vinum', ingres-saque minor filio, dor"mivit cum eo : et netunc quidem sensit,quando concubuerit,velquando illa surrexerit.
36. Conceperunt er-go duae filiae Lot depatre suo.
37. Peperitque ma-jor filium , et vocavitnomen ejus Moab : i-pse estpater Moabita-rum usque in praesen-tem diem.
maggiore si accostò alui, e dormì col padre:ma egli non si accorse,nè quando la figlia sipose a letto, nè quan-do si levò. \
34. E il di seguentela maggiore disse allaminore: Ecco che ieriio dormii col padre mio:diamogli da b?re del vi-no anche stanotte, e tudormirai con lui, affindi serbare discendenzadel padre nostro.
35. Dettero anchequella notte a bere delvino al padre loro ; è gìaccostò a lui la figliuo-la minore, e dormì conlui : e neppure allora siaccorse , nè quandoquella si pose a giace-re, nè quando si levò.
36. Restarono adun-que le due figliuole diLot gravide del loropadre.
37. E la maggiorepartorì un figliuolo, egli pose nome Moab:questi è il padre deiMoabiti, che sussisto-no fino al dì d'oggi.
Vers. 87. Gli pose nome Moab; vale a dire, che nasce dalpadre mio.

38. Minar quoque pe-perii filium, et vocavitnomen ejus Ammon ,idest, filius populi mei:ipse pater Ammonita-rum usque hodie.
38. La minore anco-ra partorì un figliuolo,e gli pose nome Am-rnon , vale a dire fi-gliuolo del popol mio?egli è il padre degliAmmoniti, che sussi-stono fino al dì d'oggi.
e A p o xx.Ad Abramo pellegrino m Gerara è tolta la mo-
glie ; ma è rimandata intatta con gran doniper comando del Signore ; e alle orazioni dA-bramo è rendala la sanità alla famiglia delre*
^\.JLrofectus indeM&raham terram au-3tralem liabitavit interCades et Sur : et pere-grinatus est in Cera-rio* .
2. Dixìtque de Saràuxore sua\ S or or me aèst. Misit ergo Abìme*lechrex Gerarae, et tu-Ut eam.
i.. .IL partitosi dicolà Àbramo, andandonel paese di mezzodì ,abitò Ira Gades e Sur:e fece sua dimora comepellegrino in Gerara»
2. E riguardo a Sarasua moglie disse: Ella èmia sorella. Mandò dun-que il re di Gerara Abi«melech a pigliarla.
Vers. 38. Gli pose nome Ammon; ebe vuol dire figliuolo delmio popolo. S. Girolamo scrive , che quella gran donna s. Paola,andando attorno per la Terra santa, giunta che fu a Segor, si ri-cordò della spelonca eli Lot, e cogli occhi pieni di lacrime avver-tiva le vergini compagne, essere da guardarsi dal vino, nel qualeè lussuria, e di cui sono opera i Moabiti, e gl'i Ammoniti.
Vcrs. i. In Gerard. S. Girolamo ed Eusebio mettono Gerarain distanza di veajtieinque miglia da Eleuteropoli di là da Daroma:
Ver?. 7.. Mando adunque A'bimelech n pigliarla. Il nome dìAhimelech era comune a' re di Gerara , come quello di Faraouo

3. Venit autem Deusad Abimelech per so-mnium nocte,et alt Hii:E n morierìs proptermulierem^ quam tulisti:habet enim vìrum.
4. Abimelech veronon tedierai eam, etait: Domine, num gen-tem i gnor an lem, et ju-stam interficies?
6. Nonne ipse dixitmihi: Soror mea est: etipsa ait : Frater meusest"? in simplicitate cor-dis mei, et munditiamanuum mearum fecihoc.
6. Dìxitque ad eumDeus: Et ego scio, quods impiici corde feceris :et ideo custodivi te, nepeccares in me, et non
5. Ma Dio siie'vede-re di notte tempo insogno ad Abimelech, edissegli : Or tu morraiper ragion della don-na , che hai rapita : pe-rocché ella ha marito.
4» Abimelech perònou P avea toccata, edisse : Signore , faraitu perire una nazioneignorante , ma giusta ?
5. Non mi ha dettoegli stesso : Ella è miasorella : e non ha elladetto : Egli è mio fra-tello? Io ho fatta talcosa nella semplicìt|idel mio cuore, e ho pu-re le mani.
6. E il Signore glidisse : Io pur so , chetal cosa hai fatta concuor semplice : e perquesto ti ho preserva-
a're dell'Egitto : Sarà avea novant'anni ; quindi è, che questo %v-venimerito dà una grande idea di sua bellezza. Vedi cap. xu. 11.
* K riguardo a Sara sua moglie ec. Qui pure come inEgitto die pena ad Abramo la bellezza della consorte ; bellezzaforse prodigiosamente cresciuta, e non senza mistero, dopo esse-re stata resa feconda.
Vers. 3. Ma Dio ti fè1 vedere. Si vede , che questo re conosce-va il vero Dio , e lo temeva , e che il popolo era , qual suoi esse-re per lo più, simile al sovrano.
Vers. 4- * Non V avea toccata. Non le avea fatto oltraggio.Vers. 5. Nella semplicità del mio cuore, ec. Si vede, che l'idea
di Abimelech era d' aver Sarà per moglie, credendola libera.

dimisi, ut tangereseam»
7. Nunc ergo recideviro suo uxorem-, quiapropheta est: et orabitpro te, et vives : si au-tem nolueris reddere,scito , quod morte mo-rieris tu, et omnia, quaetua sunt»
8. Statimque de no-cte consurgens Abime-lech, vocavitomnesser-vjji? suos, et locutus estuniversa verba haec inauribus eorum, timue-runtque omnes virivalde.
9. Vocavit autem A-bimelech etiam Abra-ham , etdixit ei: Quidfecisti nobis ? quid pec-cavimus in te> quia in-duxisti super me, etsuper regnum meumpeccatum grande! quaenon deóuis ti facere, fé-cisti nobis.
lo dal peccare controdi me ; e non ho per-messo , che tu la toc-cassi.
7. Rendi adunqueadesso la moglie al suomarito • perocché egliè profeta: ed egli faràorazione per te , e tuvivrai : ma se tu nonvorrai renderla, sappi,che di mala morte mor-rai tu, e tutto quelloche a te appartiene.
8. E tosto si alzòAbimelech di nottetempo, e chiamò tuttii suoi servi ; e raccon-tò loro tutte questecose , e tutti ebberogran paura.
9. E Abimelech chia-mò anche Abramo , egli disse : Che è quelloche tu ci hai fatto? chemale li abbiam fattonoi, che tu avessi a ti-rare addosso a me, e almio regno un peccatogrande ? tu hai fatto anoi quello che far nondovevi.
Vcrs. 6. * Ti ho preservato dal peccare. Ella è una misericor-dia ben grande, quando il Signore, anco mediante i flagelli, pre-servaci dal peccare.

10. Rursumque ex-postulanS) aiti Quid vi-disti, ut hoc facere^
11. Respondit Abra-ham: Cogitavi mecum,dicens : Forsitan nonest timor Dei in locoisto : et interficient mepropter uxorem meam :
12. Alias autem et(A vere soror mea est>fdia patris mei, et nonfilio, matris meae, etduxi eam in uxorem.
13. Postquam autemeduxit me Deus de do-mo patris meiì dixi adeam: (2) Hanc mise-ricordiam facies me-cum: in omni locot ad(juem Ì7tgrediemur, di-ces, quod frater tuus$im.
io. E ài nuovo ram-maricandosi disse: Cheavevi tu veduto , ondeavessi a fare tal cosa?
1 1. Rispose Àbramo:Io pensai , e dissi den-tro di me : Forse nonsarà in questo luogotimor di Dio ; e mi uc-cideranno a causa dimia moglie :
12. Bali' altra parteella è veramente anco-ra mia sorella ; figliuo-la di mio padre , manon di mia madre , ed"io la presi per moglie.
1 3. Ma dopo che Diomi trasse fuora dallacasa di mio padre, iole dissi : Tu mi faraiquesta grazia ; in qua-lunque luogo noi arri-veremo, dirai, càe seimia sorella*
(i) Supra i a. 1 3, (?.J Infra ai. a 3.
Vers. g. Che e quello che tu ci hai fatto? che male ee. Dioper bocca di questo principe insegna a tutti gli uomini, quantogran male sia l'adulterio, riconosciuto da tutte le genti pel sololume della natura come un orribile peccato. Il solo pensiero diessere stato vicino a cadérvi, benché per ignoranza, fa che Abi-melecb. prorompa in tante e si appassionate querele contro Abra-mo , che gli avea taciuto la verità.
Yers. io. Che avevi tu veduto, onde avesti ec. Avevi tu forseveduto cosa, onde potessi argomentare , che io , o il mio popolofossimo gente senza legge, e senza rispetto per la giustizia ?

14. Tulli igitur A-Mmelech oves, et boves^et servos , et ancillas ,et dedit Abraham: red-diditque illi Saram u-xorem suam,
i5.Etait: Terra co-ram vobis est\ ubicum-que tibi placuerìtj ha-bita.
16. Sarae autem di-xit\ Ecce mille argen-teos dedifratrì tuo\ hocerit tibi in velame n o-culorum ad omnes, quitecum sunt, et quocum-que perrexeris : me-mjjntoque te deprehen-sam.
17. Orante autemAbraham^ anavitDeusAbimelech, et uxores,ancillascfue ejus, et pe-pererunti
14« Prese adunqueAbimelech delle peco-re, e de'bovi, e de'ser-vi, e delle serve, e lediede ad Abramo, e glirendette Sarà sua mo-glie,
15. E gli disse: Que--sta terra è davanti ate; dimora, dove ti pia-cerà.
16. E disse a Sara:Ecco che io ho dato atuo fratello mille mo-nete d! argento ; conqueste avrai un veloper gli occhi dinanzia tutti quelli che soncori te, e in qualunqueluogo anderai: e ricor-dati, che sei stata presa.
17. E colle orazionidi Abramo Dio risanoAbimelech , e la mo-glie, e le serve di lui,e partorirono :
Ver». 16. Mille monete eTargento. Mille sicli.Con queste avrai un velo per gli occhi eo. Il denaro che
io he dato al tuo fratello e marito , al quale ora ti rendo , servirà• comprare un velo, col quale quasi sposa novella velerai il tuocapo j e ciò servirà a farti conoscere non solo a quelli che sonocon te, ma anche in tutti i luoghi dote capiterai, per moglie diÀbramo.
Rico^éfftti che tei stata presa. Non ti scordare del pericolo,in cui ti sei trovata ; non tornare a esporti allo stesso pericolo coldissimulare il vero tuo stato.

18. ConcluseratenimDominus omnem vui-vam domus Abìmelechpropter Saram uxoremAbraham.
18. Imperocché il Si-gnore avea Fendute ste-rili tutte le donne del-la casa di Àbimelech amotivo di Sara moglie<T Abramo.
C A P O XXI.
'Nascita, e circoncisione d* Isacco : egli fu divez-zato. Ismaele è cacciato fuori di casa insiemecolla madre per vivere né deserti. Abìmelechfa alleanza con A bramo confermata con giu-ramento.
i. JLJ il Signore visi-tò Sara, conforme aveapromesso, e adempiè lasua parola.
a. Ed ella concepirepartorì un figliuolo nel-la sua vecchiezza, altempo predettole daDio ;
3. E Abramo pose ilnome d'Isaac al figliuo-lo partoritogli da Sarà:
pr.- .i. r isitavit autemDominus Saram, sicut(i) promiserat, et im"plevit quae locutus est.
a. Concepitane, et(2)peperit filium in sene-e tute sua, tempore quopraedixerat ei Deus /
3. Vocavitcjue Abra-ham nomen filii sui ,quem genuit ei Sara,Isaac i
(1) Supra 17. 19, 1 9. io.(2) G«/44. a3. ìfebr. n. n.
Vers. 19. Il Signoro avea. rendili» iterili eC. Alcuni spieganoche non potesser le donne dare alla luce i loro parti già maturi,lo che sembra più facile ad intendersi, supponendo che non lun-go fu il soggiorno di Sara e di Àbramo presso Abìmelech.

4- Et cìrcumcidìLmimretavo die, sicut (i)*praeceperat ei Deus,
6. Cum centum essetMnnorum : hac quippeaetate patris, natus estIsaac»
6. Dixitque Sara :-Kxsum fecit mihi Deus:quicumque audierit,cor-rideòit mihi.
7. Rursumque alt :J Quis auditurum crede-
re t Abraham, tjuod Sa-ra lactaretfilium, quempeperit ei jam seni ?
8. Crevit igitur puer,et^ablactatus es ti fecit-que Abraham grandeconviwum in die abla-ctationis ejus.
9. Cumque vidissetSara filium Agar AE-gyptiae ludentem cum
4- E Tollavo giorno10 circoncise, conformeDio gli avea comandato,
5. Avendo egli cen-to anni : imperocchédi quesla ela era il pa-dre , quando nacqueIsacco.
6. E disse Sara : Diomi ha dalo , onde ride-re: e chiunque ne udi-rà la novella, rideràmeco.
7. E soggiunse : Chiavrebbe credulo, dove-re Abramo senlirsi di-re, che Sara aJlallereb-be un figliuolo parlo-rilo a lui già vecchio ?
8. Crebbe adunque11 bambino , e fu divez-zalo; e nel giorno, incui fu divezzalo feceAbramo un gran con-vilo.
9. Ma Sara avendovedulo il figliuolo dìAgar Egiziana, che
(ij Supra 17. 20. Matiti, i. a.
Vers. 8. E fu divezzato. Alcuni ( come racconta s. Girolamo )affermavano, che in antico le madri allattassero i figliuoli finoa'cinque anni; il qual sentimento è tenuto dallo stesso s. Girola-mo. Altri credevano, che 1' età, in cui i fanciulli si divezzavano ,fosse Panmo 4«odecimo : lo ché sembra meno credibile. Dal tem-po de'Macea&ei in poi si osserva, che il tempo di allattare era ri-dotto a tre,amrf interi. Vedi 2. Machab. vn. 37. a. Paralip. xxx.16., i. Reg. i. aa., IL n.

Isaac filio" suo , dixitad Abraham :
i o. ( i ) Ejice ancillamhanc, et filium ejus:non enim erit haer e s fi-lius ancillae cum filiomeo Isaac.
11. Dure accepit hocAbraham pro filio suo.
12. Cui dixit Deus;Non tibi videatur aspe-rum super puero, et su-jjvr andila tua \ omniacjuae dixerit tibi Sara ,audi vocem ejus-, quiafòin Isaac vocabitur tibisemen.
scherniva il suo figlioIsacco , disse ad Àbra-mo:
io. Caccia questaschiava, e il suo figlio:perocché non sarà ere-de il figlio della schia-va col figlio mio Isacco.
n. Duro parve adAbramo questo parlareriguardo ad un suo fi-glio.
12. Il Signore perògli disse : Non sembria te aspro il far ciò adun fanciullo , e ad unatua schiava : in tuttoquello che dirà a te Sa-ra, ascolta le sue paro-le : perocché in Isaccosarà la tua discendenza.
(i} Gai 4. 3o. (*) Rom. g. 7. Hebr. li. ij^
Vers. 9. Che scherniva, ec. Cosi quasi tutti gì' Interpreti ; ed èfuori di dubbio, che a prendere il latino nel senso di scherzare,giuocare ec. ci dilungheremmo totalmente dalla sposizione diPaolo, il quale dice che Ismaele perseguitava /.meco, Gai. iv.9.9., e non vedremmo una giusta ragione dello sdegno di Sara,della risoluta domanda, che ella fa ad Abramo , e alla quale Diovuole, che Abramo si arrenda. Vedi quello che si è detto in quelluogo della lettera a'Galati, e il mistero nascosto nella persecu-zione fatta dal figliuolo della schiava al figliuolo della donna li-Lera, S. Agostino crede, che Sara temè, che l'invidia e l'avversio-ne d'Ismaele non l'inducessero a dar morte adlsacco, e a rinno-vare l'orribil tragedia avvenuta tra'due primi figliuoli di Adamoper simili cagioni.
Vers. io. * Caccia questa schiava. Gol non riprendere nè ga-stigare il figliuol petulante, Agar meritavasi questa pena.
Vers. 12. In Isacco sarà la tua discendenza. La tua vera po-sterità verrà da Isacco: egli sarà tuo erede, ed erede delle mie

i 3. Sed et filium an-cillae faciam in gentemmagnani , qui sementuum est.
14- Surrexit itaque'Abraham mane, et tol-lens panem, et utremaquae, imposuit sca-pulae ejus, tradiditquepuerum^et dimisit eam.Quae cum abiisset, er-rabatin solitudine Ber-sabee.
15. Cumque consum-pta esset aqua in utre^abjecit puerum subter
13. Ma il figliuoloancor della schiava fa-rò capo di una nazionegrande, perchè egli ètua stirpe. l
i4- Abramo adunquealzatosi la mattina, pre-se del pane e un otredi acqua , e lo pose alei sulle spalle, e le die-de il fanciullo , e la li-cenziò. E quella par-titasi andò errando perla solitudine di Bersa-bea.
15. Ed essendo ve-nuta meno l'acqua del-l'otre j gettò il fanciul-
p|J£messe, e da lui nascerà il Cristo , del quale egli stesso saràuna viva figura. Tedi Rorn. ix. 7. 8., Gai, iv. a3., dove 1' Apostolonelle du^e donne riconosce due testamenti: la sinagoga, ela Chie-sa cristiana-, in Ismaele i discendenti d'Abramo, ma degeneranti
K dalla sua fede, i quali schernirono, e perseguitarono il Cristo ; inIsacco gli Ebrei, e i Gentili fedeli.
Vers. 14- Prese del pane e un otre di acqua, ec. La provvisionedi pane e di acqua che questa donna poteva portare sulle sue spal-le, non era grande, e di fatt,i veggiamo, che presto l'acqua mancò.Nondimeno Abramo BOB fa altro che eseguire puntualmente i co-mandi di Dio ; e certo costò grandemente al suo buon cuore iltrattare con tanto rigore una donna e un figliuolo che egli amava.E in ciò appunto si manifesta l'altissima obbedienza di Abramo.Dio dall* altra parte volle in questo fatto dimostrare molti'secoliprima quello che un dì avverrebbe alla sinagoga discacciata dallafamiglia di Abramo, ridotta ad andare vagabonda ed errante so-pra la terra, dove miracolosamente sostienla quella Provvidenzach,e la f ì sé| ir$ di evidente prova alla vera Chiesa, e la riserba«Ila futura si» conversione»
Nella solkydine di Bersabea. Questo nome è posto qui peranticipazione. Fedivers. 31.

unam arborinn, quaeibi erant.
16. Et obiit, sedìt-que e regione procul,quantum potest arcusjacere\ àixit enim: NOJIvidebo morientem pue-rumi etseclens contralevavitvocem suam, etflevit.
17. TZxaudivitàutemDeus vocem. pueri : vo-cavitque Angelus DeiAgar de coelo , dice n s :Quid agis , Agar ? No-li timer e : exaudivitenim Deus vocem pue-77 de loco , in quo est.
18. S urge ; tolte pue-rum, et tene manum il-lius , quia in gentemmagnani faciam eum.
19. Aperuitf/ue oai-los ejus Deus: quae id"dens puteum actuae,
lo sotto uno degli al-beri, ebe era n ivi.
16. E se n'andò, e sipose a sedere dirim-petto in distanza di untiro d'arco; imperoc-ché disse: Non vedròmorire il fanciullo: esedendogli in faccia al-zò la sua voce, e pian-se »
17. E il Signore esau-dì la voce del fanciul-lo : e l'Angelo di Diodal cielo chiamò Agar,dicendo : Che fai , oAgàr? Non temere: pe-rocché il Signore haesaudito la vocedelfan-ciullo dal luogo , ov'eisi trova.
18. Alzati; prendi ilfanciullo , e tienlo j^rla mano, conciosslacfièio lo farò capo di urianazione grande.
19. E Dio le apersegli occhi : ed ella videun pozzo di acqua, e
Vers. 15. Getto il fanciullo te. Ovvero abbandono il fanciul-lo : perocché non è da credere, che ella portasse addosso Ismaele,che dovea avere diciassette o diciotto anni. Veramente in alcuneedizioni de'LXX. ciò si legge al versole).; ma altre edizioni sonointeramente simili alla Volgata.
* G e ilo il fanciullo. Coli' animo abbandonandolo, comechè41QB ispirasse di più serbarselo in vita.

abiìt, et implevit utrem,dedite/uè puero bibere.
20» "Et fuit cum eo ,qui crevit, et moratusest in solitudine, fa~ctusque estjuvenis sa-gittarius*
21. Tlabìtavitque indeserto Pharan : et ac-cepit illi mater sua u-xorem de terra AEgy-ptì.
22. Eodem temporedixit Abimelech, etPhicol princeps exerci-tus ejus ad Abraham :Deus tecum est in uni-versis , quae agis.
23. Jura ergo per•4r Deum , ne noceas mi-
hi , et po s feris meis ,sti^piquemeaei sedjux-
andò ad empier l'otre 4e diede da bere al fan-ciullo .
20. E (Dio) fu con.lui, ed egli crebbe, eabitò nella solitudine,e divenne giovane e-sperto a tirar d' arco.
21. E abitò nel de»serto di Pharan : e suamadre gli diede unamoglie Egiziana.
22. Nello stesso tem-po Abimelech, e Phicolcapitano del suo eser-cito disse ad Abramo:Iddio è con te in tuttoquello che tu fai.
26. Giura adunqueper Dio di non far malea me, e a' miei posteri,e alla mia stirpe: ma
Vers. iq. Dio le aperse gli occhi, ed ella vide un pozzo ec<Dio fece, che ella ravvisasse questo pozzo che le era vicino, e acui turbata e piena d'affanno, com'era, non avea posto mente. Dì-cesi, che gli Arabi coprono colla sabbiai pozzi da loro scavati,mettendovi sopra qualche segnale ; così non sarebbe maraviglia,che Agar non avesse veduto quel pozzo, fino che Dio lo fece a leiriconoscere per qualche segno che egli avea.
Vers, 21. Nel deserto di Pharan. Nell'Arabia Petrea.Vers. 22. Abimelech, e Phicol capitano. Gredesì lo stesso Àbi-
melech, di cui si parla cap. xx., e Phicol era capitano delle sue,guardie, ovvero di tutti i suoi soldati. Abimelech veggendo, comeAbranio cresceva in ricchezze e in potenza, e come Dio lo proteg-geva tanto visibilmente, prevedendo che egli sarebbe divenuto«n grandissimo princme, pensa saggiamente a fare alleanza conlui, affine di non aver «S temere per sé, e pel suo popolo,

ta m$.sericordiam^ (i)quam feci tibi, faciesmihi , et terrae , in quaversatus es advena»
2 4. Dixìtque Abra-ham: Ego jurabo.
26. Et increpavitAbimelech propter pii-teum aquae, quem viabstulerant servi ejus.
26. "Resp&nditque A-bimelech : Néscivi quisfecerit hanc rem: sedet tu non indicasti mi-hi , et ego non audivipraeter hodie.
27. Tulìt itaque A-braham oves , et boves*et dedit Abimelech :percusseruntque ambofoedus.
28. Et statuii Abra-ham septem agnasgregis seorsum.
che, siccome io ho fattodel bene a te % cosi ti*ne farai a me, ea que-sta terra, in cui se'sta-to pellegrino.
24. E Abramo disse :Io ne farò giuramento.
26. E fece delle que-rele con Abimelech perragione di un pozzo diacqua, che i servi di luisi erano usurpati perforza.
26. E Abimelech ri-spose : Non ho saputachi abbia fatta tal cosa:ma nè pur tu me nehai fatto motto, ed ionon ne ho sentito par-lare se non adesso.
27. Abramo adunqueprese delle pecore^ ede' bovi, e li diede adAbimelecfa : e ambeduefecero alleanza.
28. E Abramo posesette agnelle di brancoda parte.
fi) Supra 20. 14.
Vers. 2.5. Per ragione di un pozzo dì acqua ec. Un pozzo , osia una cisterna d'acqua è cosa di rilievo in un tal paese, dove co-sta molto il trovarne.
Yers. 27. Prese delle pecore, e dé'bov i, e lì diede ec. Forse perfarne sàcrifìzio, come nelle alleanze sì costumava, lasciando adAbimelech l'onore d'immolare nuegli animali.

29. Cui dixit Abime-lech : Quid sibi volunt
,$%ptem agnae istae,quas stare feristi seor-sum ?
30. At ille : Septem ,inquit, agnas accipiesde manu mea : ut sintmihi in testimonium,quoniam ego fodi pu-teum istum.
31. Idcirco vocatusest locus ille Bersabee;quia ibi uterque jura-vit*
32. Et inierunt foe-dus pro puteo juramen-4,
; 33. Surrexit autemAbimelech , et Phicolpqjgpeps exercitus ejus,revèrsique sunt in ter-ram Palaestinorum .Abraham vero planta-vit nemus in Bersabee^et invocavit ibi nomenDomini Dei aeterni.
29. E dissegli Abi-melech: Che voglionodire queste sette agnel-le , che tu fai stare daparte ?
30. Ed egli disse :Sette agnelle riceveraitu dalla mia mano : af-finchè servano a me ditestimonianza, come ioho scavato quel pozzo.
31. Per questo fuquel luogo chiamatoBersabee ; perchè l'unoe 1' altro ivi fatto aveagiuramento.
32. E avean fatto ac-cordo circa il pozzo delgiuramento.
33. E se n' andaronoAbimelech , e Phicolcapitano del suo eserci-to , e tornarono nellaterra de'Palestiriì. Abra-mo poi piantò una sel-va a Bersabee , e ivi in-vocò il nome del Signo*re Dio eterno.
f'.
(i) Supra 20. 14-
Vers. 3 o. Sette ugnelle riceverai tu ec. Benché quel pozxo ap-partenesse ad Àbramo, perchè egli lo avea scavato j contuttociòper lavare ogni pretesto di litigio egli paga in certo modo il fondo,offerendo ad Abimelech queste agnelle. Vedi cetp. xxvi. 15.
Yers, 31, Fu chiamato Bersabee, cioè pozzo del giuramento,,ovvero pozzo delle sette, cioè delle sette agnelle,
Ver». 33. Piantò una selva ec. Piantò Abramo una selva peraliarvi un altare, ed ivi esercitare gli atti del culto divino, come

34. Et fuit colonusterras Palaestinorumdiebus multis.
34- E abitò pellegri-no nella terra de* Pale-stini per molto tenipo.
C A P O XXII.
È provata la fede , e P obbedienza di Àbramocol comando d' immolare il figliuolo ; ma unAngelo lo ritiene dalF immolarlo. Sono a luiper questa insigne obbedienza confermate dinuovo Le promesse : si noverano i figliuoli diNacor fratello di A bramo.
1. \^/uae postquamgesta sunt,,'(i) tentavitDeus Abraham , et di-xit ad eum : Abraham,Abraham. At ille re-spondit : Ad sum.
2. Alt illi : Tolle fi-lium tuum unigenitum,quem diligis , Isaac ,et vade in terram visio-nis ; atque ibi offeres
1. .LJopo avvenutequeste cose, Dio tentòAbramo, e gli disse :Abramo, Abramo, Edegli rispose : Eccomi.
2. E quegli disse !Prendi il tuo ijgiiuoJounigenito , il dilettoIsacco , e va nella terradi visione: e ivi lo offe-
(i) Judith 8. 22. Hébr. li. 17.
apparisce da quello che segue. In que'tempi non eravi ancora edi-lìzio alcuno consacrato agli esercizii di religione, e gli altari si-ergevano su' luoghi più elevati, o ne' boschi.
Vers. i. Dìo lento Abramo. Dio avea già più volte messa a dureprove la fede di Abramo ; ma il cimento, a cui vuole esperia ades-so è si grande, e nuovo, e unico, attese tutte le sue circostanze,che veramente fa d' uopo di credere, che non solamente a farconoscere la virtù di qaesto gran patriarca, ma a qualche altrofine ancora più grande fosse ordinato da Dio questo gran fatto. Ein vero il sacrifizio che Dio gli domanda , è figura di un sacrifiziomolto più grande e augusto, e dì maggiore importanza.

eum in holocaustum su-per unum montium,.quem monstravero ubi.
3. Igitur Abrahamde nocte consurgens ,stravit asinum suum ,ducens secum duos ju-venès , et Isaac filiumsuum : cumque conci"disset Ugna in holocau-stum , obiit ad locum ,(juem praeceperat eiDeus.
4» Die autem tertia,elevatis oculis% vidit lo-cum procul i
rirai in olocausto soprauno de' monti, il qualeio t'indicherò.
3. Abramo adunquealzatosi, che era ancornotte , imbastò il suoasino, e prese seco duegiovani, e Isacco suo fi-gliuolo : e avendo ta-gliate le legna per P o-locausto, s'incamminòverso il luogo assegna-togli da Dio.
4- E il terzo giorno,alzati gli occhi, videda lungi il luogo :
Vera. a. Prendi il tuo figliuolo unigenito ec. 1? Ebreo è più\g*ffiettuoso: Prendi il tuo figliuolo, il tuo figliuolo unigenito, il
diletto, prendi Isacco. Queste parole dimostrano (quanto a pa-role può dimostrarsi) la grandezza del sacrifizio. Abramo dee of-ferire in olocausto il figlinolo unigenito , sopra di cui tutte po-savano le sue speranze e le promesse di Dio: il figliuolo amatoper le sue virtù , e per quello , di cui.egli era figura, cioè pelMessia, che di lui dovea nascere : un figliuolo che era stato laconsolazione di sua vecchie/za e del suo esilio dalla terra e dallacasa del padre , e di tutte le afflizioni ed affanni del suo lungopellegrinaggio. Dall'altro lato ( dice s. Agostino ) poteva egli cre-dere Abramo che Dio potesse gradire vittime umane ? Ma allor-ché Dio comanda, obbedisce il giusto e non disputa.
Nella terra di visione : e ivi lo offerirai ec. Il luogo T doveDio vuole che Abramo offerisca questo sacrifizio, è lontano daBersabee, o sia da Gerara, circa cinquanta miglia ; lo che ac-crebbe a dismisura il patimento di lui, e segnalò la sua incre-<Kbil costanza. Dio adunque gli ordina di mettersi in istrada edi andare verso una certa parte , fino a quel luogo che gli saràposcia indicato: e questo luogo fu il monte che fu poi detto Mo-ria, o sia di vis Urne i dove fu poi edificato il famoso tempio, 2,Paralip. m. i. ,
Vers. 3. Alzatosi, che era ancor notte ec. Non si parla diSarà, nè si dice, se Abramo le facesse parte del coniando di Dio»Ma s. Agostino, e altri Padri credono che il marito, conoscendo

5. Dixitque ad pue-ros suos i Exspectatehic cum asino : ego , etpuer illuc usque prope"rantes, postquam ado-raverimus , revertemurad vos.
6. Tulit quoque ti-gna holocausti, et im-posuit super Isaac fi-lium suum : ipse veroportabat in manibusignem, et. gladium.Cumque duo pergerentsimul,
7. Dixif Isaac patrìsuo : P a ter mi. At illerespondit : Quid vis ,fili? Ecce, inquit, ignis,
6. E disse a'suoi gio-vani : Aspettate quicoli' asino : io, e il fan-ciullo anderemo fin colàcon prestezza , e fattache avremo 1' adorazio-ne , torneremo da voi.
6. Prese eziandio lelegna per 1' olocausto ,e le pose addosso adIsacco suo figl iuolo tegli poi portava collesue mani il fuoco, e ilcoltello. E mentre eam*minavano tutti e dueinsieme,
7. Disse Isacco a suopadre: Padre mio. Equegli rispose : Che 'vuoi, figliuolo ? Ecco ;
la sua virtù, non le nascose quello che egli dovea fare, e fife» el-la si rassegnò al volere del Signore .
Vers. 4- ^ terzo giorno ... vide da lungi il luogo. Per tregiorni interi (dice un antico interprete ) Abramo ebbe a combat-tere colla tentazione, anzi coli'agonie e colla morte.
Vers. 5. E fatta che avremo V adorazione , tornerem ec.Abramo potè ciò promettere sulla ferma fiducia nelle divinepromesse. I sentimenti di lui sono spiegati così dal!' Apostolo:àbramo offeriva l'unigenito ... egli, a cui era stato de ito : inIsacco sarà la tua discendenza, pensando, che potente è Dioanche per risuscitare uno da morte. Hebr. xi. 17. 18. 19. VediAugust. de civ. xvi. 3a., Orig. etc. Abramo adunque unisce allasua ubbidienza un'altissima fede e una speranza invincibile.
"•• Vers. 6. Prese eziandio le legna ,.. e le pose addosso ec. A!vedere^ Isacco carico delle legna , sulle quali dee essere sacrifi-cato , non si può non riconoscere queli' altro Isacco, il quale cailegno della sua croce salirà un di al Calvario ad essere effetti-vamente immolato pe' peccati degli uomini, che egli ha presisopra di sé. '

et Ugna: ubi est vidi-ma holocausti?
8. Dijcit autem Abra-ham : Deus providebitsibi victimam holocau-sti , fili mi. Pergebantergo pariter i
9. Et veneruntad lo-cum , quem ostenderatei Deus , in quo aedifi-cavìt altare^ et desuperUgna composuit : cum-que alligasset Isaac fi-lium suum, posuit eumin altare super struemlignorum.
? io. (i) "Extenditfjuemanum., et arripuit gla-dium, ut immolar et fi-lium suum.
vi . Et ecce AngelusDomini de coelo ela-mavitt dicens : Abra-
disse quegli, il fuoco je le legna: dov'è la vit-tima dell'olocausto?
8. E Abramo disse :Iddio si provvederà lavittima per l'olocausto,figliuol mio. Andavanoadunque innanzi diconserva :
9. E giunsero al luo-go mostrato a lui daDio, in cui egli edificòun altare, e sopra vi ac-comodò le legna: e a-vendo legato Isaceo suofiglio, lo collocò sull'al-tare sopra il mucchiodelle legna.
10. E stese la mano,e die di piglio al coltel-lo per immolare il suofigliuolo.
11. Quand'ecco l'An-gelo del Signore dal cielgridò, dicendo: Abra»
(i) Jac. a. ai.
Vers. 7. Dov* e la vìttima ? Quanto acerba piaga dovette* farenel cuor di un padre queste parole !
Vera, 9. E avendo legato Isacco ec. Isacco allora non aveameno df venticinque anni, e gli Ebrei gliene danno fino a tren-ta e anche treutasette. Se egli adunque fu legato dal padre, lofu di suo pieno consentimento : perocché , udito dal padre il co-mando di Dio, si soggettò volentieri alla morte; onde merito diessere un vivo anticipato ritratto dell' altissima obbedienza, col-la quale Gesù Cristo porse le mani e i piedi per essere confitta«opra la croce.

ham , Abraham . Q«irespondit'. Ad sum.
12. Dixitque ei: Nonéxtendas manum tuamsuper puerum, nequefacies illi (juidcjuam :nunc cognovi , quod ti'mes Deum, et 7ion*pe-peresti unigenito filiotuo propter me.
13. "Levavit Abra-ham oculos suos, vi-di tq uè post tergum a-rietem inter vepresìiae-rentem cornibus, quemassumens obtulit ho-locaustum pro filio.
mo, Abramo. E queglirispose: Eccomi.
12. E quegli a lui dis-se: Non stendere la tuamano sopra il fanciul-lo, e non fare a lui ma-le alcuno : adesso ho co-nosciuto , che tu temiDio, e non hai perdona-to ai figliuol tuo unige-nito per me.
13. Alzò gli occhi A-bramo , e vide dietro asé un ariete preso perle corna tra' pruni, ese lo tolse, e in olocau-sto lo offerse in vece delfiglio.
Vers. 12. Adesso ho conosciuto che tu temi Dìo ec. Adessocon questo gran fatto è dato a conoscere a tutti, come tu temiDio, e come lo ami fino a preferirlo al tuo unico figliuolo: ovve-ro, adesso ho di te una vera e certa prova che tu temi Dio, «p.
Non hai perdonato al figliuolo tuo unigenito per ine.Queste parole da un altro lato spiegano fortemente l'amore delPadre, il quale diede il proprio Figliuolo alla morte per 1' uompeccatore : onde ognuno di noi può dirgli : non hai perdonatoal figliuolo tuo unigenito per me: come del Figliuolo può direcon le parole di Paolo : egli mi amo, e per me diede se stesso.
* Non hai perdonato al tuo figliuolo. Non hai sotti-atto:Non hai negato a me il tuo figliuolo unigenito. Così l'Ebr.
Vers. 13. Vide un ariete preso per le corna tra? pruni. Laprovvidenza somministra ad Abramo la vittima pel sacrifizioin vece di Isacco ; ma questa nuova vittima è una nuova figuradi Cristo coronato di spine e offerto sulla croce. Cosi noi ci av-vezziamo a riconoscere in tutte le vittime e in tutti i sacrifiziiavanti e dopo la legge, a riconoscer, dico, queli* unica vittima equell'unico sacrifizio, da cui tutti i pfecedenti sacrifizii trasserojl loro merito, quando furono a Dio accetti; quell'unica vitti-ma, e quell'unico sacrifizio, il quale servV-a santificazione di lut-ti gli eletti di tutti i secoli precedenti, come di tutti i futuri.

14 • Appellavitque no-men loci illius, Domi-nus videi (i). Undeusque hodie dicitur :In monte Dominus vi"debit.
15. Tocavit autemAngelus Domini Abra-ham secundo de coelo,dicens :
16. (2) Per memet-ipsum juravi , dicitDominus : quia feristihanc rem, et non pe-percisti filio tuo uni-genito propter me:
17. Benedicam tibiìet multiplicabo sementuumì sicut stellas eoe-lì., et velut arenam,quae est in litore ma"ris: possidebit sementuum portas inimico-rum suorum:
14. E pose nome aquel luogo, il Signorevede. D'onde fino a que-st'oggi si dice: Sul mon-te il Signore provve-derà.
15. E l'Angelo delSignore per la secondavolta chiamò Abramodal cielo, dicendo :
16. Per me medesi-mo io ho giurato, diceil Signore : perchè haifatta un a tal cosa, e nonhai perdonato al figliotuo unigenito per me :
1*7. Io ti benedirò , emoltiplicheró la tuastirpe , come le stelledel cielo , e come l'are-na , che è sul lido delmare : il tuo seme s'im-padronirà delle portede' suoi nemici:
(1) P sal. io4« Q.(2) Eccl 44. 21. i. Mach. a. 5a. izic. i .yB. He&.6. i3. 57.
*;Preso ver le corna tra?pruni. Un' antica versione porta:preso per le corna né lacciuoli, farse credendo , ebe fosse unariete salvatico, come attesta Senofonte , che se ne trovavanonell'oriente. •. n* • j-
Vers. 14. Sul monte il Signore provvederà. Maniera di pro-verbio presso gli Ebrei, come per dire , che , quand anche unosi trovasse m istrettezzf simili a quelle di Abramo sul Moria ,Iddio sa, e può provvedervi. .,
Vers. 16. Per ,ne medesimo ho io giuralo ec. Sopra questogiuramento del Signore vedi le riflessioni di Paolo , ttebr. iv. ele note allo stesso luogo.

18. Et (i) BENE-DICENTUR in semi-ne tuo omnes gentesterrete , quia obedistivoci meae.
19. Reversus estAbraham ad puerossuoSy abìeruntque Ber-sabee simul, et habi"tavit ibi.
20. His ita gestiStnuntiatum est Abra-hae, quod Melcha quo-que genuìsset filìos Na-chor fratri suo,
21. Hus primogeni-tum, et Buz fratremejus, et Camuel patremSyrorum.
18. E nel seme tuo sa-ran BENEDETTE tul-le le nazioni della ter-ra, perchè hai obbeditoalla mia voce.
19. Tornò Abramoda'suoi servi, e se neandarono insieme a Ber-sabee, e ivi egli abitò.
20. Dopo che questecose furono avvenutecosì, fu recata ad Àbra-mo la novella, che Mel-cha avea ancor ella par-toriti de'figliuoli a Na-chor fratello di lui,
21. Hus primogeni-to , e Buz suo fratello,e Gamuel padre de'Siri.
(i) Supra 12. 3.18. 18. Infr. a6.4. Eccl. 44. a5. ct. 3.a5.
Vers. 17. e 18. Il tuo seme s'impadronirà ec. Il senso di que-sta promessa è troppo limitato, ove s'intenda della conquistadelle sole città di Chanaan ; ella ha questa promessa il suo veroe pieno effetto nelle vittorie di Cristo e della Chiesa sopra tuttele nazioni del mondo nemiche del Vangelo , e nella obbedienzarenduta allo stesso Vangelo da re e da principi della terra, iquali si glorieranno di aver parte alla benedizione meritata agli«omini da quel seme di Àbramo, in cui fu promessa con giura-mento da Dio la salute a tutte le genti.
Vers. 20. Che Melcha uvea anch'elio, partoriti a Nachor ec.Nachor, come si è veduto, era fratello di Abramo. Mosè riferisceadesso la genealogia di Nachor per riguardo a Rebecca, la qualeesser dovea moglie d'Isacco.
Vers. 21. Hiis primogenito. L' Ausile tjell' Arabia deserta eb-be nome da lui, onde è chiamata nel libro di Giobbe la terradi Hus.

22. Et Cased , etAzau, Pheldas quoque,et Jedlaph,
23» Ac Bathuel) dequo nata est Rebecca :ceto ìstos genuit Mei-<cha Nacìior fratri A-órahae,
24. Concubina veroillius , nomine Roma,peperit Tabee et Ga-éam, et Tahas, et Ma-ncha.
22. E fa sed, e Azau,e anche Pheldas, e Jed-laph ,
23. EBalhuel, da cuinacque Rebecca : que-sli otto figliuoli partoriMelcha a Nachor fratel-lo d* Abramo.
24. E una sua con-cubina , chiamata Ro-ma, partorì Tabee , eGaham, e Tahas, eMaa-cha.
jfiuz suo fratello : Elihu Busite amico dì Giobbe era forse«no de' discendenti di questo Buz , ovvero era nato nel paese, acui questi avea dato il nome. Eravi una città di Busan nellaMesopotamia.
Camusi padre de1 Siri. Cioè de' Camileti popoli della Si-ria, a ponente dell'Eufrate.
Vers. 22,. Azau. Aza e Azura città della Cappadocia possonoderivare da Azau.
Vers. 24. Tabee. Trovasi Tabea città nella Perca.Maacha. Nell'Arabia felice sono i Maceli, e una città detta
Macha verso lo stretto di Ofmus.RoTha. I LX.K. la chiamano Reman, e una città di tal nome
si trova «efla Mesopotamia.

C A P O XXIII.
Sì fa illfutto della morte di Sora, la quale è se-polta nella doppia spelonca, che A bramo
' compra a danaro contante da Ephron insiemecol campo.
1. rixit autem Sa-ra centum viginti se-ptem annis.
2. Et mortuo, est incivitate Arb&e , quaeest Hebron , in terraCJianaan : venitque A-braham, ut piangerei,et fieret eam.
1. JL; visse Sarà cen-to ventisette anni.
2. E morì nella cittàdi Arbee, che è Hebronnella terra eli Chanaan:e andò Abramo a ren-derle gli ultimi uffizii, ea piangerla.
Vers. i. Visse Sarà cento ventisette anni. Osservano gl'inter-preti , che di questa sola donna ha voluto Dio che fossero regi-strati gli anni nella Scrittura. Questo onore è renduto alla virtù,di lei e alla nobil figura che ella dovea fare nella economia del-la religione. Imperocché ella è madre de'fedeli, come accenna s.Pietro , ep. i. cap, m. 6.; ed è un' idea della Chiesa di Cristo,feconda com' ella, in virtù della promessa, conforme spiega mi-rabilmente 1' Apostolo, Gai. iv. 22. ec. Ma ecco in qual mododella fede di questa gran donna parli Io-stesso póstolo, Heb. xr.11. Per la fede ancora la stessa Stira ottenne virtù di conce-pire anche a dispetto delV età, perche*credette fedele coluiche le avea fatta la promessa. Per la qual cosa eziandio daun solo (e questo già morto ) nace/ue una moltitudine, comele stelle .del cielo e come V arena innumerabile , che e sulla,spiaggia del mare..
Yers. 2. Nella citta di Arbee, ec. Cosi credesi chiamata Ar-bee da un Cananeo, che ne ebbe il dominio, Jud. xiv. 15. Quan-to al nome di Hebron , che ella ancora portò , non ne sappiamol'origine: quelli che dicono, che ella lo ebbe da un figliuolo diCaleb chiamato Hebron , e che per conseguenza queste parolesono state aggiunte al testo di Mosè , sembrano poco cauti, e vo-gliono provare una cosa dubbia con altra non solo dubbia, maanche pericolosa a sostenersi.

3. Cumque surrexis-set ab officio funeris,locutus est ad filio sHeth dicens :
4. Advena sum, etperegrìnus apud vos\date mihi jus sepulckrivobiscum, ut sepeliammortuum meum.
6. Responderunt fi"Hi Heth, dicentesi
6. Audi nos , domi-ne: Princeps Dei esapud nos : in electissepulchris nostris se-peli mortuum tuum :nullusquG te prohibe-re poterit, quin in mo-numento ejus sepeliasmortuum tuum.
3. E spedito che fudalle cerimonie del fu-nerale, parlò co'figliuo-li di Heth dicendo : **
4- Io son forestiero,e pellegrino presso divoi: datemi tra voi ildiritto di sepoltura, af-finchè io possa seppelli-re il mio morto.
6. Risposero i figliuo-li di Heth, e dissero :
6. Signore, ascoltaci :Tu sei presso di noi unprincipe di Dio: seppel-lisci il tuo morto inquella, che più a tepiacerà, delle nostre se-polture: e nissuno sarà,che possa vietarti diseppellire il tuo mortonel suo monumento.
E ando Àbramo ec. Alcuni da questa parola ando ne in-feriscono, che Abramo era altrove, quando Sara morì in Hebron ;ma la congettura è molto mal appoggiata, mentre quella parolapuò esporsi in tal guisa: Abramo andò, ovvero, entro nel padi-g lione di Sara , ec.
Yers. 4. * II mio morto. L'EbjL aggiunge : sicché noi veggiaio più.
Yers. 6. Tu sei presso di noi un prìncipe di Dìo , ec. Tuttoquesto trattato si faceva alla porta di Hebron, Tannandosi inque'tempi il popolo alle porte delle città, come Moggi nellepiazze. Principe di Dio vale principe grande, esimio. Yedesi ilconcetto grande, in cui era Abramo presso tutti per le sue virtùassai più che per le sue ricchezze ; perocché le ricchezze disgiun-te dalla virtù partoriscono piuttosto invidia e malevoglienza.
Seppellisci il tuo morjfr in quella che più a te piace-rà , ec,JÉi ,àpn compresero, che Abramo non voleva aver comu-nanza dì sellerò con essi, perchè erano idolatri.

fj. Surrexit Abra-ham , et adoravit popu*lum terrae, filio s vide"ÈcetHeth:
8. Dixitque ad eos:Si placet animae ve-strae, utsepeliam mor-tuum m&um, audite me,et intercedile pro meapud Ephron filiumSeon
^9. Ut det mìju, spe-luncam duplicemt quamliabet in extrema parteagri sui; pecunia di-gna tradat eam mihicoram vobis in posses-sionem sepulchrL
10. Jìabitabat autemEpkron in medio filio-rum Heth. Respondit-que Ephron ad Abra-ham , cunctis audienti-bus , qui ingredìeban-tur portam civitatis il-lius , dicens :
11. Nequaquam ititifiat, domine mi: sed tumagis ausculta, quod
7- Si alzò Abramo, es'inchinò al popolo del-la terra , vale a dire aifigliuoli d' Heth :
8. E disse loro: Sepiace a voi, che io sep-pellisca il mio morto,ascoltatemi, e interce-dete per me presso E-phron figliuolo di Seor:
o,. Affinchè egli miconceda la doppia ca-verna , che egli ha alfondo del suo campo : aprezzo giusto me la diaalla vostra presenza ,affinchè io sia padronedi farne una sepoltura.
10. OrEphron si sta-va in mezzo a' figliuolidi Heth. E rispose E-phron ad Abramo, asentila di tutti quelliche entravano nella por-ta della città, dicendo :
11. Non sia così, si-gnor mio : ma fa tupiuttosto a modo mio
Vers. g. La doppia, caverna ec. Alcuni intendono, che avessedue camere, una per seppellirvi gli uomini, l'altra per le donne.
Vers. io. Ephron ti stara in mezzo ec. Questo è il sensodella volgata. Ephron, la caverna del quale volea comprareAbramo, si trovava presente traila'gente che era alla porta, do-ve Abramo parlava. Or egli alzò la voce, e fece sua risposta. Fe-di gli Atti MI. \Q.

locjuor : Agrum tradotibì, etspeluncam, quaein eo est., praesentibusfiliis populi mei: sepelimortaum tuum.
#•12. Adoravit Abra-
ham coram populo ter-rae\
13. Etlocutus est adEphron, circumstanteplebe : Quaeso, ut j^u-dias me : dabo pecu-niam pro agro : susci-pe eam, et sic sepe-liam mortum meumin eo. H
14. Responditque E-phron :
15. Domine mi, audimei Terra , quampo*stulasfluadringentis si-clis argenti valet-. istudest predum inter me,et te : sed quantum esthoc ? sepeli mortuumtuum.
\6. Quod cum au-disset Abraham, ap-pendit pecuniam.c/uamEphron postulaverat ,audiehtibus filiis Hethìquaéringentos ^c^^argeijli jjrobatae mon&tae ^bvjcae.
in quel ch' io ti dico :Io ti fo padrone delcampo, e della caverna,che ivi è, alla presenzade' figliuoli del popolmio : seppellisci il tuomorto. ^
12. S'inchinò Àbra-mo dinanzi al popolodella terra:
13. E parlò ad E-phron^,, stando tutt'aJFin tornò la moltitudine :Di grazia ascoltami : iodarò il denaro per il ^campo : prendilo, e co- _"ljsì vi seppellirò il miomorto.
14 Ed Ephron rispo-se:
15. Signor mio, a-scoltami : II terreno,che tu domandi, valequattrocento sicli d'ar-gento : questo è il prez-zo tra me e te : ma chegran cosa è ella questa ?
ijlppellisci il tuo morto.16, Udito ciò, Abra-
mo pesò il deparo do-mandato da Ephron al-la presenza de' figliuolidi Heth , quattrocentosicli d'argento di buo-na moneta mercantile.

17. Confrmatusqueest ager quondam Ep-hronis, in quo erat spe-lónca duplex , res pi-ciens Mambre, tam i-pse quam spelunca, etomnes arbores ejus incunctis ^erminis ejusper circuitum,
18. Abrahae in pos-sessionem, videntibusfiliis fletti, et cunctis,qui intrabant jtortamcivitatis illius.
19. Atque ita sepeli'vit Abraham S oramuxorem suam in spe-lunca agri duplici^ quaerespiciebat Mambre :
17. E il campo unavolta di Ephron , rie!quale era una doppiacaverna, che guardavaverso Mambre, tantoesso , come la caverna ,e ^ulte le piante , cheerano ali' intorno den-tro de'suoi confini,
18. Fu ceduto in piendominio ad Àbramo al-la presenza de' figliuolidiJHeth, e di tutti quel-lilche entravano nellaporta di quella città.
19. E così Àbramoseppellì Sara sua mo-glie in quel campo nel-la doppia caverna , cheguardava verso Mam-
Vers. 16. Peso il denaro. L'Ebreo pesùy[argento : non eravi;ancora la moneta battuta e coniata.
Di buona moneta: L'Ebreo : d'argento che corre tra?mer-catanti. I quattrocento sicli verrebbero a fare poco piìi di cin-quantatrè zecchini e mezzo , contando il siclo d' argento a solditrentadue e sei denari di Francia , col Calmet, dissert. sopra lemonete ec.
Yers. 17. e 18. Fu cedut&Jn pien dominio. Non si parla discrittura, perchè non era anitra in uso ne' contratti.
Abramo, a cui Dio avea promesso il dominio di tutta la ter-ra di Chanaau, e il quale per la ferma fede in questa promessa,fa 1' acquato della caverna di Ephron per farvi una sepolturaper Sara e per sé stesso , non ebbe da Dio in quel paese nem-meno un piede di terra, come notò s. Stefano negli Atti cap.vu.5.Abramo vi compra un campo per avervi ragione di fepoltura ;e cosi si confessa ospite e pellegrino sopra la terra, e dimostra,che ad una terra e ad una patriajpigliore egli-anela", come dice1' Apostolo, cioè alla celeste dTcui era figura la terra di Glta-naan. VeAl IJebr. x. 13. iti. V f-

( i) haec est Hebron interra Clianaan.
20. El confirmatusest ager, et antrum,quod erat in eo , Abra-hae in possessionemmonumenti a filiis Heth.
bre, la quale è Hebronnella terra di Chanaan.
20. E i figliuoli diHeth confermarono adAbramo il dominio deicampo, e della caverna,che era in esso per ser-virsene di monumento.
C A P O XXIV.*
II serpo di A bramo dopo aver prestato giura-mento è mandalo nella Mesopotamia a cerca-re una moglie ad Isacco : chiede dal Signoreun segnale , e trova Rebecca , e col consensode* genitori e del fratello, e di lei la conducead Isacco , ed egli la prende per sua moglie,e si consola della perdita della madre»
1. J-TJla Abramo eravecchio, e d' età avan-zala : e il Signore lo a-vea benedetto in tuttele cose.
2, E disse al più an-tico servo di casa sua ,Cihe avea il governo ditutto il suo: Metti latua mano sotto la miacoscia : i
i • Jiltmt autem A*braìiam senex \dierum-que multorumi et Do*-minus in cunctis bene-dixerat ei.
2. Dixitque ad ser-vum seniorem domussuae, qui praeerat o-mnibus, quae habebat:(a) Pone manum tuamsubterfemur meum:
(i) Infr. 35. »;. (a) Infr. fa ag.
Vers, i. Era. vecchio ce. Av§a cento quarant'anni, e Isacco nevea quaranta.
Ver s. a. stl'piìi antico servo: Eliezer.*' Vedi cap. xv. a.

3. Ut adjurem te perDominum Deum coeliet terrete, ut non acci-fiias uxorem filio meode filiabus Chananaeo-rum, inter t/uos habito,
4. Sed ad terramìet cognationem meamproficiscaris , et indeaccipias uxorem filiomeo Isaac.
5. Respondit servusiSi noluerit mulier ve»nire mecum in terramhanc, nunquid reduce-re debeo filium tuumad locum, de quo tuegressus es ?
3. Perchè io vo', chétu giuri pel Signore Diodel cielo e della terra,che tu non darai inmoglie al mio figliuolonissuna delle figlie deiChananei, tra' quali ioabito.
4» Ma anderai nellaterra de' miei parenti,e dì là menerai una mo-glie al figliuolo mio I-sacco.
5. Rispose il servo :Se la donna non vor-rà venir meco in que-sto paese, debbo io for-se ricondurre il tuo fi-gliuolo al luogo, dondevenisti tu ?
Metti la tua mano sotto la inia coscia. Questo rito in si-mile occasione si osserva da Giacobbe, cap. XLVH. 29., e il nonvederlo mai più adoperato in tutta la Scrittura porse ragionevo-le polivo a'Padri di considerare l'azione di questi due patriar-chi come misteriosa e di altissimo significato. Con essa adunqueveniva ad annunziarsi il Cristo , il quale dalla carne de' medesi-mi patriarchi dovea nascere e pel quale facevasi giuramento,usandosi tal ceremonia : ed»*? qui, dice s. Gregorio, come seAbramo dicesse al servo: Tocca il mio figliuolo, e giura pelmio Dìo. Vedi s. Girolamo, s. Agostino, s. Ambrogio, s. Prospero,s. Bernardo , Isidoro, ec.
Vers. 3. e 4- Non darai in moglie al mio figliuolo ec. I Cha-nanei erano un popolo maledetto da Dio, e di perversi costumi,La famiglia di Nachor, benché non fosse netta dall'idolatria, ri-teneva però la cognizione e il culto del vero Dio , e buoni co-stumi, come si vede da tutto il racconto di questo capo.
Vers. 5. Se la donna non vorrà venir meco, , ec. Interroga-zione saggia di un servo che conosce tutta P importanza di ungiuramento , e teme di non fallire.

6. Dixitque Abra-ham: Cave, nec/uandoreducas filium meumilluc.
^.DomijiusDeus coe-lì, c/ui tulit me de do-mo patris mei, et deterra nativitatis meae,cjuilocutus est mihi, etjuravit mihi dicens: (i)Semini tuo 'dabo ter-ram hanc : ipse mittetAnteluni suum coramte, et accipies inde uxo-rem filio meo:
8. Sin autem muliernoluerit segui t$ , nonteneberis juramento: fi-lium metom tantum néreducas illuc, .
' ." ' % '9. Posmt ergo ser-vus manum, sub femo-re Abraham domini<s?«j, et }uravì$iillì supersermone hoc.
10. Tulitcfue decemcamelos de grege do-
6. E Abramo disse :Guardati dal ricondurregiammai colà il mio fi-gliuolo.
7. Il Signore Dio delcielo , il quale mi tras-se dalla casa del padremio , e dalla terra , oveio nacqui, il quale miparlò , e mi giurò, di-
"cendo: Al seme tuo da-rò questa terra : eglimanderà il suo Angeloinnanzi a te, e tu me-nerai di là una moglieal figlio mio.
8. Se poi non volesseseguirti la donna, saraisciolto dal giuramento -purché tu-non ricon:duca il mio figliuolocolà.
9. Pose adunque ilservo la mano sotld, la ,coscia <i'.Aubramo tuopadrone , e giurò a luidi fare quello che erastato 4f tto.
io,E prese dieci cam-melli dalle mandre del
(i) Supra 12. 7. 13. et 15. iSrln/r. 26. 3.
Vers,§,*(riutfilati dal ricondurre giammai colali mio fi-gliuolo. Obbedisce posi Abramo al comando fattogli dal Signoredi lasciare egli e la sua discendenza i\ paese della sua prirriaorigine-.

C A P O XXIV. 235
mini sui, et abiit, exomnibus bonis ejus por-tans secum, profectus-que perrexil in Meso*potamiam ad urbemNachor.
11. Cumque carne"los fecìsset accumbereextra oppidum juxtaputeum afjuae vespere^tempore, cjuo solentmu-lieres egredi ad hau-riendam ac/uam^ dixit:
12. Domine Deus do-mini mei Abraham, oc-
' curreì obsecro, mihi ho-die, et fac misericor-dia™, cum domino meoAbraham.
13. Ecce ego sto pro-pe fontem aquae, et fi-liae habitatorum hujuscivitatis egredienturad
; hauriendam aquam.
i4- Igitur puella, cuiego dixero'. Inclina hy-driam tuam^ uKbibam :
suo padrone, e si parti,portando seco di tuttii beni di lui, e s'inviòa dirittura nella Meso-potamia alla città diNachor.
11. E fatti posare icammelli fuori della cit-tà vicino ad un pozzod'acqua la sera , neltempo in cui soglion ledonne uscire ad attin-ger acqua , disse :
12. Signore Dio delmio signore Abramo,dammi, ti prego , que-st' oggi felice incontro,e sii propizio al mio pa-drone Abramo.
i3.J2cjco tìjLe io stovicinò ^questa fontana4i acqua, e le figlie de-gli abitanti di questacittà usciranno ad at-tinger 1' acqua»
i4> La fanciulla a-dunque a cui io dirò:Porgi la tua idria, af-
Vejrs. i o. Portando seco dì tutti i beni ec. Questi erano perla dote della sposa , secondo 1' uso di que' tempi e di que' paesi,dove lo sposo dava la dote?
Vers. ii. E fatti posare i cammelli. L'Ebreo, e fatto pìisga-re iil ginocchio (a terra) at cammelli: cosi riposano questebestie .
La sera, nel tempo, in cui ec. Era incumbenza delle fan-ciulle 1' andare ad una data ora ad attingere 1' acqua. Fedi.Exod. u. 16.

et illa responderit: El-be, quin et camelis\tuisdabo potum : ipsa est,quam praeparasd ser-vo tuo Isaac : et perhoc \intelligam, quodfeceris misericordiamcum domino meo»
15. Necdùm intrase verba compleverat^et ecce Reèecca egre-dìebatur, filia Bat&uel,filii Melchae uxorisNachor fratris Abra-ham , haben&hydriamin scapula sua \
iS.^llaà^rani,mis, virgoque falche^ irima, et incognita viro:descenderat^autem adfontem, et impleverathydriam, ac ' reverte-batur.
finchè io possa bere : èla quale mi risponderà:Bevi, e anzi abbevereròanche i tuoi cammelli •questa sarà quella chetu hai preparata ad I-sacco tuo servò : e daquesto comprenderò,che tu sei stato propi-zio al mio padrone.
15. Non avea egli fi^nito di dire dentro di sequeste parole, quan-ti' ecco uscì fuora Re-becca figliuola di Ba-iimele figliuolo di Mel-cha moglie di Nachorfratello di Abramò » laquale avea un'idria sul-la spalla :
16. Fanciulla somma-mente avvenente, e ver-gine bellissima, e nonconosciutala uonjp :ella era venuta alla fon- *tana , e ave§ empiutal'idria, e se h' andava.
" * - '
Vers, 14. La fanciulla adunque a cui io Arò, ec. OsservaliCrisostomo, che il segno , al quale Questo servo vuol conoscerela fanciulla destinata d»,Dio pel figlialo di Abramo, è il segnodi una buona moglie , di buona indole , affabile, ospitale , chenon risparmia la fatica ; donna finalmente tale da piacere %àIsacco e ad Abrjtmo. Fu dunque* effetto della sua fede e dellasperanza in Dio;% Cft particolare istinto dello Spirito Santo ilchiedere un tal segnò. » ^ ?"
* Che hai preparata. Destinata.

i'7» Occurritque eiservus^ et alt : Pauxil-lum aqucte mihi ad bi~bendurn praebe de hy-
, ària tua.18. Quae respondit".
Eibeì domine mi. Cele"rilerque deposuit hy-driam super ulnamsuam, et dedit ei po-
àum'^ 19. Cumque ille bi-bisset, adjecit: Quin etcamelis tuis hauriamaquam, donec cunctibibant.
* •iQ.fffundensque liy*driam in canalibus, re-currit ad puteum, uthauriret aquam : ethaustam omnibus ea-melis dedit.
M. Ipse autem con-^templabatur eam taci-
tus> scire volens^ utrumprosperum iter suum
Jfecisset Dominus, annon.
22. Postquam autembibeAint cameli, pro-tulit vir inaures au-re&s, appendente s si-clos duos , et armiltastotidem pondo siclorumdecem.
17. E il servo le an-dò incontro , e disse :Dammi un pocolino diacqua a bere della tuaidria.
18. Ed ella rispose :Bevi, signor mio. Eprestamente si pre*sel'idria sul suo braccio,e diegli da bere.
19. E quando egliebbe bevuto, ella sog-giunse : Io attigneròpure acqua pe'tuoi cam-melli , finchè tutti ab-bian bevuto.
20. E versata l'idriane' canali, corse di belnuovo al pozzo ad at-tigner %equa: e attin-
gala iae diede a tutti icammelli.
21. Ma egli si stavaa contemplarla in silen-zio, volendo sapere, seil Signore avesse , o nofelicitato il suo viaggio.
22. E dopo che ebberbevuto i cammelli, eglitirò fuori due orecchi-ni d' oro, che pesavanodue sicli, Q due brac-cialetti , che pesavanodieci sicli.

23. Dixitque ad eam'.Cujus es filia ? indicamihi : est in domo pa-tris tui locus ad ma-nendum ?
24. Quae respondit'.Filia sum Bath.uelis,filii Melchae, quempeperit ipsi Nachor.
26. Et addidit di-€ens: Palearum quo-que et foeni flurimumest apud nos , et locusspadosus ad manen-dum.
26. InqlÌ7ia%it se ho-mo , et adorava Domi?nunij * <ft
27, Diceno : Benedi'ctus D omìnus Qleusdo*mini mm Jffaakam tqui non abstulit mìM$ricordiam^ et veritate™,suam a damino meo., etrecto itinere meperdu-xit in domum fratrisdomìni mei.
'•4'
23. E diasele : Dim-mi, di chi sei figliuola ?v' ha egli luogo in casadel padre tuo da alber-garvi ? *
24. Ella rispose :So-^no figliuola d^Bathue-le , figliuolo di Meldiia,"partorito da questi! aNachor.
26. EI soggiunse; Dipàglia e di fieno ne ab^lbiam moltissimo in ca-sa , e spazio grandis <ì%dare albergo. - •
26. L'uomo allors'in-chinò , e adorò il Si-,gnor.e,
27. Dicendo : Bene-detto il Signore Di© delpadron mio Àbramo, ilquale non ha mancatodi essere misericoièio-so, e veraci col mio|pa4drone, e per diritta viami ha eond<m*o alla ca-sa ciel Rateilo del miopadrone., *
Vers. 22. Due orecchini cP oro. La voce ebfea può significareanche ornamenti del naso o della fronte. Vedi ver s. 3 j. S. Gi-rolamo (in J3t,ech. xv%J dice, chei^e donne-di Paléiiina porta-vano 'certi ornamenti, i qjfali dalla fronte pendevano sul n|so ;e crede, che questi sieno propriatnfnte significati colla paìiwiaNes^jn, c%e à qui usata. Le fanciulle nella Siria portano «an-che in oggi nn jjjastro alLi fronte, da cui pjndono* moneted.'oro e ^'argentò; e le donne%&ì>e ejjjfirsiaue portano un anel-lo d' oro' a una delle narici.

sB. Cucurrìt itaquepuella , ei nuntiavit indomum matris suaeomnia, quae audierat.
?s 29. Jlabebat autemRebecca fratrem nomi-ne tjaban, quifestinusegréssus est ad homi'nem> ubi eratfons.
3 o. Cumque vidissetfoaures, et armillas inmanibus sororis suae,
* et ^audisset cuncta ver»ha referentis : Haec lo-$utus est mihi homo:
* venit ad virum, qui sta-I bat juxta camelos^ et
prope fontem aquae.
Si.Dìxitgue ad eum:Ingredere , benedicte
"Domini: curforis stas?^jiaeparavi domum, etlocuni camelis.
<f3 2. Etintroduxit eum
in hospitium: ac destra-vii camelos, deditquepaleas, etfoenum, etaquam ad lavandos pe-?
28. Corse adunque lafanciulla , e raccontò acasa di sua madre tut-te le cose, che aveva u-dite.
29. Or Rebecca aveaun fratello chiamato La-ban , il quale andò in.fretta a trovar l'uomo,dov' era la fontana.
30. Gonciossiachè e-gli avea veduti gli orec-chini , e i braccialettinelle mani di sua sorel-la , e avea udite le pa-role di lei, che riferiva:Queli' uomo mi ha det-to queste cose : ed eglitrovò -J? uomo , che sistava presso a' cammel-li, je*viciiÌQ alla fonUma.
ÈL.Jp dissegli : Vieniro, uom benedetto
dal Signore : perchè staifuora ? ho preparata la
jcasa , e un> luogo peicammelli.
32. E Io introdussenell'ospizio ; e scaricò icammelli, e diede loro s*lapaglia, e il fieno, e por-tò acqua per lavare i
Vers. 27. * Per diritta vìa. Addirittura.Vers. 28. A casa di sua madre. Le donne aveano la loro abi-
tazione separata. (§osi abbiam veduto, che Sara avea^ un padi-gliene separato da creilo di Àbramo. 4

des ejus, et virorum,qui venerunt cum eo.
33. Et apposit&s estin conspectu ejus pa-,nis. Qui ait : Non c&medam, donec^loquarsermones meo Ar.' Re*tpondit ei : Loquere.
34- At ille: Servus ,*inqùit% Abraham sfym :
35. Et Dominus be-nedixit domino^ meovaldeì magnificatusq&eest: etdedit ei oves^ etboves> argentoni, et au-rum , sefvoS, %t anc%>*
*las, tametos^t&sinos.
: 3& Et peperì&fSara 4
uxùrjU^ini mei^jiumdomino meo in saìn&i*'ctute sua, dedite/uè illiomnia, quae habuerat.
37. Et adjumvit medominus meus, dicehs :*Non accipies Uxorem^filio meo * de^jttiabus ^
CJiananaeorum, in quo- *rum tèrra liabito :
piedi a lui, e agli*i|i^,mini § che eran veniiffe,con lui. ». . • '*
33. E fuglì postafda-vanti del pane. Ma égJLdiése : Non mangerò, fi^no a tanta che io nonabbia esposta la mia*ambasciata. Ed eglf Ri-spose : Parla.
f 34. & quegli : Spno ,disse, ser,yo di Àbramo:
TKfr'E *il Signore ^a^benedetto grandei*ie=njte il mio padrone , e teha fatto grande; e^tgti*ha dato peQpre^ e bovi,argento, e $•% schiavi,e* s^ht^ye, e^^nimelli,e asini?* „ *r> V.- * •
36". E Sarà moglie delmio padrone ha* parto-rita in sua vecchiaja almiq padrone uniigliuo-lo, oui egli h| dato tu%to il suo. -^ 'r\, 37<(J£.il£j(> padronem i Affatto giurar^ di-rfcendo^ Non gyreno&rai*moglie pel. mio. figlionissuna delle figlie deiChananli, n^lla terrade' quali i^ dimore^
*-Ver»!. 36-, èuì egli ha dmoìutlo ^ *«o. Lo%a dichiara totem?erede universale per,do#o la sua morte.

38. Sed ad domumpatris mei perges, etde cognatione mea ac-cipies uxorem filio meo,
3<), Ego vero respon-di domino meo: Quid sinoluerit venire mecummulier ?
4°» Dominus , ah, incujus conspectu ambu~lojnittetAngelum suumtecum , et diriget viamtuam: accipiesque uxo-rem filio meo de cogna-tione mea, et de domopatris mei.
41. Innocens eris amaledizione mea, cumveneris ad propinquosmeos , &t non dederintlibi. '
42. Veni ergo hodiead fontem acjuae, etdixi: 1)ornine Deus do-mini mei Abraham,, si(lirèxisti viam meam ,in qua nunc ambulo,
43* JE^ce sto juxtafontem aquae , et vir-
38. Ma anderai allacasa del padre mio , edella mia parentelaprenderai moglie al miofigliuolo.
39. Ed io risposi almio padrone ; E se ladonna non vorrà venirmeco ?
40. Il Signore, mi ri-spose egli, nel cospettodi cui io cammino,man-derà T Angelo suo conte , e prospererà il tuoviaggio: e prenderai almio figlio una mogliedi mia parentela e del-la casa del padre mio.
41- Sarai esènte dallamia maledizione, quan-do sarai arrivato a casade' miei parenti , ed einon vorranno dartela.
4a. Sono adunquequest' oggi arrivalo al-la fontana, e ho detto tSigno/e Dio del mio pa-drone Abramo, se tu rnihai indirizzato pellastrada , in cui io oracammino,
43. Ecco che io misto presso quésta fon-
Vers. £1. * Sarai esente dalla mia maledizione. Sarai sciol«fo dal giuramento a me prestato.
Pent. Vol I. i i

gò, quae egredietur.adhauriendam aquam ,audierit a me : Da mi~hi pauxillum aquae adbibendum ex hydriatua :
44- Et dixerit mihi :Et tu bibe : et camelistuis hauriam : ipsa estmulier, f/uam praepa-ravit Dominus filio do-mini mei.
45. "Dumque haec t&*citus mecum volverem*apparuit Rebecca ve-nienscum hydria^quamportabat in scapula :descenditque ad fon-lem , et hausit aquam.Et aio ad eam-. Da mi"Jki paullulum bibere,
'46. 'Quae festinans'deposuit hydriam dehumero, et dixit mihiìEt tu bibe ; et camelisJuis tribuam p o tum. Bi~hi, et adaquavit carne-los.
4y. Interra gaviq uèeam, etdixi\ Cujus e sfilia ? Quae respondit:Filia Bathuelis sum>filii Nachor , q uem pe-perit t>i Melcha. Sus-
tana d' acqua , e la fan-ciulla, che uscirà fuoraad attigner acqua, ed acui dirò; Dammi un po'd' acqua da bere dellatua idria :
44' Ed ella mi dirà :Bevi pur tu ; io ne atti-gnerò a"nche pe' tuoicammelli : questa è ladonna destinata dal Si-gnore al figliuolo delmio padrone.
45. E mentre io que-sle cose ruminava insilenzio dentro di me ,comparve Rebecca, che fyveniva portando la sua m*idria sopra la spalla : e „* ,scese alla fonte , e at- ^tinse l'acqua. E io le .\dissi : Dammi un po- \chettino da bere.
l±6. Ed ella tosto sitolse dall'omero l'idria,e mi disse : E bevi tu ;e a'tuoi cammelli daròda bere. Io bevvi, edella abbeverò i cam-melli.
4?. E la interrogai,e dissi : Di chi sei tu fi-gliuola ? Ed ella rispo-se: Son figliuola di Ba-thuele, figliuolo di Na-chor, e Melcha. Le die-

penali itaque inauresad ornandam faciem e-jus t et armillas posuìin manibus ejus.
48» Pronusgue ado-ravi Dominum , bene"dicens Domino Deo do-mini mei Abraham^ quiperduxit me recto iti-nere, ut sumerem filiamJratris domini mei filioejus.
4p. Quamobrem sìfacìtis misericordiam,et veritatem cum domi-no meo , indicate mihi:sin autem aliud placet^et hoc dicite mihi, utvadam ad dexteram,sive ad sinistram.
60. Jtesponderunt-(jue Lnban^ et Bathuel:A Domino egressus estfermo : non possumusextra placitum ejusfjuidcjuam aliud locjui te-cum,
di allora gli orecchinida attaccarseli per or-nare il Suo volto, e ibraccialetti per le suemani....
48.E mi chinale ado-rai il Signore, bene-dicendo il Signore Diodel mio padrone Àbra-mo , il quale per dirit-ta via mi ha condottoa prendere pel suo fi-gliuolo la figlia del fra-tello del mio padrone.
49- Per la qual cosase voi vi portate conbontà e lealtà verso ilmio padrone, ditemelo:che se pensale al 1 ri-menti , ditemi anchequesto, affinchè io adestra, o a sinistra mivolga.
5o. Ma Laban, e Ba-thuel risposero: II Si-gnore ha parlato : nonpossiam dire a te fuoriche quello che a luipiace.
Vers. 49- Affinchè io a destra, o a sinistra mi volga. E unamaniera d'i proverbio, che vuol dire , affinchè io provveda allamia meumbenza in un modo o in un altro. Egli potea trovareuna moglie per Isaceo nelle famiglie degli altri ligliuoii diNaclior.

51. En Rebecca co-ram te est, tolte eam,et proficiscere, et situ-xor filii domini tui, sic-ut locutus est Domi-nus.
62. Quod cum audis-set puer Abraham, pro-cidens adoravìt in ter»ram Dominum.
53. Prolatisque vasisargenteis, et aureis, acvestibus, dedit Rebec-cae pro munere ,fratri-bus quoque e]us> et ma-tri dona obtulit.
54. Inito convivio, ve-scentes pariter, et bi-bentes manserunt ibi.Surgens autem manelocutus est puer\ Di-mittite me, ut vadamad dominum meum.
55. Responderunt-(juefratres ejus, et ma-ter•: M.aneat puella sal-
51. Ecco davanti a teRebecca , prendila , eparti, ed ella sia mo-glie del figliuolo del tuo «padrone, secondo laparola del Signore.
62. La qual cosa udi-ta avendo il servo diA.bramo, prostrato perterra adorò il Signore.
53. E tratti fuora va-si d' argento e d'oro, evestimenti, li diede aRebecca in donativo, efece anche de' presentia' fratelli di lei, e allamadre.
64. E cominciato ilconvito, stellerò ivimangiando e bevendo,La mattina levatosi ilservo disse : Lasciatemiandare a ritrovare ilmio padrone.
55. Risposero i fra-telli , e la madre : Ri-manga la fanciulla al-
Vers. 5o. Ldban e Baihuel risposero. Questo Baiimele doveaessere anche egli fratello di Rebecca ; perchè , se fosse stato ilpadre , a lui toccava a parlare a preferenza del figliuolo Laban,che fa qui sempre le prime parti. Gredesi perciò, che Bathueleil padre fosse già morto.
// Signore ha parlato. Ciò raccoglievano Laban e Bathue-le, dal segno che Dio n'avea dato ad Eliezer, facendolo imbat-tersi in Rebecca, la quale avea detto e fatto tutto quello cheegli dentro di sé avea domandato al Signore.

lem decem dies apudnos , et postea profici-scetur. >
66. Nolite , alt, meretìnere, quia Dominusdirexit viam me ani : dì-matite me , ut pergamad dominum meum.
67. Et dìxerunt: Vo-cemus puellam^ et quae-ramus ipsius volunta-lem.
58. Cumque vocatavenisset^ sciscitati sunt :Vis ire cum homine i"sto! Quae ait] Vadavi.
69. Dimiserunt ergoeam> et nutricem. illius^servumque Abraham,et comites ejus,
60. Imprecante^ pro»spera sorori suae , at-que dicentes : Sorornostra es , crescas inmille millia , et possi-deat semen tuum por-tas inimicorum suorum.
meno dieci .giorni connoi, e poi partirà.
56. Non vogliate,diss' egli, ritenermi,dappoiché il Signore haprosperato il mio viag-gio : lasciate, ch'io mene vada al miopadrone.
67. Ed ei dissero :Chiamiamo la fanciulla,e sentiamo qual sia ilsuo volere.
58. Chiamata venne,e le domandarono :Vuoi tu andar con que-st1 uomo ? Ed ella dis-se : Anderò;
59. Lasciaron adun-que , che ella partisseinsieme colla sua balia,e il servo di Abramo, ei suoi compagni,
60. Facendo voti perla loro sorella , e dicen-do : Sorella nostra, pos-si tu crescere in mi-gliaia di generazioni, ei tuoi posteri s'impa-droniscano delle portede' suoi nemici.
Vcrs. 5^. Sentiamo qual fia il suo volere. Non riguardo almatrimonio con Isacco, al quale si vede che avea acconsentito(ver s. 5i. ) ma riguardo al partir cosi subito.
Vers. 60. S* impadroniscano delle porte ce. Vale a dire dellecittà, ovver tlelle case, de' palazzi ce.

61. Igitur Rebecca,etpuellae illius, ascen-sis camelis, secutaesunt virimi : quifestinusrevertebatur ad domi"num suum,
62. Eo autem tem-pore deambulabat I-saac per viam c/uae du-cit ad puteum , (i) cu-jus nomen est viventis,et videntis : habitabatenim in terra australi:
63. Et egressus file-rai ad meditandum inagro, inclinata jamdie : cumque elevassetoculos, vidit camelosvenientes procul.
64- Rebecca quoque,conspecto Isaac, de-sceìidit de camelo,
65.Etaitadpueriim:Quis est ille homo, qui
61 .Rebecca adunque,e le sue serve, salitesu cammelli, andaronocori quell'uomo : il qua-le con lulta celerilà sene tornava al suo pa-drone.
62. In quel tempostesso Isacco passeggia-va per la strada , checonduce al pozzo , chesi noma di lui che vivee vede : imperocché e-gli abitava nella terljradi mezzodì:
. 63. Ed era uscito al-la campagna per medi-tare sui far della sera:e alzati gli occhi, videda lungi venir i eam»nielli.
64.Rebecca eziandìo,veduto Isacco, scese dalcammello,
65. E disse al servo :Chi è queli' uomo , che
(i) Sup. 16. 14.
* Sorella nostra. La seconda persona presso gli Ebrei tienluogo del vocativo.
Yers. 62. Per la strada che conduce al pozzo, che si no-ma ec. Vedi cap. xvi. 14-, xvn. n.
Abitava nella terra di mezzodì, A Bersabea, che era nellaparte meridionale di Chanaaii.
Vers. 63. Era uscito alla campagna per meditare. Alenaitraducono P Ebreo per orare ; ma 1' uno e 1' altro senso s'inclu-dono scambievolmente. Sia ch'egli meditasse, sia che egli facesseorazione al Signore, questi lo consola coll'arrivo della sua sposa.

venitper agrum in oc-cursum nobis ?Dixitqueei : Ipse est dominusmeus. At illa tollenscito pallium operuit se.
66. Servus autemcuncta, quae gesserai,narravit Isaac.
67. Qui ìntroduxiteam in tabernaculumSarae matris suae, etaccepit eam uxorem: etin tantum dilexit eam^ut dolorem^ cjui ex mor-te matris ejus accide-rat , temperare^
viene pel campo incon-tro a noi ? Ed egli dis-se: Quegli è il mio pa-drone. Ed ella tosto pre-so il velo si coprì.
66. E il servo rac-contò ad Isacco tuttoquello che avea fatto.
67. Ed egli meriolladentro il padiglione diSara sua madre , e laprese per moglie: e l'a-mor che ebbe per lei futale, che temperò il do-lore , che risentiva perla morte della madre.
Vers. 65. Ella tosto preso il velo si coprì. Quello che sì ètradotto il velo, s. Girolamo dice che era una specie di mantelloche copriva la testa e il corpo tutto.
Vers. 6". E V amor che ebbe per lei... tempero il datore, ec.Sara era morta già tre anni prima . Si mostra adunque con que-ste parole l'affetto grande d'Isacco verso una si degna madre. InIsacco figliuolo unigenito di Abramo è qui rappresentato il fi-gliuolo unigenito di Dio, cui il padre diede l'assoluto dominio ditutte le cose. Matili, xi. 27. Il padre dà al figliuolo una sposa, laChiesa, raccolta da tutte quante le naaioni, che sono sopra laterra, e a cercare, e chiamar questa sposa ( la quale senza un in-vito speciale di lui non si sarebbe mossa giammai a bramare losposo, e l'autore di sua salute) manda i suoi servi pii» fedeli, gliApostoli, ricchi de'suoi doni e animati dallo spirito dello sposo.Questa sposa è introdotta a occupare il luogo della sinagoga ; ela bellezza e la fecondità di questa sposa , che non ha nè mac-chia, nè grinza, fece svanire il giusto dolore della perdita dellasinagoga.

C A P O XXV,
Àbramo a* molti figliuoli avuti da Cetura dà deidoni ; e muore lasciando suo erede Isacco.Muore anche Ismaele dopo aver generato do-dici principi. Isacco fa orazione per la mo gliesterile , ed ella partorisce due gemelli, Esaùe Giacobbe, de* quali il maggiore vende alminore la primogenitura.
1. jfLbràhani veroaliam duxit uxorem no-mine Ceturam : f i )
2. Quae peperit eiZamran, et Jecsan,et Madan , et M.adiaiiìet Jesboc , et Sue.
3. Jecsan quoque ge-nuit Saba^ et Daddn.Filii Dadan fueruntA s sur im , et Latusim^et Loomim.
4- A t vero ex Madianortus est Epha* et O"
1. r\bramo poi spo-sò un'altra moglie pernome Getura :
2. La quale partorìa lui Zamran, e Jecsan,e Madan , e Madian , eJesboc, e Sue.
3. Jecsan poi generòSaba, e Dadan. I fi-gliuoli di Dadan furonAssurim , e Latusim, eLoomim.
4. Da Madian nacqueEpha, e Opher, ed He-
(i) i. Par. i. 3a.
Yers. i. Sposo un altra moglie per nome Cetura. Abramoavea allora cento quarant'anni. La virtù di questo gran patriarcanon permette di credere , che altro egli cercasse con questo nuo-vo matrimonio , cte di avere maggior numero di figliuoli, permezzo ile' quali la vera religione si propagasse e si adempisserole promesse fattegli da Dio , di una numerosissima discendenza.E 1' essere stato benedetto da Dio questo matrimonio con buonnumero di figliuoli dimostra, e che Dio gli conservò il vigorerendutogli miracolosamente, e che per ispirazione di lui Àbramolo avea fatto.

pher, et Henoch^ et A'bida^ et Eldaa: omneshi filii Ceturae.
6. Deditt/ue Abra-ham cuncta, quae pos-sederai , Isaac :
6. Filiis autem con-cubinarum largitus estmunera , et separaviteos ab Isaac filio suotdum adhuc ipse viveret,ad plagam orientalem.
7. Fuerunt autemdies vitae Abrahae cen-tum septuaginta quin-que anni»
8. Et deficiens mor-tuus est in s enee tu tebojia, provectaeque ae*tatiS) etplenus dierum :congregatosene est adpopulum suum.
nocb, e Abida , ed El-daa: lutti questi figliuo-li di Cetura.
5. E Abramo diedead Isaac tutto quelloche possedeva :
6. A* figliuoli poi del-le concubine diede deidoni, e li separò da I-saac suo figliuolo, men-tre era tuttora in vita,mandandoli verso 1' o-riente.
7. E tutti i giornidella vita d'Abramo fu-rono cento settantacin-que anni.
8. E venne meno emorì in prospera vec-chiezza , e d' età avan-zata, e pieno di giorni,e andò a unirsi al suopopolo.
Vers. 6. A*figliuoli poi delle concubine diede de'doni, ec. Leconcubine, o sia mogli secondarie furono Agar e Cetura. Elleerano vere mogli, ma di assai inferior condizione, ed erano sog-gette alla madre di famiglia, la quale era e dicevasi signora, ov-ver donna : elle erano per lo più serve e serve rimanevano, e ilor figliuoli non avean diritto ali' eredità paterna.
£ li separò da Isaac ..., mandandoli ec. Yedesi da ciò lasollecitudine d' Abramo non solamente di provvedere alla pacede' suoi figliuoli, ma ancile di allontanare il figliuolo Isacco ,l'erede delle promesse, e i posteri di lui dal pericolo di conta-minarsi coli' idolatria e co1 vizii, ne' quali erano per cadere i po-steri degli altri figliuoli.
Mandandoli verso Voriente. 1 figliuoli di Agar e quelli diCetura furono mandati da Abramo nell' Arabia deserta , che ri-mane a oriente riguardo a Bersabea, dove egli passò gli ultimii nui di sua vita.

9. E t sepelierun t eumIsaac , et Ismael filiisui in spelunca dupli-ci , quae sita est in a-gro Ephron , filii SeorHethaei , e regioneJfàambre.
10. Quem emerat afiliis Heth : ibi sepultusest ipse, et Sara uxorejus.
i TI Et post obitumillius benedixit DeusIsaac filio ejus, c/ui ha-bitabat juxta puteum
9. E Isaac e Ismaeìesuoi figliuoli lo seppel-lirono nella doppia spe-lonca situala nel campodi Ephron, figliuolo diSeor Heteo, dirimpettoa Mambre.
10. Il qual campoegli avea comprato da'figliuoli di Heth : ivi fusepolti egli, e Sara suamoglie.
11. E dopo la mortedi lui Dio benedisseIsacco suo figlio,il qua-le abitava presso al poz-
Vers. 8. E venne meno e mori ec. Mori Abramo non per ef-fetto di malattia o dì altra estrinseca causa ; ma consunte le for-ze e il vigor naturale, sazio (li vivere (cosi dice l'Ebreo) , senzamalattia e senza dolore passo tranquillamente da questa vita, e(indo a unirsi al suo popolo: vale a dire, spogliato della mor-talità, passò ad unirsi alla società de'giusti, agli spirili fie1 giustiperfetti, Hebr. xu. ?.3. Osservano gì' interpreti, aversi in questafrase popolare raffermata la costante tradizione dell' immortalitàdell'anima, cui la separazione dal corpo altro non è, che un pas-saggio ad un nuovo stato di vita.
Tutto quello che abbiam fin qui veduto d' Abramo, ci dàUn'altissima idea della virtù e grandezza d'animo, della pietà,della fede e della giustizia di questo patriarca. Io non m'avan-aerò a farne 1' elogio ; ma mi contenterò di riferire quello che loSpirito santo ce ne ha lasciato nell'Ecclesiastico : Abramo, ilgrande padre di molte genti, a cui nessuno fu il simile ingloria; il quale conservo la legge dell'Altissimo: e questistrinse con lui alleanza. Egli nella sua carne ratifico il pal~io, e nella tentazione fu trovato fedele. Per questo Iddio giu-ro di dargli gloria nella sua stirpe , e clCei sarebbesì mohipli,-calo , come la polvere della terra; e di esaltare il seme di lui,come le stelle del cielo, e che questo avrebbe posseduto da unmare all'altro, e dal gran fiume sino a?confini del mondo,cap. XLIV. 20. 23.

^ornine viventis 3 et vi-dentis.
12. Hae suìitgenera-tiones Ismael, filii A-brahae, quem peperitei Agar AEgfptia> fa-mula Sarae r
13. Et haec nominafiliorum ejus invocabu-lis , et generationibussuis (i). P rimo penitusIsmaelis Tiabajoth ,deinde Cedar, et Ad-beel, et Mabsam:
14- Masma quoque ,et Duma , et Massa,
15. Hadar, et Thè-ma 3 et Jethur , et Na*pliis, et Cedma.
16. Isti sunt filii I-smaelis : et haec no-mina per castella i et
zò detto di colui che vi*re e che vede.
12. Questo è il nove-ro dei posteri d'Ismae-le, figliuolo di A brani a,,partorito a lui da AgarEgiziana schiava di Sa-rà:
13. E questi sono inomi de'figliuoli di lui »co' quali nomi furorichiamati i suoi discen-denti. Primogenito diIsmaele fuNabajoth, di-poi Cedar, e Adbeel, eMabsam:
14. E Mas ma, e Da-ma , e Massa ,
15. Hadar, e Therna,e Jethur , e Naphis , eGedma.
16. Questi sono i fi-gliuoli d'Ismaele, e que -sti nomi passarono a.'loro
(\) i. Par. if 2g.
Vers. 13. Primogenito d'Ismaele Naba/oth. Da cui i Nabatei,de'quali la capitale fu Petra nell' Arabia Petrea.
Cedar. Da cui i Cedreeni vicini a' Nabatei.Vers. *4; Masma, e Dumo., e Massa^. Questi nomi di tre
de' figliuoli d'Ismaele sono usati per modo di proverbio dagliEbrei; perocché significano, ascoltare, tacere, sopportare: treregole essenzialissime per conservare la pace. Duma può averdato nome ad una città detta Duinathan nell' Arabia deserta.Vedi hai. xxh 11.
Vers. 15. Jeihur. Da cui credesi venga il nome di Ilurea, pia-col paese oltre il Giordano, che ha a levante l'Arabia deserta, aponente lo stesso Giordano.
Calma, lì paese di Cedcmoth è rammentalo Deuler, xi. 26.

oppido, eorum, duode-cim principes tribuumsuarum.
17. Etfacti sunt an-ni vitae Ismaelis cen-tum triginta septem,deficiensque mortuusest, et appositus ad po-pulum suum.
18. Habitavit autemad lievita use/uè Sur,f/uae respicit AEgy*p tum introeuntibus As-syrios. Coram cunctisfratribits suis obiit.
19. Hae quoque suntVeneratione s Isaac filiiAbraham : Abrahamgenuit Isaac :
20. Qui cum quadra^ginta esset annorum,
. duxit uxorem Rebec-cam filiam BathìielisSyri de Mesopotamia,sororem Laban*
castelli, e e i. Uà ci i . Essifuro n dodici principiognuno della sua tribù.
17. E tutti gli annidella vita d'Ismaele fu-rono cento trentasette,e andò mancando e mo-rì , e andò ad unirsi colsuo popolo.
18. Or egli abitò ilpaese , che è da Hevilasino a Sur, la quale( Sur ) guarda T Egittoper cH va neli' Assirìa.Egli morì presenti tut-ti i suoi fratelli.
19. Questa pur fu lagenealogia d'Isaac fi-gliuolo di Abramo : A-bramo generò Isaac :
20. E questi essendoin età d'anni quaranta,sposò Rebecca figliuoladi Baiimele Siro dellaMesopotamia, sorelladi Laban.
Vers. 16. Dodici prìncipi. Vedi cap. xvu. ao.* Castelli e ciltadì. L'Ebraico Tiroth in Siriaco vale ovile,
circondario in cui si chiudono i greggi.* Ivi. Dodici principi. Questi Arabi, che non hanno città
nè case murate, vàveano come oggidì i Tartari.. Vers. 18. La quale (Sur) guarda V Egitto per hi «e. La so-
litudine di Sur è sulla strada per andare dall'Egitt nell'Assiria.* Or egli abito. Altri abitarono, e lo riferisc no a' posteri
d'Ismaele.* Ivi. Morì presenti. Ovvero superstiti tutti i noi fratelli.
Vera, a o * Fevc preghiere. Fece istanti preghici

21. Deprecatusqueest Isaac Dominum prouxore sua, eo quod
tessetsterilis*. c/ui exau-diviteum, et dedit con*ceptum Rebeccae.
22. Sed collideban»tur in utero ejus parvu-li ; quae alt : Si sic mi-hi futurum erat) quidnecesse fuit concipere ?Perrexitque ut consu-lere t Dominum.
23. Qui respondens,aiti (i) Duae gentessunt in utero tuo, et duopopuli ex ventre tuo di"videntur, populusquepopulum superabitt etmajor serviet minori.
21. E Isaac fece pre»ghiere al Signore perla sua moglie, perocchéella era sterile : ed eglilo esaudì, e fece cheRebecca concepisse.
22. Ma si urtavanonel seno di lei i bambi-ni ; ed ella disse : Sequesto dovea accader-mi, qual bisogno v'era,che io concepissi? E sene andò a consultare ilSignore.
23. Il quale rispose ,e disse : Due nazionisono nel tuo seno, e duepopoli dal ventre tuousciran separati, e l'uripopolo vincerà P altro,e il maggiore servirà alminore.
fi} Rorn. g. io,
Vers. 21. E Isaac fece preghiere ec. La voce ebrea esprime,che Isacco pregò molto e ardentemente e con perseveranza. Lasterilità di Rebecca ( come quella di Sara) dimostra t che quelseme di benedizione, il Cristo, il quale da lei dovea discendere,sarebbe dato al mondo non per effetto di naturali cagioni, maper mero dono di Dio, e pe.r miracolo della bontà di lui, e me-diante le preghiere de' giusti. Vedi il Grisostomo.
Yers. 22. Se n' ando a consultare il Signore. Non pQssiarnadir con certezza, dove e da chi andasse Rebecca ; ma Teodoretoe altri interpreti credono, che ella andasse ali' altare eretto daÀbramo in un bosco vicino al suo padiglione, come vedemmo disopra, e che dopo che ella ebbe pregato il Signore, questi, o insogno, o per mezzo di un Angelo, le predicesse quello che segue,
Vers. 28. // maggiore servirà al minore. Il primogenito Esau( vale a dire i posteri di lui ) servirà a Giacobbe secondogenito.Gli Ebrei infatti, come soli eredi di Abramo , ebbero- il dominio

24. Jam tempus p a-riendi advenerat, etecce gemini in uteroejus reperti sunt.
26. (i) Qui prior e*gressus estt rufus erat,et totus in morem pellishispidus : vocatums/ueest nomen ejus lEsau.(2) Protinus alteregre-diens , pian tam fratristenebat manu', et idcir-co appellavit eum Ja-cok.
26. Sexagenarius e-rat Isaac , quando na-ti sunt ei parvuU.
24. Era già venuto iltempo di partorire , edecco , che si trovaronnell'utero di lei duegemetti.
26. Quegli che il pri-mo venne fuora , erarosso, e tutto peloso ,come uria, pelliccia ; efagli posto nome Esaù.L* altro , che immedia-tamente uscì, tenea col-la m a no i 1 piede del fra-tello : e per questo ellalo chiamò Giacobbe»
26. Isacco era di ses-sant' anni , quando glinacquero questi barn*bini.
(ij Osce la. 3. fa) Matili, i. a.
della terra di Chanaan, e furono esaltati da Dio>: e i discendentidi Esali, gì' Idumei, furono soggetti agli stessi Ebrei ne' tempi diDavidde e di Salomone e de'Macabei. Ma in un altro senso piùimportante, come- dopo s. Paolo spiega s. Agostino: II figliuolomaggiore e il popolo primogenito riprovato; il figliuolo mina-re e il nuovo popolo eletto: il maggiore servirà al minore:questo si e adesso verificato; adesso i Giudei sono i nostriservi, portano i libri santi a noi che gli Mudiamo , in Ps. 4»-E in una significazione ancora più ampia, quest'oracolo si adern»-pie negli eletti e ne'reprobi, figurati i primi in Giacobbe, i se-condi jn Esaù; perchè tutto quello che fassi da'reprobi, o intor-no ad essi, è diretto dalla Provvidenza alla salvazione degli elet-ti, redi Rom. ix.
Vers. ^5. Fug/i posto nome Esaù. Come chi dicesse nomofattoi perchè era nato tutto peloso, come se fosse già nom*»maturo.
Giacobbe. Filone tradusse lottatore , o atleta, il quale presel'avversario nel piede lo atterra. Vedi cctp. xxvu. 36.
* // piede. La pianta del piede.

27» Quibus adultis,factus estEsau vir gjia*rus venandi, et hom>oagricola : Jacob autemvir simplex habitabatin tabernaculis.
28. Isaac amabat E-san , eo quod de vena-tionibus illius vescere-tur : et Rebecca dilige'bai Jacob.
29. Coxit autem Ja-cob pulmentum , adquem cum venisset E-sau de agro lassus ,
3 o. Aiti Da mihi decodione hac riifa, quiaoppido lassus sum.Quam ob causam voca-tum est nomen ejus (i)Edom.
27. I quali allorchéfurono adulti, Esaù di-venne buon cacciatore,e uom di campagna : eGiacobbe uomo sempli-ce abitava ne' padi-glioni.
28. Isacco amava E-saù, perchè si cibavadella caccia di lui : eRebecca amava Già-*cobbe.
29. Or Giacobbe siera cotta una pietanza,quando venne a lui E-saù dalla campagna af-faticato ,
30. E disse: Dammi diquella cosa rossa , chehai cotta, perocché sa-no stanco davvero. Perquesta cagione gli fudato il nome di Edom.
(ij Ab A. i. Hébr, i?.. 16.
Vers. 27. Uomo semplice. Vale a dire schietto , innocente, edi ottimo costume. Cosi Giacobbe è chiamato uomo semplice.Quindi egli abitava ne* padiglioni, avendo cura delle cose do-mestiche, e de'greggi paterni \ mentre il naturale fervido di Esatilo portava a passare il suo tempo per le campagne e pe* boschialla caccia .
Vers. 28. Isacco amava E s alt,, perctìe si cibava ec. L' affettoe la riverenza che Esait mostrava verso del padre, e l'attenzioneche avea di provvedergli la cacciagione, della quale egli volentie^-ri si nutriva, servivano ad accrescer l'amor d'Isaeco verso questostio primogenito. Cao però non vuol dire, ch' ei non amasse e nonistìmasse Giacobbe.
Vers. 3o. Gli fu dato il nome di Edam. Vale a dire rosso,rubicondo, ec. Le lenti d'Egitto erano famose anche a' tempi di5. Agostino.

31. Cui dixit Jacob :Vende mihi primogeni'ta tua.
3a. Ille respondit :lEìi morior ; quid mihiproderunt primogenita!
33. Alt Jacob : Juraergo mihi. Juravit eiE san, et vendidit pri-mogenita*
34« JZt sic aeceptò pa-ne , et lentis edulio, co-medìt, et bibit^ et abiit^parvipendens, quodpri-mogenita vendidisset.
31. Disse a lui Gia-cobbe : Vendimi la tuaprimogenitura.
32. Quegli rispose:Ecco che io mi muoio:che mi varrà l'esser ioprimogenito ?
33. Disse Giacobbe :Giuramelo adunque.Esaù fece a lui il giura-mento , e vendè la pri-mogenitura.
34- Così preso il pa-ne, e Sa pietanza di len-ti , mangiò, e bevve, es'andò poco curando d'a-ver venduto il dirittodi primogenito.
Vers. 31. Fendimi la tua primogenitura: i diritti di primo-genito. Giacobbe sapeva già, per quello che gli avea raccontato lamadre, che secondo il volere di Dio a lui doveano appartenerele ragioni di primogenito : prende egli adunque questa occasionedi vendicare questo diritto mediante la volontaria cessione delfratello.
Vers. 3a. Ecco che io mi muoio. Quand' anche si voglia cre-dere , che questo fatto avvenisse in tempo che era cominciata lacarestia, di cui si parla nel capo seguente, come alcuni preten-dono; non è però da credere, che Esau non avesse nella casa diun ricchissimo padre altro cibo da levarsi la fame, se non lelenti di Giacobbe ; anzi è piuttosto da credere, ch' egli voglia ri-coprire la sua golosità col pretesto di estremo bisogno . Egliadunque peccò e meritò di essere chiamato profano da Paolo,Hebr, sii. 16: perchè a si vil prezzo, come è una scodella di len-ti , vendè le prerogative annesse alla sua qualità di primogenito ,e con esse la benedizione paterna, e per conseguenza anche ilmassimo de' privilegii spettanti al primogenito d'Isacco, il privi-legio d' esser padre del Cristo. ,
Vers. 34- Se ne ando, poco curando ec. E notata dopo il pec-cato l'ostinazione e l'impenitenza. Forse ebbe fin d'allora in cuo-re di non stare al contratto, benché ratificato col giuramento,onde ti fece reo di perfidia e di spergiuro.

C A P O XXVL
m Isacco pellegrino in Gerara a causa della care'stia. Promessa della terra di Chanaan, e be-nedizione del seme di lui» Abimelech lo ripren-de , perchè avea detto , die Rebecca era suasorella. Essendo venuti a contesa i loro pasto-ri per le cisterne, Abimelech fa alleanzacon Isacco: Esaù prende delle mogli.
1. \Jrta autem fa-me super terram posteam sterilitatem, quaeacciderat in diebus A-braliam, abiit Isaac adAbimelech regem P a*laestinorum in Gerara.
2. Apparuitque eiDominus, et aiti Ne de-scendas in AEgyptum\sed (juiesce in terra ?quam dixero dbi ;
3. Et peregrinare inea , eroque tecum} etbenedicavi, tibi : tibienim, et semini tuo da-
1. IVJLa essendo ve-nuta la fame in quel pae-se dopo la sterilità avve-nuta ne'giorni di Abra-mo, se n'andò Isaac daAbimelech re de' Pale-stini in Gerara.
2. E il Signore gli ap-parve, e disse : Non an-dare in Egitto ; ma po-sati nel paese , ch' io tidirò ;
3. E stavvi pellegrino,e io sarò teco, e ti be-nedirò : imperocché ale, e al seme tuo darò
Vers. i. Dopo la. sterilita avvenuta ec. L'Ebreo e i LXX. leg-gono , olire , ovvero fuori della farne avvenuta né' giorni(V Àbramo , cioè cento tre anni prima.
Ando Isaac da Abirnelech . Figliuolo probabilmente diquello che è nominato al capo xxi.
Vers. 2. Non andare in Egitto. Dio rimuove Isacco dall7 an-rkire in Egitto per trovar da vivere, benché vi avesse mandatoAbramo. Noi non vediamo le ragioni nè del primo ordine, nèdel secondo ; ma Abramo obbedii a Dio , e andò ; e Isacco obbedìa Dio, e fcrmossi, dove Dio gli comandò di fermarsi*

eo universa^ re glene shas , (i) complens ju-ramentum quod spopon-di Abraham patri tuo.
4- Et muldplicabosemen tuum sicut stei-las coeli : daboque po-sterìa tuis unìversasregiones has : (2) etBENEDICENTUR insemine tuo omnes gen-tes terras,
5. Eo quod obedieritAbraham voci meae,et custodierit praece-ptaì et mandata mea, etcaeremonias, leges queservaverit.
6. Mansit itaque Isa-ac in Geraris.
7. Qui cum interro-garetur a viris loci il-lius super uxore sua,respondit'. Soror meaest: timuerat enim con-fiteri, quod sibi essetsodata coniugio, repu-tans, ne forte interfi-
tutte queste regioni,adempiendo il giura-mento fatto da me adÀbramo tuo padre.
4. E moltiplicherò latua stirpe come le s tei-le del cielo : e darò aituoi posteri tutte que-ste regioni: e nel semetuo SàRAN BENE-DETTE tutte le nazio-ni della terra,
5. Perchè Abramo ob-bedì alla mia voce , eosservò i precelti, e co-mandamenti miei, emantenne le cerimonie,e le leggi.
6. Isacco adunque sifermò in Gerara.
7. Ed essendogli fat-te delle interrogazionidalla gente di quel luo-go intorno alla sua mo-glie, rispose : Ella è miasorella ; perocché ebbepaura di confessare, chefosse unita seco in ma»
(\) Snpra. is. 7. i5. 18.fa) Supra. 12. 3. 18. 22. 18. Infr, a8. 14
Yers, 5. Perche Abramo obbedì alici mia voce ec. Dio, diceil Crisostomo , rammenta ad Isacco l'obbedienza del padre, affin-chè veggendola cosi rimunerata nella sua persona si animi adimitarla e sorpassarla (se fosse possibile) aflin di conseguirne piùgran mercede,
. * Le cerimonie. 1 riti.

cerent eum propter il-lius pulchritudinem.
8. Cumque pertrans-issent dies plurimi, etibidem moraretur, pro-spiciens AbimelechrexPalaestinorum per fe-nestram, vidit eum jo-cantem cum Rebeccauxore sua.
9. Et accersito eo,ait : Perspicuum est,quod uxor tua sit : curfìientitus es, eam soro-rem tuam esse ? Re-spondit: Timui, ne mo-rerer propter eam.
10. Dixitfjue Abime-lech\ Quare imposuistìnobis?potuit coire (juis-piam de populo cumuxore tua , et induxe-ras super nos grande
trimonio, sospettando,che forse presi dalla bel-lezza di lei non lo uc-cidessero,
8. E passato un lun-go tempo , e abitandoegli nel medesimo luo-go , traguardando Abi-melech re de'Palestiniper una finestra , lo vi-de scherzare con Re-becca sua moglie.
9. E fattolo venir ase , disse : Egli è fuordi dubbio, ch'ella è tuamoglie: per qual moti-vo hai tu affermato, es-ser lei tua sorella ? Ri-spose i Temei di esserea causa di lei ucciso.
10. E disse Abime-lech : Per qual motivoci hai tu inganna ti ? po-teva alcuno fare oltrag-gio alia tua donna, etu ci avresti tirato ad-
Vers. 7. Ella e mìa sorella. Rebecca veniva ad essere cuginad'Isacco. S. Agostino giustifica il fatto d'Isacco colle stesse ragio-ni , colle quali avea già giustificalo il fatto d'Abramo. Vedi(ren. xii. 13., e AugusL cont. Fauni, lib. xxn. cap. 33. e fò.
Vers. 8. Lo vide scherzare con Rebecca. La parola dell'origi-nale significa ridere o scherzare, nè significa più di quello cheun marito saggio e circospetto farebbe talor colla moglie, scher-zando onestamente con lei, con quella libertà, che non userebbecon donna clic non fosse sua moglie, perchè con un7 altra ciò nonsarebbe decente.
Vers. io. Ci avresti tirato addosso un gran peccato. Avrestidato occasione a un gran peccato, qual è quello dell'adulterio.

peccatimi. Praecepit-que omni populo, di-cens :
11. Qui te ti gerit ho-minis hujus uxorem,morte morietur.
12. Sevit autem Isa-ac in terra illa , et in-venit in ipso anno cen-tuplum : benedixitqueei Dominus.
13. Et locupletatusest homo , et ibat profi-ciens , atque succre-scens, donec magnusvehementer effectus est,
\!\, Habuit quoquepossessiones ovium, etarmentorum, et fami"liae plurimum. Ob hocinvidentes ei Palaesti-ni,
16. Omnes puteos,(juosfoderant servi pa-tris illius Abraham ,illo tempore obstruxe-runt, implentes humo :
i^. In tantum , utipse Abimelech diceretad Isaac: Recede a no-
dosso un gran peccato.E fece intimare a tuttoil popolo questa pa-rola :
11. Chi toccherà lamoglie di quest' uomo,sarà punito di morte.
12. Ma Isacco semi-nò in quella terra , e inquell'anno trovò il cen-tuplo : e il Signore lobenedisse.
13. Ed egli diventòricco, e andava crescen-do di bene in meglio,talmente che divennesommamente grande.
14. Egli fu anche pa-drone di pecore, e d'ar-menti , e di numerosaservitù. Quindi portan-dogli invidia i Palesti-ni,
15. Accecarono inquel tempo tutti i poz-zi scavati da' servi delpadre di lui Àbramo,empiendoli di terra:
16. E la cosa andòtanto in là, che lo stes-so Abimelech disse ad
Ver*. 11. Sarà punito di morie. Questa era la pena dell'adul-terio tra'Filistei, e i Cliananeì, e gli Ebrei stessi avanti la legge.
Vers. 12. E il Signore lo benedisse. Perchè il Signore l'aveabenedetto.

MS ; quoniam potentiornobis factus es valde.
17. Et illediscedens',ut veniret ad torren-tem Gerarae, habita-retque ibi:
18. Rursum fodit a-• lios puteos , quos fode-
rant servi patris sui A"braham , et (juos , illomortuo^ olim obstruxe-rant Philisthiim: ap-pellavitque eos eisdemHominibus quibus ante
. - pater vocaverat,19. Foderunte/uè in
torrente, et repereruntacjuam vivam.
20. Sedetibijurgiumfuit pasforum Geraraeadversus pastores Isa-ac , dicendum : Nos fraest aqua. Quam ob remnomen putei ex eo,quod acciderat, voca-vit Calumniam.
21. Foderunt autemet alium : et pro illoquoque rixati sunt, ap-peìlavitque eum Inimi-citias.
22. Profectus indefodit alium puteum, proquo non contenderunt :
Isacco: Ritiratila noi;perocché sei molto piùpossente di noi.
17-Ed egli si partiper andare verso il tor-rente di Gerara , e iviabitare :
18. E di nuovo votòaltri pozzi scavati daiservi del padre suo A-bramo , i quali, mortoquello, i Filistei aveangià tempo otturati: epose loro gli stessi no-mi, che avean già avu-to dal padre.
*9- E avendo fattoscavo nel torrente, tro-varono dell'acqua viva.
20. Ma ivi ancora fualterazione de'pastoridi Gerara contro i pa-stori d'Isacco, dicendoquelli; L'acqua è nostra.Per la qual cosa da quel-lo, che era avvenuto,chiamò quel pozzo colnome di Soperchieria.
21. E ne scavaronoancora un altro: e perragione di questo an-cora vi ebbe rissa, e lochiamò Nimistà.
22. E partitosi di làscavò un altro pozzo,per ragion del quale

ìtac/ue vocavit nomenejus Latititelo , dìcens :"Nunc dilatavit nos Do-minus , et fecit cresce-re super terram*
23. Ascendit autemex illo loco in Eersabee^
•24. Ubi apparuit eiDominus in ipsa nocte^dìcens-. Ego sum DeusAbraliam patris tui :noli timere ; quia egotecum sum: benedicamitibi, et multiplicabo se-men tuum propter ser-vum meum Abr aliam.
26. Itaque aedificavitibi altare , et invocatonomine Domini^ exten-dittabernaculum; prae-cepitque servis suis utfoderent puteum.
non v* ebbe contrasto Je perciò chiamollo Lar-gura, dicendo: Adessoil Signore ci ha messial largo , e ci ha fatticrescere sopra la terra.
23. E salì da quelluogo a Bersabee ,
24. Dove gli apparìil Signore la stessa not-te , dicendo : Io sono ilDio d' Abramo padretuo : non temere ; pe-rocché io sono con te: tibenedirò, emoltipliche-rò la tua stirpe per amo- •re di Abramo mio servo.
26. Per la qual cosaegli edificò in quel luo-go un altare,-e invoca-to il nome del Signore,tese il suo padiglione; eordinò a' suoi servi, chescavassero un pozzo.
Vers, *>.•>,. E partitosi dì la ec. Il Crisostomo ammira qui conragione la mansuetudine d'Isacco. Il giusto, dice egli, non dis-puta , e non contrasta; ina cede anche a de*pastori', perchequesta e vera mansuetudine, non quando uno offeso da chipiù 777/0, sopporta con pazienza, ma quando offeso anche daquelli che si credono inferiori, non fa resistenza.
Adesso il Signore ci ha messi al largo. Il Crisostomo,Vedi tu , dice , un animo pio , come senza far parola delleatroci contraddizioni che se gli erano opposte , sì ricorda solodel bene, e di questo a Dio rende grazie? Perocché nissunacosa "e tanto accetta a Dio, come un1 anima riconoscente ... efacendo a noi infiniti benefizii ogni giorno, non altro chiededa noi, che rendimenti dì grazie per muoversi a darci quelliche fono pili grandi.
* Largura. Largheggiamento, allargamento.

2 6. Ad quem locumcum venissent de Gera~ris Abimelech, et Och-ozath amicus illius , etPìùcol dux militum,
27. Locutus est eisIsaac'. Quid venisti adme , hominem , quemodistis, et expulistis avobis ?
28. Qui re sponde-runt : Vidimus, tecumesse Dominum, ei id-circo nos diximus : Sit
juramentum in ter nos,et ineamus foedus,
29. Ut non factas no-bis cjuidquam mali, sic-ut et nos nihil tuorumGttigimus, nec fecimus,quod te laederet^ sedcum pace dimisimusauc tum bene die tioneDomi fil.
So. Fecit ergo eis con-vivium , et post cibumet potum -,
2,6. Nel qual luogoessendo venuti da Gè-rara Abimelech, e O-chozath suo amico , ePhicol capitano dellemilizie,
27. Disse loro Isacco:Per qual motivo sietevenuti da me , da unuomo odiato da voi, eda voi discacciato ?
28. Risposer quelli :Abbiarn veduto, che ilSignore è con te, e per-ciò abbiam detto: Sigiuri, e si stringa tranoi alleanza ,
20. Dì modo ch? lanon faccia a noi male .alcuno , come noi purenulla abbiam toccatodi quel che è tuo, nèabbiam fatto cosa intuo danno ; ma ti ab-bi am lasciato partirein pace ricco della be-nedizione del Signore.
3o. Egli adunque im-bandì ad essi il convito,^ dopo che ebber man-giato , e bevuto,
"Vers. 9.6. * Abimelech e OcJiozaih suo amico. Ovvero Abl-melech co'suoi nemici.
Vers. arj. Ne abbiam fatto cosa in Ino danno. Maaveano per-messo a'iòro pastori di jfar danno, e non ne avean fatta giusti/ia.

3i. Surgentes manejuraverunt sibi mutuo,dimisitque eos Isaacpacifice in locum suum.
3a. Ecce autem ve»nerunt in ipso die ser-vi Isaac, annuntiantesei de puteo, quemfode-rant, atque dicentes\Invenimus aquam*
33. Unde appellaviteum Abundantia : etnomen urbi impositumest Bersabee, usque inpraesentem diem.
34* Esazi vero qua*dragenarius duxituxo-res, Judith, filiam B ce-ri ìfethaeì, et Basema-th, filiam Elon ejusdemloci :
35. (i) Quae ambaeoffenderant animum I-$aac, et Rebeccae.
31. Levatisi la mat-tina fecero scambievolegiuramento, e Isaccolasciogli andare in pa-ce a casa loro.
32. Quand' ecco lostesso dì arrivarono iservi d'Isacco, recandoa lui la nuova del poz-zo scavato , e dicendo :Abbiamo trovata acqua,
33. Per la qual cosalo chiamò Abbondanza:e alla città fu posto ilnome diBersabee, comelo ha fino al dì d' oggi. -
34. Ma Esaù in etàdi quarantanni preseper mogli, Judith, fi-gliuola di Beeri Hetheo,e Basemath, figliuola diElon del medesimo luo-go:
35. Le quali ambe-due avevano disgusta-to 1' animo d' Isacco , edi Rebecca.
(i) Inff. 27. 46.
Vers. 33. E alla citta fu posto nome ec. Questo nome lo eb-be prima il pozzo ; indi la città edificata vicino al pozzo.
Vers. 35. Aveano disgustalo V animo ec. L'Ebreo: eranoamarezza (P animo per Isacco ec. Superbe per la loro nascita( Giuseppe scrive , che i loro padri erano principi degli Hethei )e per avere sposato Esali, che elle consideravan per primogenitodella famiglia : essendo anche aliene dalla pietà, servirono adesercitare la mansuetudine d'Isacco, e la pazienza di Rebecca.

C A P O XXVII.
Giacobbe^ consigliato dalla madre ottiene la be*nedizione izi luogo dì Esaù; e per metterlo alcoperto dall1 ira di lui, la madre lo esorta aritirarsi ad Haran presso di Laban,
e1. kJenuit autem /-
saac, et caligaveruntoculi ejus, et videre nonpoterat : vocavitque E-sau filium suum majo-rem , et dixit ei: Filimi? Qui respondit:Adsum.
2. Cui patera Videsyinquit, quod senuerim,et ignorem diem mortismeae.
5. Sume arma tuatpharetram , et arcum,etegredereforav : cum»que venatu aliquid ap-prehenderis,
4. Fac mihi indepul-
a Isacco erainvecchiato , e se gli e-ra infiacchita la vista ,e non poteva vedere: echiamò il figlio suomaggiore Esaù , e glidisse : Figliaci mio? Kquegli rispose: Eccomiqui.
2. A cui il padre: Tuvedi , disse , che io sonvecchio, e noti so ilgiorno della mia morte.
3. Prendi le tue ar-mi , il turcasso , e l'ar-co, e va fuori : e quan-do avrai preso qualchecosa alla caccia,
4« Fammene una pie*
Vcrs» i. Era invecchiato. Egli avea allora cento ttentasetteermi, e Giacobbe ne avea settanta sette.
Se gli era infiacchita la vista, ec. Fosse per malattia * oper ragion dell'età, egli avea perduto la vista; cosi disponendope' suoi altissimi fini la Providenza. Non sappiamo , se ne* qua-rantatrè anni ch' ei sopravvisse, gli fosse renduto il lume degliocchi. Isacco adunque ridotto in tale stato fu mosso intcriormen-te da Dìo a fare quello che vedremo.
* Se gli era indebolita la villa. Se gli erano contratti, ri-stretti gli occhi.
Pent. Vol. I. 12

mentum^ sicut velle menosti, et affer, ut come-dum : et benedicat tibianima mea antequammoriar.
6. Quod cum audis-set Rebecca , et ille ab-iisset in a^rum^ utjus-sionempatrìs impleret>
6. Dixil filio suo Ja-cob : Audivì patremtuum locjuentem cumEsau fratre tuo, et di-centem ei :
7. Affer mihi de ve-natione tua, etfac cibos,ut comedam, etbenedì-
tanza nel modo, chesai, che a me piace , eportamela, perchè io lamangi : e 1' anima miali benedica avanti cha10 muoia.
5. La qual cosa aven-do udito Rebecca , edessendo quegli andatoalla campagna per fare11 comando del padre ,
6. Disse ella a Gia-cobbe suo figliuolo: Hosentito tuo padre par-lare con Esaù tuo fra-tello , e dirgli :
7. Portami della tuacacciagione, e fammiuna pietanza , perchè
Vers. 7. Dinanzi al Signore. Alla presenza di Dio, e colla au-torità datami da Dio. Osservisi in questo luogo , quanto ammira-bile sia Dio nell'eseguire i suoi disegni, e adempir le promesse.Esau non fu mai più sicuro di adesso della benedizione del pa-dre: Giaoobbe non ebbe mai minor motivo di sperare d'esseregli il benedetto ; contuttociò Esau perde la benedizione, e Gia-cobbe la guadagna in suo luogo. Ma qual benedizione volea Isac-co dare ad Esau ? Voleva egli forse opporsi ali' espressa dichiara-zione di Dio , il quale avea detto: il maggiore servirà al mino-re? Alcuni sciolgono questa difficoltà con dire, che ad Isacco nonfosse nota questa dichiarazione: ma non è cosi facile a concepirsi,che Rebecca avesse tenuta per tanto tempo una tal cosa occultaal marito; e non è nemmeno credibile , che Isacco ignorasse lavendita de' diritti di primogenitura fatta da Esali a favor di Gia-cohbe. Sembra adunque piuttosto da dirsi, che Isacco vicino,com'ei crede vasi , a morire, determinasse di benedire Esau , se-guitando l'ordine della.natura; e di regolarsi dipoi, quanto a'ter-inini della benedizione, secondo l'ispirazione di Dio. Può an-ch' essere , ch' egli pensasse , che la parola di Dio dovesse aversuo effetto non riguardo a' <iue fratelli, ma solo riguardo a' lorodiscendenti.

eam ubi coram Dominoantequam moriar :
8. Nunc ergo, fili mi,accjuie s ce consiliis meis:
9. fàtpergensadgre-gem affer mihi duoshaedos optimos , ut fa-ciam ex eis escas pa-tri tuo , quibus libentervescitur :
i o. Quas cum intule-ris, et comederit, bene-dicat libi priuscfuammoriatur.
11. Cui ille respon-dit: N&£tì, quod Esaufrater néeus homo pilo-su$ $it, et ego lenis.
12. Si attrectaveritme pater meus> et sen-serit, timeo , ne putet,me sibi voluisse illu-dere, et inducam superme maledicùonem probenedizione.
13. Ad quem mater*In me sit, ait, ista ma-le die tio, filimi: tantumaudi vocem meam , etper gens affer, quaedi-xi.
jo la mangi, e ti bene-dica dinanzi al Signoreprima di morire:
8. Ora dunque, fi-gliuol mio , attienti almio consiglio;
9. E va alla greggia ,e portami due de' mi-gliori capretti, affinchèio faccia pel tuo padrele pietanze , delle qua-li con piacere si ciba :
10. Le quali quandotu avrai portate a lui,ed egli le avrà mangia*te, ti benedica primadi morire.
11. Le rispose egli :Tu sai che Esaù miofratello è peloso , ed iosenza un pelo.
12. Se mio padre vie-ne a palpeggiarmi, e miriconosce , temo, cheei non si pensi, che ioabbia voluto burlarlo,onde io mi tiri addossola maledizione in cam-bio della benedizione.
13. La madre a lui :Sia sopra di me , disse,questa maledizione, fì-gliuol mio : solamentefa a modo mio, e va to-sto , e porta quello cheho detto.

14. Aliiti et attutitideditque matri. Para-vìt illa cibos, sicut vel-le noverai patrem illius.
15. Et vestibus Esauvalde bonis\ quas apudsehabebat domi, induiteum:
\ 6. Pelliculasq uèhaedorum circumdeditmanibus , et colli nudaprotexit.
17. Deditquepulmen*tum, et panes, quos co*x erat, tradidit.
18. Quibus illatis,dùcit: Pater mi? At il-le respondit'. Audio.Quis es tu tfili mi ?
14. Andò , e portò, ediede alla madre. Ellacondizionò le pietanze,come sapeva esser digenio del padre di lui.
16. E lo rivestì dellevesti migliori di Esaù ,le quali ella teneva incasa presso di sé:
16. E le mani diluìinvolse colle delicatepelli de' capretti, e nericopri la parte nudadel collo."17. E diede ( a lui)
le pietanze , e i pani,che ella avea cotti.
18. I quali avendoegli portati dentro, dis-se : Padre mio ? E que-gli rispose : Che vuoi ?Chi sei tu, figliuol mio?
Vers. 13. Sia sopra, di ine «. questa, maledizione. Parla cosìnon per disprezzo della maledizione d'Isacco ; ma per quella in-terna certezza che ella avea del buon esito del suo disegno ; cer-tezza fondata sulle promesse di Dio.
Vers. 15. E Lo rivesti delle vesti migliori di Esali, le qua."li ec. Gli Ebrei presso s. Girolamo, e dietro ad essi alcuni inter-preti credono che queste vesti fossero non vesti comuni : peroc-ché queste è da credere, che fossero sotto la custodia delle mo-gli di Esa'u ; ma dicono , che fossero le vestimenta , delle quali siserviva Esali, quando in qualità di primogenito offeriva i sacrili-zii; le quali perciò, come cosa sacra, erano dalla madre di fami-glia serbate in casse odorose: imperocché non a caso è stato no-tato, che queste vesti le avea Rebecca presso di sé in casa, ovve-ro nella cassa, come potrebbe tradursi, vedendosi, che le cassed'avorio piene di odori, nelle quali conservavansi le vesti, sonochiamate case d? avorio nel Salmo 44- vers- I °'

i g. Dixitque Jacob\Ego sum primogenitustuus Esali: feci sicutpraecepisti mihi : surge,sede, et comede de ve-natione mea , ut bene-dicat mihi anima tua.
20. "Rursumque /-saac ad filium suumi
19. E Giacobbe dis-se : Io sono il tuo pri-mogenito Esaù: ho fat-to quel che m' hai co-mandato: alzati, siedi,e mangia della mia cac-ciagione, affinchè l'ani-ma tua mi benedica.
20. E soggiunse Isac-co al figliuol suo : Co-
Vers. if). Io sono il tuo primogenito Esaìi. Sono qui divisi iPadri e gl'interpreti, alcuni biasimando assolutamente Giacobbe,altri difendendolo o in tutto , o in parte. Ecco adunque in pocheparole quello che può servire a giudicare di questo fatto.
In primo luogo. La menzogna è sempre illecita, ed è sem-pre di natura sua un peccato, come egregiamente dimostra 0.Agostino.
In secondo luogo. Giacobbe menti e colle parole, e co'fatti;perocché e colle parole, e co' fatti procurò e ottenne di farsi cre-dere Esaù.
In terzo luogo. La ragion del mistero riconosciuto da tuttala Chiesa in questo avvenimento non iscusa la bugia di Giacob-be ; imperocché quantunque Dio e lo Spirito Santo siasi servitodell'inganno fatto al patriarca per adombrare, e predire un gran-dissimo arcano ; l'inganno però e la falsità di Giacobbe non can-giano perciò di natura , come da tanti altri fatti apparisce,ne' quali il mistero per essi significato non toglie la colpa ; cosìl'incesto di Thamar, ec.
In quarto luogo. Posto però che Giacobbe uomo semplice eschietto non fa altro che obbedire alla madre, persuaso che, se-condo il volere di Dio i diritti di primogenito a lui appartenga-no , e che sopra di questi avea egli acquistata nuova ragione collarinunzia e la vendita fattane a lui dal fratello ; mi sembra per-ciò potersi dire non solamente, che l'inganno usato da Giacobbe,non essendo nè dannoso, nè ingiù ioso ad alcuno, potè esserecolpa meramente leggera; ma ancor che poste le circostanze giàdette, potè ed egli, e Rebecca cred r lecita la menzogna e l'in-ganno, come usato Soltanto a vend ^are quello che era già suo.Se tanti grandi uomini celebri p r virtù e per dottrina nellaChiesa cristiana hanno potuto crede e esente da colpa e Giacob-be e Rebecca , sembra potersi dire, che molto più potè l'uno el'altra credere, benché erroneamente, lecito quello che l'unaconsigliò e l'altro eseguì.

Quomodo , inquit, tamcito invertire potuisri^fili mi ? Qui respondit:Voluntas liei fuit, ut ci-to occorrerei mihi, quodvolebam.
21. Dixitque Isaac:Accede huc, ut tangamte, fili mi, et probem,utrum tu sis filius meusEsau, an non»
22. Accessit ille adpatrem, et palpato eo,dixit Isaac : Vox qui-dem vox Jacob est\ sedmanus manus sunt E-sau.
23. "Et non cognoviteum, quia pilosae ma'nus similitudinem ma'joris expresserant. Be-nedicens ergo illi,
s»4' dìt : Tu e s filiusmeus Esau? Respon-dit : Ego sum.
26. At ille-. Affer mi-hi , inquit, cibos de ve-nalione tua, fili mi, utòenedicat tibi animamea, Quos cum oblatoscomedisset, obtulit eietiam vinum , quo hau-sto,
me, figliuol mio , haipotuto trovare cosippresto? Egli rispose:Fu volere di Dio, ch'iotosto m'imbattessi inquello ch' io bramava.
21. E Isacco disse :Appressati qua , ch3 ioti tocchi,, figliuol mio ,e riconosca, se tu sei, ono il figliuol mio Esaù.
22. S' appressò eglial padre , e quando i'ebbe palpato,disse Isac-co : La voce veramenteella è la voce di Giacob-be, ma le mani sonoquelle di Esaù.
a 3. E noi riconobbeperchè le inani peloseeran del tutto simili aquelle del maggiore.Benedicendolo adun-
Que >24. Disse : Tu sei il
figliuol mio Esaù ? Ri-spose : lo sono.
26. E quegli : Dam-mi, disse, figliuol mio ,le pietanze di tua cac-ciagione, affinchè l'ani-ma mia ti benedica.Portate le quali, e man-giate , ( Giacobbe ) glipresentò anche il vino,e bevuto cha 1' ebbe ,

12 6. "Ùtxit ad eum :'Accede ad me, et damihi osculum , fili mi.
2j. Accessit, et oscu-latus est eum. Statim-que ut sensit vestimen-forum illius fragran-tìam, benedicens illi,aiti Ecce odor filii meisicut odor agri pieni,cui benedixit Dominus.
28. DettibìDeus derore coell, et de pingue-dine terras abundan-tiamfrumenti, et vìni\
29. 'Et serviant tibipopuli, et adorent tetribus : esto dominusfratrum tuorum, et ìn-curventur ante te filiimatris tuae. Qui male-dixerit tibi 3 ille male-
26". Disse a lui: Acco-stati a me, figlino! mio,e dammi un bacio.
27. Si appressò, ebaciollo, E tosto cheegli sentì la fragranzadelle sue vestimente }benedicendolo disse :Ecco l'odore deliigliuolmio è come 1' odore diun campo ben fiorito ebenedetto dal Signore.
28. Dia a te il Si-gnore la rugiada delcielo , e la pinguedinedella terra, e l'abbon-danza di frumento , edi vino;
20. E servi a te sieno*ipopoli, e ti adorinoletribù : sii tu il signorede' tuoi fratelli , e s'in-chinino dinanzi a te ifigliuoli della tua ma-dre. Chi ti maledirà,,
Vers. 27. SenÙ la fragranza delle sue veslìmenta, ec. Ab-biamo detto di sopra, che queste vesti erano custodite in cassepiene di odori. Vedi oltre il Salmo 44- Cani. iv. 11. E general-mente gli antichi amavano le vesti profumate di odori. VediPlin. lib. xxi. cajy. ic). xn. 3.
Vers. 28. Dia a te il Signore la rugiada del cielo, ec. Aven-do paragonato il figliuolo a un campo ben fiorito e benedettoda Dio, persistendo in quella similitudine, Isacco domanda a Dio,che dia al figliuolo la rugiada del cielo ; perchè nella Palestina ,non piovendo per lo più se non circa il settembre e circa l'apri-le, le piante e l'erbe sono ne'tempi di mezzo bagnate dalle co-piose rugiade. Vedi Jud. v. 38.

dictus\ et quibenedixe-rit tibi, benedictionibusrepleatur.
30. Vix Isaac ser-mojiem impleverat : etegresso Jacob foras,venit Esau,
31. Coctosque de ve-natione cibos intulitpa*tri dicens : Surge, pa-ter mi, et comede devenatione filii tui ; utbenedica* mihi animatua.
32. Dixitque illi /-$aac: Quisenimestu?Qui respondit: Ego sum
filius tuus primogenitusEsau.
33. Expavit Isaacstupore vehementi : etultra quam credivotest,admirans ait : Quis i-gitur ille est, quidudumcaptam venationem at-tuBt mihi, et comedi exomnibus priusquam tu
sia egli maledetto \ echi ti benedirà , sia dibenedizioni ricolmo.
30. Appena avea Isac-co finite queste parole:e Giacobbe se n'era an-dato, quando arrivò E-saù.
31. E le pietanze disua cacciagione cucina-te portò al padre suo,dicendo : Alzati, padremio, e mangia della cac-cia del figliuol tuo ; af-finchè l'anima tua mibenedica.
32. E Isacco gli dis-se : Ma chi sei tu ? Ri-spose egli : Io sono ilfigliuol tuo primogeni-to E saù,
33. Inorridì per gran-de stupore Isacco: e ol-tre ogni credere stupe-fatto disse: Chi è adun-que colui, il quale giàa me portola presa cac-ciagione , e io di tuttomangiai prima che tu
Vera. 9.9. Servi a te fieno t popoli, e ti adorino le tribù. ILXX leggono: siena a te servì i popoli, e lì adorino i principi.
Sii tu il signor e d(? tuoi fratelli, ec. Nelle parole prece-denti possono intendersi i popoli e i regni stranieri che saranno«oggetti a' discendenti di Giacobbe ; in queste i posteri di Esaue quelli di Agar e quelli di Cetura.

vemres ? benedixirjueci, et erit benedictus.
34- Auditis Esau $er*moribus patrisy irrugiitclamore magno, et con-sternatus ait\ Benedicetiam et mihi, pater mi.
35. Qui aiti Venitgermanus tuus fraudu-lenter, et accepit bene-dictionem tuam.
36. At ille subjunxit:Juste vocatum est no-men ejus Jacob : sup-plantavit enim me enaltera vice : primogeni-ta mea ante tulit , etnunc secundo surripuitbenedictionem meam.Rursumque ad patrem:Hfunquid non reserva-
venissi? e io l'ho be-nedetto , e benedettosarà.
34. Udito il discorsodel padre, ruggì Esaù,e die grande strido , ecosternato disse: Dà labenedizione anche ame , padre mio .
35. Disse egli : Ven-ne cori astuzia il tuofratello , e si prese latua benedizione,
36. Ma quegli sog-giunse : Con giustiziafu a lui posto nomeGiacobbe : imperocchéecco che per la secondavolta egli mi ha sop-piantato : mi tolse giàla mia primogenitura ,e di nuovo la mia be-nedizione mi ha tolto.
Vers. 33. Inorridì per grande stupore ec. I LXX: Usci fuordi se per una. grande eslasi: e in questa grande estasi, dice s.Agostino, che gli fu svelato tutto il mistero ed ebbe cognizionede' decreti di Dio : ciò ben si conosce dal raffermare, ch' egli faimmediatamente la benedizione già data: io V ho benedetto e be-nedetto sarà : e ciò in un tempo, in cui pareva che piuttosto do-vesse accendersi d'ira contro chi lo avea ingannato, e ritrattarequello che avea fatto per ignoranza. Non si può qui non ricono-scere il dito di Dio, e 1' operazione del suo spirito nel cuored'Isacco.
Vers. 34 ... 38, Ruggì Esali, e die grande strido, ec. A questeparole allude l'Apostolo, quando dice, che Esau non trovo luogoa penitenza, benché con lagrime la ricercasse. He.br. xu. ij.Vedi le note in questo luogo.
12 *

sti, ait, et mihi bene-dictionem?
Sap. 26. 33.
37. Respondit Isaac:Dominum tuum illuniconsti tui, et onuies fra-tré s ejus servituti illiusjsubjugavi : frumento, etvino stabilivi eum : etubi post haec, fili mi,ultra quid faciam ?
38. Cui Esau : Numunam, inquit, tantumbenedictionem Jiaòes,pater ? mihi quoque ob-secro, ut benedicas.Cumque ejulatu magnofieret,
3p. Motus Isaac di-xìt ad eum: (i) In pin-guedine terrae et in ra-re coeli desuper
4-0. "Erit benedictiotua. Vives in gladio, etfratri tuo serviesi tem-pusque veniet, cum ex-
E di nuovo disse al pa-dre : Non hai tu^'o pa-dre, serbata benedizio-ne anche per me ?
37. Rispose Isacco:xIo lo ho costituito tuo^signore, e ho soggetta-ti ai suo servaggio tut-ti i suoi fratelli : lo hofatto forte a frumento,e a vino: e dopo di ciò,che farò io ancora perte , figlio mio ?
38. Disse a lui Esaù;Hai tu, o padre, soluna benedizione ? be-nedici, ti prego, ancheme. E piangendo egli,e urlando altamente,
39. Commosso Isac-co gli disse : Nella pin-guedine della terra, enella rugiada di su dalcielo
40. Sarà la tua bene-dizione. Viverai dellaspada , e sarai servodel tuo fratello: e tem-
fi ) Hebr. » i. ao.
Vera. 3g. Nella pinguedine della, terra e nella, rugiada., ec.Avrai una terra fertile e renduta vie più feconda dalle rugiadedel cielo. I monti di Seir erano molto fertili, Gen. xxxvi. 6. 8. efurouo di Esaìi, Jud. xxiv. 4- Ma questa fu la minima delle bene-dizioni date a Giacobbe.

cutias, et solvas jugumejus de cervicibus tuis.
41. Oderatergosem-, per EàSau Jacob pro be-nedicdone^ qua benedi'x erat ei patera dixitquein corde suo: (i) Ve-nient dies luctus palrismei, et occidam Jacobfratrem meum.
42. Ifuntiate sunthaec Rebeccae : quae
^mittens, et vocans Ja-cob filium suum, dixitad eum: EcceEsaufra-ter tuus minatur., ut oc~cidat te.
po verrà , che tu scuo-terai , e scioglierai dai'tuo collo il suo giogo.
4*. Esaù adunqueavea sempre in odioGiacobbe per la bene'dizione, che questi avearicevuto dal padre ; edisse in cuor suo: Ver-ranno i giorni del lut topel padre mio, e io am-mazzerò Giaeobbe miofratello.
42- Fu ciò riferito aRebeeca: la quale man-dò a chiamare Giacobbesuo figlio , e gli disse :Ecco che Esaù tiio fra-tello minaccia d' ucci-derti.
(i) Abd. io.M.ers. 4<°- Priverai-della spada,. Predice lò spirito feroce e
guerriero degP Idumei discendenti di Esau. Intorno a che vediGiuseppe de Bel. lib. iv. cap. v.
Sarai servo del tuo fratello: e tempo verrà ec. Gì'Idumeifuron soggetti a' re di Giuda da David fino a Joraro. Vedi 4-Reg. vai. 20. Al tempo di Joram si ribellarono, e si crearonoun re.
Egli è da notare, come la benedizione stessa data ad Esauè una confermazione di quella che avea avuto GiacoBbe.
Yers. 41- berranno i giorni del lutto pel padre mio, ec. Puòsignificare primo: ferrei il tempo che mio padre, morrà, e sifarà duolo per lui, e allora io ammazzerò mìo frarelio : ov-vero: Verrà il tempo che mìo padre avrà da piangere perquel di' egli ha fatto in favor di Giacobbe, perche io uc^ideruGiacobbe, e il padre morrà di dolore, i LXX leggono: Vaiila-no presto i giorni del lutto del padre mio. Ho tradotto iu -uisuda lasciar luogo al doppio senso. Dal versetto fa. 45. appariscech« Rebecca credette Esau disposto a uccider Giacobbe alla pri-uva occasioiiCa

1^3 .Nunc ergo,fili mitandi vocem meam, etconsurgensfuge ad La-ban fratrem meum inJìaran :
44- "Rabitabisquecum eo dies paucos, do-li ec requiescatfurorfra-tris tui;
45. Et ce s set indi'gnatio ejus, oblivisca-ture/uè eorum, quae fé-cisti in eum • posteamittam, et adducam teinde huc. Cur utroqueorbaborfilio in uno die?
l\6.Dixitque Rebeccaad Isaac : (i) Taedetme vitae meae propterfilias Heth. Si accepe-rit Jacob uxorem destirpe hujus terra e, no-lo vivere.
fi) Supra 26. 35.
43. Or adunque, figliomio, credi a me, e fug-gi tosto a casa di Labarimio fratello inHaran:
44- E con lui ti sta-rai per un poco di tem-po , fintantoché si am-mansisca il furore di tuofratello ;
46. E passi la sua ira-condia , e si scordi del-le cose , che tu gli haifatte t poscia io mande-rò chi di là ti riconducain questo luogo. Perchèdovrò io perdere tuttidue i figli miei in un soigiorno ?
46. E disse Rebeccaad Isacco : Mi viene anoia la vita a causa diqueste figliuole diHeth.Se Giacobbe prende unamoglie della razza diquesto paese, io non vo-glio più vivere.
Yers. 45. Perche dovrò io perdere ambedue i figli mìei inan sol giorno? Ucciso l'uno, l'altro sarà costretto ad andare ra-mingo, onde io reslerb senza figli.
Vera. 4& Mi viene a noia la vila^ a causa di queste ec. Eccoun altro gran motivo , per cui Rebecca spinge Giacobbe ad anda-re nella Mesopotamia affinchè egli prenda ivi per moglie unafanciulla della sua stirpe, i costumi della (juale convengano a leipiù clic quelli delle mogli di Esali.

C A P O XXVIII.
Giacolle, ricevuta la benedizione del padreparte verso la Mesopotamia. Vede in sognouna scala, alla quale era appoggiato il Si-gnore. Promessa a lui fatta di quella terra,e della moltiplicazione della sua stirpe. Voto,die egli fa al Signore nello svegliarsi.
1. r ocavit itaque 1-saac Jacob , et benedi'xit eum, praecepitqueei dicens : Noli accipereconjugem de genereChanaan :
2. Sed vade , et pro-ficiscere in Mesopota*miamSyriae ad domumBathuel) patris matristuae , et accipe tibi in-de uxorem de filiabusLaban avunciili tui.
3. Deus autem omni-potens benedicat tibi> etcrescere te faciat, at-que multiplicet-, ut sisin turbas populorum.
4. Et det tibi bene-dictiones Abr'aliae, etsemini tuo post te ; ut
1. -Isacco adunquechiamò a sé Giacobbe ,e lo benedisse, e gli die-de questo comando, di-cendo: Non prender mo-glie della stirpe di Gha-naan i
2. Ma parti, e va nel-la Mesopotamia di Siriaalla casadiBathuele, pa-dre di tua genitrice, equindi prenditi una mo-glie delle figlie di La-ban tuo zio.
3. E Dio onnipotenteti benedica, e ti facciacrescere , e ti moltipli-chi ; onde tu sii capo dìuna turba di popoli.
4. E dia egli le be-nedizàoni di Abramo ate, e alla tua stirpe do-
Vers. i. * /sacco chiamo. Fece venire.Ycrs. 2. Ma parti e va, ec. 1 LXX sorgit fuggì- ^ec** sea xtl-
il, Sap. x, IQ,

possideas terram pere*grinationis tuae, quampollicitus est avo tuo.
6. Cumquedimisisseteum Isaac, profectusvenit in MesopotamiamSyriae adLaban, filiumBatìiuel Syri, fratremKebeccae matris suae.
Osce 12. 12.
6. Videns autem E-sauì quod benedixissetpater suus Jacob , etmisisset eum in Me-sopotamiam Syriae, utinde uxorem ducereteet quod post benedictio-nem praecepisset ei, dì-cens : Non accipie-s u*xorem de filiabus Cha-naan :
7. Quodque obediensJacob parentibus suis,i&set in Syriam :
8. ProbaJts quoque,
po di te; onde tu sii pa-drone della terra, dovesei pellegrino, promes-sa da lui al tuo nonno.
5. Licenziatosi Gia-cobbe da Isacco, si par-tì , e giunse nella Me-sopotamia di Siria allacasa di Laban, figliuolodi BafeWele Siro, fra-tello di Ilebecca sua ma-dre.
6. Ma reggendo Esaù,come il padre suo aveabenedetto Giacobbe, elo avea mandato nellaMesopotamia di Siria aprendervi moglie, e co-me dopo la benedizio-ne gli avea dato que-st'ordine dicendo : Nonprenderai in moglie al-cuna delle figlie di Cha-naan :
7. E come obbeden-do Giacobbe a' suoi ge-nitori, era andato nellaSiria :
8. A.vendo ancora spe-
Vers. 4- E dia egli te benedizioni di /(bramo a te, e alla tuastirpe ec, CWi le promesse di Dio concernenti il dominio dellaterra di Chanaan , la moltiplicazione della stirpe, e (quello cheogni altra felicità sorpassa) il Cristo che da questa stirpe doveanascere, queste promesse fatte ad Àbramo e ad Isacco sono ap-propriate a Giacobbe e a'discendenti di Giacobbe, com* osservas, Agostino th ciV. xvi. 38.

quod non libenter aspi-cerei filias Chanaanpa-ter suus :
p. Ivit ad Ismaelem," et duxituxorem absque
iis> quas prius kabebatìMaheleth ^ filiam Is-mael, filii Abraham,sororem Nabajoth.
10. Igitur egressusJacob de Bersabee,pergebat Haran.
11. Cumque venissetad quemdam locum, etvellet in eo requiescerepost soliò' occubitum,tulit de lapidibus , quijacebant, et supponenscapiti suo , dormwit ineodem loco.
12. Viditque in somniis scalarti stantemsuper terram , et cacu-men illius fan gens eoe-luni : Angelos quoqueDei ascende n te s, et de-scendentes per eam,
rimentato , Che non dibuon occhio vedeva ilpadre suo le figlie diChanaan:
9.Andò alla casa d'Is-maele , e prese moglie,oltre quelle che primaavea, Maheleth, figliuo-la d'Ismaele , figliuolodi Abramo , sorella diNabajoth.
10. MaGiacobbe par-tito da Bersabee, anda-va verso Haran.
11. E arrivato in uncerto luogo , e volendoivi riposare dopo il tra-montare del sole, preseuna delle pietre, che e-rano per terra , e se lapose sotto del capo, e nelluogo stesso si addor-mentò.
12. E vide in sognouna scala appoggiataalla terra , la cui som-mità toccava il cielo: egli Angeli di Dio , chesalivano per essa, escendevano,
Vera. 9. Ando alla casa. cT Ismaele. Ismaele era già mortoquattordici anni prima. Con questo nuovo matrimonio sembra ,che Esau cerchi di racquistare la grazia de'genitori ; ma per pic-ca verso il fratello, ch' era andato a cercare una moglie della ca-sa di Nachor, egli va a prendere una figliuola d'Ismaele. Miike~leth è chiamata altrove Busemath. Vedi Gsn. sxxvi. 3.

13. Et Dominum in»nixum scalae dicentemsibi: (i) Ego sum Do-minus Deus Abrahampatris lui, et DeusIsaac : terram , in quadormìs, libi dabo , etsemini tuo.
i4- TZritque sementuum quasi pulvis ter"rae: dilataberis ad oc-cidentem , et orientem.
13. E il Signore ap-poggiato alla scala, ilquale a lui diceva s- Iosono il Signore Dio diAbramo tuo padre , eDio d'Isacco : la terra ,in cui tu dormi, la da-rò a te, e alla tua stirpe.
i4- E la tua stirpe sa-rà pme la polve dellatetta : ti dilaterai a oc-cidente, e ad oriente, e
(i) Infra 35. i. 48. 3.
Vers. 12. e 13. Vide una /cala appoggiata alla terra, ec.E il Signore appoggialo alla scala, ec. In questa scala, secondola più ordinaria sposizione, si ha una immagine della Previdenzadivina, onde in capo di essa vedesi Dio. Gli Angeli che salgonoe scendono, sono i ministri ed esecutori della Previdenza. VolleDio con questa visione consolare Giacobbe, il quale fuggiascodalla casa de' genitori per timor del fratello, coli' animo pieno ditristezza riposava sopra di un sasso. A lui dunque fa vedere que-sta scala che va fino al cielo ; gli fa vedere gli Angeli che per or-dine di Dio si adoperano a benefizio e consolazione de' giusti, egli fa vedere Dio stesso protettore e rimuneratore della virtù.Ma forse con più ragione diremo, che per questa scala lo SpiritoSanto volle significare l'incarnazione del Verbo di Dio , il qualedovea nascere di Giacobbe, e scendere per varii gradi e genera-zioni fino alla terra, quando lo stesso Verbo fu fallo carne, e ilcielo riunì colla terra, e le somme alle infime cose, e P uomocongiunse con Dio. Scendono ad annunziare si gran novità gliAngeli, e salgono a riportare i ringraziamenti e le benedizioniche a Dio danno i giusti per un* opera così grande. Qual consola-zione ali' afflitto e ramingo Giacobbe il vedere adombrato sottoi suoi occhi un mistero si grande, vedere il Cristo che dovea na-scere del suo sangue, e nel quale tutte le promesse di Dio fattea lui e a tutti i suoi padri doveano avere il pieno e perfetto loroadempimento !
La terra, in cui tu dormi, ec. Giacobbe era tuttora nel pae-se di Chanaan , ma presso a' confini.
A te e alla tua stirpe. Vuol dire a te, o sia alla tua stir-pa; perocché la particella e molte volte è esplicativa.

etseptemtrionem, et me-ridiem\ (i) et B E NE-DICENTffR IN TE,et in semine tuo cun-ctae tribus terrete.
15. Et ero custostuus , quocumque per*rexeris , et reducam tein terram hanc : necdimittam, nisi compie-vero universa, quaedixi.
16. Cumque evigilas»setJacobde somno^ aitiVere Dominus est in lo-co isto , et ego nescio*bam.
17. Pavensque\ Quamterribilis , est, inquit,locus iste ! non est hicaliud) nisi domus Dei,et porta coeli.
(i) Deut. 12. 20. 19. 8.
a settentrione, e a mez-zo giorno, e IN TE , enel seme tuo SARANBENEDETTE tutte letribù delia terra.
15. E io sarò tuo cu-stode,in qualunque luo-go anderai: e ti ricon-durrò in questo paese :e non ti lascerò senzaavere adempiuto tuttoquello che ho detto.
16. E svegliatosi Gia-cobbe dal sonno, disse:Veramente il Signore èin questo luogo, e io noisapeva.
17. E pien di paura !Quanto è terribile, dis-s' egli, questo luogo !non è qui altra cosa, senon la casa di Dio? e laporta del cielo.
Vers. 14. E IN TE, e nel teme"tuo SARAN BENEDET-TE ec. Anche queste parole debbono intendersi nella stessamaniera: IN TE, o sia nel seme tuo: il qual seme è Cristo. Co-si Dio viene qui egli stesso colle parole ad esporre al patriarcaquello che avea voluto dimostrare col simbolo della misterio-sa scala.
* Ti dilaterai. Ti forai largo.Yers. 16. Svegliatosi ...disse: fieramente il Signore à in
questo luogo. Giacobbe svegliatosi colla mente piena di tuttoquello che avea veduto e udito , crede di essersi messo a dormi-re senza saperlo in un luogo consecrato al Signore ; mentre ivise gli era dato a vedere, e gli avea parlato con tanto amore.

18. Surgens ergo Ja-cub mane, tulitlapìdemyquem supposuerat ca-piti suo, et erexit in ti-tulum, (\)fundens o-leum desuper.
19. Appellavitquè no-men urbis Bethel, quaeprius Luza vocabatur.
18. Alzatosi adunqueal mattino Giacobèe ,prese la pietra, cheaveaposta sotto il suo capo,e la eresse in monumen-to, versandovi sopra del-T olio.
19. E alla città, cheprima chiama va si Luza,diede il nome di BetheL,
(i) Supra a6. 4-
Tera. 17. Quanto e terribile ... questo luogo! non b qui altra.èosa,ec. Quanto venerabile, e sacrosanto è questo luogo, doveDio si fa vedere, come in sua casa, e dove mi è stata mostrata lamistica scala, per cui gli Angeli scendono, e salgono, e la via, ela porta dimostrano per entrare nel cielo! Questa via, e questaporta è Cristo, come dicemmo. Vedi Joan. x. g. Non sarà inutiledi osservare, come fin da que' tempi si degnò Dio d'illustrarecerti luoghi con apparizioni, e miracoli, e favori a pro degliuomini.
Vers. iS. La eresse in monumento, versandovi ec, Giacobbealza in quel luogo la pietra per memoria sacra e religiosa dei-gran favore ivi ricevuto da Dio, e perciò unge con olio la stessapietra, come per consacrarla, La Chiesa cattolica prese quindi1' esempio della unzione sacra, colla quale a Dio si dedicano i«uoi templi, e gli altari, Giacobbe non. si fa un idolo di questapietra, nè verun culto superstizioso le rende; ma la innalza sol-tanto in commemorazione delle grazie ivi ricevute da Dio. Vedicap. xxxv. 3. Ma gl'idolatri, a'quali si vede evidentemente, chepassò la notizia di questo gran fatto, lo depravarono, e della pie-tà di Giacobbe si fecero argomento dell'antichissimo vituperosoculto, che da lor si rendette alle pietre, le quali furono chiama-te Belhule dal luogo stesso diBethel, dove lasciò Giacobbe iljuo monumento. Alcune erano consacrate a Saturno, altre al so-le, altre ad altri dei; e di esse raccontavano grandissime favole,come per esempio che avessero vita e moto, rendessero oracoli ec.
Vers. ig. E alla citta che prima chiamatasi Luza, ec. Illuogo prima chiamavasi Luza dalla copia de' mandorli che vi sitrovava; e lo stesso nome avea la città, o sia il borgo, presso ilquale dormì Giacobbe; e questi al luogo e alla città diede il no-me di Betbel, cioè casa di Dio.

20. Vovit edam va-tum , dice n s ; Si fueritDeus mecum , et custo-dierit me in vìa , perquam ego ambulo, etdederit mihi panem advescendum., etvestimejt-tum ad induendum,
21. Reversusque fue-ro prospere ad domumpatris mei', erit mihiDominus in Deum,
2 2.Et lapis iste, quemcrexi in titulum , voca-bitur domus Dei-, cun-'ctorumque , quae dede-rìs mihi, decimas offe*ram dbi.
20. Fece ancora voto,dicendo: Se il Signoresarà con me, e sarà miocustode nel viaggio dame intrapreso, e mi da-rà pane da mangiare, eveste da coprirmi,
21. E tornerò felice-mente alla casa del pa-dre mio , il Signore sa-rà mio Dio,
22. E questa pietraalzata da me per mo-numento, avrà il nomedi casa di Dio: e di tut-te le cose , che darai am*5, tiofferiròla decima.
Ver», ai . e aa, U Signora sarà mìo Dìo, e questa pietra ec.Con queste parole il Signoro sarà mio J9i'o, Giacobbe non pro-mette a Dio il culto interiore ed esterno, secondo il quale eglilo avea per suo Dio fin dal primo momento della sua nascila;ma promette le speciali esteriori dimostrazioni di culto e di gra-titudine, come l'erezione di un altare in quel luogo , l'offertadelle decime, ce. »
* Ti offerirò la decima. Da erogarsi o ne' saerilùii «Ile a te«i debbono, o in quello che ti piacerà d'ordinare.

C A P O XXIX.
Giacobbe accolto da Laban serve a lui per pat-to sette anni per aver la figlia di lui Rachele.Gli vien data Lia in vece di quella : ed egliè costretto a servire per la medesima settealtri anni. Rachele è sterile, e Lia partoriscequattro figliuoli.
1. JLrofectus ergoJacob venit in terramorientalem.
2. Et vidit puteumin agro, tres quoque gre-ges ovium accubantesjuxta eum : nam ex illoadaquabantur pecora, etos ejus grandi lapideclaudebatur*
3. Morisque erat, utcunctis ovibus congre-gatis devolverent lapi-dem, et refectis gregi-bus rursum super os pu«tei ponerent.
4- Dixitque adpasto-res : Fratres, unde e-s tisi Qui responderunt:De Ilaran.
1. JL artitosi quindiGiacobbe giunse nellaterra d' oriente.
2. E vide in un cam-po un pozzo , e pressoa questo tre greggi dipecore sdraiate : peroc-ché a questo si abbeve-ravano le pecore , e lasua bocca era chiusa conuna gran pietra.
3. Ed era usanza, cheraunate tutte le pecoreribaltavan la pietra, eristorati i greggi la ri-mettevano sopra la boc-ca del pozzo.
4. Ed egli disse a'pa-stori : Fratelli, dondesiete ? Ed ei risposero :Di Haran.
Vcrs. i. Nella terra cT oriente. La Mesopòtamia, e i paesi ol-tre l'Eufrate sono indicati nella Scrittura col nome di oriente.
Vers. 2. E la sua bocca era cliiusa con una pietra. Cautelaopportuna in un paese che scarseggiava d'acqua, affinchè i greggil'avesser più pura e salubre e abbondante.

6. Quos interrogane:ffiunquid, etiti nostisLaban> filium Nachor ?Dixerunt: Novimus.
6. Sanus ne est? in*quit. Valet, inquiuntiet ecce Rachelfilia ejusvenit cum grege suo.
7. Lixitque JacobiAdhuc multum dieisuperest, nec est tem-pus , ut reducantur ad•caulas greges: date an-te potum ovibus, et siceas adpastumreducite.
8. QuiresponderuntiUfon possumus, donecomnia pecora congre-gentur, et amoveamuslapidem de ore putei, utadaquemus greges.
9. Adhuc loqueban*tur, et ecce Rachel ve-niebat cum ovibus pa-tris sui : nam gregemipsa pascebatt
5. E interrogolli: Co-noscete voi forse La-ban, figliuolo di Na-chor? Dissero: Lo co-nosciamo.
6. È egli sano? dis-se egli. Risposero: Esano : ed ecco Rachelesua figlia , che vien colsuo gregge.
7. E Giacobbe disse;Rimane ancor moltodel giorno, e non ètempo di ricondurre igreggi ali' ovile : dateprima da bere alle pe-core , e poscia ricondu-cetele al pascolo.
8. Risposer quelli :Noi possiam fare , finoa tanto che sien radu-nate tutte le pecore,e tolta dalla bocca delpazzo la pietra , si ab-beverino tutti i greggi.
9. Non avean finitodi parlare, quand' eccoche Rachele veniva col-le pecore di suo padre :perocché ella pasceva ilgregge.
Vers. 5. Laban figliuolo dì Nachor. Laban era nipote di Na-ctior e figliuolo di Bathuel; ma Giacobbe nomina Nachor, coi»ecapo ili quella famiglia.
.Vers. G. * E egli sano? Ebr. Ha egli pace?

10. Quam cum vidis-set Jacobt et sciret con»svbrinam suam, oves*queLaban avunculisui^amovit lapidem, quoputeus claudebatur*
11. Et adaquato gre*ge , osculatiti est eam :et elevata voce flevìt,
12. Et indìcavit ei,quodfrater essetpatrissui, et filius Rebeccae:at illa f esdn an s nun-tiavit patri suo,
15. Qui cum audis-set venisse Jacob, fi-lium sororis suae, cu-cui^rit obviam ei : com-plexusque eum, et inoscula ruens duxit mdomum suam. Audìtisautem causis itineris,
14« "Respondit: O smeum es, et caro mea»
10. E avendola vedu-ta Giacobbe» e sapendoch' ella era sua cuginagermana , e che le pe-core erano di Labansuo zio, tolse la pietra,colla quale chiudevasiil pozzo.
11. È fatto bere ilsuo gregge, la baciò:e alzata la voce pianse,
12. E le accenno, co-me era fratello del pa-dre suo, e figliuol diBebecca: ed ella andò*in fretta a recarne nuo-va a suo padre.
io. Il quale avendoudito esser venuto Gia-cobbe , figliuolo di suasorella, gli corse incon-tro : e abbracciatolo , ebaciatolo, e ribaciatololo condusse a casa sua.E udite le ragioni deisuo viaggio,
i4- Rispose : Tu seiosso mio, e mia carne.
Ters. n. La baciò: e alzata la voce pianse. Il bacio era unamaniera di saluto usata particolarmente tra gli stretti parenti. Gia-cobbe pianse o per tenerezza, vedendosi giunto tra persone delsuo sangue, o, come altri pensano, per sentimento di dolore, ri-flettendo al povero stato, in cui si trovava, onde non avea nullada poter farne un presente alla cugina secondo il costume. Il ti-more del fratello, e la sollecitudine di schivare il suo sdegnolo avean fatto partire da casa solo, e seuz'altri preparativi, chemi poco di provvisione per vivere.

Et postguam impletisunt dies mensis unius.,
15. Dixit ei: Numquia frater meus e s,gratis servies mihi ?die quid mercedis ac*cipias,
16. Habebat veroduasfilias: nomen ma+joris Lia ; mmor veroappellabatur Racket»
17. Sed Lia lippiserat, oculisi Racket de»cora facie, et venusto
,aspectu.
E passato che fu unmese ,
16. Gli disse : Forseperchè tu sei mio fra-tello , servirai a megratuitamente ? dimmiquel che tu vuoi.
16. Or egli avea duefigliuole : la maggiorechiamavasi Lia; la mi-nore Rachele.
17. Ma Lia avea gliocchi cisposi : Racheleera bella di volto, e av-venente.
Vers. 14- Tu sei osso mio, e mìa carne. Siamo tu ed io dellostesso sangue; e perciò in casa mia avrai accoglimento, e sceglie-rai la consorte : la mia casa è tua casa.
Vers. 15. Servirai a me gratuitamente? Giacobbe non volen-do mangiare il pane a ufo, come si dice, in casa di Laban, si oc-cupava nelle faccende di casa, e nella cura de' greggi.
Vers. 16. La maggiore chiamavasì Lia; la. minore Rachele.Giacobbe è qui una bella figura di Gesù Cristo, Lia della sina-goga, Rachele della Chiesa cristiana. Lia maritata la prima, co-me di età maggiore, non ebbe mai intero il possesso del cuordello sposo; e se fu unita a Giacobbe, Io fu , per così dire , in
f razia di Rachele sotto il nome di cui la prese Giacobbe. Rache-e, l'amor di Giacobbe, acquistata con prezzo di sue fatiche, e
rispetto alla quale tutte le fatiche a lui sembrano un nulla-, Ra-chele amata con infinita costanza, Rachele è degna di rappresen-tare la Chiesa di Gesù Cristo. Alla fondazione di questa Chiesafuron dirette tutte le cure della Provvidenza divina fin dal prin-cipio del mondo, e i misteri, e i Sacramenti di lei furono figu-rati in tutte le ceremenie ^ e ne'riti e ne' sacrifizii dell' antico te-stamento. I Sapti stessi di questo antico testamento non piacque-ro a Dio, «e non in quanto appartennero a questa Chiesa, e fu-rono uniti per la fede col capo di lei il Messìa. Questi venne inpersona a .fare 1' acquisto di questa novella sposa a prezzo di fa-tiche e di patimenti, e diede finalmente la vita stessa per lei,cffin di renderla degna dell'eterno amor suo; perocché con que-sta sposa egli si starà fino alla fiue de7 secoli.

18. Quam ditìgensJacob aiti Serviam ti-òi pro Rachel filia tuaminore septem annis»
19. Respondit La*ban : Melius est, ut li-bi eam dem, quam al-teri viro : mane apudme.
20. Servivit ergo Ja*cob pro Rachel septemannis : et videbanturilli pauci dies prae a*moris magnitudine,
21. Dixitque ad La*ban : Da mihi uxoremmeam : quia jam tem-pus impletum est, utingrèdiar ad illam.
22. Qui, vocatis mul-tis amicorum turbis adconvivium, fecit nu*ptias*
25. Et vespere Lia™.filiam suam introduxitad eum,
18. E a questa por-tando amore Giacobbedisse : Ti servirò perRachele tua figlia mi-nore per sette anni.
io.. Rispose Laban :E meglio, ch' io la diaa te, che ad altro uo-mo: statti con me.
20. Servi adunqueGiacobbe per Rachelesette anni : e pochi gliparver quei giorni pelgrande amore.
21. E disse a Laban:Dammi la mia moglie :perocché è compiutogià il tempo di spo-sarla.
. . 22. E quegli, fattainvito di una gran tur-ba di amici al convito ,fece le nozze.
23. E la sera condus-se a lui la sua figliuolaLia,
Vers. 18. Ti tervìrb per Rachele „. sette anni. Si è già altro-ve osservato, che j mariti compravano le mogli e davano ad essela dote ; cosi oltre gli Ebrei usavano i Greci, i Germani, ec.
Vers. 20. E pochi gli parver quei giorni pel grande amore.Il maggior numero degl' interpreti credono, che i sette anni pre-cedettero il matrimonio, in cui in vece di Rachele gli fu dataLia. E bisogna confessare, che questo senso è quello che natural-mente risulta dalle parole del testo sacro. E di più, a qual finesarebbe detto, che la servitù di sette Anni parve poca cosa aGiacoLbe pel grande amore, se egli avesse già avuto la ricom-pensa de'suoi servigi, l'amata Rachele?

24- Dans ancillamfiliae, Zelpham nomi-ne. Ad quam cum exmore Jacob fuisset in*gressus, facto manevidit Lìam*
26. Et dixit ad scce*rum suum : Quid est,quod facere voltasti^nonne pro Racliel ser-vivi tibi ? quare ìmpo-suis ti mihi?
26. Respondit La--Itan: Non est in loconostro consuetudÌ7zis, utminores antetradamusad nuptias.
24. Dando alla figliuo-la una serva chiamataZelpba . Ed essendoGiacobbe andalo a sla-re con lei secondo ilcostume, allorché ven-ne il giorno , conobbech'ella era Lia.
26. E disse al suosuocero : Che è quelloche tuli sei indotto afare ? non li ho io ser-vito per Rachele ? per-chè mi hai tu gabbato?
26. Rispose Laban :Non è usanza nel no-stro paese , che le fi-gliuole minori sieu leprime a maritarsi.
Vers. 2.3. Condusse a lui... Lia. Peccò gravissimamente La-ban , e peccò anche Lia facendo a modo del padre, e accordando-si al peccato di stupro, anzi di adulterio e d'incesto. Ella sape-va , che Giacobbe era maritato cou sua sorella : Giacobbe è scu-sato dall'ignoranza.
Vers. 24. * Secondo il costume. Queste parole, che mancanonell'originale e in molte versioni, sono a proposito pej: dichiara-\re in qual maniera Giacobbe non conoscesse l'inganno, quandoin vece di Rachele gli fu consegnata Lia, portando il costume,che la sposa la prima volta si appressasse allo sposo colla fac-cia velata.
Vers. a5. Perche mi hai tu gabbato ? Giacobbe non avea ve-runa obbligazione di sposar Lia, anche dopo quello che era av-venuto ; perchè egli non avea dato verun consenso di matrimoniocou Lia: e se questo matrimonio si sostenne, fu in virtù del con-senso che egli vi diede in appresso.
Vers. 26. Non e usanza ... che le figliuole minori ec. Questoè un pretesto evidentemente falso: imperocché se fosse stata ve*ra la consuetudine di non maritare le figlie minori avanti allemaggiori, non avrebbe egli fatto con solennità le nozze di ìlache-le, che tutti sapevano minore di età.
Peni. Vol-1* 13

27- Intple hebdoma-dam dierum hujus co-pulae ; et hanc quoquedabo libi pro opere, quos er vìturus es mihi se-pfem annis aliis.
28. Acquievit piaci-to: et liebdomada trans-acta , Rackel duxit «-xorem :
29. Cui pater servaniE alani tradiderat.
30. Tandemque poti-lus optalis nuptiis , a-moreni secjuentis 'prio-ri praetulìt, serviens a-pud eum septem annisaliis.
31. Videns autemDominus , quod despi-ceret Liam , aperuitvulvam ejus, soro?*esterili permanejite.
52. Quae conce p tumgenuit filium, vocavit-que nomen ejus Ruben,dicensi Vidit Dominus
27. Compisci la set-timana di questo spo-salizio ; e ti darò anche1' altra pella servitù ,che mi presterai peraltri sette anni.
28. Si accomodò allaproposta : e passataquella settimana,preseper moglie Rachele ;
29. A cui il padre a-vea data per serva Ba-lani.
30. E giunto final-mente al possesso dellenozze bramate, l'amoredella seconda fu in luipiù forte, che quel del-la prima, servendo incasa di Laban per altrisette anni.
31. Ma il Signore veg-gendo, com'ei disprez-zava Lia , la rendettefeconda, rimanendo stè-rile la sorella.
32. Ed ella partorì ilfigliuolo, che avea con-ceputo, e posegli nomeRuben , -dicendo : II Sir
Vers. 27. Compisci la. settimana di questo sposalizio ec. Lafesta di nozze durava sette di, e Laban volendo che Giacobbe ri-tenga Lia per sua moglie , lo prega a terramare con lei i settegiorni nuziali, e che poi subito gli darà Rachele colla condizioned'i altri sette anni di servigio.
* E lì darò. Ebr, E ti daremo.

humilitatem meam ;nunc amabit me virmeus.
33. Rursumqne con-cepìt, et peperit filium,et alt : Quoniam audi-vitme Dominus liabericonlemptuiì dedit etiamistum mihi: vocaviicjuenomen ejus Siineon.
34- Concepitane ter-fio, et genuit alium fi-lium , dixitcjue : Nuncquoque copulabitur mi-
• ìli maritus meus, eoquod pepererim ei tresfilios : et idcirco appel-lavit nomen ejus Levi.
35. Quarto concepii^etpeperitfilium, et aitiModo confitebor Domi-no : et ob lioc vocaviteum Judam ; cessavit-que parere.
gnore ha veduta la miaumiliazione ; adesso ilmio marito mi amerà.
33. E di bel nuovoconcepì, e partorì unfigliuolo , e disse^. Per-chè il Signore intese,come io era dispregia-ta , mi ha dato anchequesto figliuolo: e die-degli ilnomediSimeon.
54- E concepì la ter-za volta , e partorì unaltro figliuolo, e disse :Adesso sarà ben unitocon me il mio marito ,dacché gli ho fatti trefigliuoli : e perciò chia-mollo col nome di Levi.
35. Concepì per laquarta volta, e partorìun figliuolo , e disse :Adesso io darò laudeal Signore : e perciòchiamollo Giuda ; e ces-sò da fare figliuoli.
Vers. 31. Dìsprezzm'fi Lia. Le volea meno bene; avea perlei minore affetto. Questo è il senso di questo luogo, come ap-parisce da altre simili espressioni della Scrittura. Vedi Matth. K.3r. vi. 9.4.
Vers. 3a. Riiben. Figliuolo della visione, o sia della previ-denza: attribuendo Lia alla bontà del Signore l'averla rendutamadre di un figliuolo , e F averla mirata con occhio di miseri-cordia , mentre il marito non l'amava quanto la sorella.
Yers. 33. // nome dì Sìrneon. Ynol dire Dio ha udilo, ovveroesnudilo.
Vera. 34- Levi. Vale vincolo, unione, ce.Yers, 35. Giuda. Confetfione, laude ec.

C A P O XXX.
Rachele sterile , e Lia , die più non partorisce ,danno al marito le loro serve , dalle quali ot-tengono due figliuoli per ciascheduna. Oltre aquesti Lia due altri jie partorisce ed una figlia,e Rachele partorisce Giuseppe : dopo la nasci-ta de quali Laban pattuisce la mercede da darsia Giacobbe, il quale cosi diviene assai ricco.
i* \^ernens au-tem Rachel, quod ui-foecunda esset, inviclitsorori suae, et alt ma-rito suo : Da mihi libe-ros, alioqriìn morìan
2. Cuiiratas respon-dit Jacob : Num proDeo ego sum, c/ui pri-vavit te fmetu ventrisfui?
3. At illa: Jìabeo, in-(] uìt, familiam E alam :
1. iT.iaRacbeleveg-gendosi sterile , porta-va invidia alla sorella ,e disse al suo marito :Dammi de' figli, altri-menti io morrò.
2. Le rispose disgu-»stato Giacobbe: Tengoio il luogo di Dio, il qua-le ti ha privala dellafecondità ?
5. Ed ella: Io bo, dis-se, la serva Baia: pren-
Vcrs. i. Portava, invidia alla sorella. Un antico proverbiodice, che le donne sono querule e invidiose. Rachele non eraancora quello che fu di poi ; onde non è miracolo , se veggendola fecondità della sorella, e paragonandola colla sua disavventu-ra, se ne inquietava.
Dammi elevigli, altrimenti ec. Alcuni vogliono, che Rache-le (sapendo, come il padre di Giacobbe avea ottenuto colle suepreghiere la fecondità a Rebecca ) domandi al marito, che impe-tri la stessa grazia per lei, perchè altrimenti ella di afflizione simorrebbe. Ma il disgusto che a tali parole mostrò Giacobbe e larisposta di lui sembra, che dia ragione al Grisostomo di dire,che qui Rachele parlo con un po' di stoltezza.
Yers, a. * Tengo io il luogo dì Dio. Prevalgo a Dio.

ingredere ad illam, utpariat super ge n uàmea, et ìiabeam ex il'la filio s,
4. Deditque illi Ba-lam Ì7i conjugìum :quae,
6. Ingresso ad se vi'ro, concepii et peperitfilium.
6. Dìxitque Rachel:Judicavit mihi Domi-nus', et exaudivit vo-cem meam^ dans mihifilium : et idcirco ap~pellavit nomen eiusDan.
7. Rursumque Baiaconcipiens peperit al"terumt
dila, affinchè la prole dìlei io mi prenda sullemie ginocchia, e di leiio abbia de'figli.
4- E diede a lui Baiaper moglie : la quale
5. Data a marito con-cepì , e partorì un fi-gliuolo.
6. EdisseRachele: liSignore ha giudicato inmio favore, e ha esaudi-ta la mia voce , dando-mi un figlio : e per que-sto chiamollo col nomedi Dan.
7. E di nuovo Baiaingravidò, e partorinneun altro,
Vers, 3. Prendila, affinchè ec. Sposala, affinchè il figlio cheella partorirà , possa io prenderlo per mio, e metterlo sulle mieginocchia, qual madre. Così ella corretta da Giacobbe risponde( dice il Crisostomo ) più saggiamente dimostrando , che la solabrama di aver prole, la quale partecipi alle promesse di Dio, ècagione, che ella sopporti di mal animo la sua sterilità.
S. Agostino lib. xxir. còni. Faust. cap. 48. e 49. fa l'apologiàdi Giacobbe contro i Manichei, i quali rimproveravano a questosanto patriarca, come un gran delitto, l'avere avuto quattro mo-gli. Il fatto di Giacobbe, come osserva s. Agostino, non era nècontro la natura , nè contro il costume ( assolutamente parlando)di que' tempi ; e la propagazione della stirpe d' Abramo, propa-gazione tante volte promessa da Dio , sembra che inchiudesse lapermissione della pluralità delle mogli : ma dove gli empii tro-vano occasione di mordere e di biasimare , i saggi e i giusti am-mireranno con ragione in questo medesimo fatto la temperanzadi Giacobbe. Una sola moglie egli sposò di sua volontà , che fuRachele. Si è veduto, come per fraude del suocero fu costretto aeposare anche Lia ; e le due serve non di propria elezione le spo-sò , ma per compiacere le mogli.

8. Pro quo alt Ra-chel: Comparagli: meDeus cum sorore mea^ei invalili: VQcavitcfueeum NephtalL
g. Sentiens Lìa^ quodparere desiissett Zel-pham ancillam suammarito tradidit.
io. Qua, post conce-ptumt edente filium,)
u.Dìxit: Felicìter:et idcirco vocavit no-men eius Gad.
12. Peperit quoqueZelpha alterum.
13. Dixitque Lìa •Hoc pro beatitudinemeai beatani quippe
8. In proposito delquale disse Rachele : liSignore mi ha messaalle mani colla mia so-rella, e io l'ho vinta ; echiamollo Nephtali.
9. Veggendo Lia, co-me avea lasciato di farfigliuoli , diede a suomarito la sua schiavaZelpha.
10. E avendo questaconcepito , e partoritoun figliuolo ,
11. Disse ella: Forti!-,na: e chiamollo perciòcol nome di Gad.
is.NepartorìZelphaanche un altro.
13. E Lia disse : Que-sto è per mia beatitu-dine : nerocchè beata
Vers. 6. Chìamollo col nome di Dan. Dan significa giudica-re , far giudìzio.
Vers. 8. Mi ha messa, alle mani ec. Dio ha voluto, che io ab-bia avuto a disputare dell* onore della fecondità colla mia pro-pria sorella, moglie dello stesso marito; ma io con astuzia aven-do fatto «posare a lui la mia serva son rirnasa vincitrice. Nephta~li vale lottatore, combattitore vantaggioso.,
Vers. ii. Fortuna, ovvero prosperità. E 1'esclamazione diZelpha in vedersi madre di questo nuovo figliuolo. I LXX les-serò ho avuto buona fortuna: e il Caldeo e il Siro hanno lostesso senso, ch' è seguitato dal maggior numero degP interpretiantichi e moderni. Lia adunque diede a questo figliuolo il nomedi buona fortuna, e con ciò fece vedere, che ella non era ancorainteramente esente dalla superstizione del suo paese e della ca-sa di Laban uomo idolatra, nella qual casa ella dovea aver senti-to nominare sovente, e fors' anche invocare come una divinità, labuona fortuna. Vedi cap. xxxv. 24.

me dicent mulieres :propterea appellaviteum Aser.
14» Egressus autemRuben tempore messistriticeae in agrum, re-perit mandragora^)cjuas matri Liae detu-lit. Dixitque Rachel:Da mihi partem demandragoris filii lui.
15. Illa respondit:Parumne libi videtur,quod praeripueris ma"ritum mihi, nisi etiammandragora^ filii meituleris ? Alt Rachel:Dormiat tecum hacnocte pro mandragorisfilii tui.
mi diranno le donne :per questo lo chiamòAser.
i4- Ma essendo Ru-ben andato'alla campa-gna in tempo che mie-tevasi il grano, trovòdelle mandragore, lequali egli portò a suamadre Lia. Ma Racheledisse: Fammi parte del-le mandragore di tuo fi-glio.
15. Rispose quella iTi sembra egli poco l'a-vermi rapito il consor-te, se non mi togli an-che le mandragore delmio figlio? Disse Rache-le : Dorma egli questanotte con te in ricom-pensa delle mandrago-re di tuo figlio.
Vers.- 13. Questo e per mìa beatitudine, I LXX beata meCosì applaudisce a sé stessa per aver avuto un sesto figliuolo.
Vers. 14- Fa?nmi parte delle mandragore ec. I LXX e ilCaldeo leggono come la Volgata mandragore, ovvero frutti dimandragora ; e quantunque tra' moderni interpreti sieno nonpochi quelli che pretendono di dare un altro significato alla vo-ce del testo ebreo , io non credo, che tutte le ingegnose conget-ture possano mettersi in paragone coli' autorità de' LXX e delCaldeo , trattandosi di un frutto che dovea essere cognitissimonella Mesopotamia e nella Giudea, che è rammentato anche nel-la Cantica. Questo frutto assai bello e odoroso è buono a conci-liare il sonno, a cacciar la tristezza , e a dare la fecondità, con-forme attestano moltissimi autori antichi e moderni. Posto ciò ,ognuno intende, per qual motivo Rachele avesse tanta premuradi avere una parte delle mandragore trovate da Ruben. Ella pe-rò «i rimase sterile, fino a tanto che a Dio piacque di consolarla.

16. Redeunti(j7ie advesperam Jacob deagro, egresso, est in oc-cursum 6)11$ Lia, et: Adme, inquit, intrabìs :quia mercede conduxite pro mandragorìs filiimei. Dormivitque cumea nocte illa,
17. Et exaudivitDeus preces ejus: conce*pàglie, et peperit filiumffuintum,
18. Et ait\ DeditDeus mercedem mihi,quia dedi ancillammeam viro meo : appel-lavitque nomen ejus Is-sachar.
19. Rursum Lia con-cipiens peperit sextumfilium,
20. Et alt: Dotavitme Deus dote bona :etiam hac vice mecumerit maritus meus, eoquod genuerim ei sex
16. E tornando allasera Giacobbe dallacampagna, usci incon-tro a lui Lia, e: Meco ,disse, verrai: perchè tiho caparrato col prezzodelle mandragore delmio figliuolo. Ed egli sidormì con lei quellanotte.
17. E il Signore esau-dì le preghiere di lei : econcepì, e partorì ilquinto figliuolo,
18. E disse: II Signo-re mi ha renduta mer-cede , perchè diedi lamia schiava a mio ma-rito: e gli diede il nomed' I s sachar.
1.9. E di bel nuovoLia concepì, e partorìil sesto figliuolo,
20. E disse; II Signo-re mi ha dotata di buo-na dote: anche questavolta si starà con me ilmio marito per avergli
Vers. 15. Ti sembra egli poco P avermi rapito ec. Lia rinfac-ìa a Rachelc l'aver tolto a lei Giacobbe, il quale veramentevea sposata prima lei. Rachele però avrebbe ben potuto ritor-ere 1' argomento.
* Dorma teco. Vedrai v che a scanso d'inquietudini fralleuè mogli solea Giacobbe iu tempi fìssati starsi or con questa oron quella.
Vers. 18. Gli diede il nome (P Issachar. Vale adire, nomodella ricompensa , della mercede.

Jìliosi et idcirco appel-lavi t nomen eius Za-bulon.
21. Post quem pepe*rit filiam nomine Di-ri am.
22. Uecordatus quo-que Dominus Rachelis,exaudivit eam, et ape-
' ruit vulvam ejus»23. Quae concepii,
et p ep erit filium ^ dicens:A òs tuli t Deus oppro-brium meum.
2 4 • E t vaca vit nomenejus Joseph, dicens :Addat mihi Dominus,filium alterum.
26. Nato autem Jo-seph, dixit Jacob so-cero suo: Dimìtte me,ut revertar in patriam,et ad terram, meam.
10 fatti sei figliuoli : eper questo chiamollocol nome di Zabulon.
21. Dopo di questopartprì una figlia pernome Dina.
22. Ricordatosi il Si-gnore anche diRachelela esaudì, e la rendè fe-conda.
23. E concepì, e par-torì un figliuolo, dicen-do: II Signore ha tolto11 mio obbrobrio.
24. E chiamollo colnome di Giuseppe , di-cendo .• Il Signore dia-mi ancora un altro fi-gliuolo.
26. Ma nato che fuGiuseppe, disse Giacob-be al suo suocero : Dam-mi licenza, che io mene torni alla patria , enella mia terra.
Vers. 9.0. Chiamollo col nome dì Zabulon. Alcuni interpre-tano Zabulon, abitazione, coabita/ione.
Vers. 21. Per nome Dina. Questo nome ha la stessa radice,che quello di Dan. Gli Ebrei dicono, che Dina fu moglie di Giobbe.
Vers. 9,3. Il mìo obbrobrio. La sterilità, la quale era conside-rata come un gran disdoro.
Vers. i^. Chiamollo col nome di Giuseppe ec. Significa unoche crescerà, augumenterà ec., volendo Rachele dimostrare lasperanza di non restare con questo solo figliuolo , ma di averneancora un altro. Giuseppe venne alla luce 1' «inno nonagesimoprimo di Giacobbe t il decimoquarto anno dopo il suo arrivonella Mesopotarnia.
i3 * .

26. Da mihi uxores,et libero* meos, proquibus servivi tibi^ utabeam: tu nosti ser-vitutemì qua servivilibi.
27. Ait illi LabaniInveniam gratiam inconspectu tuoi experi-mento didicì, quia be-nedixerit mihi Deuspropter te.
28. Constitue mercé-dem team, quam demtìbi.
29. At ille respon-dit i Tu nosti quomodoservierim tibiì et quan-ta in manibus meisfuerit possessio tua.
30. Modicum Tiabui-sti antequam veniremad te: et nunc diveseffectus es: benedixit-que libi Dominus adintroitimi meum. Ju-stum est igitur, ut ali-quando provideam et*iam domui meae.
26. Dammi le mogli,e i miei figliuoli, per liquali sono stato a' tuoiservigi, affinchè io mene vada: tu sai qual sor-te di servigio sia stato ilmio.
27. Disse a lui La-^ ^ban: Possaio trovar gra-zia dinanzi a te : io hoconosciuto alla prova,che Dio mi ha benedet-to per causa tua.
28. Determina tu laricompensa, ch' io deh* *ba darti.
29. Ma quegli rispo-se : Tu sai in qual mo-do ti ho servito, e quan-to sieno augumentatinelle mani mie i tuoibeni.
30. Poco tu avevi pri-ma ch' io venissi a te :ora sei divenuto ricco :e il Signore ti ha bene-detto alla mia venuta.È'adunque giusto, cheio pensi una volta an-che alla casa mia.
Ver*. «7. Possa io trovar grazia dinanzi a te. E una speciedi complimento di Laban , come s'ei dicesse : Fammi graiìa dìascoltarmi,
* Per cania tua. Al tuo venir qua.

Si. Dixitque Laban:quid tibi dabo ? At il-le aìt : Nihil volo : sedsifeceris, quod postu-lo , iterum pascam , etcustodiam pecora tua.
32. Gyra omnes gre-ges tuos, et separacunctas oves varias, etsparso veliere', etquod-cumque furvum, et ma-culosum , variumquefuerit tam in ovibus,quam in capris, eritmerces mea.
33. Respondebitquemihi cras justitia mea>quando placiti tempusadvenerit coram te: etomnia, quae non fue-rint varia, etmaculosa^etfurva tam in ovibus,quam in caprist furtime arguent.
31. E Laban gli dis*se : Che ti darò io ? Maquegli replicò: Non vo-glio nulla t ma se faraiquello ch' io chiedo ,pascerò di nuovo le tuepecore , e n 'avrò cura,
32. Raduna insiemetutti i tuoi greggi, emetti da parte tutte 1«pecore variegate,e mac-chiate di pelame: e tut-to quello che verrà fo-sco , e macchiato, e va-rio tanto di pecore, chedi capre , sarà la miamercede.
33. E parlerà un dì amio favore la mia fedel-tà, allorché verrà il tem-po concordato tra noi :e tutto quello che nonsarà di vario colore , omacchiato, o fosco tan-to di pecore , come dicapre, mi dimostrerà reodi furto.
Vers. 31. Non voglio milia ; ma se farai ec. Non voglio date nulla gratuitamente; ovvero non voglio che tu dia mercede :non son io «n mercenario ; fa solamente quello die io dirò.
Yers. 3?,. E lutto quello che verrà fosco e macchiato e va-rio ... sarà mio. La lana delle pecore varia di colore è poco sti-mata, perchè non può tingersi; e lo stesso dicasi del pelo dellecapre, delle quali però il pelo nero era stimatissimo; onde Gia-cobbc non chiede le capre di color nero, ma quelle di color fo-M-o. (."osi egli si contenta di aver per ricompensa i rifiuti, p«r co-s'i dire, de' greggi di Labaii.

34- Dixitque Labari*.Gratum habeo quodpetis.
35. Et separavit indie illa capraS) etoves,et hircoS) et arietes va-rìos, atque maculosos :cUnctum autem gregemunicolorem, idest albi^et nigri velleris tradì"dit in manu filiorumsuorum.
34- Disse Laban.- Mipiace quello che do-mandi.
35. E quel giorno se-parò le capre, e le pe-cora, e i capri e i mon«toni di vario colore , emacchiati : e tutto ilgregge di un sol colo-re, cioè di bianco, e ne-ro pelame lo diede ingoverno de' suoi fi-gliuoli.
Vera. 33. E parlerà un <ù n mio favore la mìa fedeltà, al-lorché , ec. Vale a dire, tu vedi qual disuguaglianza si trovi inquesto patto in mio svantaggio. Tu mi lascerai le pecore e le ca-pre di un solo colore, ed io non dovrò avere, se non quello chedi esse nascerà pezzato, e macchiato di varii colori; e quelle diun sol colore debbono essere tue. L' ordine naturale delle coseti mostra, ch'è come se io patteggiassi, che tu dovessi avere ognicosa. Ma io spero, che la giustizia colla quale ho proceduto eprocedo con te, mi assisterà, e mi otterrà da Dio quella merce-de, che tu non vorresti darmi.
E lutto quello che non sarà dì vario colore ... mi dimo-strerà reo di furto. Quando dovrai! dividersi alla fine dell'annoi nuovi parti secondo il concordato tra noi, ove mai io ne rite-nessi alcuno, che non fosse di vario colore, mi contenterò di es-sere condannato qual ladro.
Vers. 35. Separò le capre, e le pecore .... dì vario colore ... etutto il gregge di un sol colore ... lo diede in governo de"1 suoi
figliuoli. Di chi sono questi figliuoli messi da Laban al governode' greggi separati di un solo colore, cioè o bianco, o nero, e ri-messi a Giacobbe ? Sono indubitatamente i figliuoli di Laban.Quest'uomo avaro e sospettoso, affinchè Giacobbe non potessein qualche modo o frodare le figliature , o introdurre tra' suoigreggi delle pecore, o delle capre di vario colore, dà a Giacobbecome per compagni, e aiuti, ma in realtà per esploratori, i suoifigliuoli, ed egli'si ritira co'suoi greggi tre giornate di stradalontano dal genero. Cosi egli non ha paura, che il suo bestiamepossa mescolarsi con quello di Giacobbe, nè le sue pecore, e ca-pre di color vario esser vedute dalle bianche, e nere di Giacobbe.

36. È pose una di-stanza di tre giorni diviaggio tra sé, e il ge-nero , il quale pascola-va il rimanente de' suoigreggi.
37. Prese adunqueGiacobbe delle verghedi pioppo verdi, e dimandorlo, e di platano,e ne levò parte dellacorteccia, levata la qua-le , dove le verghe era-no spogliate, spiccò ilbianco: e dove non era-no state toccate rima-sero verdi : onde in talguisa risultò vario co-lore.
38. E le pose ne' ca-nali , dove gettavasil'acqua, affinchè venutea bere le pecore , aves-ser dinanzi agli occhile verghe , e concepis-sero rimirandole.
36. Et posuit spa-tium itineris trium die-rum biter se., et gene-rum, qui pascebai re li"quo s gregei ejus.
07. Tollens ergo Ja-cob vir gas populeas vi-rides, et amygdatinas^et ex platanis^ ex par-te decorticavi eas : de-tractisque corticibus, inhis, quae spolìata fue-rant, candor apparuit :illa vero, quae integrafuerant, viridia per"manserunt-, atque inìiunc modum color ef-fectus est varius.
38. Posuitque eas incanalibus^ ubi effunde*batur aqua : ut cum ve-nissent greges ad hi-bendum, ante oculoshaberent virgas, et inaspectu earum conci-perent.
Vers. 36. Tre giorni di viaggio. Solito pero farsi da nn guar-diano di greggi dietro al suo bestiame.
Yers. 37., e 38. Prese ... delle verghe di pioppo verdi, ec. Ec-co l'arte usata da Giacobbe per avere delle pecore e capre d'unsol colore de'parti di color vàrio. Egli prende delle verghe, oscudisci di varie piante , ne incide , e ne leva in più luoghi lascorza ; cosi queste verghe restano di vario colore : dipoi le ponene' canali, dove andavano i greggi ad abbeverarsi ; il resto è assaichiaro.
* E ne levo parie della corteccia. E ad una parto tolsela corteccia.

3<). Factumque est,ut in ipso calore coitusoves intuerentur vir-gas, etparerent macu-Iosa, et varia, et diver-so colore respersa.
40. Divisitque gre-gem Jacob, et posuitvir gas incanatibus an*te oculos arie tum: e-rant autem alba> et ni"gra quaeque Laban :cetera vero Jacob, se*paratis inter se gregi-bus*
41. Igitur quandoprimo tempore ascen-debaniur oves,ponebatJacob vir gas in e an a»libus aquarum anteoculos arietum et oviuni,
3$. Ed avvenne, chele pecore in calore mi-ravano le verghe , e fi-gliavano agnelli conmacchie , e pezzati, esparsi di vario colore.
4o. E Giacobbe divi-se il gregge , e pose leverghe nei canali da-vanti agli occhi degliarieti : ed erano di La-ban tutti i bianchi, e ineri : gli altri poi tuttidi Giacobbe , avendo igreggi separati tra loro.
4.1. Quando adunquealla primavera doveartconcepire le pecore,mettea Giacobbe le ver-ghe ne'canali dell'acquadinanzi agli occhi dei
Vers. 4<5. E Giacobbe divise il gregge, ec. Era riuscito a Gia-cobbe colla diligenza descritta ne'versetti 3j. 38. 3g. di averedegli agnelli e de'capretti pezzati di vario colore: questi egliseparò dagli altri, e questi egli procurava di metter davanti allepecore al tempo, in cui sogliono concepire. Vedesi però e inquesto, e nel seguente versetto, ch' ei continua a mettere delleverghe ne' canali, dove i suoi greggi andavano a bere , osservataperò la distinzione posta nel verso ì\i.
Altri per queste parole divise il gregge intendono, che egliandasse separando via via , e mettendo in disparte gli agnelli, ei capretti macchiati, e di vario colore, che erano suoi, e non lilasciva stare mescolati co'greggi di Laban, aftinché questi nonavesse pretesto di querelarsi, perchè Giaeobbe si procurasse unsi gran profìtto col mettere quegli agnelli e capretti dinan/ialle bianche pecore e capre, aliinchù queste faccsser simili i lo-ro parti.

ut in earum contem*platione conciperent :
42. Quando vero se»ratina admissura erat,et conceptus extremus,non ponebat eas. Fa-ctaque sunt e«, quaeerant serotina, Labaniet quae primi tempor^s^Jacob.
montoni , G delle peco-re, affinchè queste con-cepissero in guardan-dole :
42. Al tempo poi, incui le pecore concepi-scono, e portano per laseconda volta, non met-teva le verghe. E le pe-core della seconda erandi Laban : quelle poidella prima figliaturaerano di Giacobbe.
Vers. 4?-. Al tempo poi della seconda, figliatura,. Noi suppon-gìiiamo, che le pecore nella Mesopotamia figliassero,due volte,come suppose s. Girolamo, e come avviene in Italia. E detto nelversetto precedente, che Giacobbe metteVa le verghe ne'canalial tempo di primavera, quando le pecore doveano concepire -, loche egli certamente faceva, perchè bramava, che di vario colorefossero, per conseguenza suoi gli agnelli, che dovean poi nascerenell'autunno. Dice adesso, ch' egli non metteva le verghe uè' ca-nali al tempo in cui per la seconda, ovvero per l'ultima volta lepecore concepivano, vale a dire nel tempo d' autunno. Dondefassi evidente, che Giacobbe sapeva, che migliori e piìi robustierano i parti concepiti in primavera, e partoriti in autunno , chequei concepiti in autunno, e partoriti in primavera : e perciò iprimi egli volea per sé, e lasciava i secondi a Laban.
Due cose sono ancora da notare in questo fatto. In primoluogo il Crisostomo, e dietro a lui gl'interpreti Greci hanno cre-duto, che l'avere le pecore di Giacobbe partoriti agnelli di variocolore al vedere le verghe da lui messe ne'canali, fosse un effetto-non naturale, ma sopra le leggi della natura, e per conseguenzamiracoloso. S. Girolamo, s. Agostino, e dietro ad essi moltissimiinterpreti sostengono, che ciò poteva accadere naturalmente perla forza della immaginazione, per ragione della quale si sono ve-duti , e si veggono sovente impressi ne' corpi degli uomini, e de-gli animali i segni di quelle cose, che agitarono la fantasia dellemadri nel tempo del concepimento, e della gravidanza. La storianaturale è piena di simili esempi; i quali benché difficilmentepossano comprendersi e spiegarsi , non e però possibile di negarli.
In secondo luogo si disputa, se Giacobbe poteva senza colpaservirai di UH tal mezzo per migliorare il suo contratto conii»

43. Tììtatasque esthomo ultra modum, ethabuit greges multos,ancillas, et servos, ca-meloSf et asinos*
43. E questi si fecsricco formisura , e feceacquisto di molti greg-gi , di serve , e servi, edi cammelli, e asini.
C A P O XXXI.
Giacobbe per comando del Signore parte nasco*stamente con tutta la sua famiglia per tornareal padre. Laban gli corre dietro. Rachele, cheavea rubati gì' idoli del padre , delude con a*stuzia Laban, che li cercava, finalmente dopovarie cjuerele,ealtercazioni, Giacobbe e Laban^fatta alleanza, se ne vanno alle case loro.
1. JLostquam au-tem audivit verba filio-rum Laban dicentiumtTutit Jacob omnia,quae fuerunt p atris no-stri, et de illius facui-tale ditatus factus estinclytus*
2. Animadvertit quo-quefaciemLaban, quodnon esset erga se sicutheri, et nudiustertius,
1. ÌT.1 a dopo cheebbe udite le parole deifigliuoli di Laban , chedicevano : Giacobbe hausurpato tutto quelloche era di nostro padre,e dei beni di lui si è fat-to ricco signore :
2. Osservò ancora,che Laban non lo guar*dava collo stesso occhio,che per lo passalo ,
l'intenzione del suocero, il quale certamente suppose, che a Gia-cobbe dovesser toccare le pecore di vario colore, che tali na-scessero senz' arie , e fortuitamente : ma se noi porrem mente ,che Dio stesso suggerì a Giacobbe questo mezzo di ritrarre final*-ineiite la giusta mercede di tante e sì lunghe fatiche, delle qua-li tutto il frutto /ino allora era stato di Laban, e che per conse-guenza Dio volle, che a lui si appartenesse il bestiame, che me-diante una tal arte dovea nascere, non avremo bisogno di ricor-rere ad altre ragiona per giustiiicarlo. Vedi caf>. xxxi. 9. 11. 12,

3. Maxime elicentesibi Domino: Reverterein terrarii patrum tuo-rumt et ad generatio-neni tuamt erofjue te-cum.
4- Misit et vocavitRachel et Liam inagrum, ubi pascebatgreges^
6. Dixitque eis: Vi-deo faciem patris ve-stri^ quod non sit ergame sicut heri,, etnudius-tertius : Deus autempatris mei fuit mecum,
6. Et ipsae nostistquod totis viribus meisservierim patri vestro,
7. Sed et pater t>e-ster circumvenit me,et mutavit mercedemm eam decem vicibus> ettamen non dimisit eumDeus, ut noceret mihi.
3. Dicendogli di piùil Signore : Torna allaterra de' padri tuoi, ea' tuoi parenti, e io sa-rò teco.
4. Fece venire Rache-le e Lia al campo, do-ve ei pasceva i greggi,
5. E disse loro : Ioveggo, che il padre vo-stro non mi guarda col-lo stesso occhio, che perlo passato: ma il Dio dimio padre è stato conme.
6. E voi sapete, co-me con tutto il mio po-tere ho servito al padrevostro.
7. Ma il padre vostromi gabbò, e ha mutatodieci volte la mia mer-cede : e con tutto que-sto Dio non ha permes-so , ch'ei mi fecesse delmale.
Vers. "r Un mutato dieci volte la mia mercede. Nelle Scrit-ture dieci volte è posto per molle volte, Levit. xxvi. 26. Ec-clcs. vii. 20. Zachar. vii. a3. Ma qui s. Girolamo prendequest'espressione letteralmente, e sembra, che cosi vada presain questo luogo ; perchè la stessa cosa d' aver cambiato dieci vol-le riguardo alla mercede dovuta a Giacobbe è rinfacciata a La-ban nel versetto 4 i > Questi pertanto, ogni volta che si veniva afare la divisione del bestiame, che era suo , da quello che eradi Giacobbe (la qual divisione face vasi du§ volte i' anjao) , reg-

8. Si quando dixiivarine erunt mercedestuae ; pariebant omnesoves varios foetus:quando vero e contra-rio alt: A lò a quaequeaccìpies pro mercede:omnes greges alea pe*pererunt.
<j. Tulitque Deusvub s tantiam fratris ve*8 tri> et dedii mihi*
10. Postquam enimconceptus ovium tem*pus advenerat, levavioùulos méóSt et vidi insomnis ascendente^mares $uper foeminasvarioS) et maculosos,et diversorum colorum.
11. Dixitque Ange-lus Dei ad me in som-nis\ Jacob ? Et ego re-spondi • Adsum.
8. Se una volta dis-se : Quelli di color va-rio saranno la tua mer-cede, le pecore figlia va-no tutte agnelli chiaz-zati : quando per lo con-
trario egli dìsse:Tupren-derai per tuo salariotutti i bianchi, tutti igreggi figliavano agnel-li bianchi.
o. È Dio ha prese lefacoltà del padre vostro,e le ha date a me.
io. Imperocché quan-do fu venuto il tempo,in cui le pecore doveanconcepire , io alzai gliocchi miei, e vidi dor-mendo i maschi pezza-ti, e macchiati, e di colo-ri diversi, i quali co-privano le femmine.
il. E l'Angelo di Diomi disse in sogno: Gia-cobbe ? E io risposi :Eccomi qui.
gendo, che la parte di Giacobbe era vantaggiata sopra la suaparte, non volea più stare a quello che erasi pattuito ; onde bi-sognava che questi si contentasse di fare nuova convenzione. Cosìandò la cosa per cinque interi anni ; onde ha ragione Giacobbedi dire, che per dieci volte Laban mutò la mercede pattuita. Illesto anno poi egli se ne fuggi, come Dio gli avea comandato.
Vèrs. 8. Le pecore figliavano tutte ec. Tutte le pecore vuoldire la massima parte delle pecore, e cosi di poi tutti i greggiintendesi /.« massima parte de* greggi ; e in sostanza vuol dire ,che a dispetto delle angherìe dì Laban, Dio faceva sì, che il me-glio e il pia del frutto de' bestiami toccava sempre a Giacobbe.

12. Qui alt: Leo aoculos tuos, et vidouniversos masculos a-scenclentes super foe-minas, varios, macu-losos, cttcjiiQ respersosividi enim omnia^ quaefecit doi Laban.
13. Ego sum DeusBethel, (i) ubi unxistilapidem, et votum vo-visti mihi. Nunc ergosurge, et egredere deterra hac, revertens interram nativitatis tuae.
i t\.R.esponderuntc/uenachel et Lia : Nun-quid habemus residuiquidquam in facuitati-bus, et haereditate do-mus patris nostri ?
(i) Sap. 28. 18.
12. EH egli disse: Al-za gli ocelli tuoi, e mi-ra i maschi tulli, checuopron le femmine,pezsali, e macchiati, edi vario colore : peroc-ché io ho vedulo tulioquello che ha fallo a leLaban.
13. Io sono il Dio diBethel, dove tu ungestila pielra, e facesli a meil volo. A-dessoadunquelevali, e parti da questaterra per tornare allaterra dove sei nato.
14» Rachele e Liarisposero : Riman egliforse qualche cosa pernoi delle facollà , e del-1' credila della casa dinoslro padre ?
(i} Sap. 28. 18.
Vers. i").. Io ho veduto tutto quello che ha fatto a te Labari.Assai bella è a questo passo la riflessione del Crisostomo: Di quinoi impariamo, che se allora quando ci sarà fatta ingiurianoi sarem mansueti e pazienti e pacifici, goderem più copiosoe abbondante Vaiuto divino. Non ci mettiamo pertanto a com-battere con quelli che ci premono e ci calunniano , ma sop-portiarn generosamente, sapendo che Dio non ci disprezzerà.Riconosciamo noi la sua amorevolezza: perocché egli ha det-to: a me la vendetta, e io renderò mercede, hora. 67.
Vers. i3. * Ove ungesti la pietra, e facesti a me il voto. Perdimostrargliene il gradimento. 11 Signore rammenta a Giacobbei di lui atti di religione, e per animarvelo gli dà a vedere d'averpresente il di lui voto .
Vers. 14.6 15. Riman egli forse qualche cosa ec. Che ab-biarn più noi da sperare delle facoltà e de' beni di uostro padre?

15. Nonne quasi alie-nas reputavit nos, etvendidit, comeditquepretium nostrum?
\6. Sed Deus tulitopes patris nostri, eteas tradidit nobis', acfiliis nostris: unde om-nia, quae praecepit tibiDeuSjfac.
17. Surrexit itaqueJacob, et ìmpositis li-óerìs, ac conjugibussuis super camelos>abiit.
18. Tulitque omnemsubstantiam suam, etgreges, et fjuidquid inMesopotamia acquisie-rat, pergens, ad Isaacpatrem suum in terramChanaan.
i p. Eo tempore ieratLabaìi ad tondendasoves, et Rachel furataest idola patris sui.
15. Non ci ha egli ri-guardate come stranie-re , e ci ha vendute , eha mangiato i! prezzo,che di noi ha ritratto ?
16". Ma Dio ha presele ricchezze di nostropadre, e le ha date anoi, e a' nostri figliuo-li: fa adunque tuttoquello che Dio ti ha co-mandato.
17. Si ammannì a-dunque Giacobbe 3 emessi i figliuoli, e lemogli sopra i cammelli,se ne partì. |.
18. E prese tutto ilsuo , e i greggi, e tut-to quello che avea gua-dagnato nella Mesopo-tamia, incamminandosiverso suo padre Isaccoalla terra di Chanaan.
19. Laban in queltempo era andato a to*sarè le pecore, e Rache-le rubò gl} idoli di suopadre*
Egli ci ha quasi diseredate , e dandoci a te senza dote, e usur-pandosi tutta la mercede che tu avevi meritato colle fatiche diquattordici anni, la qual mercede era il prezzo che tu pagastiper averci , e dovea essere nostra dote.
Vers. i p. Rachele rubò gV idoli di suo padre. La voce ebreaTeraphìm renduta qui con quella ds idoli si prende altrove in

20. Noluìtr/ue Jacobco7?fiteri socero suo ,quod fageret.
21. Cumque abìlssettam ipse, quam omnia ^quae juris sui erant, etamjie transmisso per-geret contra moJttemGalaad 3
20. E Giacobbe nonvolle accusare a Labarila sua fuga.
2T. E partito ch'eifu con tutto quello chea lui apparteneva, men-tre passato il fiume( Eu-frate ) si avanzava ver-'so il monte Galaad,
altri sensi. Ma da Ezechiello xxi. a., e da Zacheria x. 2. appari-sce, che sotto questo nome s'intendevano tra1 Caldei certe figuresuperstiziose le quali si consultavano per sapere le cose future.Molti dotti interpreti credono , che i Terapnim fossero talisma-ni , cioè figure eli metallo gettate o incise a certi aspetti di pia-
- neti, alle quali figure si attribuivano effetti straordinarii; maadattati alla qualità del metallo, al nome de' pianeti e alle figu-re che in essi erano rappresentate. In oriente regna tuttora lasuperstiziosa e ridicola mania di questi talismani o degli amu-leti, o sia preservativi contro gì' incanti, contro le disgrazie , ec.Questi amuleti sono iscrizioni sulla carta o sulla carta pecora ,o sopra pietre preziose. Sembra molto verisimile, che questi ido-li , o Teraphim di Laban fossero figure , nelle quali ei credevache risedesse qualche soprannatural virtù.
Il motivo, per cui Rachele si portò via questi idoli, non ènotato nella Scrittura; onde chi ne assegna uno , e chi un altro.Alcuni Padri credono, che ella gli adorasse, come anche Lia, evolesse averli anche con sé nel viaggio; e il non averne fattomotto a Giacobbe (come si vede vers. 3-2.) sembra un grande in-dizio , che Rachele non fosse ancora esente da questa superstizio-ne. Vi sono però clegl' interpreti che suppongono, che questi ido-li fosser d' oro, e fossero quello che v' era di più pregiato in casadi Laban ; onde Rachele se li prese in compensazione dell' ingiu-stizia che ella pretendeva essere stata fatta dal padre a sé e allasorella. Comunque ciò sia quando ella possa essere assoluta dallasuperstizione, non può essere in verun modo assoluta dal peccatodi furto. Vedi vers. 3 2.
Vers. 21. Passato il fiume. L' Eufrate ch' è di mezzo tra laMesopotamia e la Chananea.
Verso il monte Galanti. Monte, che è quasi unito al Liba-no , e ha alle sue radici un' ampia e fertil regione chiamata Ga-laad. Vedi Deuler. xxxiv. i. Jerern. xn. G. Questo nome di Ga-laad lo ebbe questo monte per la ragione detta nel versetto 4&

22. Nuntiatum estLaban die tertia , quodfumerei Jacob.
23. Qui, assumptisfratribus suis, persecu-tus est eum diebus se-ptem : et comprelienditeum in monte Galaad.
24. Viditque in so-mnis dicentem sibiDeum: (i) Caveì nequid quam aspere lo-quaris contra Jacob.
26. Jamque Jacobextenderatin monte ta-bemaculum : cumqueille consecutus fuisseteum cum fratribus suis^in eodemmonte Galaadfixit tentorium.
26. Etdixit ad Ja~cob\ Quare ila e gisti,ut ciani me abìgeresjìlias meas, quasi ca-ptivas gladio?
27. Cur ignorantemefugere voltasti^ necindicare mihi, ut pro»sequerer te cum gau-dìo, et canticiS) et tym-pajus, et citharis ?
(i) Infr. 48. 16.
22. Fu portato avvi-so a Laban il terzo gior-no , che Giacobbe fug-giva.
23. Ed egli, presi se-co i suoi fratelli, lo se-guitò per sette giorni,e lo raggiunse sul mon-te di Galaad.
24. E vide in sognoDio, che gli disse : Guar-dati dal dire una tortaparola contro Giacobbe.
26. E Giacobbe aveagià teso suo padiglionesul monte : e soprag-giunto Laban co' suoifratel l i , la sua tendapian lò sullo stesso mon-te di Galaad.
26". E disse a Giacob-be: Per qual motivo haioperato in tal guisa,menando via le mie fi-glie senza mia saputa,come prigioniere diguerra ?
27. Perchè hai tu vo-luto fuggire senza ch'iolo sapessi, e non anziavvert irmi, affinchè tiaccompagnassi con fe-sta, e cantici, e timpa-ni , e cetre ?

2 8. Non es passus,ut oscularerfUios rneos,etfilias: stulte opera'tus es\ et nunc quidem
29. Valet manusmeo. recidere libi mo-limi. Sed Deus patrisvestri heri dixit mihi:(i) Cave, ne locjuariscontra Jacob quidquamdurius.
30. Esto, ad tuos irecupiebas, et desiderio
• erat tibi domus patrislui: curfuratus es deosm eos ?
31. Respondit JacobiQuod inscio te prof e-ctus sum, timui> n,e vio-lenter auferres fitiastuas.
32. Quod autem furti77/e arguìs : apud quem-cumque inveneris deostuos, necetur coramfratribus iiostris : scru>tare quìdquìd tuorunapud me inveneris> etaufer. Haec dicens,
28. Non mi hai per-messo di dare un bacioa' miei figliuoli, e allemie figlie : ti sei porta-to da stollo : e certa-tamente adesso
29. È in poter miofarti pagar il fio. Ma ilDio del padre vostro ie-ri mi disse : Guardatidal parlare con aspreis-za contro Giacobbe.
30. Tu desideravi diandartene a trovare ituoi, e ti stimolava ildesiderio della casa pa-terna , ti si conceda :perchè mi hai rubati imiei dei?
31. Rispose Giacob-be : Quanto ali' esserepartito senza tua sapu-ta , io temei , che nonmi togliessi per forzale tue figlie.
32. Quanto poi al fur-to , di cui mi riconvie-ni ; chiunque sia colui,presso del quale ritro-verai i tuoidei, sia mes-so a morte alla p res e n-za de'luoi fratelli : fa letue ricerche: tutto quel-
fO Infr. 48. 16.

ignorabat, quodRachelfurata esset idola.
33. Ingressus itaqueLaban tabemaculumJacob.et Liae^et utrius-que familiae, non in-venit. Cumque intras-set tentorium Rachelis,
34- Illa jestinansabscondit idola subterstramenta cameliì etsedit desuper \ scrutan-tique omne tentorium^et nihil invenienti,
35. Aiti Ne irasca-tur dominus meustquod coram te assur-gere nequeo : quia juxtaconsuetudinem foemì-narum nunc acciditmihi-, sic delusa solici*tudo quaerentis est.
36". Tumensque Ja-cob cum jurgio aitiQuam ob culpam meamìet ob quod peccatum
lo che troverai di tuopresso di me , prendilopure. Dicendo questo,egli ignorava , che Ra-chele avesse rubato gl'i-doli.
33. Entrato adunqueLaban nella tenda diGiacobbe e di Lia, edell' una e dell' altraschiava, niente trovò.Ma entrando egli nellatenda di Rachele,
34. Nascose ella confretta gì' idoli sotto ilbasto di un cammello ,e vi si pose sopra a se-dere : e rifrustando eglituttala tenda senza tro-varli ,
35. Ella disse : Nonprenda in mala parte ilsignor mio , se io nonposso alzarmi alla tuapresenza : perocché hoadesso il solito incomo-do delle donne : così fudelusa l'ansietà del cer-catore.
56. E Giacobbe sde-gnato disse con agrerampogne: Per qual miacolpa , o per qual mio
Vers. 32. * Sìa messo a morte. Ovvero: muoia ì per modo disemplice imprecazione.

meum sic exarsisti postme,
67. Et scrutatus esomnem supellectilemmeam? Quid invenistide cuncta substantiadomus tuael pone hiccoram fratribus meis^etfratribus tuis, et ju-dicent inter me^ et te.
^.Idcirco viginti an*nis fui tecuml Ovesluae, et caprae sterilesnoji fuerunt ; arietes
. gregìs tui non comedi:
3o,. Nec captum abestia ostendi tìbi : egodamnum omne redde-bamjjuidquidfurto per-ibat) a me exigeóas:
4o. Die, noctuque ae~stu urebar^ et gelu,fu-giebatque somnus aboculis meis.
4i • Sicfjue per vìgin~ù annos in domo tuaservivi ubi, quatuorde-cim pro filiabus, et sexpro gregibus tuis : im-
peccato mi hai tenutodietro con tanto calore.
67. E hai rifrustatotutta la mia suppellet-tile ? Che hai tu trova-to di roba della tua ca-sa ? ponta qui alla pre-senza de' fratelli miei,e de'tuoi fratelli , ed cisie n o giudici tra me , ete.
38. Stetti io per que-sto venti anni teco? Letue pecore, e le tue co-pre non furono sterili-,io non mangiai gli arie-ti del tuo gregge :
39. Nè io tifacea ve-dere quelle che avea ra-pito una fiera; io paga-va tutto il danno : tuesigevi da me tutto queiche era rubato :
40. Dì, e notte io eraarso dal caldo, e dal ge-lo, e fuggiva il sonnodagli occhi miei.
41. E in tal guisa ate servii per venti anniin tua casa, quattordiciper le figliuole , e seip^' tuoi greggi : tu pur
Vers. 3g. Ne io ti facea vedere ec. Io non ti portava a vederegiammai qualche lacero membro di bestia rapita o lacerata dallefiere: tutto il danno anche casuale e avvenuto senza mia colpa,toccava a me a pagarlo,
Pent. Vol. L 14

mutasti quoque mercé-dem meam decem vici*bus.
42. Nisi Deus p a tri smei Abraham, et timorIsaac affuisset mihi,forsitan modo nudumme dimisisses : affli-ctionem meam, et labo-rem manuum mearumrespexit Deus, et ar-guit te Iteri.
43. "Respondit mLa*&an : Filiae meae, etfilii, et greges fui, etomnia, quae cernis, mea$unt: quid possum face-re filiis, et nep&tibusmeis ?
44> Veni ergo, et in*eamusfvedus^ ut sit intestimonium inter meet te.
46. Tulit itaque Ja-cob lapidem, et erexitillum in titulum :
cangiasti la mia mercé*de per dieci volte.
42. Se II Dio del pa-dre mio Abramo , e co-lui , che è temuto daIsacco, non mi avesseassistilo, mi avrestiforse adesso rimandatoignudo : Dio ha miratola mia afflizione , e lafatica delle mie mani, eieri ti sgridò.
43, Rispose a lui La-ban : Le mie figliuole,e i figliuoli, e greggituoi, e quanto tu vedi,son cosa mia : che pos,-so io fare contro de' fi-gli , o sia nipoti miei ?
44- Vieni adunque,e contraiamo allean-za , la quale serva ditestimonianza tra mee te.
4& Prese adunqueGiacobbe una pietra, ela eresse in monumento:
Vers. 4<>. * Ecco accennati i meriti d' nn buon pastore che acosto di fatiche e d'incomodi assiste il suo gregge.
Vers. 43. Le mie figliuole e i figli ... e quanto tu vedi son co-sa mia- Laban si mostra rappacificato, perchè avea paura cheDio lo gastigasse. Egli dice, che considera come cosa sua non solole figliuole e i figli delle figliuole, ma anche i greggi e tuttoe .-elio che appartiene a Giacobbe, e che perciò «gli non può vo-„,;r fare a lui alcun male.

46. Dixitque fratri-bus suis : Afferte la-pides. Qui congregan-tes fecerunt tumulum,comederuntcjue supereum,
Lfi.Quem vocavitLa-ban, Tumulimi testis, etJacob, Acervum testi-monii , uterque juxtaproprietatem Linguaesuae.
48. Dìxìtfjue Laban:Tumulus iste erit testis
' inter me et te hodie; etidcirco appellatum estnomen ejus Galaad^idest tumulus testis.
46. E disse a'suoi fra-telli : Portale pietre. Equelli, raunateie, ne fe-cero un monticello, so-pra del quale mangia-rono.
47. E Laban ehiamol-lo^il Mo n lice Ilo del te-stimone , e Giacobbe ilMonticello della testi-monianza , ciaschedunosecondo la proprietà delsuo linguaggio.
48. E Laban disse :Questo monticello saràoggi testimone tra mee te ; e per questo fudato a quel monticelloil nome di Galaad, cioèMonticello del lesli-ii) o ne.
Vers. 47- Labari chìamollo il Montichilo del testimone, sGiacobine il Monlicello della testimonianza. Nell'Ebreo la cosa( parlando rigorosamente ) è viceversa , dicendosi, che Laban kchiamò il Monlicello della testimonianza, e Giacobbe il Mon-ticello del testimone; e dee credersi, ebe dalla trascuratezzade' copisti venga la lezione differente, ebe si ha adesso nella Yoi-gata. Ma nel versetto 4& dell' Ebreo si attribuisce a Laban diaver dato il nome di Galaad a quel mouticello , e bisogna tra-durre colla Volgata fu chiamato per nome Galaad , benchél'Ebreo porti: diede ( Laban J a quel nwnticello il nome diGalaad: il senso però è lo stesso dell 'una frase e dell'altra .Mancano ancor nell' Ebreo, e sono state aggiunte dal traduttorequelle parole : ciascheduno secondo la proprietà del suo lin-guaggio : vedes? però da questo passo , che la lingua Caldea eradifferente già dall' Ebraica usata da Giacobbe, benché in originatessero probabilmente una medesima lingua.
* Della testimonianza. Dell' attestazione.

4.9. Intueatur, et ju-dicetDominus inter nos,quando recesserimus anobis.
60. Si affiixeris fi-lius meas, et si intrò-duxeris alias uxoressuper eas: nullus ser-monis nostri testis est,absque Deo, qui prae-sens respicit.
51. Dixitque rursusad Jacob : E n tumulushic, et lapis, quem erexiinter me et te,
62. Testis erit: tu-mulus, inquam, iste, etlapis sint in testimo-nium, si aut ego trans-iero ad illum per gensad te, aut tu praeterie-ris, malum mihi cogi-tans.
55. Deus Abraham,et Deus Nachor judicetinter Jios, Deus patris
49.11 Signore ponganiente, e sia giudice tradi noi, quando ci sa-rem dipartiti l'uno dal-1'altro.
5o. Se tu farai oltrag-gio alle mie figliuole ,e se oltre di esse pren-derai altre mogli : nis-suno è testimone dellenostre parole eccettoDio, il qual presente cimira.
61. E di poi disse aGiacobbe : Ecco il mon-licello , e la pietra, che-io ho eretta tra me e te,
62. Sarà testimone :questo monticeli©, iodico, e questa pietrarendan testimonianza,se io l'olire passerò istra-dandomi verso di le , ose tu l'oltrepasserai eoaintenzione cattiva con-tro di me.
53. Il Dio d' Abramo,e il Dio di Nachor, ilDio del padre loro sia
Vers. 5o. Se tu farai oltraggio alle mie figlie ... nissuna*;testimone delle nostre parole, ec. Labari vuol dire , che se Gia-cobbe verrà giammai a violare 1' alleanza che egli stabilisce oggicon ^lui , egli non citerà contro di lui altra testimonianza chequella di Dio, il quale tutto vede e ascolta. Di quello che io pat-tuisco tra me e te (dice Laban) sarà sempre testimone Dio , chevede tutto e ha possanza di punire chi viola i patti.

eorum. Juravit ergo Ja-cob per timorem patrissui Isaac :
6/\. Immolatisene vi-ctimis in monteì vocavitfratres suos^ ut ederentpanem» Qui cum come-
* dissenti manserunt ibi.
55. Zaban vero denocte consurgenS) oscu-latus estfilìos, etfiliassuast et benedixit illis;
. reversusque est in lo-cum suum.
giudice tra di noi. Giu-rò adunque Giacobbeper lui, che Isacco suopadre temeva :
54- E immolate sulmonte le vittime, invi-tò i suoi fratelli a man-giare del pane. E quel-li mangiato che l'ebbe-ro , ivi si fermarono.
55. Quindi Laban al-zatosi , che era ancornotte, baciò i figliuoli,e le figlie sue , e li be-nedisse , e tornossenea casa sua.
Vers. 53. // Dio d'àbramo , e il Dio di Nachor, il Dio del•padre loro. Notisi, che la voce usata nel!' Ebreo e nel Caldeo invece di il Dio può tradursi gli dei, e che con questa sono soven-te significati gì' idoli de' Gentili. Abbiam già veduto , che Tharée Nachor adorarono i falsi dei, come facea Laban, unendo il loroculto con quello del vero Dio ; cosi egli qui giura per gli dei diThare e di Nachor; d' onde osservano gì' interpreti essere lecitoad un fedele di ricever il giuramento che un infedele faràpe'suoi falsi numi; anzi essere anche lecito in caso di necessitàl'esigere un tal giuramento.
Giuro adunque Giacobbe ec. Giacobbe intero nella suafede giura per colui, al quale il padre suo Isacco rendeva il cul-to e l'onore che è dovuto al solo vero Dio.
Vers. 54- E immolale sul monte le vittime, ec. Giacobbe of-ferse a Dio ostie paciiìche in ^rendimento di grazie della pace fat-ta col suocero.

C A P O XXXII.
Giacobbe veduti gli Angeli spedisce messi condoni ai fratello Esaù, di cui temeva', frattan-to fa alla lotta con un Angelo, e ottiene la be-nedizione , e il cambiamento del nome , dopoche fu toccato il nervo della sua coscia.
1, J acob (i) quo-que abiit itinere, quocoeperat : fueruntque eiobviam Angeli Dei.
2. Quos cum vidis-set, alt: Castra D ei sunthaec : et appellavit no-men loci illius Malia-naim> idest Castra»
1. \_Tiacobbe anco-ra prosegui l'intrapre-so viaggio: e furono in-contro a lui gli Angelidi Dio.
2. E vedutili disse :Questi sono gli accam-pamenti di Dio : e die-de a quel luogo il nomedi Mahanaim, vale a di-re Accampamenti.
(i} Infra 48. 16.
Vers. i. Furono incontro a lui gli Angeli, Giacobbe liberodal timore di Laban , entrando nel paese di Chanaan avea ancorda temere il fratello Esali: Dio pertanto incoraggia il patriarcacon questa visione.
Vers. a. Questi sono gli accampamenti di Dìo. Nell' Ebreo lavoce Mahanaim, che significa Accampamenti, è duale; ondecomunemente gli Ebrei, e dietro ad essi molti interpreti sup-pon'.'ono, che due furon le schiere degli Angeli veduti da Gia-cobbe; l'una di quelli protettori della Mesopotamia, che lo avea-no accompagnato e custodito fino a quel luogo, P altra di quellidella terra di Chanaan, Intorno a questi Angeli custodi de' regnie delle provincie vedi Dan. XH. i. Alti xv. 9. Vedesi qui adem-piuta letteralmente quella parola di Davidde, Salmo xxxm. :U Angelo del Signore si accamperà intorno a coloro che lotemono e li salverà. Cosi Eliseo serrato d'ogni parte da' nemicivide le schiere degli Angeli armati in sua difesa, iv. Reg. vi. 1xlu quel luogo fu poi una citta che i'^be il nome di Mahanaim ,Jot. xu, a6., xxi. 38.

3. Misit autem etnunti&s ante se ad E-sau fratrem suum interram Seir, in regio*nem Edom.
4- Praecepitque eis,dicens : Sic locjuimi-ni domino meo Esau :Haec dicit frafór tuus.Jacob: A pudL ab an per-egrinatus sum , et fuiusque in praesentemdiem.
5. Habeo boves, et, asinosì et oves, et ser^
vos, et anciilas: mit-tof/ue nunc legatìonemad dominum meum, utinveniam gratiam inconspectu tuo.
6. Reversique suntinuntii adJacob dicen-tes: Venimus ad Esaufratrem tuum, et ecceproperat tibi in occur-
3. E spedi messi an-cora innanzi a sé al fra?tello Esaù nella terradi Seir, nella regionedi Edom.
4- E fece loro questacomandamento, dicen-do : Voi direte cosi alsignor raio Esaù : Gia-cobbe tuo fratello dice :10 andai pellegrino nellacasa di Laban, e vi sonostalo sino a questo dì.
5. Ho de' bovi, e de~gli asini, e delle pecore,e de'servì, e delle schia-ve : e adesso* invio mes»si al signor mio pertrovar grazia dinanzi alui.
6..E tornarono i mes^si a Giacobbe , e riferì*rono, : A.bbiam trovato11 tuo fratello Esaù, equesti ceco, ebe viene
Vers. 3. Nella terra, cfì Seir, nella ragiono di Ectàm. Moltidotti interpreti distinguono due Idumee; l'una orientale, l'altrameridionale. Della prima si parla adesso, nella quale è il montedi Seir, e in essa abito per molto tempo Esau e i suoi figliuoli ;indi occuparono anche l'idumea meridionale.
Così Esali disgustato della preferenza data a Giaqobbcda'suoi genitori, e della poca soddisfazione che questi mostrava-no delle sue consorti, avea abbandonata la Chananea, lasciandolaa Giacobbe e a* suoi figliuoli.
Vers. 4- Al signor mio Esali, Con questa dimostrazione di ri-spetto usata affine di mitigar queli' uomo feroce, non rinunziaGiacobbe a' diritti della sua primogenitura, i quali nè pure dor-\tMuo aver effetto, te non in favor de' suoi discendenti.

sum cum cjuadringeji-tis viris»
7. Timuit Jacob val"de ; et perterritus divi-sit populmn, qui sec.umerat) greges quoque, etoves, et boves,et carne-los in duas turmas,
8. Dicens : Sì vene-rìt Esau ad unam tur-mam, et percusseriteam, alia turma, quaereliqua est, salvabitur.
o.. Dixitque Jacob :Deus patris mei Abra-ham, etDeuspatris meiIsaac: Domine, quidi-xisti mihi : Reverferffin terram tuam, et inlocum nativitatis tuae,et benefaciam tibi.
io. Minor sum cun-ctis miserationibus tuiset veritate tua, quamexplevisti servo tuo. Inbaculo meo transiviJordanem istum : etnunc cum duabus tur-mis regredior*
in fretta ad incori! rarticon quattrocento uo-mini.
7. S'intimorì Giacob-be grandemente ; e pie-no di ansietà divise lagente, ch'era seco, ei greggi ancora, e le pe- ,core, e i bovi, e i cam-melli in due squadre,
8. Dicendo : Se Esaùarriverà , e darà addos-so ad una squadra, l'al-tra squadra , che resta,si salverà.
9. E disse Giacobbe :Dio del padre mio A-braham , e Dio del pa-dre mio Isaac: Signore,che dicesti a me : Tor-na alla tua terra , e alluogo dove sei nato, eio ti farò del bene.
10. Io sono indegnodi tutte le tue miseri-cordie , e della fedeltà,colla quale tu hai man-tenute le promesse fat-te al tuo servo. Solo colmio bastone io passaiquesto ( fiume ) Gior-dano: e ora ritorno condue squadre.
Yeis. 7. Divine la gente ch,' era seco ec. Osserva a questopasso s. Agostino, che il giusto dee conlidare in Dio, senza peròirascurare le diligenze e ^li aiuti umani.

11. Ente me de manufratris mei Esau, quiavalde eum timeo, ne
forte veniens percutìatmatrem cum filiis.
12. Tu locutus es,quod benefaceres mihi,et dilatares semenmeum sicut arenammaris, quae prae multi"tudine numerari nonpotest.
13. Cumque dormis"set ibi nocte illa, sepa-ravi de his, quae ha»bebat, munera Esaufratri suo>
r 4» Capras ducentas,hircos viginti, oves du-centas, et arietes vi»^inti,
15. Camelos foetascum pullis suis trigin-ta, vaccas quadraginta,et touros viginti, asi»nos viginti , et pullosearum decem.
11. Liberami dallemani di mio fratello E-saù, perocché io lo te-mo forte , che in arri-vando non uccida ma-»dre, e figliuoli.
12. Tu bai detto difarmi del bene, e di di-latar la mia stirpe co-me l'arena del mare, laquale per la moltitudi-ne non può contarsi.
13. E avendo dormi-to in quel luogo perquella notte, mise aparte di quello che a-vea , doni pel suo fra-tello Esaù,
14. Dugento capre,venti capri, dugentopecore^e venti montoni,
16. Trenta cammellifemmine , che avean fi-gliato ; co' loro parti ,quaranta vacche, e ven-ti tori, venti asine condieci loro rede.
Vers. i i . * Non uccìda madre e figliuoli. Frase proverbialesignificante la crudeltà più barbara che nella vendetta non sadistinguere fra tempo ed età.
Vers. i3.* Diijuel che avea. Di quel che gli veniva alle mani.Vers. 15. Cammelli femmine, che avean figliato ec. Il latte
de'camraelli era anche a tempo di s. Girolamo, e lo è anche ades-so la bevanda più deliziosa degli Arabi. Fedi Plin. lib. xi. 4^.

16. Et misitper ma-nus servorum suorum,singulos seorsurn gre-ges, dixitqua puerissuis: Antecedile me: etsit spatium inter gre-gem et gregem.
17. E tpraecepitprio-ri, dicens : Si obviumhabuerisfratrejn meumEsaut et interrogave-rit te : Cujus es ? aut:Quo vadis ? aut cujussunt ista, quae seque-ris ?
i $.Respondebis:Ser-vi tui Jacob ; muneramisit domino meoEsau:ipse quoque post nosvenit*
19. Similiter deditmandata secundo, ettertio, etcunctis•, qui se-quebantur greges, di-cens : lisdem verbisloquiminiadEsau, cuminvenerids eum.
20. Et addeds : Ipsequoque sèrvus tuus Ja-cob iter nostrum inse-quitur-, dixit enim: Pla-cabo illum muneribus,quae praecedunt, etpo&tea videbo illum :
16. E inviò per mez-zo dei suoi servi ognu-no di questi greggi se-parato dall'altro , e dis-se a'suoi servi: Andateinnanzi a me : e siaviun intervallo tra greg-ge e gregge.
17. E al primo co-mandò , e disse : Se in-contri il mio fratello E-saù , e ch' ei ti doman-di : Di chi sei tu ? ov-vero: Dove vai tu? o dichi son queste cose, al-le quali vai appresso?
18. Risponderai! So-no di Giacobbe tuo, ser-»vo ; egli manda questidoni al mio signore E-saù: ed egli stesso viendietro a noi.
19. Simili ordini die-de al secondo , e al ter-zo , e a tutti quelli cheandavano dietro ai greg-gi, dicendo : Nella stes-sa guisa parlate ad E-saù,quando lo troverete.
20. E soggiungerete :Lo stesso servo tuoGiacobbe seguita le no-stre pedate ; imperoc-ché egli ha detto : Loplacherò co* doni, chevanno innanzi, e poscia

forsi fan propidabiturmihi.
21. Praecesseruntitacjue munera anteeum \ ipse vero mansitnocte illa in castris.
22. Cumque mature$urrexisset, tulit duasuxores suas, et toddemfamulas cum undecimfiiiis, et transivit va-dum Jaboc.
23. Traductìsc/ueòmnibus* quae ad sepertinebant,
24. Mansit solus : etecce vir luctabatur cumeo usfjue mane.
vedrò lui : forse sì ren-derà a ine propizio.
21» Andarono adun-que innanzi a lui i do-ni ; ed egli quella nottesi stette nello alloggia-mento.
22. E alzatosi moltoper tempo, prese le suedue mogli , e le dueschiave con gli undicifigliuoli, e passò il gua-do di Jaboc.
23. E quando furo npassate tutte le cose ,che a lui appartenevano,
24. Ei si rimase solo:ed ecco un uomo fececon lui alla lotta finoalla mattina.
Vera. ao. Forse si renderà a me propizio- Forse mi darà animoa sollevar la mia faccia. L'originale.
Vers. 23. Passo il guado di Jaboc. Vale a dire passo il tor-rente Jaboc al guado, che era appresso a Mahanaim. Questo tor-rente nasce ne'monti di Galaad, ed entra nel Giordano presso alluogo, dove il Giordano esce dal lago di Genesaret. Notisi, chein questo luogo cominciava il paese delle dieci tribù, e che per-ciò già cominciavano ad effettuarsi le promesse di Dio.
Yers. ?4- Pece con itti alla lolla ec. La maggior parte de* Pa-dri e degl'interpreti in quest'uomo, che fa alla lotta con Gia-cobbe, riconoscono un Angelo del Signore, il quale rappresenta-va Dio, o sia il Figliuolo di Dio, onde nel versetto 3o se gli dàil nome di Dio. Quest'Angelo, lasciandosi vincere in questa lotta,Teniva a dare una ferma speranza a Giacobbe di poter con moltomaggior facilità superare non solo Esau, ma anche tutti i nemicie tutte le contraddizioni^ Se a petto di Dio sei stalo forte ,quanto pili vincerai tutti quanti gli uomini? vers. a 8.
Questa lotta è un' immagine della vita del giusto aopra laterra; la qual vita è una lotta e una continua milizia, o sia com-battimento , come dice Giobbe.

25. Qui cum vieterei^quod eum superare nonposset^ tetigìt nervumfemoris ejus, et statimemarcuìt.
26. Dixitque ad eum:Dimitie me ; jam enimascendit aurora. Re»spondit: Non dimittamte, nisi benedixerismihi.
27. Ait ergo: Quodnomen est tibit Respon-dit: Jacob.
28. At ille: Nequa-quam, inquit, Jacob ap-pellabiturnomen tuum,sed Israel: quoniam sicontra Deumfortisfui-sti, quanto magis con-tra homines praevale*bis?
26. E questi reggen-do, che noi polca supe-rare , toccò a lui il ner-vo della coscia., il qua-le subitamente restòsecco.
26.E disse a lui: La-sciami andare ; che giàviene l'aurora, Rispose( Giacobbe ) : Non ti la-scierò andare, se tu nonmi benedici.
27. Disse adunque iQual nome è il tuo ?Rispose : Giacobbe.
28. E quegli (disse):II tuo nome non saràGiacobbe, ma Israele :perocché se a petto aDio sei stato forte, quan-to più vincerai tuttiquanti gli uomini ?
Vers. 25. leggendo che noi polca, superare ec. Dio non vol-le, nè permise, che l'Angelo si servisse di tutta la sua possanza,nel lottar con Giacobbe. Del rimanente quello che egli col solotocco del nerbo della coscia fa provare al patriarca, è argomentodella facilità, colla quale avrebbe potuto abbatterlo. Ma si di-mostra così 1' efficacia dell' orazione e della vera pietà a muovereil cuore di Dio, e a fargli una specie di violenza per renderlopropizio agli uomini.
* Tocco. Percosse.Vers. 26. Già. viene l'aurora. Era tempo che Giacobbe andas-
se a riunirsi colla sua gente, alla quale non volea l'Angelo far-si vedere .
Se In non mi benedici. Colle lacrime agli occhi e con grandeaffetto chiese Giacobbe questa benedizione, onde si dice in Osca,ch' ei pianse e pregò.

29. Interrogavi? eumJacob : Die mihi, quoappellaris nomine ? Re-spondit : Cur quaerisnomen meum ? Et be-nedixit ei in eodem lo-co .
5o. Vocavitque Jacobnomen loci illius, Pha-nuel, dicens: VidiDeumfacie ad. faciem^ et sal-vafacta estanimamea.
29. Giacobbe lo in-terrogò : Dimmi, conqual nome ti chiami ?Rispose: Perchè doman-di del mio nome ? E lobenedisse nello stessoluogo.
30. E Giacobbe posea quel luogo il nome diPhanuel, dicendo : Hoveduto il Signore facciaa faccia, e l'anima miaha avuto salute.
Vers. 9.8. Il tuo nome ... non sarà Giacobbe, ma Israele,Questo nome è dato di nuovo a Giacobbe, cap. xxxv. io., e se-condo la più probabil sentenza significa principe di Dio, ovveroprincipe con Dio, quasi dicesse l'Angelo: Com'io son principe,cos\ anche tu che hai potuto lottare con me, sarai chiamaloprincipe, Hier. Trad. Hebr.
Vers. 29. Perche domandi del mio nome? I,'Angelo non vol-le dire il suo nome, o perchè non ne prendessero i posteri diGiacobbe occasione di rendergli un culto superstizioso, o piutto-sto perchè quest' Angelo rappresentava il Verbo , il quale doveaincarnarsi, il cui nome non dovea ancor rivelarsi.
Vers. 3o. Pose a quel luogo il nome di PhanueL Questo no-me significa faccia di Dio. 1 LXX lo traducono forma di Dio,ovvero figura di Dio: della qual versione ci dà questo senso ilCrisostomo (hom. 58.) dicendo: Giacobbe diede a questo luogoil nome di figura, o immagine di Dìo , e venne edire, che questi avrebbe un (ù presa V umana
. i i ..?; _ j , _ _ _ _• _ z . _ • •
goenne con ciò a pre-
, , umana natura. Maperche allora non altro aveasi, che un cominciamento , e unpreludio delle cose future , il Verbo appariva a que"1 palriar-chi in figura. Ma allorché il Signore degnassi di prendere laforma ' deW uomo , non prese solo una carne apparente ,ma vera.
JJ anima mia ha avuto salute. Osservò s. drillo, esserestata antica opinione , che il vedere un Angelo portava seco lamorte; onde cosi egli, come altri interpreti spiegano: Non soloho veduto V Angelo ; ma ho trattato con lui lesta lesta, e nonme n1 e venuto alcun male: altri pero col Grisostomo intendo-no, che Giacobbe voglia dire, che la visione mandatagli da Dio,e la benevolenza e affetto mostratogli per mezzo dell' Angelo lo

31. Ortusque est eistatim sol, postf/uamtrans gressus est Pha-nuel : ipse vero claudi-cabat pede.
32. Quam ob causamnon comedunt nervumfilii Israel) qui emar-cult in femore Jacob,usque in praesentemdiem : eo quod tetigeritnervum femoris ejus, etobstupuerit.
3i. E il sole venne anascer subito, dopo cheegli si fu avanzato di làda Phanuel : ed egli zop-picava del piede.
3s. Per questa ragio-ne i figliuoli d'Israelefino a questo dì nonmangiano il nervo, chesi seccò nella coscia diGiacobbe : perchè que-gli toccò il nervo dellacoscia di lui , e ( il ner-vo ) restò senza moto.
avrà liberato da ogni timore , e lo avea riempiuto di generosafidanza. '
Vcrs. 31. * Zoppicava del pied*. A Giacobbe vincitore nellamisteriosa lotta, e quindi benedetto e onorato dì assai gloriosonome, un ricordo si conveniva della natural sua debolezza, per-chè non si levasse in altura: ricordo simile a quello che nellalegge di grazia ebbe l'istesso Paolo favorito dal cielo di doni spe-ciali. Vedi II. Cor. XII. v. 7.
Yers. 3a. I figliuoli <? Israele non mangiano ec. Ciò fu os-servato e si osserva tuttora dagli Ebrei non per legge, ma pertradizione in memoria di quello che era avvenuto a Giacobbe. IlBuxtorf racconta , che in Italia gli Ebrei levano dalla parte didietro degli animali non solo il nervo, ma anche le vene ; che inGermania poi si astengono totalmente da'quarti didietro, e l ivendono a'Cristiani ; ma (dicesi) dopo aver mandate mille im-precazion! contro chi li mangerà, e fatte altre sordide cose, leyuali sono attestate da tutt i i Giudei convertiti.

C A P O XXXIII.
dacobbe è accolto benignamente da Esaù , chegli va incontro , e a mala pena ottiene , chefjuègli accetti i suoi doni, e se ne torni a suacasa. Quindi Giacobbe arriva a Salem, e vicompra una parte di un campo , e piantate letende alza un altare.
ìjjlevans autemJacob oculos suoSt viditvenientem Esau,etcumeo quadringentos viros :•divisitcjue filios Liete,
. etRachel.amèarumf/ùefamularum :
2. Et posuit utram-fjue ancillam, et Uh erosearum in principio :Liam vero, et filios ejusin secundo Loco : ha"chel autem, et Josephnovissimos.
3. Et ipse prQgre-diens adoravit pronusin terram septies , do-nec appropine/uaretfra-ter ejus*
4- Currens itaqueEsau obviamfratri suoamplexatus est eum :
1. i'Ja alzando isuoi occhi Giacobbe vi-de Esaù , che veniva, econ lui quattrocentouomini : e divise i tìglidi Lia , e di RacheJe , edelle sue schiave:
2. E 1* una , e P altraschiava, e i loro figliuolili pose in primo luogo.Lia , e i figliuoli di leinel secondo luogo : eRachele, e Giuseppe daultimo.
3. Ed egli andandoinnanzi s'inchinò finoa terra sette volte, pri-ma che si approssimas-se il suo fratello.
4. Corse allora Esaùincontro al suo fratello,e lo abbracciò : e strin-
Vers. 3. S'inchinò fino a. terra sette volte, Giacobbe per am-mansire la ferocia di Esau lo saluta fino a sette volte col massi-mo se^no di rispetto.

stringensque collumejuSt et osculans flevit.
6. Levatisque oculis^vidit mulieres et par-vulos earum , et alt :Quid sibi volunt isti?et si ad te pertineìit ?Respondit: Parvulisunt^quos donavit mihi Deusservo tuo.
6. Et appropinquan-te s ancillae^ et filii ea-rum incurvati sunt.
7. Accessit quoqueléia cum pueris suis :et cum similiter ado-rassent, extremi Jo-seph, et Racliel adora-verunt.
8. "ùixitque E s an :Quaenam sunt istaeturmae^ quas obviamhabui? Respondit : 171:invenirem gratiam co-ram domino meo.
9. At ille alt : Habeoplurima, frater mi: sinttua liói.
gendoglì il collo, e ba-ciandolo pianse.
5. E alzati gli occhi,vide le donne , e i lorobambini, e disse : Chison questi? son eglinotuoi ? Rispose : Sono ifigliuoli, che Dio ha do-nati a me tuo servo.
6. E appressandosi leschiave, e i loro figliuo-li s'inchinarono profon-damente.
7. Si appressò ancheLia co' suoi figliuoli t e -dopo che si furono nel-la stessa guisa inchina-ti, Giuseppe, e Rache-le fecero ultimi profon-do inchino.
8. E disse Esaù : Chesignificano le squadre,che io già incontrai ?Rispose: Bramai di tro-var grazia nel cospettodel signor mio.
9. Ma quegli disse :Ho dei bene di là damolto , fratel mio : tie-ni il tuo per te.
Vers. f». * E appressandosi. E condotte avanti.Vers. 8. Che significano le squadre? Parla de' bestiami man-
dati innanzi da Giacobbe in dono ad Esaù. Esali dovea già esse-re stato informato da' guardiani ; ma interroga di bel nuovo peraver occasione di rifiutare il dono.

io. Dixitque Jacob :"Noli ita, obsecro : sedsi ìnvenì gratiam inoculis tuis t accipe mu-nuscukim de manibusmeis : sic enim cidi fa-ciem tuam, quasi vide-rim vultum Dei : e stomihi propiduSy
\ i. Et suscipe bene-fVdictionem> quam aitali
tibi et quam donavitmihi Deus triluensomnia. Vixfratre com-pelle nte suscipienS)
12. Ait: Gradìamursimuli eroque sociusitìneris lui.
13, Tìixitquè Jacoh :Tfastiy domine mi, quodparvulos habeant tene-ros, et oves, et bovesfoetas mecum : quas siplus in ambulando fè-
i o. E Giacobbe disse ;Non far così, ti prego:ma se ho trovato gra-zia negli occhi tuoi, ac-cetta il piccol dono dal-le mie matti : imperoc-ché io ho veduto la tuafaccia , come se io ve«dessi il volto di Dio :siimi propizio }
11. E accetta la be-nedizione , che io ti horecato, e la quale fudonata a me da Dio, ilquale dà tutte le cose.E accettandola a matapena sforzato dal fra-tello ,
12. Disse quegli: An-diamo di conserva, e ioti sarò compagno nelviaggio.
13. Ma disse Giacob-be: Tuvedi,signor mio,che io ho meco de' te-neri bambini, e pecore,e vacche pregne : è segli affaticherò più del
Vers. io. Ho veduto la tua faccia, come se io vedessi ce. Laclemenza, e 1' amorevolezza che io ho trovato in te-, mi ha rin-francato lo spirito ne' miei timori, e ha fatto in me un effetto si-mile a quello che farebbe 1' apparizione di Dio o di un Angeloin un uomo afflitto e bisognoso di conforto.
Siimi propizio. Concedimi questa grazia.Vers. 13. Pecore e vacche pregne, ovvero, che allattano le
laro rsde.
Pcnt. Vol L 14 *

cero lavorare, morien-tur una die cuncti gre-ges.
14« Praecedat domi-nus meus ante servuinsuum: et ego sequarpaulladm vestigio. ejus,sicut videro parvulosmeos posse, donec ve-niam ad dominummeum in Seir.
15. Respondit Esau :Oro te, ut de populo,qui mecum est, saltemsodi remaneant viaetuae. Non est, inquit,necesse: hoc uno tan-tum ìndigeo, ut inve-niam gratiam in con-spectu tuo, domine mi.
\ 6. Reversus est ita*que illo die Esau itine're, quo venerai in Seir.
17. EtJacob venitinSocoth-. ubi aedificatadomo, etfixis tentoriis^appellavit nomen loci
dovere a camminare,morranno in un dì tut-ti i greggi.
14- Vada il signor miodavanti al suo servo: eio seguirò bel bello lesue pedate, conformevedrò, che possano farei miei bambini, lino atanto ch'io giunga pres-so al signor mio a Seir.
16. Rispose Esaù:Ti prego di lasciar, chealmeno restino dellagenie , che è con me, .alcuni, che ti accompa-gnino nel viaggio. Nonè necessario, disse que-gli : di questo solo hobisogno , di trovar gra-zia nel cospetto tuo, miosignore.
16. Tornò adunquein quel giorno Esaù perla strada, per cui eravenuto in Seir.
17. E Giacobbe giun-se a Socoth : dove fab-bricata avendo una ca-sa, e piantate le tende,
Vers. 14- Fino a tanto ch' io giunga ... et Seir. Giacobbe pen-sava allora di andare lino colà a casa dei fratello; ma di poi can-giò di parere forse per timore che non si risvegliassero in Esaule antiche gelosie, o perchè ricevesse qualche notizia, per la qua-le conosi-esse che non era opportuna allora questa visita.

illius Socoth, id est,Tabernacula.
18. Transivitque inSalem urbcm Sichìmo-rum, f/uae est in terraClianaan, postfjuam. re-versus est de Mesopo-tamia Syriae : et habi"tavit juxta oppidum.
io,. Emitfjiie partemagri, in quafìxerat ta-bernacula , a filiis JZe-mor patris Sichem ceri-
~ tum agnis.
diede a quel luogo ilnome di Socoth, vale adire Padiglioni.
18. E dopo il suo ri-torno dalla Mesopota-mia di Siria passò a Sa-lem città de' Sicbimiti,che è nella terra di Cha-naan : e abitò pressoalla città.
io,. E comprò quellaparte di campo , doveavea piantate le tende,da' figliuoli di Hemorpadre di Sichem percento agnelle.
Vers. 17. A Socolh, dove fabbricala ec. Dalle tende che alzòivi Giacobbe, venne il nome di Socoth a questo luogo , dove fupoi edificata una città dello stesso nome, che era nella tribù diGad. L' avervi Giacobbe fabbricata una casa dà argomento percredere che ivi si fermò qualche tempo.
Vers. 18. Passo a Salem citta de> Sichimiti. Passò il Giordano,e da Socoth andò nel paese de' Sichimiti, .dove fece sua dimorapresso la città di Salem nella Chananea. Alcuni moderni seguen-do la tradizione degli Ebrei traducono in questa guisa P Ebreo :arrivo salvo alla citta de1 Sichimiti : perocché la stessa voceSalem significa salvo , sano,ec.; e soggiungono gli Ebrei, chein questo luogo Giacobbe rimase sano dalla gamba, della qualeera stato zoppo fino a quel punto , onde dicesi: arrivo salvo ec.
Vers. iq. Per cento agri elle. La prima maniera di contrattarenell'antichità fu certamente per via di permute; e gli antichi in-terpreti tutti quanti suppongono fatta questa compra da Gia-cobbe con dare cento agnelle. Molti moderni però la voce origi-nale spiegano in significazione di moneta, danaro, ec. e alcunidi questi pretendono , che fossero monete che portavano l'im-pronta d'un'agnella, come effettivamente si costumava nell'anti-chità; onde dalle pecore venne il nome di pecunia alla moneta.Basti 1' avere toccato questo punto senza entrare in più lungadiscussione di una materia, sopra la quale non possono aversi secon deboli congetture.

so. Et erecto ibi al-tari , invocavit super il-ludfortissimum DeumIsrael.
so. E ivi alzato unaltare, dinanzi ad essoinvocò il fortissimo Diod'Israele.
C A P O XXXIV.
Dina è rapita da Sichem figliuolo del principede* Sichimiti, i quali prima circoncisi son tru-cidati da Simeone, e da Levi , fratelli di Di-na ; e dagli alfri figliuoli di Giacobbe è deso-lata la loro città : per la qual cosa Simeone^ eLevi sono sgridati dal padre.
i. tLgressa est au-tem Dinafilia Lìae, utvideret mulierem regio-ms illius.
3. Quam cum vìdis-set Sichem filius HemorHevaeitprinceps terreteillius^ adamavit eam :et rapmty et dormivit
1. ITXaDina figliuo-la ài Lia uscì di casa pervedere le donne di quelpaese.
2. E avendola vedutaSichem figliuolo diHe-mor Heveo, principe diquella terra , se ne in-namorò .* e rapili a, e
V)Vers. 20. Dinanzi ad esso invoco ec. Ovvero gli pose nome
il fortissimo Dio d1 Israele per significare, ebe a lui e in onoredi lai era dedicato questo altare. Questa imposizione di nomeagli altari, a'mouumenti, e a'luoghi particolari serviva a conser-var la memoria de' fatti, e anche a conservare la tradizionede'principii della religione. Così il nome del Dio d'Israele ram-memorava nn gran fatto, per cui fu cambiato il nome a Giacob-be. fedi cap. preeed.
Vers. i. Ma Dina ec. Élla poteva avere in quel tempo circaquindici anni. Se crediamo a Giuseppe, la curiosità di questafanciulla ( la quale costò a lei cosi cara) fu risvegliata dal rumoredi una festa solenne che si celebrava con gran concorso. Din*volle vedere, come si ornassero le fanciulle del paese, e sgvazia-tornente usci della casa paterna.

cum illa, vi opprimensvìrginem.
3. Et conglutinataest anima ejus cumea,tristem(/ue delinivitblanditiis.
4» Etpergens ad He-mor patrem suum: Ac-cipeì inquit,, mihi puel-lam hanc conjugem.
6. Quod cum audis-set Jacob, absentibusfiliis et in pastu peco*rum occupatis^ situa,
. donec redirent.
6. Egresso qutemHemor, patre Sichem,ut loquGreturad Jacob;
7. JScce fila ejus ve*niebant de agro : andi'toque, quoé acciderat,ir ad sunt valde, eo quodfoedam rem operatusesset, in Israel, et vio-lata filia Jacob, rem il-licitam perpetrasset.
violentemente disonoròla fanciulla.
3. E concepì jper leiun'ardente passione,ed essendo ella afflittal'acquietò con carezze.
4. E andato dal pa-dre suo Heraor: Prendi»disse, per me in mogliequesta fanciulla.
5. La qual cosa aven-do udita Giacobfoe,mentre i figli erano as-senti , e occupati a pa-scer le pecore, si tacque^finchè non furon torna ti.
6. Ma essendo andatoHemor, padre di Si-chem , a parlare a Già-cobbe;
7. Eccoti che i fi-gliuoli di lui tornava»dalla campagna : e in-tesa quel eh' era avve-nuto, ne concepironogrande sdegno, perchèsì brutta cosa avessefatta ( Sichem ) controIsraele , e violata la fi-gliuola di Giacobbe, a-vesse commesso un'a-zione vituperosa.
"Vers i. * Violen temente disonoro. Ebr. Umiliò.Vers. 4- * E andato dal padre suo. La stessa ragion natural*
consiglia, che non s'impegnino i figli nel matrimonio senza Pap-*provazione e il consenso de'genitori.

8. Locutus est. itaqueHe m or ad eos : Sichemfilii mei adhaesit ani*ma filine vestrae : dateeam illi uxorem:
9. Etjungamus vicis-sim connubia : filiasvestras tradite , nobis,et filias nostras acci-pi te.
10. Et habitat e no-biscum : terra in potè-state vestra est, exer-cete, negotiaminì, etpossidete eam.
11. Sed et Sichem adpatrem, et ad fratresejus ait: Inveniam gra-tiam coram vobis, etcjuaecumque statueritisdabo.
12. fugete (totem, etmunera postulate, etlibenter tribuam, quodpetieritis : tantum datemihi puellam hanc uxo-rem.
13. Responderunt fi-lii Jacob Sichem, etpatri ejus in dolo, sae-
8. Disse pertanto adessi Hernor : L' animadi Sichem mio figlio èunita inseparabilmentea questa vostra fanciul-la : dategliela in moglie .
9. E facciamo scam-bievoli matrimonii; da-te le \rostre fanciulle anoi, e sposate delle no-stre fanciulle .
10. E abitate tra noi :la terra è in poter vo-stro , lavoratela , traffi-cate, voi siete i padroni,-
11. Anzi lo slesso Si-chem disse al padre , ea' fratelli di lei: Piega-tevi a' miei desiderii, edarò tutto quello ch e viparrà.
12. Augumenlate ladote , e chiedete dono-ra , e volentieri daròquello che chiederete :purché mi diate in mo-glie questa fanciulla.
13. Risposero i fi-gliuoli di Giacobbe aSichem, e al padre di lui
Vcrs. 7. Contro Israele. Contro Giacobbe padre di Dina.Vers. i«. Augiimenlate La dole e chiedete donarci, ec. Si è
già notato altrove il costume che lo sposo dotasse la sposa e fa-cesse de'presenti al padre e a'fratelli di lei.

vientes ob stuprum so-roris :
14- Non possumusfacere, quod petitis, necdare sororem nostraniflamini incircumciso ,'fjuod illicitum, et nefa.rìum est apud nos.
io. Sed in hoc vale-l>ìmus foederariì sì vo-lueritis esse similesnostri .etcircumcidatur
9 in vobis omne mascu-liìii sexus j
16. Tunc dabimus,et accipiemus mutuo fi-lius vestras, ac nostras :et habitabimus vobis-cum, erimusfjUG unuspopulus.
17. Si autem circum-cidi nolueritiS) tollemusfiliam nostram, et rece-demus.
con fraude, essendo esa-cerbatipel disonore del-la sorella :
14. Non possiam farequello che voi bramate,nè dar la nostra sorellaad un uomo incirconci-so : la qual cosa è ille-cita , e abbominevolepresso di noi.
16. Ma potrem farealleanza con questacondizione , se vorretefarvi simili a noi , e sesi circonderanno tra voitutti i maschi ;
16. Allora vi daremole nostre fanciulle, eprenderem parimentele vostre : e abiteremocon voi, e faremo un solpopolo.
17. Ma se non vorre-te circoncidervi, pren-deremo la nostra fan-ciulla , e ce ne andere-mo.
Vera. 14. Ne dar la nostra sorella ad un uomo incirconciso.Egli è vefisimile , die appoco appoco s'introducesse tra'posterid'Abramo questa regola anche prima della legge di Mosè ; ma inquesto tempo non si poteva egli rispondere a costoro , che il loropadre avea sposate le figlie di un incirconciso , qual era Luban ?E Giuda e Simeone sposarono pure donne Ghananee, come ve-dremo; parlano adunque con menzogna e con frode.
Vers. i^. Prenderem la nostra fanciulla. Da queste parolee dal versetto 26, apparisce , che Dina era tuttora in casa deirapitore.

18. Placuit oblatioeorum Hemor, et Si-chem filio ejus :
19. Nec distulit ado-lescens quin statim,quod petebatur, exple-rct i amabat enim puel-lam valde, et ipse eratinclytum in omni domopatris sui.
20. Ingressique por*tam urbis , loculi suntad populum :
21. Viri isti pacificisunt, et volunt habita-re nobiscum: negotien-tur in terra , et exer-ceanteam, quae spa-tiajta, et lata cultori-bus indiget : filias eo-rum accipiemus uxo-res, et nostras illis da-èimus.
22. Unum est, quodiffertur tantum bo-num', si circumcidamusmasculas nostros , ri-tum gentis imitantes.
«5, TZtsubstantia eo-rumt et pecora, et cun*cta,quaepossident, no>stra erant : tantum inhoc acquiescamus, et
18. Piacque la loroofferta ad Hemor , e aSichem suo figliuolo.
19. E il giovane nondifferì ad eseguire quel-lo che era stato richie-sto : perocché amavagrandemente la fan-ciulla , ed egli era ingrande onore pressatutta la famiglia del pa-dre suo,
20. Ed entrati dentrola porta della città, dis-sero al popolo :
21. Costoro son buo-na gente , e amano diabitare tra noi : traffi-cheranno qui, e lavore-ranno la terra,la quale,spaziosa e vasta com'è,ha bisogno di coltivato-ri: noi sposeremo le lo-ro fanciulle, e daremoloro delle nostre.
22. Una sola cosa èd' ostacolo a un benesi grande : vuoisi, chenoi circoncidiamo! no-stri maschi, imitandoil rito di questa gente»
23. Con questo sarannostre le loro ricchez-ze, e i bestiami, e luttoquello ch' ei posseggo*rio : accordiamoci sol^

iialitàntes simul unumefficiemus populum.
. 24. Assensique sunt'omnes fircumcisis cun»ctis maribus.
26. Et ecce die tertio,quando gravissimusvulnerum dotor est, or-reptis j duo filii Jacob,Simcon, etLevitfratresDinae, gladiist ingres-si sunt urbem confiden-ter: (i) interfectisqueomnibus masculist
26. Hemor, etSichempariter necaverunt^ tol-lentes Dinam de domoSichem&ororem suam.
27. Quibus egressistìrruerunt super occiso*
in questo, e vivendo in-sieme faremo un sol po-polo.
24. Diedero tutti illoro assenso , e circon-cisero tutti i maschi.
26. Ed ecco il terzogiorno, quando il dolo-re delle ferite è più a-cerbo, i due figli diGiacobbe, Simeone, eLevi, fratelli di Dina ,impugnate le spade, en-trarono a man salvanella città: e uccjsi tut-ti i maschi,
26. Trucidarono an-che Hemor, e Sichem,e tolsero Dina loro so-rella dalla casa di Si-chem.
27. E quando questisi furono ritirati, gli
(i) Infra 4<> 6.
Ver» 23. Saran nostre le toro ricchezza e 1 toro bestiami ec.Vedesi-j che Hemor e Sichem non propongono altro motivo chequello dell' interesse per abbracciare la circoucisiotìfc. Essi «no-strano a' lorp concittadini P accrescimento grande di potenza edi ricchezza che ne verrà dalla unione de' nuovi ospiti in un solpopolose la pietà e la religione non ebbero parte alla risolu-zione di quella gente.
Vers, z5. Il terzo giorno , quando il dolore delle ferite ec.Nelle ferite il terzo giorno suoi venir la febbre a causa dell'in-fiammazione.
Sitneon e Levi. Fratelli uterini di Dina. Questi certamenteebbero seco un gran numero di servi : gli altri fratelli non si ve-de che avessero parte a questo macello, «aa, eplamejute al tac-cheggiamerito della città, ver s. 27.

ceteri filii Jacob : etdepopulad sunturbemin ulùonem stupri.
28. Oves eorum, etarmenta^et asinos^ cun-ctaque vastantes^ quaein domibus', et in agriserant.
29. Parvulos quoqueeorum, et uxores duxe~runt captivas*
3 o. Quibus patratisaudacter, Jacob dixitad Simeon , et Levi :Turbastis me , et odio-sumfecistis me Ghana-naeis, et Pherezaeis,habita foribus terraehujus : nos pauci su-mus : illi congregatipercutient met et dele~hor ego, et domus mea.
31. Responderunt :Numguid ut scorto abutidebuere sor ore nos trai
altri figliuoli di GiacoK-be si gettarono sopra gliuccisi : e saccheggiaro-no la città per vendettadello stupro.
28. Preserie loro pe*core , e gli armenti, egli asini, e diedero ilguasto a quanto era perle case, e alla campagna.
29. E menarono an-che schiavi i fanciulli, e fle donne loro.
30. Eseguite che eb-bero essi queste cosecon tanta audacia dis-se Giacobbe a Simeon,e a Levi : Voi mi aveteposto in affanno , e miavete renduto odioso aiGhana nei, e a'Pherezei,abitatori di questa ter-ra : noi siam pochi : que-gli uniti insieme mi ver-ranno addosso, e io sa-rò sterminato con la miafamiglia.
31. Risposer quegli:E dovean essitrattar ]anostra sorella come unadonna di mal affare ?
Vers. 27. Si gettarono. Infierirono, andaron sopra gli uccisi.Vers. 28. e »g. Fresar le pecore eo. Giacobbe, il quale disap-
provò quest' azione come perfida e temeraria , non si dubita chefacesse rendere e la libertà, e la rolsa loro alle donne, e a' fau-ciuili rimasi in vita.

C A P O XXXV.
Giacobbe dopo aver seppelliti presso a SìchemgV idoli della sua gente, per comando del Si'gnore sale a Bethel : dove alzato un altareal Signore offerisce sacrifizìo , ed è conforta-to da una nuova apparizione di Dio. Morte diTì ebora. Nascita di Bemamin colla morte diRachele. Ruben commette incesto con Baia.Novero de*figliuoli di Giacobbe , e morte à"I«sacco suo padre.
i. \_nterea locutusest Deus ad Jacob :
* S urge i et ascende Bet-hel, ethabita ibi,facquealtare Deo, qui appa-ruit tibi^ quando fugie-basE&suifratrem tuum.
rallento il Si-gnore disse a Giacobbe :Sorgi, e va in Bethel, eivi fermati, e fa un al-tare a Dio , il quale tiapparve allorché fug-givi Esaù tuo fratello.
Suor." 38, 16.
Vers. 3 o. Voi mi avete posto in affanno, ec. Giacobbe dimo-strerà anche con maggior enftrgfa 1' orrore, col quale udì unacrudeltà si grande de'proprii figliuoli nel capo XLV. 5. Peccaronoi figliuoli di Giacobbe di menzogaa, di perfidia, d* ingiustizia, disacrilegio e di vendetta barbara e inumana. Ingannarono i Sichi-miti e tradiron la fede, e pel peccato di un solo trucidarono uàgran numero di persone, e a compiere si orribil disegno abusa-rono di un rito sacro e religioso, servendosene di pretesto a co-prire lo spirito di vendetta. Finalmente non può non condannar-si d' empietà il disprezzo ch' ei fecero del proprio padre, intra-prendendo cosa tale senza sua saputa, portando un colpo morta-le al cuore di lui pieno di umanità e di amore de'prossimi. Dal-l'altro lato la giustizia divina permise, che i Sichimiti portasserla pena delle loro iniquità; e dell'audacia e della perfidia e inu-manità de* due fratelli si valse ad eseguire i suoi decreti sempregiusti e adorabili.
* Mi avete renduto odioso. Ebr. Puzzolente.Vers. i. // Signore. disse a Giacobbe : sorgi ec. Dio viene a
confortare Giacobbe nell' agitazione, in cui si trovava per quello

a. Jacob ver o i convo-cata omni domo sua,alt: Abjicite deos alie*nos, qui in medio vestrisunt, et mundammiì acmutate vestimenta ve-stra.
3. Sur gite > et ascen-damus in Bethel, ut fa*ciamus ibi altare Deo:qui exaudivit me in dietribulationis meae , etsocius fuit itineris mei.
4« Sederunt ergo eiomnes deos alienos^quos habebant^ et inau-res, quae erant in aw*
2. E Giacobbe, rati-nata tutta la sua fami-glia, disse : Gettate viagli dei stranieri, che a-vete tra voi, e monda-tevi , e cangiate le vo-stre vesti.
3. Venite, e andiamoo Bethel per far ivi unaltare a Dio: il quale miesaudì nel giorno di miatribolazione , e mi ac-compagnò nel mio viag-gio.
4« Diedero pertanto alui tutti gli dei stranie-ri che aveano, e gli o-recchini, che quegli a-
eKe i suoi figliuoli avéati fatto centrò de' SicKimiti, e per quelloche di ciò poteva avvenirne, irritati per tanta crudeltà gli animide' Chananei.
Yers. 2. Gettate vìa. gli del stranieri che avete ec. Può essereclie gl'idoli, i quali Giacobbe comanda di gettar via fossero statiserbati della preda de' Sichimiti; e può anch'essere, che in ungrandissimo numero di servi che erano in quella famiglia con-dotti dalla Siria, ve ne fosse più d'uno che continuasse a rende-re culto a' falsi dei. Ma non sembra credibile , che alcuno de' fi-gliuoli o delle mogli di Giacobbe peccassero in questo. Il v$,de-re che questi intima l'ordine di gettar via gl'idoli, dopo che Diogli avea parlato e l'avea avvertito di quello che dovea fare aBethel in suo onore, può dar fondamento per credere che nonprima di adesso egli venisse in cognizione di questo disordine, eche Dio stesso gliene desse notizia.
Mondatevi, e cangiate le vostre vesti. Per un interno istin-to del rispetto dovuto a Dio fu sempre costume, che volendo glinomini accostarsi a lui per onorarlo, o si mutasser le vesti, 2.Reg. xn. ao., ovvero le lavassero, Exod. xix. 20. Levit. xv. i3., ela nuova veste era simbolo di penitenza, e di conversione. CosiGiacobbe esorta la sua gente a prepararsi per andare a Betliel aonorare il Signore.

rìbns eorum : at illeinfodit ea sub ter tere-bìnthum^ quae est posturbem Sìchem.
5. Cumque profectiessent^ terror Dei in-vasit omnes per circuì»tum civitates, et nonsunt ausi persegui re"cedentes.
6. Fenit igitur JacobLuzani) quae est in ter-»ra Chanaan , cogno-mento Bethel : ipse etomnis populus cum eo.
7. J&dificavitque ibialtare, et appellantinomen loci illius, Do-mus Dei : ibi enim (i)apparuit ei Deus , cumfugeretfratrem $uumf
vevano alle orecchie :ed egli li sotterrò sottoil terebinto, che è di làdalla città di Sichem.
5. E partiti ch' ei fu-rono , il terrore di Dioinvase tutte le città al-l'intorno, e non ardiro-no d'inseguirli, mentreSÌ ritiravano, ìt
6.Giacobbe adunque,egli, e tutta la sua gen-te con lui arrivò a Lu-za cognominata Bethelnella terra di Chanaan.
7. E ivi edificò l'alta-re, e a quel luogo poseil nome di Casa di Dio :perocché ivi apparveDio a lui, quando fug-giva il fratel suo.
(i) Supr, »& j3.
Vers, 4- E gli orecchini che quegli aveano allò orecchie.La voce ebrea significa propriamente anelli da attaccarsi alleorecchie e al naso, o da appendere per ornare la fronte. S. Ago-etino, il Crisostomo e altri interpreti credono, che questi anelli,o sia orecchini ornavano gì' idoli, e non gli uomini. Fedi anchePlin. lib. xxin. cap. i. Simili anelli con figure de* falsi dei siportavano assai comunemente dagli uomini e dalle donne, ederano una specie di Talismani, o Amuleti contro le malattie, ledisgrazie, ec. Vedi August. de doctr. Christ. lib. n. a o.
Li sotterro sotto il terebinto ce. Si può credere, che li met-tesse in pezzi, ovvero li fondesse, e di poi segretamente li sep-pellisse sotto il terebinto, o sia quercia.
Vers. 5. Il terrore di Dio invase e e. Il timore ( dice il Criso-stomo ) con cui Giacobbe onorava Dio, merita che Dio lo rendaterribile a tutti gli uomini; onde nessuno ardisca di nuocergli)nè di pensare a far vendetta della «trago de' Sicbjmiti.

8. Eodem temporemortuo, est Decora,nutrix Rebeccae, et se-putta est ad radìcesBethelsubterquercum :vocatumque est nomenLoci illius Quercusfle-tus.
g. Apparuit autemiterumj)lpusJacob,post-fjuam reversus est deMesopotamia Syriae>òenedixitque ei,
io. Dicens : (i) "Nonvocabèris ultra Jacobtsed Israel erit nomentuum. Et appellavìteum Israel.
i.i. Dixitque ei: EgoDeus omnipotens ; cre-sces et multiplicare :gentes, et populi natìo-
8. Nello stesso tem-po si morì Debora, ba-lia di Rebecca , e fu se-polta appiè di Bethelsotto una quercia : e fuchiamato quel luogo laQuercia del pianto.
9. E Dio apparve aGiacobbe la secondavolta, dopo il suo ritor-no dalla Mesopotamiadella Siria , e lo bene-disse,
10. Dicendo :Tu nonti chiamerai più Giacob-be , ma il tuo nome sa-rà Israele. E chiamolloIsraele.
11. E soggiunsegli ;Io il Dio onnipotente ;cresci, moltiplica : tusarai capo di nazioni, e
(i) Supr. 3a. 28.
Vers. 7. A quel luogo pose il nome di Casa dì Rio. Confer-mò il nome di Bethel dato già a quel luogo, cap. xxvui. ap.
Vers. 8. Appiè dì Sethet. Appiè del monte, sopra del qualefu edificata la città di Bethel.
Quercia del pianto. Perchè quivi Giacobbe co'suoi feceroil lutto della morte di Debora, la quale dovette essere donna dinon ordinaria virtù.
* Si mori Debora balìa di Rebecca. Ma come si parla quidella morte di questa donna ? Fors' ella già restituitasi nel suopaese, nell'occasione del ritorno di Giacobbe alla madre, erasimossa per far visita ali' antica padrona.
Vers. g. La seconda volta, dopo il suo ritorti o ee. Eragli giàapparso poco prima, quando gli ordinò di portarsi a BetheL

num ex te erunt, regesde lumbis tuis egre'dientur.
12 .Terramque, quamdedi Abraham^t Isaac,dabo tibi3 et semini tuopost te.
13. Etrecessitab eo.14» Hie vero erexit
titulum lapideum in lo-co, quo locutus fueratei Deus : libans supereum libaminaì et ejfun-dens oleum :
16. Vocansque no-men loci illius Bethel.
16. Egressus auteminde venit verno tem-pore (id terram, quaeducit Éphratam: in quacum parturìret Rachel,
17. Ob difficultaióm,partus periclitari coe-pit. Dixitque ei obste-trix : Noli timere ; quiaet hunc habebis filium.
18. Ingrediente au-tem anima prae dolore,et imminente jam mor-
al popoli, da te usciran-no de're.
12. E la terra, che iodiedi ad Abramo , e adIsacco , la darò a te , ealla tua stirpe dopo dite.
13. E partissi da lui.i4- Ed egli eresse un
monumento dil* pietranel luogo, dove Dio gliavea parlato: facendovisopra le libagioni, e ver-sandovi dell' olio :
15. E pose a quel luo-go il nome di Bethel.
16. E partitosi di co-là andò nella primave-ra ad un luogo sullastrada diEphrata : dovevenendo i dolori di par-to a Rachele,- 17. Essendo il parto
difficile, cominciò ad es-sere in pericolo. E lalevatrice le disse : Nontemere ; tu avrai ancoraquesto figliuolo.
18. E stando ella perrendere l'anima pel do-lore , e già in braccio
Vers. 14. Facendovi sopra le libagioni. Lavò col vino, e imsecon olio la pietra. Vedi cap. XXVIH. 18. Questa pietra servi al-1' altare ch' egli eresse in quel luogo secondo 1' ordine di Dio 3

te vocavit nomen filio*sui Bertoni, id est, fi-lius doloris mei : patervero appellavit eumBen-iamin,id est, filiusdextrae.
19. Mortua est ergoRachel. Et sepulto, estin via, quae ducit E-phratamjiaec estBeth-lehem^
20. Erexitque Jacobtitulum super sepul-crum ejus : (i) Hic esttitulus monumenti Ra-cfiel usque in praesen*lem dìrm,
2i.Egressusinde,fi-xit tabernaculum transturrem gregis.
alla morie , pose al fi-glio suo il nome di Be-noni, cioè figliuolo delmio dolore : ma il padrechiamollo Ben-iamin,cioè figlio della destra,
io.. Morì adunqueRachele, e fu sepoltasulla strada , che menaad Ephrata, che è Beth-lehem.
20. E Giacobbe eres-se sulla sepoltura di leiun monumento t Que-sto è il monumento diRachele fi no al di d'oggi, "
21. Partitosi di la,piantò il padiglione dilà della torre del gregge.
•(i) /n/i-. 48. 7,
Vera. 18. Pìglio della destra. Come se dicesse figliuolo caris-simo, amatissimo.
Vers. IQ. Sulla, strada, cJio mena, ad Ephrata^ cha e Beth-lehem. Bethlehem ebbe il nome di Ephrata, dopo l'ingresso de-gli Ebrei nella Chananea, ed ebbe questo nome dalla moglie diCaleb, i. Paralip. n. a/j.- Yedesi anche adesso il luogo, dove f«sepolta Rachele distante circa un miglio da Bethlehem ; sopra ilsepolcro di lei fu eretto di poi un monumento più grande de-scritto dal Brocardo.
Vers. ai. Dì là dalla torre del gregge. Questa Corre era uncol mìglio di là da Bethlehem verso levante , dove erano ottimipascoli, onde vi correvano i greggi. Simili torri servivano di ri-covero a' pastori ; di là badavano a' greggi, e facevano sentinellaper custodirli da' ladri. In questo luogo si vuole che apparissea' pastori l'Angelo , che annunzio loro la. nascita del Salvatore.Così «. Girolamo ed altri. Quindi vi fu poi eretta da a. Elenauna chiesa sotto l'invocazione de'canti Angeli.

25». Cumque habita-ret in illa regione, abitiJiuben^etdormwitcumBaia concubina patrissui : quod illum minimelatuit. Erant autem fi-lii Jacob duodecim.
Infr. 49* 4-a3. FiliiLiaei pri-
mogenitus Ruben, etSirneon, et Levi, et Ju-das, et lssacliarì etZabulon.
24. Filii Racket:Joseph^ et Beniamin.
a 5. Filii Balae an-cillae Rachelis: Dan,et Nephtali.
26. Filii Zelphae,anciilae Liae : Gad^ etA seri hi sunt filii Ja-cob, qui nati sunt ei inMesopotamia Syriae.
27. Tenit etiam adIsaac patrem suum inMambre, civìtatem Ar-beet haec est Hebron,
sa. E mentre egli sistava in quel paese,Ruben andò , e dormicon Baia concubina disuo padre : e questi nonlo ignorò. Or dodici era-no i figliuoli di Gia-cobbe.
s3. Figliuoli di Lia :^primogenito Ruben , eSimeon , e Levi, e Giu-da , e Issacbar, e Zabu-lon.
s4« Figliuoli di Ra-chele: Giuseppe e Benia-min.
26. Figliuoli di Baia,schiavadiRachelejBan,e Nephtali.
26. Figliuoli di Zel-pha, schiava di Lia :Gad, e Aser : questi so-no i figliuoli di Giacob-be , che a lui nacqueronella Mesopolamia del-la Siria.
27. Andò poscia a tro-var Isacco suo padre aMambre, alla città diArbee , che è Hebron ,
Vers. 22. E questi non lo ignoro. Vedremo il gastigo di Ru-l>en , cap. xux. 4- Non si parla del dolore che ebbe Giacobbe diquesto fatto, perchè era quasi inesplicabile.
Vers. a6. Che a lui nacquero nella Mesopotamia. Eccettua-to il solo Beniamin, nato nella Chananea, Siouil «lattiera dj par-lare è usata vav. x.\vi. 15,, E&od. xu, 4°- £c-

in quaperegr'matus estAbraham, et Isaac,
28. Et completi suntdies Isaac centum o-ctoginta annorum.
29. Consumatusqueaetate mortuus est, etappositus est populosuo senex, et plenusdierum : et sepelierunteum Esau et Jacob fi-lii sui.
dove Abramo , e Isaceostettero pellegrini.
28. E tutti i giorni<T Isaceo furono centoottanta anni.
29. E consumato d'e-tà si mori, e vecchio, epieno di giorni si riunial suo popolo : e Gia-cobbe ed Esaù suoi fi-gliuoli lo seppellirono.
Vers. ag. Sì rìtirìt al suo popolo. Vedi eap. xxv. 8. Abblampiù volte osservato in Isacco una espressa e parlante figura diGesù Cristo."Isacco figliuolo della promessa, aspettato e deside-rato sì lungamente, nato non secondo 1' ordine naturale , comeosserva 1* Apostolo, Gai. iv. a3., ma per divina virtù da genitoristerili e di età avanzata, era degno di rappresentare quel figliuo-lo d' Abramo secondo la carne che dovea nascere di una Verginea consolare le brame , e le suppliche de'giusti di tutti i secoli.L'obbedienza renduta da Isacco al padre, sino a contentarsi didare la propria vita in sacrifizio per fare la sua volontà, l'andataal monte Moria colle legna pel sacrifìzio sopra le spalle, tuttoquesto era una viva pittura dell' unico figlio fatto obbediente fi-no alla morte , e morte di croce , che dovea andar al Calvario*,portando egli stesso il legno, su cui dovea essere confitto. Ma ilsacrifizio di Gesù Cristo dovea esser unico nella sua specie. Quelsacrifizio, per cui solo poterono essere accetti i sacrifizii di qua-lunque sorta offerti a Dio nella legge di natura, e sotto la leggescritta ; quel sacrifizio, il quale solo bastava ad espiare tutti ipeccati del mondo, e ad impetrare la riconciliazione degli Uomi-ni con Dio, e la copia de' divini favorì : questo sacrifizio non do-vea avere esempio ; e Isacco non dovea essere effettivamente sa-crificato ; quindi è sostituita a lui un' altr' òstia , figura di quel-1' agnello di Dio , il cui sangue mónda le nostre coscienze dalleopere di morte per servire a Dio vivo, Hebr. ix. 14.
Lo sposalizio d'Isacco con una donna di paese rimoto r laquale viene introdotta nella tenda di Sara, rappresenta l'allean-za di Dio con un nuovo popolo formato di tutte le nazioni delmondo riunite nella Chiesa cristiana, alla quale l'antica sinagogacede il suo luogo. Isacco finalmente, il quale per superiore dis-posizione è condotto a benedire Giacobbe in vece di Esaù, ci

C A P O XXXVI.
Esaù colle mogli., e figliuoli si separa dal fra-tello, perchè £ uno e f altro erano troppo ric-chi. Genealogia de'figlìu&li dì Esaù3 e in qualipaesi abitassero.
*• JjLae sunt au-tem generatìonesEsau,ipse est Edam.
2. Esau acczpit uxo-res de filiabus Cha-naan: A da, filiam ElonJfethaei, et Oolìbama,filiam Anae ìfiliae Se-beon 'Hevaei\
3. Basemath quoque,filiam Ismael sororemNabajoth.
1. v^/uesta è la ge-nealogia di Esaù , o siadi Edom.
2. Esaù prese moglidelle figlie di Chanaan:Adà , figlia di Elon He-theo , e Oolibama , fi-gliuola di Ana, figlio diSebeon Heveo:
3. E ancheBasemath,figliuola d'Ismaele , so-rella di Nabajoth.
annunzi» la riprovazione della ingrata e infedele sinagoga, percui principalmente era stato mandato il Cristo , e della qualeegli fu (secondo la, parola di Paolo ) ministro e predicatore; ri-provazione già stabilità ne' divini decreti ; e la esaltazione dellaChiesa delle genti t divenuta' dopo questa benedinne l'amoredel Padre, e del Figlio, e feconda di un' amplissima e fedelissima posterità. In una parola, tutta la vita di questo gran patriar-ca ha una continua ammirabil somiglianza colla vita, e collamissione di Gesù Cristo; ed è come una continua profezia diquesto Salvatore divino.
Vers. 2. e 3. Ada,figlia tìi Elcn Helheoì ec. Quella, ebe quiè chiamata Ada figliuola di Helon Hetheo , è chiamata Judith,figliuola di Beeri Hetheo, nel capo xxvi. 34; e quella, che quiè Oolibama , figliuola di Ana, è ivi detta Basemath , figliuola dìElon , e quella , che qui è Basemath, figliuola d'ismaele, nel ca-po XXVIH. p. ha il nome di Maheleth. Or sopra di ciò convien os-servare, ch' è cosa assai frequente nella Scrittura il vedere unastessa persona portare più nomi ; onde la differenza de' nomi,che son dati adesso alle tre mogli dlEsaù, non è argomento, chequeste non sieno le stesse, che quelle rammentale di sopra.

4. P&peritftutemAdaElìphaz: Basemath ge-nuit Rahuet,
i. Parai, i. 35.6. Oolibama genuit
Jehus,etJhelon ,et Gore.Hi filii Esau, qui natisunt ei in terra Cha*naan.
6. Tulit auìem Esauuxores suasì etfilios,et fiéìas, et omnem ani-mam domus suae, etsubstanti&m, et peco*ra, et cuncta, quae ha~bere poterat in terraChanaan: etabiitin al-teram regìonem^ reces*sitque afratre suo Ja«cob.
7. (i) "ùivìtes enimerant valde, et simulhabitare non poterant :nec sustinebat eos ter-ra peregrinationis eo*
4. E Ada partorì E-liphaz: Basemath gene-rò Rahuel.
6, JOolibama partorìJehus , e Jheloti, e Go-re. Questi sonoifigliuo-li di Esaù nati a lui nel-la terra di Chanaan.
6. Poscia Esaù presele sue mogli, e i figlino-»li, e le figliuole, e tuttala gente di sua casa . etutti i suoi beni, e i be-stiami , e tutto quelloche ave a nella tèrra diChanaan : e andò in unaltro paese , e si ritiròdal suo fratello Giacoh*he.
7. Perocché eranomolto ricchi, e non po-teano stare in un me*desimo luogo: e per la.moltitudine de* greggi
(ij fupr. »3. 6.
Yers. 4*. E •dda partorì jZltphat. S. Girolamo, e dietro a luipaolti interpreti credono, che questo Eliphaz sia queli' EliphazThemanite rammentato nej libro di Giobbe.
Vers. 7. PeroccKk erano molto ricchi, e non potevano ec. Sivede da questo luogo, che Giaeobbe ed Esaù erano in buonaamistà tra di loro ; pnde abitarono insieme per qualche tempadopo la morte del loro padre : indi si separarono per la ragione,ch'è qui specificata ; ed Esali, che era già stato del tempo nelpaese di Seir, ( cap. xxxy. 3.J si ritirò in quelle parti non senz^disposizione di Dio, il quale avea promessa la terra, di Chaflaan,a Giacobbe, fedi s. Agoslino, quadri, mg.

tuffi prae multìtudinegregum.
8. (i) HabìtavìtqneEsau in monte Seìr,ipse est Edom.
9. Hae autem suntgener ationes'Esau, pa*tris Edom in monte Seiri
10. Et haec nominafiliorum ejus : (2) Eli"phaz, filius A da uxorisEsau : Rahuel quoquefilius Basemath uxorisejus.
11. Fueruntque Eli"phaz filii: Theman, O*mar, Sepho> et Gatham,et Cenez.
12. Erat autem Tha*mna concubina Eli"phaz, filli Esau : quaepeperit ei Amalech. Hisunt filii Ada, uxorisEsau.
13. "Filii autem Raȓmel: Nahath, et Zara^Samma^et Meza. Hifilii Basemath uxoris$sau.
14. Isti quoque erantfilii O oliò ama. filiae
non potea sostentarli laterra, doy' erano pelle-grini.
8, E abitò Esaù, osia Edom, sul monteSeir.
9. Or questa è la genea-logia di Esaù,padre degVIdumei del monte Seir :
10. E questi sono inomi de' suoi figliuoli:Eliphaz, figliuolo di Adamoglie di Esaù : e Ra-huel, figlio di Basemathmoglie di lui.
11. Figliuoli di Eli-phaz furono : Theman,Ornar, Sepho, e Galliam,e Cenez.
12. Thamna poi eraconcubina di Eliphaz,figliuolo di Esaù : edella gli par tori Arnalech.Questi sono i discenden-ti di Ada, moglie di Esaù.
13. Figliuoli di Ra-huel : Nahath , e Zara ,Samma, e Meza. Questi(sono) figliuoli di Base-math moglie di Esaù.
14. Oolibama,figliuo-la di Ana figliuola di Se-
Ver s. g> Genealogia di E s alt, p ad fè degli Iduineì. Vale a dì-re : ecco i discendenti di Esaù, o sia « figliuoli di lui nati »dtpaese di Seìr,
(ij Jot. 24, 4, (aj i. Parai i. 35,

'Anae, filiae Sebeon,uxoris Esau, ^#o,y #<?-màt ei Jehus, e£ Jhe-lon, et Gore.
16. Hi duces filiorumEsau: filii Eliphaz pri-mogeniti Esau : duxTheman, dux Ornar,dux Sepho, dux Cenez*
16. Dux Cere, duxGatham, dux Amalech.Jìi filii Eliphaz in ter-ra Edem, et hi filii Ada.
17. Hi quoque filiiRahuel, filii Esau: duxNahath, dux Zara, duxSammat dux Meza, itiautem duces Rahuelinterra Edom. Isti filiiBasemath uxoris Esau.
beòn , moglie ài Esau ,partorì a lui questi fi-gliuoli, Jehus, e Jhelon,e Gore.
16. Questi ( sono ) icapitani de' figliuoli diEsaù, i figliuoli di Eli-phaz, primogenito diEsaù : Theman capita-no, Ornar capitano, Se-pho capitano, Cenezcapitano-,
16. Gore capitano,Gatham capitano, A-malech capitano. Que-sti figliuoli di Eliphaznella terra di Edom, equesti figliuoli di Ada.
17. Questi pure (so-no) i figliuoli diRahuel,figlio di Esaù : Nahathcapitano , Zara capita-no , S anima capitano ,Meza capitano. E que-sti (sono) i capitani di-scesi da Rahuel nella ter-ra diEdom. Questi (so-no ) i figliuoli di Base-math moglie di Esaù.
Vers. 15. Questi sono i capitani de'jiglìuoli di Emù. La vocee&rea tradotta colla latina duces corrisponde alla, greca chi-Ifarcki, o sia. capitani di mille uomini. Descrive adunque inquesto luogo Mosè i capi, da? quali furono governati da primagl'Idumeì, i quali capi erano come quelli che erano chiamati da-gli Ebrei )' principi delle tribù. Ognuno di questi capitani aveail governo di una città, o di un tratto di quel paese abitato dauna tribù de' discendenti di Esaù.

r 18. Hi autem filiiOolibama uxoris Esau:duxJehus, dux Jhelon,dux Gore. Hi ducesOolibama^ filiae Anaeuxoris Esau.
i g. Isti sunt filii E~sauì et hi duces eorum*,ipse est Edom.
20. Isti sunt filii SeirHorraei, habitatoresterrete: Lotan, etSobal,et Sebeon, et Ana.
Parai, i. 38.21. EtDison, et E-
$er, et Disan. Hi ducesHorraei filii Seir in ter-ra Edom.
22. Facti sunt autemfilii Lotan Hori, et He-man: erat autem serarLotan Tamna.
23. Et isti filii Sobal:Alvan, et Manahat^ etEbal, et Sepho, et O-nam.
24. Et hifiliiSebeon:Aia , et Ana . Is-te estAna, qui invenit ayuas
i8. Questi 'poi i fi*gliuoli di Oolibama mo-glie di Esaù : Jehus ca-pitano, Jhelon capitano,Gore capitano. Questi icapitani discesi da Ooli-bama, figliuola di Anamoglie di Esaù.i o, .Questi so no i figliuo-
li di Esaù, o sia di E doni :e questi i loro capitani.
20. Questi sono i fi-gliuoli di Seir Horreo,abitanti di quella terra:Lotan^SobaljeSebeon,e Ana.
21. E Dison, edEser,e Disan. Questi i capi-tani Horrei, figliuoli diSeir nella terradiEdom.
22. Figliuoli di Lotanfurono Hori, ed Heman:e sorella di Lotan eraTamna.
a3. E questi ifigliucKlidiSobal: Alvan,eMa-nahat, ed EbaJ, e Se~pho, ed Onam.
24. E questi i figliuo-li di Sebeon : Aia , e A-na. Questi è quell'Ana,
Vers. m Questi sono i figliuoli eli Seir H&rreo. Si notano
?ui da Mosè i discendenti di Seir Horreo , i quali abitarono nel-' Idumea prima di Esaù, e da Eliphaz, e da altri de' figliuoli di
Esali, i quali perciò abitarono insieme con quelli, ed ebbero di-poi il dominio del paese.

calidas in latitudine,cum pascere* asinosSebeon patria sui.
26. "ttabuitque filiumDison, et filiam Ooli-bama.
26. Et isti filii Dison:Hamdan, et Eseóan, etJethram, et Charan»
27. Hi quoque filiiEser: Balaan, et Za*vaii, et Acan.
28. Habuit autem fi*lios Disan : Hus ? etArari.
29. Ni duces 7/or»raeorum : dux Lotan,dux Sabat) dux Sebeon,dux Ana,
5o. Dux Dison, duxEser, dux Disan. Istiduces Horraeorum^quiimperaverunt in terraSeir.
31, Reges autem, quiregnaverunt in terraEdcm, antequam fiabe*
che trovò le ac<|ue cal-de nel deserto, mentrepasceva gli asini di Se-beon suo padre.
26. E suo figliuolo fuDison , e sua figliuolaOolibama.
26. E questi ( sono )i figliuoli di Dison :Hamdan , ed Eseban, eJethram, e Charan.
27. Questi pure (so-no ) i figli di Eser : Ba-laan , e Zavan, e Acan.
28. Disan ebbe que-sti figliuoli » Hus, e A-ran.
29» Questi i capitanidegli Horrei : Lotan ca-pitano, Sobal capitano,Sebeon capitano, Anacapitano,
3o. Dison capitano,Eser capitano, Disancapitano. Questi i capi-tani degli Horrei, cheebber comando nellaterra di Seir.
31.1 regi poi, che re-gnaron nella terra diEdom , prima che gì51-
V«ttj~a£ TVocè le acque calile nel deserto, ec. Le acqne ter-mali. I<e dispute mosse sopra questo passo dagi' interpreti, co-minciate già fino da' tempi di e. Girolamo , sono fuori del nostraistituto. Dirò solamente, che alcuni fonno Aua inventore delta

rent regem filii Israel,fuerunt hi:
32. Bela filius Beortnomenque urbis ejusDenaba.
33. Mortuus est au*tem Bela, et regnavi*pro eo Job ab > filius Za*rae de Bosra.
sraeliti eressero re, fu-ran questi:
32. Bela figliuola diBeor, e il nome di suacittà Denaba.
33. Morì poi Bela , ein luogo di luì regnò Jo-bab , figliuolo dil Zaradi 8osr$.
Yers. 31. /regi che regnarono ... prima che ee. Alcuni inter-
5reti sono di opinione , che questi regi non fossero discendentii Esali, ma di altra nazione, i quali in diversi tempi soggiogas-
sero l'Idumea. Ma quando fossero stati veramente della stirpe diEsaù, notisi in primo luogo, ch'ei non succedettero l'uno ali' ak
' tro di padre in figlio: lo che si vede chiaro nella descrizione chequi abbiamo; in secondo luogo da'versetti 3 a. e 35. si ha indizio che questi regi non regnarono tutti nè pur nello stesso luogo:finalmente nello spazio di dugento anni in circa, quanti possontrovarsi dal tempo, in cui Esaù si fece grande nell' Idumea, finoa Mosè, ei può trovar luogo per gli otto re, che son qui notati.Imperocché vuoisi osservare, che può benissimo l'Idumea avereavuto de' capitani in una parte e in un' altra parte de' regi. Cosìin sostanza tutto quello che dobbiamo ricavare da questo luogo,si è, che l'Idumea ebbe uno stato e un governo già stabilito mol-to prima che i figliuoli d'Israele avessero una forma di governoe un condottiero e capo del popolo, ch* è quello che vuoisi quiindicar col nome di re. Quésto condottiero, o re, che ebbero di-poi gli Ebrei, fu Mosè , a cui è dato quésto titolo; perchè egli Tcome capo di tutte le tribù , le governò con autorità dipendente(solo da Dio, Onde Mosè è detto da Filone e da altri re, legisla-tore, profeta e pontefice. Il titolo di re è dato nella Scritturaa'semplici giudici, governatori e magistrati. Vedi Jud. xvn. 6., i.Reg, xxi. 12. Del rimanente Dio vuole far qui osservare, com«Esaù e i suoi posteri erano grandi sopra la terra, mentre Giacobbee i suoi discendenti erano ancor pellegrini e senza possessione edominio stabile, e senza quasi aver forma di popolo. Imperocchéquesto popolo dovea esser figura di tutti i giusti, i quali non vi-vono su questa terra , se non come ospiti e pellegrini ; perchè aduna terra migliore anelano, dov'è la loro felicità.
Vers. 33. Jobab,figliuolo di Zara di Bo fra. Moltissimi Pa-dri e interpreti credono , che questi eia il santissimo Giob, ec?ni~piare della pazienza»

34. Cumque mortuusesset Jobab, regnaglipro eo Husam de terraThemanorum.
35. Hoc quoque mor-tuo , regnavit pro eoAdad, filius Badad^quipercussiftyLadianin re-gione Moab : et nomenurbis ejus Avith.
36. Cumque mortuusesset Adad, regnavitpro eo Semla de Ma-sreca.
3y. Hoc quoque mor-tuo, regnavitpro eo Sauldefluvio Rohoèoth*
38. Cumque et hico&iisset, successit inregnum Balanan^fiUusAchobor.
39. Isto quoque mor-tuo., regnavit pro eo A-dar\ nomenque urbisejus Phau : et appella-batur uxor ejus Meta-bel, fitia WLatred fifoaeMezaab.
34» E morto Jobab,regnò in luogo di luiHusam della terra deiThemniti.
35. Morto anche que-sto , regnò in sua veceAdad, figliuolo di Ba-dad } il quale sbaragliòi Madianiti nel paese diMoab : e il nome dellacittà di lui Avith.
36. E morto Adad,regnò in luogo di luiSemla di Masreca.
37. E morto anche .-questo, regnò in luogo I,di lui Sauì di Rohoboth, iche è presso il fiume(Eufrate).
38. E dopo che anchequesto fu morto, suc-cedette nel regno Bala-nan, figliuolo di Aeho- fbor.
39. Morto anche que- ,sto, regnò in suo luogoAdar: e il nome dellasua città era Phau : e lasua moglie si chiamavaMetabel,figliuola di Ma-ired, figliuola diMezaab,
Vers. 3q. Figliuola di Mittred, figliuola, (ti Mezaab, Vuol di-re, ch'ella era figliuola di Matred, e nipote di Mezaab , ovvero fi-glia naturale di Matred, e adottiva di Mezaab..

4o. Haec ergo nomi-na ducum Esau in co-gnationibuS) et locis, etvocabulis suis : duxThamna , dux Alvo,,dux Jetheth,
41 • Dux O olibama,dux Ela, dux Phinont
42. Dux Cenez, duxTheman, dux Mabsar,
43. Dux Magdiel,dux Hiram. Hi ducesEdomhabitantes in ter-ra imperii sui-, ipse estEsau pater Idumaeo-rum.
40. Questi (sono)a-dunque i nomi de'capi-tani discesi da Esaù se-condo le loro stirpi, e iluoghi, e i nomi di que-sti: il capitano Tha-mna, "il capitano Alva,il capitano Jetheth,
41. Il capitano Oolì-bama , il capitano Ela,il capitano Phinon,
42.IlcapitanoCenez,il capitano Theman , ilcapitano Mabsar,
43. Il capitano Mag-diel, il capitano Hiram.Ecco i capitani di Edom,che abitavano ognunonella terra, a cui coman-davano : questo Esaù èil padre degli Idumei.
Vers. 4o. Questi (sono) adunque * nomi decapitarli di Esali.Dopo il governo de' re P Idumea tornò ad avere de' capitani dellastirpe di Esaù. ,
Secondo le loro stirpi e i luoghi e i nomi dì questi. Valea dire secondo i luoghi, ne' quali le diverse famiglie abitarono, ea' quali diedero il loro nome. Donde ancor di nuovo si vede, chequesti capitani ( e così i loro regni ) erano ne' diversi paesi del-l'Idumea; lo che è ancor ripetuto nel versetto fé. Questi capita-ni forse erano quelli che reggevano gì'Idumei, allorché gì' Israe-liti passarono dall'Egitto nella Chananea , e de'quali dice Mosè:allora furono in ìscompiglio i principi di Edom , Exod. xv. 13.
Vers. 43. Questo Esali e il padre ec. Finisce con dire, che icapitani e i re, de'quali ha parlato, derivano da Esaù, il quale fupadre e progenitore degl' Idumei. Di Esaù non sappiamo il tem-po della morte. Egli fu, come già dicemmo , figura de' reprobi ;ma ciò non porta di necessità, ch' egli pure sia stato riprovato :onde sono divisi gì' interpreti e i teologi riguardo alla salvazioneeterna di lui, come altrove si è detto.

C A P O XXXVII.
Giuseppe per aver accusati di grave colpa i fra-telli presso del padre, e per aver raccontati isuoi sogni si tira addosso 1* odio dei fratelli :vogliono ammazzarlo ; ma per consiglio diRuóen lo gettano prima in una cisterna : indisenza saputa di Ruben lo vendono agi'Ismae-liti. Il padre lo piange, credendolo ucciso dauna fiera; Giuseppe frattanto in Egitto è ven-duto a Putifare.
1. XJL abitavit autemJacób in terra Ghana-an, in qua pater suusperegrinatila est.
2. Et hae sunt gene-r&ti&nes ejus i Josephcumsexdecim esset an-»norum, pascebat gre*gem cumfratribus suisadhuc puer: et erat cumfilis Balae> et Zelphae,uxorum patris suis i ac*cusavitquefratres suosapud patrem criminepessimo.
4. vJTiacobbe adun-que abitò nella terrà diGhanaan , dove fa pel-legrino suo padre.
2. E questa è la ge-nealogia di lui : Giusep-pe essendo di sedici an-ni pasceva ancor fan-ciullo il gregge insiemeco'suoi fratelli : e stavaco'figliuoli di Baia, e diZelpha, mogli del pa-dre suo ; e accusò pres-so al padre i suoi fratel-li di pessimo delitto.
Vera. a. E questa è la genealogìa di luì. Queste parole siriferiscono al novero de' figliuoli di Giacobbe, cap, XXT. a3. 26.Or ivi avendo Mosè interrotta la storia di quel patriarca per tes-sere la serie de'discendenti di Esaù, ripiglia adesso la sna narra-zione, e viene a parlare del santo e casto e pazientissimo Giusep-pe, onde è come se dicesse: la genealogia di Giacobbe è quellache già dicemmo : ma Giuseppe uno de'suoi figliuoli eo.

5. Isràel autem dili-gebat Joseph super otnnes filios suos, eoquod in senectute ge-nuìsset eum, : fecitqueei tunicam polymitam.
4. Videntes autemfratres ejus., quod a pa-tre plus cunctis filiisamaretur^ oderant eum^nec poterant ei quid"quam pacifice loqui.
3. Or Israele amavaGiuseppe più di tutti isuoi figliuoli, perchè loaveva avuto in vecchiez-za : e gli fece una tona-ca di varii colori.
4. Ma i suoi fratellireggendo, com' egli erapiù di tutti gli altri fi-gliuoli amato dal padre,1' odiavano, e non pote-vano dirgli una parolacon amore.
Essendo di sedici anni. Di sedici anni compiti, ed era en-trato nel diciassettesimo, Hebr. Ctiald. IAX,
Stava co* figliuoli di Baia e di Zelpha. Si vede che Gia-cobbe avea divisi in due parti i suoi greggi, e una parte eran go-vernati da'figliuoli diLia, 1' altra da' figliuoli delle due serve,Co'quali uni Giuseppe, separandolo da'figliuoli diLia, i quali es-sendo nati della prima moglie di Giacobbe, che era ancor viva,non vedevano di buon occhio questo figliuolo della defuntaRachele,
Dì pessimo delitto, Alcuni per questo delitto intendono gliodii e le risse de' fratelli tra di loro ; altri qualche cosa di piùnefando.
* È accuso presso il padre. Con accusarli, Giuseppe nonaltro intendeva, che l'emenda de'cattivi fratelli. • -,
Vers. 3. Perche lo avea avuto in vecchiezza. E naturalene' genitori una certa predilezione pe' figliuoli avuti nell' etàavanzata: ma in Giuseppe nato a Giacobbe già vecchio, doveaquesti notare una certa somiglianza e con sé, e con 1' avo ; peroc-ché come Giuseppe nacque di Rachele sterile , e di Giacobbe giàvecchio, cosi Isacco da Sara sterile, e da Abramo gii vecchio, e Gia-cobbe stesso da Rebecca sterile , e da Isacco , che già passava inovant' anni, Oltre queste ragioni l'innocenza e santità di costu-mi rendevano più amabile al padre questo figliuolo, onde le piùantiche parafrasi portano: .Egli era un fanciullo saggio e pru-dente.
Gli fece una. tonaca divarii colori. La tonaca era la vesteinteriore che portavasi sopra la carne, ed era di lino, almeno in -que'luoglii, dove il liao si usava, il quale iu que'paesi era comune,

6. Accidit quoque^ utvisum somnìum refer-retfratribus suis: quaecausa majoris odii se-minarium fuit,,
6. Dixitque ad eos i'Audite somnìum meum^quod vidi-.
7. Putabam, nos li-gare manipulos in agro,,et quasi consurgeremanìpulum meum, etstare, vestrosque ma-nipulos circumstantesadorare manìpulummeum.
8. Responderuntfra-tres ejus: Numquid rexnoster eris ? aut subìi-ciemur ditioni tuae ?Haec ergo causa so-
3. Avvenne ancóra,ch' egli riferì a' suoi fra-telli un sogno, che aveaveduto : la qual cosa fu«n semenzaio di odiomaggiore.
6. E disse loro : Udi-te il sogno veduto dame :
7. Mi pareva, che noilegassimo nel campo imanipoli, e che il miomanipolo quasi si alza-va, e stava diritto, e chei vostri manipofistandoalP intorno adoravano •'il mio manipolo.
8. Risposero i suoifratelli • Sarai tu forsenostro re ? o sarem noisoggetti alla tua pote-stà? Questi sogni adun-
Vers. 6. Udito il sogno. Questo sogno, profezia delle cose fu-ture , era stato certamente mandato da Dio ; ma Giuseppe nonne intendeva il significato , e perciò con tutta semplicità lo rac-conta a'fratelli. Tutto dovea concorrere a rendere questOvfigliuo-lo odioso a' fratelli, l'amore del padre, le distinzioni, che questiusava verso di lui, la santità stessa della sua vita, cho era unrimprovero continuo a' costumi degli altri, 1' annunzio delle suefuture grandezze , che Dio stesso poneva a lui in bocca, affinchèquesto figliuolo fosse un compiuto, e perfetto ritratto di GesùCristo. 1 sogni profetici di Giuseppe ci chiamano alla memoriale profezie senza numero sparse in tutto il vecchio Testamento,nelle quali e i patimenti, e la gloria del Messia erano stati pre-detti; profezie sovente citate in prova di sua missione da GesùCristo , e le quali non illuminarono gli Ebrei, ma gì' irritaronoancor più contro di lui.

mniorum, atque sermo-num, invidiae, et odiifomitem ministravit.
g. Aliud quoque vi-dit s omnium, quodnar-rans fratribus ait: Vidiper somnium, quasi so-lem, et lunam , et stel-las undecim adorareme.
10. Quod cumpatrisuo, et fratribus retulis-
set, increpavit eum pa-,w ter suus, et dixit-, Quid
sibi vult hoc somnium,quod vidisti ? num ego,et mater tua, etfratrestùi adorabimus te su-per terram ?
11. Invidebant ei igi-tur fratres sui : pater
que, e questi discorsisomministraron escaali' invidia, e ali' avver-sione.
y. Vide pure un altrosogno, e raccontandoloa' fratelli, disse : Ho ve-duto in sogno, come seil sole, e la luna, e un-dici stelle mi adoras-sero.
10. La qual cosa aven-do egli raccontata alpadre, e ai fratelli, suopadre sgridollo, dicendo:Che vuol egli dire que-sto sogno, che hai ve-duto ? forse che io, e latua madre, e i tuoi fra-telli prostrati per terrati adoreremo ?
11. I suoi fratelli per-tanto gli portavano in-
Vers. 9. * Vide pure un altro sogno. Col primo si pronosti-cavano gli onori che a lui renderebbero i soli fratelli. XLII. v, 6.XLIII. v. 26. Col secondo sogno quelli che posteriormente ri-scuoterebbe dall'intera famiglia del padre. Del resto, che indichiil sogno replicato sullo stesso soggetto, vedesi Gap. XLI. v. i•>..
Vers. io. E la madre tua, ec. La madre era significata per laluna, come il p^dre pel sole. Ma Rachele era già mortn. Quindio queste parole debbono intendersi di Baia, la quale di serva diRachele divenne moglie di Giacobbe , e riguardo a Giuseppe te-neva il luogo di madre, ovvero Giacobbe rammenta }a vera ma-dre Rachele per dimostrare , che quel sogno era stravagante al-meno in questo, ebe quando fosse stato possibile, che il padree i fratelli rendessero a lui quegli onori, non potea renderglienela madre sia morta.

vero rem tàcite* eonsi*derabat.
i2é Cumque fratresillius in pascendis gre-gibus patris moraren-tur in Sicnem^
i3. Dixit ad eumIsraeli Fratres tui pa-scunt oves in Sichimisìvenit mittam te ad eos*Quo respondentei
i4» Praesto sum> aitei; Vade, et vide, sicuncta prospera sint er*ga fratres tuos , et pe*-cora: et renunda mihi,quid agatur. Missus devalle Hebron venit inSìchem:
15. Invenitque eumvir errantem in agro,
vidia j il padre poi con-siderava la cosa in si-lenzio.
12. E dimorando isuoi fratelli a pascere igreggi del padre in Si-chem,
13. Israele disse alui : I tuoi fratelli sonoin Sichem alla pastura:vieni, vo'mandarti ver-so di essi. E avendoegli risposto :
14- Son pronto, glidisse : Va, e vecli, se tut-to va bene riguardo a1 s
tuoi fratelli, e ai be-stiami ; e riportamiquello che ivi si fa. Spe-dito dalla valle di He-bron arrivò a Sichem :
15. E un uomo loincontrò, mentre anda-
Vergi li. Il padre poi considerava la cosa ec. Giaóobbe con*siderando la virtù del figliuolo, la sua innocenza, la sua sempli-cità, e riflettendo su questi sogni medesimi, sì sentiva dire alcuore, che veramente Giuseppe fosse destinato da Dio a qual-che cosa di grande. E da ciò vedesi, che s' ei lo sgridò, come di-cesi nel versetto precedente, ciò egli fece non per altro fine, cheper ammansire l'invidia de'fratelli, e per avvertirlo di usaremaggior circospczione nel trattare con essi.
Vers. 12. In Sìchem. Vale a dire nel territorio di Sichem , do-ve Giacobbe avea comprato un campo, cap. XXMII. rg. Da He-bron a Sicbem v' erano piìi di sessanta miglia. Si vede da moltiluoghi della Scrittura, che si menavano i greggi molto lungi dalluogo, dove i capi di famiglia abitavano. Ve Ai cap. xxxi. 19. 32.E molto credibile, che Giacobbc mandò qualohoduno de* serviad accompagnare Giuseppe,

et interrogavit, quidyuaereret.
16. At Ille respondit-,"Fratres 'meos quaero :indica mihijubipascant$reges.
17. Dixitcjue ei vir :Recesserunt de locaista ; audivi autem eosdicentes : Eamus inDothaiìt» Perrexit ergoJoseph post fratressuos) et inventi eos inDothaìn.
18. Qui cum vidis-seni eum procul, ante-quam accederei adeos*cogitaveruntillum occi-demi
19. J&É mutuo loque-lantur\ Ecce somniatorvenite
20. Venite > occida**mus eum, et mittamus
va qua e là per la cam-pagna, e domandogli,che cercasse.
16. Ma egli rispose :Cerco i miei fratelli :insegnami, dove sienoa pascere i greggi.
17. Colui gli disse :Si sono partiti da que-sto luogo : ed hogli udi-ti, che dicevano : An-diamo a Dothain. An-<fò adunque Giuseppein traccia dei suoi fratel-li, e trovogli in Dothain.
18. Ma questi vedu-tolo da lungi, primache ad essi si accostas-se, disegnarono di ucci-derlo:
19. E dicevano gliuni agli altri : Ecco ilsignore dei sogni cheviene :
ao. Su via, ammaz-ziamolo, e gettiamolo
Ver*. 16. Cerco i miei fratelli. Risposta piena di mistero, e ve-rissima anche riguardo a quel Figliuolo unigenito, il quale man-dato dal Padre venne a cercare i suoi fratelli, pe' quali dovea es-sere priecipio di salute. L'Apostolo ammirò altamente P umiltà,e la bontà di Cristo , il qiiale non isdegnò di riconoscere la fra-tellanza, ch' egli avea contratta cogli uomini in assumendo la lo-ro natura: Non ha rossore di chiamarli fratelli, Hebr. n. 11.
Vers. ip. e 20. Ecco il signare de1 sogni ... Su via ec. La per-secuzione che soffrirà il Cristo da'suoi fratelli, gli scherni, leburle , e i crudeli disegni contro di lui sono adombrati nel rice-vimento fatto da'figliuoli di Giacobbe a Giuseppe.
Pent. Vol. L 16 •

in cìsternam veterem :dicemus que: Pera pes~finta devoravit eum: ettunc apparebit) quid il-li prosint somma sua»
21. Audiens autemhoc Ruben nitebatur li-berare eum de manibuseorum.) et dicebat :
Infr. 42. 22.22. Non interficiatis
animam ejus^neceffun-datis sanguinem, sedprojicite ^urtt in cister-nam hanc, quae est insolitudine, manus quevestras servate inno*&ias. Hoc autem dice»batt volens eripere eumde manibus eorum , etreddere patri suo.
a 3. Confestim igiturut pervenit ad fratressuos, nudaverunt eumtunica talari, et poly*mità,
24. Miseruntque eumin cìsternam veteremtquae non habebat a"quam*
in una vecchia cister-na : e diremo : Una fie-ra crudele lo ha divora-to: e allora apparirà,che giovino a lui i suoisogni.
21. Ma Ruben uditoquesto si affaticava diliberarla dalle loro ma-ni, e diceva :
22. Non gli date lamorte, e non ispargeteil suo sangue : ma get-tatelo in questa cister-na , che è nel deserto,e pure serbate le vostremani. Or ei ciò dicevacon volontà di liberarlodalle loro mani, e resti-tuirlo a suo padre.
23. Appena adunquegiunse presso a'fratelli,lo spogliarono della to-naca talare a tarii co-lori ,
%k E lo caliKWJQjw^-la vecchia cisterna, cheera al secco.
Vers. 9.2. * Con volontà di liberarlo. Avrà pensato Ruben diricuperare per questa via la buona grazia del genitore oltraggiato.
Vers. 24. Lo calarono nella ... cisterna, ec. Si ravvisa qui lasepoltura di Cristo, il quale è poi liberato dalla morte, e daTSepolcro , e comprato dagl'Ismaeliti (cioè da'Gentili) cól prezzodella loro fede, dice s, Eucherjo.

2 5. E£ sedentes utcomederent partem, vi-derunt Ismaelitas via*tores venire de Galaadtet camelos eorum, por-tantes aromata, et resi"nam, et stacten in AE-gyptum.
26. Dixit ergo Judasfratribus suis: Quid no-bis prodest, si occideri-musfratrem nostrum,et celaverimus sangui-ftem ipsius?
27. Melius est, ut ve*% nundetur Ismaelitis, etmanus nostrae non pol~luantur\ frater enim etcaro nostra est.Acquie*tferuntfratres sermoni-bus illius.
2 8 (1 )Et pràétéreun*tibus Madianitis ne-gòti&toribiis, extrahen- 'te s eum de cisterna ven-diderunt eum Ismaeli-tis viginti argenteis :qui duxerunt eum inAEgyptum.
26. E postisi a sedereper mangiare il pane vi-dero dei passeggiar! I-smaeliti che venivan diGalaad co'loro cammel-li , e portavano aromi,e resina e mirra stillatain Egitto.
26. Disse adunqueGiuda a' suoi fratelli :Qual bene ne avremonoi , se ammazzeremoun nostro fratello, e ce-leremo la sua morte?
27. E meglio che sìvenda agl'Ismaeliti, eche non imbrattiamo lenostre mani : perocchéegli è nostro fratello enostra carne. Si acquie-tarono i fratelli alle sueparole.
28. E mentre passa-vano quei mercanti Ma-dìaniti, avendolo trattodalla cisterna lo vende-rono a certi Ismaelitiper venti monete d'ar-gento: e questi lo con-dussero in Egitto.
( i ) Sap. io. 13.
Vers. 28, Per venti monete (P argento. Per venti sìcll, cioèdieci di meno di quello che sarà venduto il Salvatore del mon-do: imperocché non dovea il servo esser venduto a prezzo ugua-le a quel del padrone, dice s. Girolamo. Ma ella è cosa degnissi-ma di riflessione, come in tutto il tempo del negoziato fatto

29. "Reversusque Ru-&en ad eis ter nam nonìnvenit puerum.
3 o. Et scissìs vesti»bus', per gens adfratressuos alt: Puer no?t com*paret, et ego quo ióo?
3«. Tulerunt autem,tunicam ejus, et in san-guine haedi, quem occi*derantt tinxerunt,
32. Mittentes , quiferrent ad patrem , etdicerent : Hanc inveiti-*mus\ vide , utrum tuni-ca filii lui sìtt an non.
, 53.Quam cum agno-visset pater^ aiti Tuni-ca filii mei est : fera,pessima comedìt eumy
29. E tornato Rubenalla cisterna non vi tro-vò il fanciullo.
30. E stracciatesi levesti, andò a trovare isuoi fratelli, e disse : IIfanciullo non si vede, eio dove anderò ?
3 i. Ma quelli preserla tonaca di Giuseppe ,e la intriser del sanguedi un agnello che avea-no ammazzato j
32. Mandando perso-ne a portarla al padre ,e dirgli: Questa abbia-mo trovato: guarda, seè , o no , la tonaca del.tuo figliuolo.
33. E il padre aven-dola riconosciuta disse :Ella è la tonaca del miofigliuolo : una fiera cru-
tra'fratelli, nel tempo cK'ei fu spogliato di stia veste, gettato nel-la cisterna, e poi venduto agi' Ismaeliti, non si nota una sola pa-rola uscita di bocca a Giuseppe. I suoi fratelli però rimprove-rando a sé stessi il loro orrendo delitto, dicono: Peccammo con-tro nostro fratello, veggendo le angustie del suo cuore, men-rtr>ei ci pregava e noi non ascoltammo, cap. XLII. 21. Ma lo spi-rito di Mosè intento pia al divino originale, ch' egli avea dinanziagli occbi di sua niente, che alla figura, tace qui le preghiere, ele lagrime di Giuseppe ; perchè queste non convenivano al Giu-sto per eccellenza, il quale venduto e straziato non aperse suabocca. Ricordiamoci, che di lui, e per lui scrisse principalmen-te Mosè,
Vera. 39. Tornalo Riiben alla cisterna, ec. Si vede, che Ru-ben aon sì trovò presente alla vendita, perchè erasi allontanatocol pretesto di qualche affare, ma in realtà per andar solo ia
o opportuno alla cisterna per trame fuora Giuseppe,

bestia devoravit Jo-seph»
34- Scissisque vesti-bus indutus est cìli-cio, lugens filium suummulto tempore.
35. Congregatìs au-tem cunctis liberis ejus>ut lenirent dolorem pa-triSi noluit consolatio-nem accipere, sed ait\Descendam ad filium
L meum lugens in infer-num. Et illo perseve-rante in fletUy
06. lHadianitae ven-"diderunt Joseph in AE-
dele lo ha mangiato, unabestia ha divorato Giu-seppe.
34. E stracciatesi levestimenta , si copri dicilizio, e pianse permolto tempo il suo fi-glio.
55. Ed essendosi rau-nati tutti i suoi figliuo-li per alleggerire il do-lore del padre, non vol-le egli ammettere con-solazione , ma disse :Scenderò piangendo atrovare il mio figliuolonell' inferno. E mentreegli perseverava nelpianto,
36. I Madianiti in E-gitto venderon Giusep-
Vers. 34. Si coprì di cilizio. Di abito di duolo, a cui fu dato ilnome di cilizio, perchè simili abiti di fosco colore, e grossolani sifaceano di pelo di capra della CiUcia-. fu imitato sovente que-st' esempio di Giacobbe da'suói posteri nelle occasioni di afflizio-ne , e di penitenza.
Vers. 35. Scenderò piangendo ec. Vale a dire, io non mi con-solerò giammai, fino a tanto che io muoia, evada a trovare ilmio figliuolo nell' inferno, cioè nel luogo, dove le anime de'giu-sti si stavano aspettando il Salvatore, che dovea condurlo seconel cielo. A questo luogo è dato anche da' Padri della Chiesa ilnome d'myèrrao, e di seno di àbramo coerentemente alle Scrit-ture, e dà'Teologi più ordinariamente il nome di limbo. Sarebbeuna gran semplicità ( per non dire di peggio ) quella di.chi inquesto luogo per la parola inferno intender volesse il sepolcro :imperocché come dir potrebbe Giacobbe, che anderà nel sepol-cro a riunirsi col figliuolo, il quale era stato ( com'ei dicea )mangiato da una fiera, divorato da una bestia ? Riconoscasi adun-que nelle parole del patriarca la fede dell' immortalità dell'aui-me, e della riunione di tutti i giusti ia un' altra vita.

gyplo Putìphari eunu-che PliaraoniS) magi"sfro militum.
pe a Putifare eunuco d»Faraone, capitano del-le milizie.
C A P O XXXVIII.
Giuda avendo avuto tre figli di una moglie Cha*nanea, fece sposar Thamar al primo e al se-condo: dopo la morte di essi ebbe che fare conlei senza saperlo , credendola donna di malavita , e generò di lei Phares e Zara.
i. Jd odem temporer&escendensJudas afra-tribus suis divertii advirum Odollamitem,no-mine jffiram,
•fr»' (i) Widitqw ibifiliam howinis Chance*naei., vocabulo Sue: et^
1. IN elio stessotempo Giuda separatoda' suoi fratelli andò aposare in casa di un uo-mo di Odollam, per no-me Hiram.
2. E ivi vide la figliadi un Chananeo , chia-malo Sue : e , presala
(i) Parai, a, 3.
Vers. 36. Eunuco di Faraone ec. Il titolo di eunuco è soven-te posto per titolo di uffizio, e di dignità ; onde qui vale mini-stro, ovvero cortigiano, ovvero uffiziale di Faraone. Il Caldeo lochiama satrapa, o sia principe.
Yers. i. Nello stesso tempo. Vale~a Aìre poco dopo la venditadi Giuseppe. Lascio da parte la maniera di ordinare la seriede' fatti, che sono qui descritti? come cesa fuori del mio istituto,JB ebe non può farsi in poche paróle.
Giuda ... andò a posare in casa di un uomo di Odollam.Lo Spirito santo ha voluto, che fosse in questo luogo descrittala genealogia di Giuda, perchè da questo per via di Thamar do-vea nascere il Cristo; quindi a dimostrare P estrema esinanizio-ne, alla quale volle per noi discendere il Verbo di Dìo, si rac-contano anche le vergognose cadute di quelli, da'qtuJMgli nonebbe a sdegno di nascere, affinchè nascendo di peccatori cancel-lasse i peccati di tutti gli uomini. •

accepta uxore^ ingres-sum est ad eam.
3. Quae concepii, etpeperit filium , et voca-vit nomen ejus Her.
4- Rursumque conce"ptofoetu^ natum filiumvocavit Onan»
Num. 26. 19.5. Tertium quoque
peperitl, quem appella-vit Selai quo nato, pa-rere ultra cessavit.
6. D edit autem Judasuxorem primogenito suoHer, nomine Thamar.
7. (i,) Fuit quoqueMer, primogenitus Ju-itepBt n e guani in conspe-cto Domini • et ab eooccisus est.
8. Di&it&rgo Judasad OnanfiUum suum :Incedere ad uxoremfratris tuit et sodare il-
per moglie , conviveacon lei.
3. Ed ella concepì epartorì un figliuolo , egli pose nome Her.
4- La quale concepì-.lo un' altra volta , poseal figliuolo, che le nac-que, il nome di Onan.
o. Partorì anche ilt«rzo , cui ella chiamòSeta : e nato questo, nonebbe più figliuoli.
6. È Giuda diede inmoglie ad Her, suo pri-mogenito, una chiama-ta "Tha mar.
7. Ma Her, primoge-nito di Giuda, fu uomoperverso nel cospettodel Signore : il quale lofece morire.
8. Disse pertantoGiuda ad Onan suo fi-glio: Prendi la mogliedi tuo fratello, e convi-
('i) Num. 26. 19.
Vers. 3. Gli pose nome Her. Giuda fu quegli, che diede quiil nome al figliuolo : al figlimelo poi del versetto seguente il no-me fu imposto dalla madre, coinè apparisce dall' Ebreo.
Vers. 7. Her ...fu uomo perverso ec. Gredesi comunemente,che il peccato di Her fosse lo stesso, che quello di Onan ; vale adire, che ambedue con eccesso d'infame libidine procurasseroche la donna non concepisse.
* Perverso nel cospetto del Signore. Scellerato ali' eccesso.Espressione notata altrove.

li, ut suscites seme/ifratri tuo.
9. Ille sciens non sibinascifilios.) introiens aduxorem fratris sui, se-menfundebat in terramìne liberi fratris nominenascerentur.
10. Et idcirco per*tussit eum Dominus^quod rem detestabilemfaceret.
11. Quam ob rem di-xit JudasTìiamarnuruisuae\ E sto vidua in do-mo patris tuì, doneccremai Selafilius meus :timebat enim ne et ipsemorereturì sicut fratresejus, Quae abiit> et ha-bitavit in domo patrissui.
vi con lei affin di darefigliuoli al tuo fratello.
9. Sapendo quegli,che i figliuoli, che na-scessero, non sarebberosuoi*, accostandosi allamoglie del fratello, im-pediva ilconcepimento,affinchè non nascesserofigliuoli col nome delfratello.
10. Quindi il Signorelo fece morire , perchèfaceva cosa detestabile.
11. Per la qual cosadisse Giuda a Thamarsua nuora : Rimantivedova nella casa deipadre tuo, fino a tantoebe Sela mio figlio cre-sca : or ei temeva , chenon morisse anche que-sto , come i suoi fratel-li. Ella se n' andò , e a-bitò in casa del padresuo.
Ver*, g. Affinchè non nascessero figliuoli col nome del fra-tello, II primogenito portava certamente il nome del fratello de-funto • ma quanto agli altri figliuoli credesi, che portassero ilnome del loro padre naturale,
Vers. ii. Or ei temeva, che non morisse anche questa, Vuolsignificare, che Giuda, benché mostrasse di voler dare a Thamarper suo marito il terzo figliuolo, e di non aspettare, se non chequesti avesse l'età competente, in realtà però la rimandava allacasa paterna colla speranza, ch' ella frattanto trovasse occasionedi rimaritarsi con alti'uomo, perchè temeva che non facesse Sela

12. JZvolutis autemmultis diebus i mortuo,estfiliaSuey uxorJudaeiqui post luetum, conso-latione suscepta ascen-debatadtonsores oviumsuarum^ ipse, et Hirasopilio gregis O dottami"tes> in Tìiamnas.
l'S.NuntiatumqueestThamar, quod socer il-lius ascenderei in Tha-mnas ad tondendasoves.
14- Quae) depositisviduitatis vestibus^ as-sumpsit theristrum : etmutato habito, sedit inbivioitineris\quod ducitTHamnam ; eo quodcrevisset S ela, et noneum accepisset mari*tum.
15. Quam cum vidis-set Judas, suspicatusest esse meretricem :aperuerat enim vultumsuum) ne agnosceretur.
12. Passati poi molligiorni morì la figliuoladi Sue, consorte di Giu-da : il quale dopo gliuffici funebri, passato ilduolo, se n'andò a tro-vare quelli che tosava-no le sue pecore inTha-mnas , egli, e Hiras diOdóllam, pastore dipecore.
13» E fa riferito aThamar, come suo suo-cero andava a Tha-mnas a tosare le pecore.
i4« Ed ella , posati ivestimenti da vedova,prese un velo : e trave-stita si pose a sedere inun bivio della strada,che mena a Thamnas ;perocché Scia era cre-sciuto, e non le era sta-to dato in isposo.
15. E avendola vedu-ta Giuda, sospicó, ch'el-la fosse donna di malavita : conciossiachè ellaavea coperta la sua fac-cia per non essere rico-nosciuta.
lo stesso fine che avean fatto gli altri due. Così egli non parlavaa Thamar eoa sincerità.
l6' *

\6Jngrediensque adeam alt : Dimitte me ,ut coeam tecum: nescie-bat enim, quod nurussua esset. Qua respon-dentei Quid dabis mihi,ut fruaris concubitomeo ?
17. Dixit : Mittam ti-bihaedum de gre gibus.Rursumque illa dicen-te : Patiar quod vis, sidederìs mihi arrhabo-nemt do/tee mìttas, quodpolUceris.
A 8. AitJudasi Quidubi vis pro arrhabonedarìì Respondit: An-nulum tuum, et armil-lam, et baculum, quemmanu tenes. Ad unumigitur coitum mulierconcepiti
19. Et sur gens ab'liti depositoque habita,quem sumpseratt indù-ta est viduitatis vesti-bus.
16. E appressatosi alei la richiese di mal fa-re : perocché non sape-va , ch' ella fosse suanuora. E avendo ella ri-sposto : Che mi daraiper fare il tuo volere ?
17. Disse egli : Timanderò un caprettodel mio gregge. E re-plicando quella : Accon-sentirò a tutto, purchétu mi dia un pegno,perfino a tanto che tumandi quel che prch-metti.
18. Giuda disse: Chevuoi tu, che ti sia datoper pegno ? Rispose :L'anello , e il braccia-letto , e il bastone, chehai in mano. Concepìadunque la donna adun sol atto :
19. E si alzò, e se neandò : e deposto l'abito,che avea preso , si ve-sti di vaslimenii da ve-dova.
Vers. 18. // braccialetto. La voce ebrea alcuni la spieganoper un berretto, altri per una fascia, colla quale gli orientali sicingevano la testa, altri in altra guisa. Siccome sappiamo, ch«Anticamente gli uomini portavano de'bracciale Iti, non vrè ragio-ne di allontanarsi dalla Volgata.

20. Misit autem Ju-das haedum per pasto-remsuum Odollamitem,ut reciperet pignus,quod dederat muìieri :qui cum non invenisseteam,
21. Interrogavi? ho-mines loci illius : Ubiest mulier, quae sede-bat in bivio ? Respon-dentibus cunctis : Nonfuit in loco isto mere-trix :
22. Re versus est adJudam, et dìxit ei : Noninveni eam, sed et ho-mines loci illius dixe-runt mihi, nunquam se-disse ibi scortum»
a 3^ J£fr -J#das ^M&-beat sibi\ certe menda*di arguere nos nonpot-est : ego misi haedum,quem promiseram, etnon invenisti eam.
24. Ecce autem posttres menses nuntiave-
20. Ma Giuda mandòper mezzo del suo pa-store Odollamite il ca-pretto, affine di riavereil pegno dato alla don-na : ma questi non a*vendola trovata,
21. Domandò allagente di quel luogo sDov' è quella donna ,che stava a sedere nelbivio? E tutti rispon-dendogli: Non è statain questo luogo donnadi mala vita :
22. Se ne tornò a Giu-da, e gli disse : Non l'hatrovala : e di più tuttola gente di quel luogomi hanno detto, nonessere ivi stata giammaidonna di mala vita.
23. Disse Giuda : Selo tenga perse : almenonon può ella rinfacciar-mi bugia : io ho man-dato il capretto promes-sole, e tu non l'hai ri-trovata,
24. Ma di li a tre me-si , ecco che venne chi
Vers. a3. Se lo tenga per se; almeno non può ee. L'Ebreoè più espressivo: Se lo tenga per s$ (il mio pegno} affinchè noncadiamo noi in vergogna , ovvero non siamo noi svergognati.Giuda dice, che non vuole cercare più il suo pegno per non ve-nire cosi a propalare 1' azione suu vergognosa.

runt Judae, dicentes :Fornicata est Thamarnurus tua,etvideturute~rus illius intumescere .DixitfjueJudasi Prodii'cite eam, utcomburatur.
26. Quae cum duce-retar ad poenam, misitad socerum suum, di*cens : De viro, cujushaec sunt, concepì : co-gnosce, cujus sit annu*lus, et armilla, et ba*cuius,
26. Qui, agnìtìs mu-neribus , alt : Justiorme est: quìa non tradì'dì eam S ela filio meo.Attamen ultra non co-gnovlt eam.
disse a Giuda : Thamartua nuora ha peccato ,e si vede, ch'ella è gra-vida. Disse Giuda : Con-ducetela fuori ad esserbruciata.
26. E mentre ella eracondotta al supplizio,mandò a dire al suo suo-cero : Io sono gravidadi colui, di cui sono que-ste cose : guarda di chisia l'anello, e il brac-cialetto , e il bastone.
26. Ed egli, ricono-sciuti i pegni , disse :Ella è più giusta di me:perocché io non l?ho da-ta in moglie a Sela miofiglio. Ma però egli nonebbe più che fare con lei.
Vers. 24. Conducetela fuori fui esser bruciata. Questa doveaessere in quel tempo la pena ordinaria dell'adulterio pressoquelle nazioni : e generalmente severissime furono sempre pressotutti i popoli anche barbari le leggi contro gli adulteri.
Thamar era sposa di Sela secondo il convenuto con Giuda;ma dovea ella esser bruciata essendo gravida? Si può credere,che Giuda non avrebbe lasciato, che ei eseguisse aJlora la sen-tenza pronunziata da Jui nel primo impeto di sdegno. Giuda quici rappresenta il carattere degP ipocriti, i quali non facendo casode'proprii peccati, sono ardentissìmi nel punire gli altrui.
Vers. 26. Ella e più giusta di /ne. Giuda differendo semprecon mala fede il matrimonio di Thamar col suo figliuolo Sela,«ivea dato occasione alla donna di lasciarsi trasportare a simileeccesso, di procurarsi per mezzo del suocero i figliuoli, che nonpoteva avere col matrimonio di Sela. Ella non altro bramava,che di esser madre di un primogenito della famiglia di Giuda ;i-osi Thamar in un senso era men ingiusta di Giuda. Ciò peròeoa fa si, chè il delitto di Thamar, delitto di adulterio e d' ÌB-

27. (i) Instante au-le m partii, apparueruntgemini in utero : atquein ipsa effusione in/an-tìum unus protulit ma*num, in qua obstetrixlìgavitcoccinum dicens :
28. Iste egredieturprior.
29. Illo vero re tra'hente manum, egressusest alter : dixitque mu-lier : Quare divisa estpropter te maceria ? etob hanc causam voca*vit nomen ejus Phares.
*" 3o. (2) P os tea e gres-<sus estfrater ejus, in cu-jus manueratcoccinum'.quem appellavit Zara.
27. Ma appressando-si il parto, si conobbe,che avea in seno duegemelli : e nell' uscirede' bambini uno misefuori la mano, alla qua-le la levatrice legò un fi-lo di scarlatto, dicendo;
28. Questi uscirà ilprimo.
29. Ma avendo egliritirata la mano , uscil'altro , e la donna dis-se : Per qual motivo siè rotta per causa tuala muraglia ? e per talmotivo gli pose nomePhares.
30. Usci dipoi il suofratello, che aveva allamano il filo di scarlatto :e lo nominò Zara.
fi) Matth. i. 3. £aj i. Parai 2. 4,
cesto, non sia molto più grave, che quello di Giuda, il qualepeccò di fornicazione , non avendo saputo, che quella donna Cos-ce sua nuora, ma credendola di mala vita. Credasi, che Tha-mar non ebbe più altro marito, e che Sela sposo altra donna(Niun, xxxvi. 19.), e dopo quello che era avvenuto, non avrebbecertamente potuto, nè voluto averla per moglie.
Vers. 28. Questi uscirà il primo, L'Ebreo: è uscito il primo;e vuol dire : questi è il primogenito.
Vers. 29, Per qual motivo si e rotta ec. Perchè è ella stataper te divisa la membrana, onde tu eri involto, affinchè tu pas-
. sassi il primo?Gli pose nome Phares. Eccole parole di s. Girolamo: Pha~*
res, perche divìse la membrana delle secondine, prese il nomedi divisione ; onde anche i Farisei, i quali come giusti si JS-l'aravan dal popolo., preser tal nome,

C A P O XXXIX.
Giuseppe essendo in prospero stato netta casadel padrone Putifare , ed essendo a lui caro,e governando questi la famiglia) per aver dis~prezzata la padrona , che sovente lo tentava,è accusato dinanzi al padrone, e messo incarcere , dove si acquista il favor del custode,il quale dà a lui la cura de' prigionieri.
i. i gitur Joseph du-ctus est in AEgyptum,emitque eum Putiphareunuchus Pharaonis,princeps exercitus, virAEgyptius, de manuIsmaelitaruni) a quibusperductus erat.
i. Fnitque Dominuscum eo , et erat vir incunctis prospere agens :Jiaòitavitquc in domodomini sui.
1. \JTiuseppe adun-que fu condot lo in Egit-to , e lo comperò Puti-phar Egiziano eunucodi Faraone, capitanodell' esercito degP I-smaeliti, che ve l'avea-no condotto.
2. E il Signore eracon lui, e gli riuscivabene tutto quel che fa-ceva: e abitava nella ca-sa del suo padrone,
Vers. 3o. Chiamollo Zara* Vale a dire l'appariscente, il na-scente, perchè fu il primo a comparire. Phares adunque, benchéfigliuolo del peccato, f» primogenito di Giuda, progenitore diDavidde, e di Salomone, e-di tutti i re della stirpe di Giuda, edel Cristo medesimo promesse alla famiglia di Giuda, come ve-dremoj, cap. XLIX. io.
Vers. 2. Abitava nella casa del suo padrone. Anche questoi dettò per dimostrare l'affetto e la stima del padrone versoGiuseppe. Putiphar non lo tenea occupato nelle faccende della<*ampagna, ma nella propria casa, il governo della quale a lui af-fido interamente.

5. Qui optime nove-rat Dominum esse cumeo* et omnia, quae ge-reret, ab eo dirìgi inmanu illius.
4* Invenitque Josephgratiam coram dominosuo, et ministrabat eita q uopraepositus omni»bus gubernabat eredi-tavi sibi domum, et uni-versa , quae ei traditafuerant.
6. Benedixitque Do-minus domui AEgyptiipropter Joseph, et mul-tiplicavit tam in aedi-bus-, quam in agris cun-ctam ejus substantiam,
6. Nec rjuidquamaliud noverai nisi pa*nem, quo vescebatur.Erat autem Josephpul*era facie, et decorus a*spectu.
7. Post multos ita-que dies injecit dominasua oculos suos in Jo-
3. II quale benissimoconoscea , che era conlui il Signore, e condu-ceva a buon fine tuttoquello che intrapren-deva.
4- E Giuseppe trovògrazia dinanzi al suopadrone , e lo serviva ,ed essendogli stata datada lui la soprintenden-za di tutte le cose, go-vernava la casa a sé af-fidata, e tutti i beni ri-messi nelle sue mani.
o. E il Signore bene-disse la casa dell'Egizia-no per amor di Giusep-pe , e moltiplicò tuttele facoltà di lui tantoin casa, come alla cam-pagna ,
6. Ed egli non aveaaltro pensiero , ebe dimettersi a tavola a man-giare. Or Giuseppe eradi volto anreaènte, e digraziosa presenza.
7. Passato adunqueassai tempo , la padro-na fissò i suoi occhi so
Ver*. 6. Ed egli non avea altro pensiero, ce* Giuseppe pen~sava a tutto : il padrone non avea da prenderai pensiero di cosaveruna, fuori che di mangiare, e di b,ere» È una maniera diproverbio.

^eph,et alt : Dormì me-cum.
8. Qui nequaquamacquiescens operi nefa-rioì dixit ad eam'. Ec-ce dominus meuS) omn-ibus mihi traditis, igno-rai quid habeat in do-mo sua :
9. Nec tjuidquam est,quod non in mea sitpotestate, vel non tra-dideritmihi) prae ter teìquae uxor ejus es : quo-modo ergo possum hocmalum facere^ et pec-care in Deum meum?
i o. Hujuscemodi ver-bis per singulos dies etmulier molesta eratadolescenti, et ille re-cusabat stuprum.
11. Accidit autemquadam die, ut intraretJoseph domum} et ope-
pra Giuseppe , e disse:Dormi meco.
8. Il quale non ac-consentendo ali' operaindegna , le disse : Tuvedi come il mio padro-ne avendo rimessa ognicosa nelle mie mani,non sa quel che si abbiain sua casa :
9. E veruna cosa nonè, ch'ei non abbia a meaffidata , e di cui nonm'abbia fatto padrone,fuori di te , che sei suamoglie : come adunqueposs'io fare questo ma-le , e peccare contro ilmio Dio ?
10. Cogli stessi dis-corsi ogni dì e la don-na inquietava il giovi-netto, ed egli ricusavadi peccare.
11. Ma avvenne, cheun dì Giuseppe entròin casa, e si pose a far
Ver». 7. Passato assai tempo i, la padrona ec. Egli dovea ave-s-e venti sette anni, quando avvenne quello che qui si racconta;ed erano circa dieci anni, ch' egli serviva neJla casa di Putifare.
* E disse: dormi meco. E invitollo a peccare.Vers. p. E peccare contro il mio Dio? I sentimenti del san-
tissimo giovine furono in simile occasione ripetuti da una castis-sima donna : Egli e meglio per me il cadere nelle mani vostresenza aver fatto U male, che il peccare al cospetto del Si-gi IL re. Dan. xui. 22.

rìs t/uippiam absquearbitris /acereti
12. At illa, appre-hensa lacinia vestimen-ti ejus, diceret: Dormimecum. Qui relicto inmanu ejus pallio fugit,et egressus est foras.
13. Cumque vidissetmulier vestem in mani-bus suis, et se essecontemptam :
14. Vocavit ad sehomines domus suae,et ait ad eos : En ìn-troduxit virum He-braeum, ut illudereinobis. Ingressum estad met ut coirei mecum.".cumque ego succlamas-sem,
15. Et audisset vo-cem meams en reUquitpalUum, quod tenebam,et fugit foras.
1.6. In argumentumergo fidei retentum pal-
qualche cosa non aven-do alcun con sé :
la, E quella , presol'orlo del suo mantello,gli disse: Vieni con me.Ma egli lasciato in mandi lei il mantello, si fug-gì fuori di casa.
13. E la donna veg-gendo in sue mani ilmantello ? e sé disprea*zata :
14. Chiamò a se lagente di casa, e disseloro : Ecco che egli hacondotto qua quest'uo-mo Ebreo, perchè ci fa-cesse vergogna. Egli èvenuto a trovarmi perpeccare con me : e ave n»do io alzato le grida,
16. Egli all'udir lamia voce ha lasciato ilmantello, per cui io loteneva, e si è fuggito.
16. In prova adunquedella serbata fede fece
Yers. 12. Sì fuggi fuori di casa. Sopra queste parole s. Ago-stino serm. aSo. Giuseppe per sollrarsi all'impudica padrona,fuggi. Impara tu ne'pericoli e/' impurità a prender la fuga,se vuoi ottenere la palma della castità ... Di lutti i combatti-menti del Cristiano i più duri e diffìcili sono quelli della ca-stità , ne' quali quotidiana e la pugna , rara la -vittoria: inquesti adunque non può mancare al Cristiano un quotidianomartirio ; imperocché se Cristo e castità , e verità, e giustizia te se chi insidia a queste, è persecutore, colui, che le difendinegli altri, e in se stesso le custodisce, tara marlù*.

lium ostendit maritorevertenti domum,
i 7. Et alt: Ingressumest ad me servus ile"braeus^ quem adduxi-sti, ut illuderei mihi :
*8. Cumque audissetme clamare, reliquitpallium, quod tenebam^etfugitforas.
19. His auditis do-minuS) et nimium ere-duluj verbis conjugisììratus est valde :
50. (i) TradiditqueJoseph in carcerem,ubivincti regis custo-dìebantur, et erat ibiclausus.
21. Fuit autem Do-mìnus cum Joseph^ etmisertus illius dedit ei
veder al marito tornatoa casa il mantello rite-nuto,
17. E disse : E venu-to a trovarmi quel ser«vo Ebreo, che tu haicondotto a svergognar-mi:
18. Il quale, sentitocome io alzava le grida,ha lasciato il mantello,che io teneva, ed è scap-pato.
19. Tali cose avendo«dite il padrone troppofacile a credere alle pa-role della moglie , neconcepì grande sdegno :
20. E fece metterGiuseppe nella prigio-ne, in cui erano tenutii rei di delitto commes-so contro del re, ed eglifu quivi rinchiuso.
21. Ma il Signore fucon Giuseppe, e avendocompassione di lui fece
fi) P sal. 104. 18.
Vew. 16. Fece vedere al marito ... i? mantello. Se il mar ilofosse stato capace di ben riflettere, questo mantello, ch' ella avearitenuto, evidentemente provava cui de' due avesse voluto farviolenza.
Vers. 17. * Quel terco Ebreo, che tu hai condotto. Con ogniartifizio la rea donna cerca inasprire il marito contro il virtuosogiovine, esagerandone la servii condizione, la qualità di stranie-ro, la circestanz* d'ingrato col suo benefattore.

gratiam in conspectuprincipis carceris.
22. Qui tradidit inmanu illius unwersosvinctoS) qui in custodiatenebantur : et quid"quid fiebat^ sub ipsaerat.
23. Nec noverai ali-quid\ cunctis ei credi"tis : Dominus enim eratcum illo, et omnia ope*ra ejus dirigebat.
sì, ch' ei trovò graziadinanzi al provveditoredella prigione.
22. Il quale diede alui potestà sopra tuttii prigionieri, che eranoin quella carcere: e tut-to quello che si facea ,era fatto per s,uo ordine.
23. E quegli non pen-sa va a nulla, avendo da-to di ogni CQsa l'arbi-trio a Giuseppe: peroc-ché il Signore era conlui, e conduceva a buonfine tutto quel ch'ei fa-ceva.
„ Vers. 21, Fece « , ch1 ei trovo grazia te. Questo principe, osia provveditor della carcere era lo stesso Putifare, il quale do-vette ben riconoscere l'innocenza di Giuseppe, e diminuì la suapena, senza però liberarlo aflin di salvar 1' onore della moglie.Cosi il Pererio. f^edi, cap. xu. 12. Ed è ancora molto probabile ,che lo stesso Putifare fu quegli, che diede la sua figliuola permoglie a Giuseppe. Gii uomini non vorrebbero ( osserva il Cri-sostomo ) che Dio lasciasse così sovente cadere i giusti nell' affli-zioni, ma li liberasse, e lì tenesse in perfetta tranquillità: manon è ella cosa più degna di Dio, e pii» degna dell'amore, ch'egliha pe'medesimi giusti, l'esercitare la loro virtù, e far conoscerequello ch' egli può fare in essi, e finalmente far si, che le-affli-zioni stesse, e le tentazioni divengan per essi occasione di gran-de allegrezza? Ecco di fatti un giusto calunniato, e messo in pri-gione, divenuto vero martire della castità, come notò s. Ambro-gio, il quale libero in certo modo tra tutti que' rei, rispettato, eamato da tutti esercita un' assoluta potestà sopra tutti i compa-gni , come se tra essi fosse stato mandato non come uno di essi,ma come loro provveditore, e consolatorc. Ma tutto questo è unnulla in paragone della gloria, a cui la P*ovideuza vuole innal-zare Giuseppe col mezzo stesso della sua umiliazione, e dellasua prigionia.
Il Giusto per eccellenza, il Cristo, di cui Giuseppe è semprefigura, potò essere calunniato, tradito, confuso co* peccatori per

C A P O XL.
^Giuseppe nella prigione interpreta i sogni de*dueeunuchi di Faraone , e predice, che UJIQ saràrestituito al primiero uffizio, /' altro finirà lavita sul patibolo-, e tutte queste cose si avvera-rono nel dì della nascita di Faraone.
1. flis ita gestisaccidit, ut peccarentduo eunuchi, pincernaregis AEgypti) etpistor}domino suo»
2. Iratusque contraeos Pharao (nam alterpincernis praeerat, ai-ter pìstoribus )
3. Misit eos in car-cerem principis mili-tum, in quo erat vin-eius et Joseph.
4» Atcustos carceristradidit eos Joseph, quiet ministrabat eis. Ali*quautulumtemporisflu-
i. Uopo di ciò av-venne , che due eunu-chi , il coppiere, e ilpanettiere del re d'E-gitto peccarono controdel loro signore.
2.E Faraone sdegna-to contro di costoro( uno dei quali era ca-po dei coppieri, e l'altrode' panattieri )
3. Li fece metterenella prigione del capi-tano delle milizie, doveera rinchiuso ancheGiuseppe.
4- E il custode dellaprigione li consegnò aGiuseppe , il quale an-cor li serviva. Era pas-
la malignità di una perversa donna, la sinagoga ; ma nella slessasua umiliazione egli eserciterà una potestà suprema e divina aconsolazione e salute de'peccalori, e dal suo sepolcro uscirà pie-no di gloria, e riconosciuto , e adorato come vero Dio , e unico«alxalore di tutte le genti.

xerat, et illi in custo-dia tenebantun
6. Videruntque ambosomnium nocte una jux-ta interpretationem con-gruam sibi.
6. Ad quos cum in-troisset Joseph mane,et vidisset eos tristes>
7. Sciscitatus est eostdicens' Cur tristior esthodie solito facies ve-stra*
8. Qui responderuntiSomnium vidimus, etnon est, qui interprete-tur nobis. Dixitque adeos Joseph : Numquidnon Dei est interpreta-£ìo? re/erte mihi, quidvideritis*
salo un tratto di tem-po, dacché quegli eranorinchiusi :
6. Quando ambeduela stessa notte vi,deroun sogno di significazio-ne adattata al caso loro.
6. Ed essendo la mat-tina andato Giuseppe atrovargli, e " vedutilimalinconici,
7. Gì'interrogò, di-cendo: Per qual motivooggi avete la faccia piùafflitta del solito ?
8. Risposer quegli :Abbiam veduto un so-gno, e non abbiamo chia noi lo interpreti. ElGiuseppe disse loro :Non appartiene egli aDio l'interpretarli ? di-temi quel che avete ve-duto»
Vers. 4- Un tratto di tempo. Credesi un anno. L'Ebreo de*gior-ni; lo che, secondo gli Ebrei, e altri interpreti, posto assoluta-'mente, significa un anno: cosi questi due rei sarebbero stati messinella prigione quasi nello stesso tempo, che vi fu messo Giuseppe.
Vers. 5. Di significazione adattata ec. Sogno, che era unapredizione di quello che ali' uno e ali' altro dovea accadere.
Vers. 8. Non appartiene egli a Dio ec. L' interpretazionede' sogni è dono di Dio , e Dìo darammi grazia d'interpretarequello che voi avete veduto. De' sogni mandati da Dio abbiamoanche altri esempi nelle Scritture j talora Dio ne dà l'interpre-tazione a quegli stessi, a' quali li manda -, talora vuol, ch' essi lacerchino dalle persone, alle quali egli comunica lo spirito diprofezia. Vedi Dan. cap. iv. v., e Gen. cap. XLI. Siccome sono-assai rari ì casi de' sogni mandati da Dio , ed è cosa ditficilissima.

$. Narravit priorpraepositus pincerna-rum somnium suum :Videbam coram me vi-lem,
10. In qua erant trespropagines, crescerepaulladm in gemmas,et posi flores uvas ma*turescerei
11. Calicemgue Pha*iraonis in manu mea\tuli ergo uvas, et ex-prassi in calicem, quemtenebain., et tradirti po*culunt Pharaonì.
12 .Respondit Joseph:Haec est interpretatiosomniii tres propagi-nes t tres adhuc diessunt)
13. Post quos recor-dabitur Pharao mim-sterii tuit et restìtuettein gradum prìstìnum:dabisque ei calicemjux-ta officium tuum, sicutante facere consueve-ras.
14* Tantum memen*tornei, cum bene tiòifuerit^ etfacias mecum
g. 11 gran coppiereraccontò il primo il suosogno : lo vedeva da-vanti a me una vite,
10. La quale avea tretralci, che gettavano apoco a poco gli occhi,e poi i fiori, e poi le uve,che maturavano:
11. E nella mia manoera la coppa di Faraone :e presi le uve, e le spre*mei nella coppa che aveain mano, e presentai dabere a Faraone.
12. Rispose Giusep-pe : La spiegazione delsogno è questa : Tretralci, tre giorni vi so-no ancora,
13. Dopo de' quali siricorderà Faraone deituoi servigi, e ti rende-rà il posto di prima : epresenterai a lui la cap-pa secondo il tuo uffizio,come per F avanti sole-vi fare.
i4- Solamente ricor--dati di me, quando sa-rai felice, e abbi com-
il distinguerli da'sogni vani, o mandati dal Demonio; quindi il*pia «icuro m generale si è di non dar retta a' sogni per non c&?derc in una superstfzfoffe, la quale è sovente rinfacciala altegenti idolatre nelle Scritture

lìusericordiam: ut sug-geras Pharaonì, ut edu-cai me de isto carcere*.
15. Quìa furto subia-te sum de terra He-braeornm, et hic inno-'cens in lacum missussum.
16. Videns pistorummagis ter, e/uod pruden-ter sonmium dissolvis-jet, alt: Et ego vidisomnium. Quod tria ca-lustra farinae haberentsuper caput meum;
17. Et in uno cani-atto, quod erat excel-sius, portare me omnescibo S) qui fiunt arte pi-storia.^ avesque come-aere ex eo.
18. Respondit Jose-ph-. Haec est interpr$-tatio somniii Tria cani-
passione eli me» e solle-cita Faraone , che mitragga da questa pri-gione :
15. Perocché con fro-de fui condotto via dal-la terra degli Ebrei, einnocente fui gettato inquesta fossa.
16. Vedendo H capodei panattieri, com'egliavea saggiamente dici»ferato quel sogno , dis-se: Io pure ho vedutoun sogno. Pareami d'a-vere sopra il mio capotre canestri di farina:
17. E che nel cane-stro di sopra io portas-si d'ogni specie di man-giare, che si fa dall'artede'panattieri, e che gliuccelli ne mangiavano,
18. Rispose Giusep--P&l-Jrfik «posizione delsogno è questa : treca-
Yers. 15. Dalla terra degli Ebrei. Dalla terra di Chanaan as-segnata da Dio, e donata alla famiglia d'Abramo. La fede di Giu-seppe &rric0nosce anche in questo, che egli non dubita del do-minio , che i suoi aver debbono di un paese , nel quale non sonofinora se non pellegrini. ,
* Con frode fui condotto via. E prodigiose il contegno diquesto Giusto, il quale nella più iniqua oppressione non incol-pa, come avrebbe potuto, nè gì' invidiosi fratelli, nè la malignapadrona, poiché presagiva l'umiltà, e la mansuetudine di quelloche a noi volle farsi maestro di tali virtù,

tf tra, tre s adhuc diessunt,
i g. Post quos aufe-ret Pharao caput tuum,ac suspendet te in cru-ce, et lacerabunt volu-cres carnes tuas.
20. Exinde dies ter*Aus natalitius Pharao-nis erat: qui faciensgrande convivium pue-ris suis recordatus estinter epulas magistripincernarum, et pisto-runt principis >
21. Restituite/uè al*terum in locum suum ,ut porrigeret ei pocii»lum:
32. Alterum suspen-dit in padbulo, ut con-jectoris veritas probd-retur.
nestri, cioè tre giornivi sono ancora,
19. Dopo i quali Fa-raone ti farà tagliare ilcapo , e ti farà crocifig-gere, e gli uccelli dell'a-ria beccheranno le tuecarni.
20. Il terzo giorno dipoi era il dì della nasci-ta di Faraone ; il qualefacendo un gran convi-to a' suoi servi si ricor-dò a mensa del capo deicoppieri, e del capo deipanattieri,
21. E rendè all'unoil suo uffizio di presen-targli la coppa :
22. E l'altro fece ap-piccare a una croce, on-de fu dimostrata la ve-racità dell' interprete.
Vers. ir). Ti farà tagliare il capo ec. Si vede che gli Ebrei,e gli Egiziani faceano tagliare a' rei la testa prima di appiccare iloro cadaveri, fedi Jerem. Thr, v. 42-? *• RC&- xxxi. io., e ordi-nariamente si uccidevano prima tutti quelli che si doveano ocrocifìggere, o impiccare. Vedi Deut. xxi. 22. Nitm. xxv. 4- ec-Ma non si lasci d' osservare, con qual fermezza , e autorità nelluogo stesso della sua abbiezione Giuseppe sedendo arbitro del-la sorte di questi due uomini dà ali' uno vita e salvezza, e l'al-tro condanna alla morte. Chi puù non riconoscere in lui GesùCristo, il quale in mezzo agli obbrobrii della sua croce dà il pa-radiso a uà ladro, e l'altro lascia nella sua dannazione, venendocosì ad annunciare la separazione, che Carassi di tutto il genereumano in due parti nell'ultimo giorno, quando agli uni dirà eglistesso: Venite benedetti dal Padre ?m'o, ec. e agli altri: Andatemaledetti al fuoco elerìioì ec.?

23. Et tamen sue-cedentibus prosperis ,praepositus pincerna-rum oblitus est inter-pretis sui.
a3. Ma tornalo inprosperità il capo deicoppieri si scordò delsuo interprete.
C A P O XLI.
IXon potendo alcuno interpretare i sogni di Fa-raone, gli spiega Giuseppe : qumdt è fatto so-printendente di tutto l'Egitto. Faraone gli dàper moglie Aseneth , dalla quale ha due fi-gliuoli prima de' sette anni di carestia. Suc-cede finalmente la sterilità ali abbondanza.
1. jLost duos annosvìdit Pharao somnium.Putabat, se stare super$uviumt
2. ,Q& quo ascende^bant septem boves pul-chrae, et cras$ae ni-mis: et pascebantur inlocis palustrìbus.
3. Aliae quoque ,ye-ptem emergebant deflumine, foedae , con-fectaeque macie: et pa-
i. JL/ue anni dopoFaraone ebbe un sogno.Parevagli di stare allariva del fiume,
2.Dal quale uscivanosette vacche belle, egrasse formisura: e an-davano a pascere neiluoghi palustri.
3. 4tì*e sette ancorascappavan fuori del fiu-me, brutte, e rifinite permagrezza, e si pasceva*
Vera. i. Due anni dopo. Due anni dopo la liberazione delgran coppiere, l'anno terzo della prigionia di Giuseppe.
Alla riva del fiume, ovvero di un canale del fiume Nilo.Notisi, che dal Nilo viene la fertilità, o sterilità dell' Egitto: Seil Nilo (dice Plin. lib. v. g.) inonda aW altezza di dodici cubi-/i, V Egitto e alla faìne, se a tredici VEgitto e alla carestia 7quattordici cubiti portano allegrezza, i quindici tranquillila ,i sedici abbondanza e delizia : quindi è, che dal Nilo vede Fa<»raone venir su le vacche grasse, e le vacclie magre.
Pent. prol, I. 17

scebanturin ipsa amiiisripa in locis virentibusi
4- Devoraveruntqueeast quarum mira spe-cies., et habitudo corpo-rum erat. Expergeja-ctus Pharao,
5. Rursum dormivit,et vidit alterum ,so-mnìum* Septem spicaepuliulabant in culmouno plenae, atque for-mosae:
6. Aliae quoque tati"dem^spicae tenues, etpercussaeuredine orie-bantur,
if.lìevorantes omnempriorum pulchritudi-nem. Evigìlans Pha-rao post (juietemt
8. Et facto mane >.pavore perterritus, mi"sit ad omnes conjecto-res AEgyptìjcuncèosque-sapientes', et accersitisnarravit somnium ; nec
no sulla riva stessa delfiume,dov'era del verde:
4» E ( queste ) si di-vorarono quelle ebe era-no mirabilmente belle,e di grassi corpi. E Fa-raone si risvegliò,
6. Poi si raddormen-tò , e vide un altro so-gno. Sette spighe si al-zavano da un solo stelopiene e bellissime ;
6. E altrettante na-scean dipoi spighe sot-tili, e bruciacchia te dal'V euro,
7. Le quali si divora-vano tutte le prime sìbelle. Svegliatosi Farao-ne dal sonno,
8. E venuto la matti*na, pieno di pauraman-dò a cercare tutti gl'in-dovini d'Egitto, e tuttii sapienti: e rannali chefurono, raccontò il so-
Vers. 3. E si pascevano sulla- riva stessa del fiume. Delleprime sette disse., che andavano, a pascere in luoghi palustri,perchè il Nilo avea largamente Laon.dato la campagna ; onde bi-sognava andar lontano per trovar pascolo, ma di queste sette sì4lee, «ifie pascolavano sulla ripa: segno che il fiume nou aveadato fuori ; onde lontan da esso mancava 1' erba, e solo si trovavadel verde alle rive.
Vers. 6. Bruciacchiale dall'euro. L'Ebreo bruciacchiale dal-VorientC) o SÌA dal vento droriente, cioè l'euro, il quale è noce-vole all'Egitto; perchè è molto caldo, soffiando dal vasto e seccodeserto d'Arabia.

erat, qui interpretare-tur.
9. Tunc demum re»miniscens pincerna-rum magister^ aiti Con-fiteor peccatum meum\
10. Iratus rex servissuis me , et magistrumpistorum retrudi jussitin carcerem principismilìtum:
11. Ubi una nocteuterque vidimus som-nium praesagum futu-rorum.
12. ~Er alibi puerile-braeust ejusdem ducismìGt&m famulus : cuinarrante» somnìa
13. Auéfómmu&tquid-quidpostea rei proba*vit èventus : ego enimredditus sum officio
gno ; e non v'ebbe chine desse la spiegazione.
9. Allora finalmenteil capo de'coppieri siricordò , e disse : Con-fesso il mio fallo :
10. Disgustato il recontro i suoi servi or-dinò, che io, e il capode' panattieri fossimorinchiusi nella prigionedel capitano delle mi-lizie :
11.Dove in una stes-sa notte ambedue ve-demmo uri sogno, chepresagiva il futuro.
12. Bravi un giovi-netto Ebreo, servo del-lo stesso capitano dellemilizie : al quale aven-do noi racconta ti i sogni
13. Ne udimmo l'in-terpretazione verificata&& <|mef elle è di poi av-venuto : perocché io fui
Vers. 8. Tutti gl'indovini ec. Questi , credesi, che fosseroque' medesimi, che poi sono chiamati maghi di Faraone, facendoessi ambedue i mestieri d'indovini, e di maghi.
E littti i sapienti. Questi erano i sacerdoti, la vita dei qua-li era occupata tutta nel culto degli dei, e nello studio della sa-pienza. Spendevano la notte nello studio, e nella considerazionedegli astri, il giorno nel servigio degli dei, a' quali cantavano in-ni a quattro differenti ore della giornata. Erano versatissimi nel-la geometria, astronomia, e aritmetica.
Vers. p. * Confesso il mio fallo. Se lo sconoscente coppiereali' usanza de' cortigiani non credesse adesso di far piacere al suore, non ricorderebbe Giuseppe nè i di lui meriti.

meo, et ille suspensusestincruce.
14- (i) Protinus adregis imperium edu-ctum de carcere Josephtotonderunt : ac vestemutata, obtulerunt ei.
15. Cui ille ait: Vidisomma,) nec esigui edis-serati quae audivi tesapientissime conjicere.
16. Respondit Jo-seph: AbsquemeDeusrespondebit prosperaPharaoni»
ij. Narravit ergoPharao, quod viderat:Putabam.) me stare su-per riponi fluminis,
18. Et septem boves
restituito a! mio impie-go, e quegli fu appesoalla croce.
1,4. Subitamente percomando del re fu trat-to di prigione Giusep-pe : e fattolo radere, ecambiatogli il vestito,lo presentarono a lui.
15. E questi gli dis-se: Ho veduti de'sogni,e non ho chi gì' inter-preti: ed ho sentito,che tu con gran saviez-za li sai diciferare.
16. Rispose Giusep*be : Iddio senza di merisponderà favorevol-mente a Faraone.
17. Raccontò adun-que Faraone quello cheavea veduto : Pareamidi stare sulla ripa delfiume,
18. E che dal fiume
(i) Ps. 104 • 20.
Vers. 14. E fattolo radere, e cambiatogli il vestito ec. Nellutto era cosa ordinaria il lasciar crescere i capelli, e la barba.Yedesi ancora, che nissuno entrava nel palazzo d e' re in abito diduolo. Vedi Esther. iv. a., Gen, i. 4.
Ver». i*>. Iddio senza di ine ec. Giuseppe non volea, che Fa-raone si pensasse, ch' egli o per qualche naturale sua virtù, o peralcuno de'mezzi usati dagl'indovini dell'altre nazioni potesse da-re una giusta interpretazione de' suoi sogni. Egli dichiara perciò,che da Dio solo può venire agli uomini la cognizione di quel chepresagiscono i sogni mandati da lui, e che da Dio egli aspettaquesto lume a consolazione di Faraone,

22. Vidi somnìum.Septem spicae pullula-bant in culmo uno, pie-nae atquepulcherrimae.
23. Aliae quoque sep-tem tenues , et percus-sae uredine oriebanture stipula-.
24. Quae priorumpulchritudinem devora-verunt. N'arrapi coJtje-ctoribus somnium, etnemo est qui edisseraL
uscissero sette vacchebelle formisura, e moltograsse r i e quali pascen-do ne' luoghi paludosispuntavano l'erba verde:
19. Quand* ecco die-tro a queste venivanosette altre vacche tan-to brutte e macilente ,che mai le simili nonho vedute nella terrad' Egitto :
20. Le quali, divora-to avendo3 e consuntole prime,
21. Non diedero nis-sun segno d' esser sa-tolle; ma erano abbat-tute come prima dallamagrezza e dallo squal-lore. Mi svegliai, e dinuovo fui oppresso dalsonno,
22. E vidi questo so-gno. Sett« spighe spun-tavano da uà solo, ste-lo , piene e bellissime.
26. Parimente altresette sottili, e bruciac-chiate dall'euro nasceva-no da un filo di paglia :
24. Le quali divora-rono le prime si belle.Ho raccontato il sognoagl'indovini, e nissunv'ha, che lo spieghi.

26. 'Respondit Jo-seph; S omnium regis u-num est: quaefacturusest Deus, ostendit P ha»raonì.
26. Septembovespul-chrae et septem spicaeplenae septemubertatisanni sunt\ eamdemquevim sommi comprehen-dunt.
27. Septem quoqueboves tenues^atque ma-cìlentae, quae ascende»runtpost eas, et septemspicae tenues, et ventourente percussae^ se-ptem anni venturae suntfamìf.
28. Qui hoc ordinecomplebuntur.
29. Ecce septem an-ni venient ferdlitatismagnae in universaterra AEgypdi
30. Quos sequenturseptem anni alii tantaeàterilitatiS) ut oblivionitradatur cuncta retroabundantia t consumi-
26. Rispose Giusep-pe : Uno è il sogno delre : Dio ha mostrato aFaraone quel che vuolfare.
26. Le sette vacchebelle, e le sette spighepiene sono sette annidi abbondanza; e sonoun soi senso.
27. Parimente le set-te vacche gracili e ma-cilente , che vennerodietro a quelle, e le set-te spighe sottili, e ofie-se dal vento, che brucia,sono sette anni di fu-tura carestìa.
28. E la cosa avrà ef-fetto con quest' ordine.
29. Ecco che verran-no sette anni di gran-de fertilità per tutta laterra d'Egitto :
So. Dopo i quali sa-ran sette altri anni disterilità cosi grande,che andrà in obblio tut-ta la precedente ab-
Vers. «5. Uno e il sogno del re. Riguarflo al significato il so-gno del re è un Solo.
Dio ha mostrato a Faraone eo. Si vede qui la special pre-videnza di Dio verso i rettori e pastori de' popoli. Vedi ancheDan. cap. n.

ptura est enim Jamesomnem terram,
Si.Et ubertalis ma-gnitudinem perdituraest inopiae magnitudo.
32. Quod autem vidi"sti secundo ad eamdemrem pertinens som-nium; firmitatis indi"cium est, eo quod fiatsermo liei, et velociusimpleatur. t
33. "Nunc ergo provi-deat rex virum sapien-tem, et industrium, etpraeficiat eum terraeJEgypti:
34- Qui constituatpraepasites per cunctasregiones : et quintampartem fructuum perseptem annos fertìhta-tis,
36. Qmjam nunc fu-turi sunt, congregentin horrea; et omne fra."mentum sub Pharaonis
bondanza : perocché lafame devasterà tutta laterra,
31. E la gran care-stia assorbirà la gran-de abbondanza.
32. L'aver poi tu ve-duto replicato sogno,che una stessa cosa si-gnifica , segno è que-sto, come la parola diDio avrà sicuramenteeffetto, e senza dilazio-ne si adempirà.
33. Scelga adunqueadesso il re un uomosaggio, e attivo, e diagliautorità in ( tutta ) laterra d'Egitto:
34* E questi deputidei soprintendenti inogni regione : ela quin-ta parte del proventode* sett'anni di fertilità,
"36* I quali fin d'ades-so comincieranno ad es-sere , sia raunata ne'granai : e tutto il fru-
Vers. 34- La quinta parie del-provento ec. Giuseppe consi-glia al re di far portare ne'suoi granai la quinta parte delle gra-sce di ciaschedun anno di fertilità. Siccome è probabile, chene' luoghi più vicini al Nilo qualche piccola cosa si raccogliesseanche ne' sette anni della fame, Giuseppe previde che questaporzione riserbata pòtea bastare al mantenimento del popolo ;oltre di che negli anni magri suoi usarsi maggior risparmio.

potestate condatur, ser-ve tur que in urbibus*
36. Et praepareturfuturae septem anno-rum fami, quae oppres-suro, est AEgyptum, etnon consume tur terrainopia.
67. Placuit Pharaoniconsilium , et cunctisministris ejus.
38. Locutusque estad eos ; Num invenirepoterimus talem virum^qui spiritu Dei plenussit?
3g. Dixit ergo ad Jo-seph: Quìa osiendit ti'bi Deus omnia, quaelocutus es, numquid sa-pientiorem, et consimi-lem tui invenire poteroì
4°- Tu eris super do-mum meam , et ad tuioris imperium cunctuspopulus o&edlet: unotantum regni s olio tepragcfidam.
Psal. 104. 21. i.Mach. 2. 53. Act. 7. io.
4i. Dixitf/ue rursusPharao ad Joseph-, Ec-ce cons litui te super un i-
mento si rinchiuda adisposizione di Farao-ne, e si conservi nellecittà.
56. E si tenga pre-parato per la futura ca-restia di sette anni, cheverrà sopra 1' Egitto,affinchè il paese non siaconsunto dall* inopia.
37. Piacque il consi-glio a Faraone, e a tut-li i suoi ministri. "
38. Ed egli disse lo-ro : Potrem noi trovareuomo come questo, chepieno sia dello spiritodi Dio ?
So,. Disse pertanto aGiuseppe : Dacché Dioha mostrato a te luttoquello che hai detto,potrò io trovare uomopiù saggio, e simile at e?
4°» Tu avrai la so-printendenza della miacasa, e al comando del-la tua bocca obbediràtutto il popolo : nonavrò precedenza sopradi te, se non quella deltrono reale.
4i. E disse tPC.pJ'aFaraone a Giuseppe :Ecco che io ti do aulo-

versam terram AEgy-pti.
42. Tulitque annu-lum de manu sua, etdedit eum in manuejus : vestivitque eumstola byssina^ et collolor quem auream cir-cumposuit.
43. Fecitque eum a-scendere super currumsuum secundum, cla-mante praeconet ut o-mnes coram eo genu fle-tter ent, et praepositumesse scirent universaetefrae AEgypti.
t&fòìxitquoquerex adJoseph-, Ego sum Pha-rao: absque tuo imperionon movebit quisquammanum, aut pedem inomni terra AEgypti.
46- Verdtque nomenejus ..et vocavit eum lin-
rità sopra tutta la ter-ra d'Egitto.
4 a--E si levò dal suodito l'anello, e lo posein dito a lui : e lo fecevestire di una veste dibisso, e al collo gli poseuna collana d' oro.
43. E lo fece saliresopra il suo secondococchio, gridando Faraldo, che tutti piegas-ser le ginocchia dinan-zi a lui, e sapessero,come egli era soprin-tendente dì tutta laterra d'Egitto.
44- Disse ancora ilre a Giuseppe : Io sonFaraone : nissuno intutta la terra di Egittomoverà piede, o manofuori che per tuo co-mando.
45. E mutogli il no-me, e chiamolio in lin-
Vers. 4^ Sopra il suo secondo cocchio. Alcuni pretendono,che sia un cocchio che andava sempre dietro a quello, in cui erail re. Vedi 2. Parai, xxxv. 24. Altri intendono il cocchio desti-nato per la seconda persona del regno, come fu Mardocheo sottoAssuero; onde traducono l'Ebreo : il cocchio del secondo «orno,della seconda persona.
Yers. 44- Nissuno in tutta la terra d1 Egitto moverà ec. Iogiuro, dice Faraone, che i miei sudditi saranno talmente soggettia te , che non solamente nissuna resisterà a' tuoi comandi, manon vi sarà chi ardisca di far cosa d'importanza , se non sarà dituo piacimento e consenso,,
17 *

gua, aegyptìaca Salva-torem mundi. DeditqueUH uxorem Aseneth fi'llam PutipJiare sacer-dotis Helìopoleas. JE-gressus est itaque Jo-seph ad terroni AE-sypà-
4& (Triginta autemdnnorum erat, quan-do stetìt in conspectu
gua egiziana Salvatoredel mondo. E gli diedeper moglie A.seneth fi-gliuola di Putifare sa-cerdote di Heliopoli .Parti adunque Giusep-pe per visitare la terrad'Egitto.
4$. (Or egli aveatrent' anni, allorché fucondotto davanti al re
Ver». 45. Chìamollo ... Salvatore del mondo. E gli diede permoglie ec. Chi mai avrebbe pensato , che in un sol giorno Giu-seppe di schiavo sarebbe divenuto signore, di prigioniero viceré,ceibe in luogo della prigione dovesse abitar nella reggia, e daun' estrema ignominia salire ali' altezza suprema ? Ma tutto ciòanche meglio risplende nel vero Salvatore del mondo , il qualedopo tre giorni significati ne' tre anni della prigionia di Giusep-pe risorge da morte pieno di gloria, e in premio delle sue umi-liazióni riceve dal padre un' assoluta potestà in cielo e in terra,onde nel nome di lui si pieghi ogni ginocchio in cielo, in terrae nell'inferno; di lui costituito giudice de'vivi e de'morti, a cuiil Padre stesso dà una sposa, vale a dire, la Chiesa delle nazionisalvate col* merito de'suoi patimenti e della sua morte.
La fame e la mancanza d'ogni bene sarà fuori del paese, do-ve regna Giuseppe; ma i sudditi di lui viveranno, e a lui offeri-ranno in ricompensa tutti i loro beni. A lui correrà la famigliadel fedele Giacobbe, ed egli dopo essere stato riconosciuto eadorato Salvatore de'Gentili, riunirà finalmente al suo regno an-che i discendenti d' Abramo.
Figliuola di Putifare sacerdote di Helìopoli. Abbiam no-tato di sopra, che alcuni credono, che questo Putifare sacerdotedella città del sole possa essere lo stesso che il Putifare, in casaài cui fa servo Giuseppe. Tale fia il sentimento degli Ebrei, e«U Origene, e di ». Girolamo ; ma «. Agostino, il Crisostomo T emolti dtftti interpreti lo credeno differente. La città di Heliopo-Ji, cosi detta dal colto che ivi réndevasi al sole, di cui vi eranode'templi, avea un gran numero di sacerdoti, i quali erano con-siderati come i personaggi non solo i più dotti e saggi di tuttol'Egitto, -ma anche come i più nobili ; onde dal lor ceto ae fuinnalzato più A1 uno al regno. Cosi si vede, che fu grande l'ono-re fatto a Giuseppe in fargli sposare una figlia di uno di que' sa-cerdoti.

r*gis Pharaonìs)\ et cir-cuivlt omnes regionesAEgypti.
47. Vernicine fertili"tas septem annorum ;et in manipulos reda-ctae segetes congrega"tae sunt in horrea AE-gypti.
48. Omnis etiamfru~gum abundantìa in sin-gulis urbibus conditaest.
49. Tantaque fuit a-bundanùa tritici,ut are-nae mariscoae(juaretur%et copia mensuram ex-cederei.
50. (i) TJati sunt au-tem Joseph filii duoantequam -veniret fa*mes : quos peperit eiAseneth filia Putipìia-re sacerdotis Heliopo-leoS.
51. Vocavitque no~men primogeniti Ma»nasses^ dìcens: Oblivi-sci me fecit Deus o-
Faraone ) : ed ei fece ilgiro di tutte le provin-eie dell'Egitto.
4y. E venne la ferti-lità di sette anni : e igrani legati in manipo-li furono raunati ne*granai dell' Egitto.
48. Tutta ancor l'ab-bondanza delle biade-fariposta in ciaschedunadelle città.
4p. E tanto grandefu l'abbondanza delgrano» che uguagliò Tarena dei mare, e laquantità non potea mi-surarsi.
50. E nacquero aGiuseppe due figliuoliprima che venisse lacarestia, i quali furonoa lui partoriti da Ase-~neth figliuola di Putifa-re «aeerdote d'Helio-poli.
51. E al primogenitopose il nome di Manas-se, dicendo : Dio mi hafatto dimenticare di
(O Infr. 46. 20. 48. 5.
Vers. 4y- % granì legati in manìpoli ec. lì grano nella suaspiga si conserva meglio e più lungamente.
Yers. 51 ( Mantisse ; Colui clje fa dimenticare,

iruiìum laborum meo-rum , et domus patrismei.
02. Nomen quoquesecundi appellavit .E-pliraim^ dicens: Cresce-re me fecit Deus in ter»ra paupertatis meae.
63. Igitur trans actìsssptem ubertads annistquifuerant in AEgypto,
54- Coeperunt venirestptem anni inopiae ,f/uos praedixerat Jo-Jteph.etin universo orbefames praevaluit : incuncta autem terra AE-gypfi panis erat.
65. Qua esuriente,tlamavit populus adPìiaraonem, alimentapetens. Quibus ille re-spondit : Ite ad Joseph,et cjuidquid ipse vobisdixerit ,facite.
66. Crescebat autemquotidie fames in omniterra : aperuitque Jo-seph universa horrea, et\-endebat AEgyptiis ;
tutte le afflizioni sof-ferte in casa del padremio.
62. Al secondo poidiede ( i l nome di E-phraim, dicendo : 11 Si-gnore mi ha fatto cre-scere nella tèrra, doveio era povero.
63. Passati adunquei sette anni di ubertà,che erano stati nell'Egitto,
64. Principiarono avenire i sette anni dìcarestia predetti daGiuseppe, e la fame re-gnò per tutto il mon-do : ma in tutta la ter-ra di Egitto v'era delpane.
55. E quando gliEgiziani sentirono lafame, il popolo alzo legrida a Faraone, chie-dendo cibo. Ed egli ri-spose loro : Andate daGiuseppe, e fate tuttoquello ch' ei vi dirà.
66. Or la fame cre-sceva ogni dì più intutta la terra : e Giusep-pe aperse tutti i granai,e vendeva agli Egiaia-
Yers. 3-},. Epfiraiin: Un clic fruttifica, che cresce.

nam et illos oppresse-rat fames.
67. Omnesqueprovin-ciae veniebant in AE-gyptum, ut emerentescas, et malum mo-piàe temperarent.
ni ; perocché sì trova-vano aneh' essi alla fa-me.
67. E venivano tullele provincia in Egiltoa comprar da mangiare,e trovar sollievo ai ma-le della carestia.
C A P O XLIL
/ fratelli di Giuseppe strettì, dalla fame sonomandati dal padre in Egitto a comprare deviveri ; e sono da lui riconosciuti , e trattatiduramente , e messi in prigione. Finalmentelasciato Simeone in carcere^ si partono., e sen-za saperlo riportano ciascuno nel suo saccoil denaro insieme col grano.
\.jnLudiens autemJacob, quod alimentavenderentur in AEgy-p to.dixit filiis suis: Qua-re negligiti ?
2. Audivi, quod tri-deum venundetur inAEgypto: descendite^ etemite nobis necessaria,ut possimus vivere , etnon consumamur ino-pia.
1. Irla Giacobbe a-vendo udito, che si ven-deva da mangiare in E-gitto, disse a' suoi fi-gliuoli : Perchè state aguardarvi in viso ?
2. Ho sentito dire ,che si vende grano inEgitto : andate, e com-prate quello che ci bi-sogna, affinchè possiamvivere, e non siani con-sunti dalla fame.
Vers. i.* Giacobbe avendo udito. Ebr. Avendo veduto. Nonè però necessario supporre, come ad alcuni piacque, per rivela-zione divina, '

3. Descendentes igi-tur fratres Joseph de-cem , ut emerent fru?menta in AEgypto,
^.Beniamin domi re-temo a Jacob, qui dixe-ratfratribus ejus, neforte in itinere quid-(juam patiatur moli*
5. Ingressi sunt ter-tam AEgypti cum aliisquipergebant ad emen-dum. Erat autem farmes in terra. Chanaan.
6. Et Joseph eratprinceps in terra AE-gyptit atque ad ejus nu"tum /rumenta populisvendebantur. Cumqueadorassent eum fratressui,
7. Et agnovisset eos,quasi ad alienos du-rìus loquebatur, inter-rogans eos : Unde veni*stis? Qui responderuntiDe terra Chanaan, ut
3. Andarono adunquedieci fratelli di Giusep-pe in Egitto a compra*re del frumento,
4. Essendosi Giacob-be ritenuto Beniamin acasa, avendo detto aisuoi fratelli, che nongli succeda qualche dis-grazia nel viaggio.
6. Entrarono nellaterra di Egitto con al-tra gente, che andavaa comprare. Perocchénella terra di Chanaanera la fame.
6. E Giuseppe domi-nava in Egitto, e a pia-cimento di lui si vende-vano a' popoli 3e biade.E i suoi fratelli avendo-lo adorato,
7. Ed egli avendoliriconosciuti, parlava lo»ro con qualche durezza,come a stranieri, inter-rogandoli: D'onde sietevenuti? Risposero : Bai-
Vera. 6, S i tuoi ffi&tellì avendolo adorato. Così questi fra-telli cominciano a verificare senza saperlo i sogni del loro fratello,
* Giuseppe dominava in Egitto. Se non si sapesse, che lastoria tutta de'patriarchi è profetica, regolata cioè straordinaria-mente da'Dio, ci farebbe sorpresa il vedere Giuseppe per queidieci anni che signoreggiava in Egitto, niente sollecito di procu-rarsi notizie dell* amato suo padre.

emamas vicini neces*saria.
8. "Et tamen fratresipse cognoscens, nonest cognitus ab eis.
9. ìtecordatusque so*mniorum, quae aliquan-do vìderat, alt ad eos:Exploratores estìs: utvideatis infirmiora ter-raet venistis.
10. Qui dixerunt:Non est ita, domine', sedservi fui venerunt > utemerent cibos.
11. Omnes filii uniusviri sumus\ pacifici ve»nimus, nec quidquamfamuli tw machinan-t&r mali,
12. Quibus ille r&~spondit: Aliter esk im-munita terrae hujusconsiderare venistis.
13. At illi : Duode-cim, inquiunt, servi tui,fratres sumus, filii viri
la terra di Ghana à n percomprare quello che cibisogna per -vivere.
8. £ riconoscendo e*gli i fratelli, non fu pe-rò da essi riconosciuto.
9. E rammentandosii «ogni veduti una vol-ta, disse loro : Voi sie-te spioni: e siete venu-ti a riconoscere i luoghimen forti del paese.
10. Dissero quelli:Signore, non è così ^ma i tuoi servi sono ve-nuti a comprar da man*giare.
11. Siamo tutti fi»gliuoli di uno stessouomo: siam venuti abuon fine, e nissun ma-le tramano i frervi tuoi.
12. Rispose loro : Lacosa è ben diversa : sie-te venuti ad osservarei luoghi di_ questo pae-se men fortificati.
13. Ma qudK: Siamo,dissero , noi tuoi servi,dodici fratelli, figliuoli
Vers. g. Voi slete spioni. Giuseppe parla così per provare ifratelli, e per condurli passo passo a dargli nuova del padre edel fratello rimaso a casa ; onde benché egli sappia, che i fra-telli non sono spioni, dimostra che tali li crederàt se non dannobuon conto dell'esser loro. Piccola mortificazione rispetto a quel-lo che essi avean fatto verso di lui,

unius in terra Chanaan:mìnimus cum patre no-stre est, alius non estsuper.
i^.Hoc est, alt, quodlocutus sum: Explora-tores estis.
15. Jam nunc expe-rìmentum vestri ca-piami per salutem Pha-raonis non egrediemi-ni hinc, donec vernaifrater vester mìnimus.
16". Mittìte ex vobisunum^ et addueat eum:vos autem eritis in vin-cvlis, donec probentur,quae dixisds^ utrum ve-ra , an falsa sint : alio-quin per salutem Pha-raonis exploratores e-stis.
d'uno slesso uomo nel-la terra di Ghanaan : ilpiù piccolo è con nostropadre, l'altro più non è.
i4- La cosa, diss'egli,è come ho detto : Sietespioni.
15. Io fin d'adesso vimetterò alla prova : perla salute di Faraone voinon partirete di qua ,fino a tanto che vengail fratello vostro piùpiccolo.
16. Mandate uno divoi, che qua lo condu-ca : e voi starete in ca-tene , fino a tanto chesia manifesto, se vero ofalso sia quello che ave-te detto : altrimenti voiper la salute di Faraonesiete spioni.
Vers. 14. e 15, La cosa ... è, come ho detto: Siete spioni, ec.Voi dite che siete dodici fratelli figliuoli di un solo padre, e cheun piccol fratello è restato a casa e P altro morì. Io non credonulla di tutto questo, se voi non mi fate toccar con mano la ve-rità. Andate e menatemi quel fratello piccolo che dite essere re-stato a casa. Cosi ( dice il Crisostomo ) volea assicurarsi, ch'einon avessero trattato il secondo figliuolo di Rachele, come aveantrattato il primo.
Vers. 16. Per la salute dì Faraone. Alcuni in queste parolericonoscono una veemente affermazione e asseveranza piuttostoche un giuramento ; ma quand' anche elle contenessero nn verogiuramento, potè Giuseppe giurare per la salute di Faraone suobenefattore, e cui dovea tutto il rispetto e 1' amore , venerandanella creatura il Creatore, da cui Faraone avea ricevuto la realpotestà, e tutta la sua grandezza. Cosi Gesù Cristo c'insegna,che chi giurava pel cielo, per la terra, ec- secondo il comune

17. Tradidit ergo il-los custodiae tribus die-bus..18. Die autem tertia
eductis de carcere, aitiFacile, quae dixit etvivetis : Deum enim ti-meo.
19. Si pacifici estiS)frater vester unus lige-tur in carcere: vos au-tem abite, et ferie fru-mentat quae emistis, indomos vestras ,
20. (i) Et fratremvestrum minimum adme adducile, ut pos-sint vestros probare ser-mones^ et non morìa*mini. FeceruntyUt dijce-rat,
21. Et loculi sunt adinvicem:Merito haecpa-
17. Li fece adunquemettere in prigione pertre giorni.
18. E il terzo giornofattigli uscir dalla car-cere, disse : Fate quelloche ho detto , e saretesalvi: perocché io temoDio.
19. Se avete buoneintenzioni, uno di voifratelli stia legato inprigione: e voi allriandate, e portate il fru-mento , che avete com-prato , alle vostre case,
20. E conducetemi ilvostro fratello più pic-colo , affinchè io possaesser chiarito di quelche dite , e non siatecondannati a morire.Fecero, com' egli aveadetto,
21. E si dissero l'unoali' a&ro : Con ragione
(,) Infr. 43. 5.
uso delle nazioni e l'intemione di chi facca tal giuramento, giu-rava pel loro Creatore, Malth. xxxui. 21. I Martiri di Gesù Cri-sto soffrirono la morte piuttosto che giurare pel genio degl' im-peratori idolatri ; ma la ragione si fu, perchè un tal giuramentoveniva a riconoscere una specie d' idolatria, mentre faceasi lostesso giuramento per l'imperatore, come per un dio. Ma nissu-no ha finora immaginato, che fosse ne'tempi di Giuseppe unatal frenesia ne'principi d'Egitto di aspirare agli onori divini. Si-mili giuramenti si trovano, i. Reg. i. 26., xvu, 55., WLY» 26.

tìmur,quia pecc&vimusiji/ratrem nostrum, vi"dentes angustiam ani-mete illius, dum depre-cnretur nos, et non au-divimus: idcirco venitsuper nos ista tribula-tio.
22. E quibus unusRu&en, alt: Numquidnon dixi vobis-, (i) No*lite peccare in puerum:et non audistis me? ensanguis ejus exquiri-tur.
23. Nesciebant au~tem , quod inteUigeretJoseph: eo quod per in»terppetem loquereturad eos.
soffriamo questo, per-'chè peccammo controil nostro fratello, ve-dendo le angustie delsuo cuore mentr' ei cipregava , e noi non a-scoltammo : per questoè venuta sopra di noitribolazione.
2 2. Uno diessi Ruben,disse : Non vel diss'io:Non peccate contro ilfanciullo : e voi non mideste retta ? ecco chedel sangue di lui si favendetta.
23. E non sapevanodi essere intesi da Giu-seppe ; perocché questiparlava loro per inter-prete.
(i) Sup. 3y. *2.
Vers. ai i--Con ragione soffriamo questo. Osserva s. Gregorio,che la pena apre gli occhi che avea chiusi la colpa, E il Cri-sostomo: Come un ubriaco quando si e caricato d'i mollo vi-no, non sente alcun ìnule, ma lo sente di poi; così il peccato,Jìno a tanto che sia consumato, quasi densa calìgine, ottene-bra, la mente ; ma dipoi si leva su la coscienza, e più cru-damente dì qualsisia accusatore rode la mente, mostrandol'indegnità del mate, che si e fatto. Notisi, che eran già corsiveutidue o ventitré anni dal tempo, in cui era stato vendutoGiuseppe ; contuttociò non aveano potuto ancora scordarsi del-l'atroce delitto.
Vers. a3. Parlava loro per interprete. Non si vede, che i fi-gliuoli di Giacobbe avester -bisogno d'interprete per essere inte-si dagli Egiziani ; ma Giuseppe o per grandezza, o piuttosto per-chè i.fratelli no) riconoscessero alla voce, o alla pronunzia, par-lava loro per via d'interprete.

^.Avertitque se pa-rumper, etflevit: et re-versus locutus est adeos.
26. Tollensque Si"meon , et lìgans illispraesendbus•, jussit mi"nistris, ut implerent eo-rum saccos tritico, etreponerent pecuniassingulorum in sacculissuis, datis supra ciba-riis in viam : qui fece-rint ita.
26. At illi portantes/rumenta in asinis suistprofecti sunt.
27. Apertoque unussaeco, ut daretjumentopabulum in éwersorio^co72templatu$ pecuniamin ore s acculi,
28. Dixit fratnbussuist Reddita est mihipecunia, en habetur insacco. Et obstupefacù,turbatique mutuo dixe-runti Quìdnam est hoc,quod fecit nobis Deus?
24* Ed egli si volseper un poco in altraparte , e pianse : e tor-nò , e parlò con essi.
26. E fatto pigliare ,e legare Simeone sottode' loro occhi, ordinò aiministri, che empisserdi grano le loro sacca ,e rimettessero il denarodi ciascheduno nel suosacco, dando loro di piùde'viveri pel viaggio : equelli fecer cosi.
26. E quelli portan-do sopra i loro asini ilgrano, se n* andarono.
27, E avendo uno diloro aperto il sacco perdar da mangiare al suoasino all'albergo, osser-vando il denaro alla boc-ca del sacco,
«8. Disse a' suoi fra-telli: Mi è sialo rendu-to il denaro, eccolo quinel sacco. E stupefatti,e turbati dissero is unoall'altro: Che è maiquello che ha Dio fattoa noi ?
Vers. 2 5. E fatto pigliare , e legare Simeone ec. Egli doveaessere stato uno de' più fieri persecutori di Giuseppe ; ma si puòanche credere di Giuseppe, che dopo questa dimostrazione dirigore trattasse Simeone eoa tutta la maggior carità. ^^^

29- yeneruntque adJacob patrem suum, interram Chanaan, etnarraverunt ei omnia)quae accidissent sibi^dicentes:
3o. Locutus est no-bis\ dominus terrae du-re, et putavit nos ex-ploratores esse provin-tiae.
Si.Cui respondimus\Pacifici sumus, nec ul-las molimur insidias.
3 2. Duodecimfratresuno p atre geniti sumus:unus non est super, mi"nimus cum patre no-stro est in terra Cha-riaan.
35. Qui ait nobis :Sic probabo, quod pa-cifici sitis: Fratrem ve-strum unum dimitdteapud me, et cibaria do-mibus vestris necessa-ria sumitet et abitei
34. Fratremque ve-strum minimum addu-cile ad me, ut sciam,quod non sitis explo-ratorés , et istum , quitenetur in vinculis , re-
zg. E giunsero a casadi Giacobbe loro padrenella terra di Ghanaan,e a lui raccontaronotutto quello che era lo-ro avvenuto, dicendo:
30. Il signore diquella terra ci ha par-lato con durezza, e hacreduto, che andassimoa spiare pel paese.
31. Gli abbiam rispo-sto : Noi siamo uominidi pace, e non macchi-niamo nulla di cattivo.
32. Siam dodici fra-telli nati tutti di unistesso padre : uno piùnon è : il più piccolo ècon nostro padre nellaterra di Chanaan.
33. Quegli ci ha det-to : Mi chiarirò in que-sto modo» se voi sieteuomini di pace : La-sciate presso di me unvostro fratello, e pren-dete quel che bisognadi viveri per le vostrefamiglie, e partitevi :
34. E conducete ame il fratello vostro piùpiccolo onde io cono-sca, che non siete spio-ni , e voi ricuperiatequello che rimane in

cipere possi tis\ ac dein-cepsì quae vultis> emen-di habeatis licentiam.
35. His dictis, dumfrumenta effimderent,singuli repererunt inore saccorum ligataspecunias, exterritisquesimul omnibus,
36. Dixit pater Ja-cob-. Absque ìiberis meesse fecistis; Josephìion est super, Simeontenetur in vinculis, etEeniamin avferetis: inme haec omnia malareciderunt.
37. Cui respondit Ru-teni Duos filios meosinterface, si non redu-xero illum tibi : frodeillum in manu mea> etego eum tibi restituam.
38. At ille : Non de-scendet, inquit, filiusmeus vobiscum-.fraterejus mortuus est., et
prigione; e abbiate dipoi permissione di com-prare quello che vor-rete.
35. Delle che ebberoquesle cose , votando igrani, trovò ognuno diloro rinvolto il denaroalla bocca del sacco: edessendo tulli fuori disé,
56. Disse il padreGiacobbe : Voi m'avetecondotto ad essere sen-za figliuoli ; Giuseppenon è più , Simeone èin catene, e mi torreteBeniamin : sopra di mericadono tutte questesciagure.
07. Rispose a lui Ru-ben: Uccidi due dej
miei figliuoli, se io nonlo riconduco a te : con-segnalo a me, ed io telo restituirò.
38. Ma quegli: Nonverrà, disse, il mio figliocon voi : suo fratello simorì, ed egli è rimaso
Vers. 35. Essendo tutti fuori di se. Eglino avean già trovatoil denaro alla bocca del sacco di ciascheduno , come si vedecap. XLIU. 2. ; ma probabilmente non vollero far conoscere al pa-dre d'essersene accorti prima, perchè ei non gli sgridasse di nonaverlo riportato a chi avea dato loro il grano : quindi dimostranodi restarne sorpresi e sbigottiti. •

ipse solus remansit : siquid ei adversi accide*rit in terra, ad quampergitis, deducetis ea-nos meos cum doloread in/eros.
solo : se alcuna cosa av-verrà di sinistro a luinella terra , dove anda-te, precipiterete col do-lore nel sepolcro la miavecchiaja.
C A P O XLIII.
I fratelli dì Giuseppe con gran pena ottengonodal padre, che ritornando in Egitto con donite col doppio del denaro^ vada con essi ancheBeniamino. Sono invitati a un convito , e trai"tofuor di prigione Simeone, banchettano tutti,con Giuseppe.
\.Mnterimfdmes o-mnem terram vehemen-ter premebat.
a. Consumptisf/ue ci-bis, quos ex AÉgyptodetulerant, dixit Jacobad filios suosf. Reperti-mini, et ernìte nobispauxìllum escarum.
3. Respondit Judas :Denuntiavit nobis virille sub attestatione ju*Pisjurandì, dicensiìtonvi&ebitis faciem meam,nisi fratrem vestrumminimum adduxerìtisvobiscum,
4- Si ergo vis eummittere nobiscum, per-
1. J. rattanlo la fa*me vessava crudelmen-te tutta la terra.
2. E consumati i vi-veri , che aveano porta-ti d'Egitto, disse Gia-cobbe a'suoi figli : Tor-nate a comprarci qual-che poco da mangiare.
3. Rispose Giuda:Queli' «orno e' intimòCon giuramento, dicen-do i Non vedrete la miafaccia, se non menatecon voi il fratello vostropiù piccolo.
4- Se adunque tuvuoi mandarlo con noi,

gemaó pariter , et eme-mas libi necessaria*.
5. Sin autem non vis,non ibimus : vir enim,ut saepe diximus, de-nuntìavit nobis, di»censi (i) Nonvidebitìsfaciem meam absquefratre vestro minimo.
6. Dixit ei Israeli Inmeam hocfecisds mi"seriam, ut indicaretisei, et alium habere vosfratrem.
7. At illi responde*r»nk Interrogavit noshomo per ordinem no*$tr&f$pj*ogemem: si po*ter vìvèrQfri #i habere»m^fratréffii Wn&0 re*spondimuf -et' Ctonse*quenter juxta idt (jnodfueratsciscitatusi num*quid scire poteramus^quod dicturus esset: Ad-ducite fratrem vestrumvobiscumt
8. Judas quoque di-xit patri suo : Mit-te puerum mecum, utprqficiscamurt et possi-mus vivere, ne morìa"
anderemo insieme, ecompreremo quello cheti bisogna :
6. Se tu non vuoi,non andremo : perchèquell'uomo, come ab-biam detto più volte, ciha intimato, e ha det-to : Non vedrete la miafaccia senza il fratellovostro più piccolo.
6. Disse a lui Israe-le : Per mia sventuraavete fatto sapere a co-lui, che avevate ancoraun altro fratello.
7. Ma quelli rispose»ro : Quell'uomo c'inter-roga per ordine intor-no a tutta la nostra stir-pe : se il padre era vivo :se avevamo altro fratel-lo ; e noi gli risponde-vamo a tenore dellesue ricerche : poteva-mo noi sapere, ch'ei fos-se penlto^rCoìidaoetecon voi il vostro ire*tello ?
8. Disse ancor Giudaa suo padre : Manda conme il fanciullo, affinchèpartiamo, e possiamosalvar la vita, e non
4*} Sitp, 4^. 20.

mur nost et parvuli no»s tri.
9. '(O Ego suscipiopuerum: de manu mearequire illum: nisi re-dux ero , et reddìderoeum tibi, ero peccatireus iti te omni tem~pore.
10. Si non interces"sisset dìlatìoyjam, vicealtera venissemus*
11. Igitur Israel po-ter eorum dixit ad eos:Si sic necesse est ,./#-citet quod vultìs : sumi-te de optimis terraefructàbus in vasis ve~stris ; et deferte viromunerat modicum resi-nae, et mellis, et sfarà*ciS) stactes , et terebin-thit et amygdalarum.
12. Pecuniam quo-que duplicem ferte vo-bisc,um\ et illam, quaminvetiistis in s acculisi
mojamo noi, e i nostripargoletti.
9. Io entro malleva-dore pel fanciullo : fam-mene render conto ss'io noi riconduco, e noirendo a te, sarò persempre reo di peccatocontro di te.
10. Se non fossimostati a bada , saremmogià ritornati la secondavolta.
11. Disse adunquead essi il padre loroIsraele: Se bisognatosi,fate quel che volete :prendete nehrostri va-si de'frutti più lodatix
di questo paese ; e por-tategli in dono a queli'uomo, un po'di resina,e di miele , e dello sto-race , e della mirra, edel terebinto, e §dellemandorle,
la.Portateunche convoi il doppio del dena-ro; e riportate quelloche avete trovato ne'
0) jiiifr 44- 32.
Vers. 8. Manda con me il fanciullo. Gli Ebrei davano al fi-gliuolo minore il nome di fanciullo senza badare all'età. Benia-min avea ventiijualtro anni.

reperiate^ ne forte erro-refactum sit.
13. Sed et fratremvestrum tolìite^ et Ite advirum.
\[±.J)eus autem meusomnipotens faciat vo-bis eum placabilem3 etremittat vobis cum fra-treni vestrum quem te-net , et hunc Beniamin.Ego autem quasi orba-tus absque liberis ero.
15. Tulerunt ergoviri munera, et pecu-niam duplicem, et Be*niamin, descenderunt-que in AEgyptum, etstete funicoram Joseph.
16. Quos cum ille vi~disset) et Beniamin si-mal, praecepit dispen-satori domus suae, dircens: In troducviros do-mum , et occide vieti-mas , et instrue convi-vium : quoniam meciimsunt comesturi meridie.
sacchi, che forse nonsia stato sbaglio.
13. Ma prendete an-cora il vostro fratello ,e andate a trovar queli'uomo.
i4- E il mio Dio on-nipotente vel rendapropizio, e rimandi convoi quel vostro fratello,che ha nelle mani, equesto Beniamin. Iopoi sarò come uomo ri-maso privo di figliuoli.
16. Presero adunquequegli i doni, e il dop-pio del denaro, e Benia-min, e calarono in Egit-to, e si presentaronoa Giuseppe.
16. E quegli avendo-gli veduti , e insiemecon essi Beniamin, die-de ordine al suo mae-stro di casa, dicendo :Conduci costoro in casa,e uccidi le vittime, eprepara il convito : pe-rocché questi mange-ranno a mezzogiornocon me.
Vers. 12. * Portate — doppio del denaroso perchè bramasteclic si facessero provvisioni maggiori, o perchè temesse, che rin-cresciuto fosse il prezzo de' viveri.
Vers. 16. Uccidi le vittime, e prepara ec. Vittime sono quidetti, come in altri luoghi, gli ammali uccìsi per farne baucliet-% Pent.rol.1. 18

17. Fecit illet quodsibifuerat imperatimi,et introduxit ciros do-munì.
18. "Ibique exterritidixerunt' mutuo; Pro-pter pecuniam, quamretulimus prius in sac-eis nostris, introductiburnus: utdevolvat innos calumniam, et vio-lenter subjiciat servitu-tì et nos\ et asinos no-stros.
i p, Quamobrem inIpsis foribus acceden-tes ad dispensatoremdomus,
a o. Loculi sunt: ora-mus, domine> ut audiasnos. (i) Jam ante de*3cendimus, ut emere-mus escasi
21. Quibus emptis,cum venissemus ad di-
17. Fece egli quelloche gli era stato impo-sto , e condusse colorodentro la casa.
18. Ed ivi pieni dìpaura dicea n tra di lo-ro : Per ragion del de-naro , che riportammogià ne' nostri sacchi,siam condotti qua dén-tro : volendo egli ag-gravarci con questa ca-lunnia per ridurre vio-lentemente in ischiavi-tù noi, e i nostri asini.
19. Per la qual cosasulla stessa porta si ac- •costarono al maestro dicasa,
20. E dissero : Tipreghiamo, signore, ch,eci ascolti. Siam già ve-nuti altra volta a com-prar da vivere :
21. È compratone,giunti che fummo allo
fij Sup. 42. 3.
lo. Ma dee riflettersi, che presso gli Ebrei anche prima dellalegge 11 sangue degli animali, che si uccidevano, era riserbatoal Sigaofe, Gen. ix. 4» 5. Quindi il motivo di dar il nome di vit-tima agli animali scannati per uso anche domestico. Nella leggepoi fu comandato, che si conducessero alla porta del taber-nacolo le bestie 7 che -uno volea ammazzare per mangiarle,Levìt. xvir. 5. 6. <j.
Vera. 18. Noi, e i nostri asini. Gli antichi contavano nella fa-miglia i più utili animali'domestici. Così Esiodo mette ih mazzocolla moglie e'1 marito il bue aratore.

versonum aperuimussaccos nostros ) et inve-nimus pecuniam in oresaccorum, quam nunceodem pondere repor-tavìmus.
22. Sed et aliud at-tulimus argentum , utemamus , quae nobisnecessaria sunt : nonest in nostra conscien-tia quis posuerit eamin marsupiis nostris.
23. At ille respondit:Pax vobiscum, nolite
* timer ei Deus vestert etDeus patris vestri de-dit vobis thesauros insaccis vestris : nam pe-cuniam quam dedìstismihi, probatam ego Tia*beo . Éduxltgue &d eosSimeon.
a 4- Et introductadomum, attulit aquam^
albergo aprimmo i no-stri sacchi, e trovammoil denaro alla bocca deisacchi, il quale abbiamoora riportato dello stes-so peso.
22. E abbiamo ancorportato altro denaroper comprare quelloche ci bisogna : noi nonsappiamo chi rimettes-se quello nelle nostreborse.
23. Ma quegli rispo-se : Pace con voi, nontemete : il vostro Dio,e il Dio del padre vo-stro ha posti que'tesorine'vostri sacchi, peroc-ché il denaro, che destea me, lo ho io in buonamoneta. E condusseglia veder Simeone.
,24. Ed entrati chefurono nella casa, portò
Vers. 22. Nelle nostre borse. Dal versetto 35. del capo prece-dente, e da questo luogo intendiamo, come 1' argento, o sia de-naro contavasi a borse, come si fa anche oggi in Levante, e chein tante borse avean pagato i figliuoli di Giacobbe il grano com-prato, e queste borse tali quali furon rimesse ne'loro sacchi; on-de dove la Volgata ha ligalas pecunias, che si è tradotto il de-naro rinvolto, si potrebbe tradurre il denaro imborsato, il de-naro nelle borse. Di queste borse è fatta menzione in Aggeo,ea/?. 1.6.
• Vers. 9,3. Il denaro, che deste a me, lo ho io ec. Io ricevei ilvostro denaro, e benché ve l'Abbia renduto, lo tengo per pagatoa me lealmente.

et laverunt pedes suos-,deditque pabulum asi-nis eorum»
zò.Ilti veroparabantmunera, donec ingre-deretur Joseph meridie',audierant enim, quodibi comesturi essentpanem.
26. Igitur ingressumest Joseph domumsuam., obtuleruntque eimunera, tenentes inmanibus suis et adora-verunt proni in terram.
27. At ille dementarrescdutotis eis, interro-gaviteos dicens\S alvusne est pater vester se-nex, de quo dixeratismihi? adhuc viviti
28. Qui responde-runt: Sospes estservustuus pater noster ; ad-irne vivit. Et incurvati,adoraverunt eum.
29. Attollens autemJoseph oculos vidit Be-niamin Jratrem suumuterinum,) et aiti Isteestfrater vester parvu-lus, de quo dixeratismihi?Et rursum\ Deus,
dell'acqua, e lavarono iloro piedi , e diede damangiare a'ioro asini.
26. Ed eglino appron-ta vano i regali,per quan-do fosse venuto Giusep-pe a mezzo giorno : pe-rocché avevano udito,come ivi doveano man-giare.
26. Entrò dunqueGiuseppe in casa sua,e quelli offerirono a luii doni, presentandolicolle loro mani, e loadorarono inchinandosifino a terra.
27. Ma egli, rendutoloro benignamente il sa-luto, gl'interrogò dicen-do : II yecchio padrevostro , di cui mi par-laste, è egli sano ? viveegli ancora ?
28. Risposero : Stabene il tuo servo il pa-dre nostro ; ei vive tut-tora. E incurvatisi loadorarono.
&g. Ma Giuseppe al-zati gli occhi vide Be-niamin suo fratello ute-rino , e disse : È egliquesti il fratel vostropiù piccolo , di cui miavevate parlato ? E sog-

inquit^ misereatur lui,fili mi.
30. Festinavitque,quia commota fyerantviscera ejus super fra-tré suo, et erumpebantlacrimae : et introienstubiculum fievit.
31. Rursumque Iotafacie egressus conti-nuit setetait:Ponitepa-nes.
32. Quibus apposidsseorsum Joseph, etseorsumfratribus, AE-gyptìis quoque, qui ve-scebantur simul, seor-sum (ilUcitum est enimAEgyptiìs comederecum Hebraeis, etpro-fanum putant hujusce-modi convivium)
33. Sederunt corameo, primogenita juxta
giunse: Abbia Dio mi-sericordia di te, figliomio.
3o.E in fretta si riti-rò, perchè le viscere dilui si erano commossea causa del suo fratello,e gli scappavano le la-crime: ed entratogli ca-mera pianse.
31. E di poi lavatosila faccia venne fuora, esi fè'forza, e disse : Por-tisi da mangiare.
32. E imbandita chefu la mensa a parte perGiuseppe ed anche aparte per gli Egiziani,che mangiavano insie-me, e a parte pe' fratel-li ( perocché non è le-cito agli Egiziani dimangiar cogli Ebrei, eprofano credono tal con-vito ),
33. Sederono alla de-stra di lui, il primoge-
Vers. 3a. Non e lecito agli Egiziani dì mangiar cogli, EbreiSi sa, che gli Egiziani fuggivano di mangiare co' forestieri in ge-nerale ; onde non è meraviglia, che credessero illecito di man-giar cogli Ebrei. Tra le varie cagioni, che sogliono addimi diquesta loro ripugnanza, crederei che la più vera fosse il sapersidagli Egiziani, che le altre nazioni mangiavano di continuo certianimali^, e altre cose7 dalle quali si asteneva tutto 1' Egitto , chele adorava come tante divinità. Quindi la generale proibizionedi mangiare colle altre nazìonj riguardate da essi come impare,€ sprewatrici de' loro dei.

primogenita sua, etminimus juxta aetatemsuam. Et mìrabanturnimis,
34. Sumptàs partibus,quas ab eo acceperant:majorque pars venitBeniamin, ita ut quin»que partibus excederet*Biberuntqueì etinebrìa-ti sunt cum eo.
nito secondo la suamaggioranza , e il piùpiccolo secondo la suaetà. E restavano mara-vigliati oltre modo,
34-Ricevendo le por-zioni , che eran loromandate da lui : e laporzione maggiore,cheera cinque volte piùgrossa fu per Beniami-no. E bevvero, e si esi-lararono con lui.
Vers. 33. Restavano maraviglìatì ec. L'ordine, col quale era-no stati fatti «edere ciascuno secondo la sua età, e 1' umanità diGiuseppe, e il cangiamento grande di scena li tenea auasi fuo-ri di sé. • .,
Vers. 34. Ricevendo le porzioni... la porzione maggiore, ce.Giuseppe mandò ad ognuno de'fratelli la porzione secondo l'usodi que' tempi. Ne'conviti generalmente davansi da colui, che erail capo di tavola, le porzioni uguali a ciascuno de' convitati ; maatte persone di maggior conto si dava la porzione più grossa. Co-si fece Giuseppe riguardo a Beniamino.
Bevvero, e ti esilararono. Letteralmente *' inebriarono ;ma dee intendersi nel modo, che abbiamo tradotto, perchè nonpuò supporsi veruna intemperanza ne' fratelli, che mangiavanoin un tal luogo, e dinanzi a un signore cosi grande non conosciu-to pel loro fratello, e in tali circostanze. Nello stesso senso èusato il verbo inebriarsi in altri luoghi della Scrittura. VediCant. v. i. 4gg. i. 6., Joan. xi. io.

C A P O XLIV.
Giuseppe comanda, che la sua coppa sia nasco-sta nel sacco di Beniamin : e ài poi fattalatrovare , affratelli fatti tornare indietro rim-provera il furto. Ma Giuda si offerisce ad es*sere schiavo in luogo di Beniamin*
1. JLraecepit autemJoseph dispensatoti do-mus suae, dicens : Im-pie saccos eorum fru*mento, quantum possuntcapere ; et pone pecu*niam singulorum insummitate sacci.
2. Scyphum autemmeum argenteum, etpretiam, quod dedit tri-tici i pone in ore saccijunioriSé Factumcjue estita.
3. Et orto matte, di?missi sunt cum asinissuis.
4 J inique urbeexie-rant, et processerai
1. vyomandó poiGiuseppe al suo mae-stro di casa , e disse :Riempi i loro sacchi digrano, quanto possoncapirne ; e il denaro diciascheduno mettilo al-la bocca del sacco.
2. E la mia coppad'argento col prezzodato pel grano metfilain cima del sacco delpiù giovine. E così fafatto.
3. E venuto il^ matti-nò, furon lasciati parti-re co' loro asini.
4» Ed éran già uscitidalla città, e aveanfat-
Vers. 2. Mettila in cima del tacco del più giovine. Volle conquesto Giuseppe venir in chiaro , se i fratelli amassero veramen-te Beniamino, ovvero gli portassero invidia particolarmente dopola parzialità , ch' egli avea dimostrata verso di lui nel convito. Aquesto fine potè egli recare un breve travaglio a Beniamino , il
rie noi meritava ; e a questo fine ancora mostrò di credere ,i fratelli avesser rubata la coppa. Quindi s. Agostino stessa
pretende, non essere stata veruna menzogna nelle parole fattedire dal maestro di casa a' fratèlli,

paullulum: tunc Joseph,accersito dispensatoredomus : S urge , inquit,et persequere viros , etapprehensis dicito :Quare reddidistis ma"lum pro bono ?
5. Scyphus, quem fu-rati estis , ipse est, inquo bibit dominus meus,et in quo augurari so-let : pessimam rem fe-ci s tis.
6. Fecit ille, ut jus se-rat. Et apprehensis perordinem locutus est.
7. Qui responderuntiQuare sic loquitur do-minus noster, ut servitui tantum fiagitii com-miserint?
8. Pecuniam quam in-venimus in summitate
io un po' di strada , al-lorché Giuseppe chia-mato a se il maestro dicasa : Su via , disse, vadietro a coloro, e rag-giuntili dirai ; Per qualmotivo avete rendutomale per bene?
6. La coppa, che ave-te rubato, è quella, al-la quale beve il signormio, e colla quale è so-lito di fare gli augurii :pessima cosa avete voifatto.
6. Eseguì egli il co-mando. E raggiuntiliripetè parola per parola.
7. Risposer quelli :Per qual motivo cosìparla il signor nostro,quasi i tuoi servi aves-ser commessa sì gran-de scelleraggine ?
8. Il denaro ritrovatonella cima de'sacchi noi
Vera. 5. Colla quale è solilo dì fare gli augurii. E stato giàosservato da varii interpreti, che la parola augurio, e augurarenon tempre significa indovinamento magico, e superstizioso. Tut-ti sapevano, che Giuseppe era stato innalzato al posto , in cui sitrovava, p«r la sua perizia e virtù nell'interpretare i sogni, epresagire il futuro. Giuseppe, il quale non era ancor tempo, chesi facesse conoscere a'fratelli, fa dire ad essi, che la coppa, chehanno rubata, era quella usata da lui, allorché dovea interpreta-re alcun sogno , facendo con essa delle libagioni a Dio. Questasposizione mi sembra assai chiara ; e certamente Giuseppe nouvolea neppur per giuoco farsi credere mago , o incantator egiziano,

saccornmìreportavimusad te de terra Chanaan : 'et quomodo consequensest, ut furati simus dedomo domini tui aurum,vel argentum ?
9. Apudquemcumquefuerit inventum servo-rum tuoriim, quodquae-rìs, moriafur. et nos eri^mus servi domini no»atri.
i o. Qui dixit eis iFiat juxta vestram sen»tendami apud quem,"cumque fuerit inven-tum , ipse sit servusmeus ; vos autem eritisinnoxiì.
11. Itaque festinatodeponentes in terramsaccoS) aperuerunt sin-guli.
12. QÌIOS scrutatasiindpiens a majore us-que ad minimum, inve-nit scyphum in saccoBeniamin.
13. At illi, scissi^vestibus, oneraùsquerursum asinis, reversisunt in oppidum.
14« Primusque Judascunìfratriltus ingressusest ad Joseph {necdurn
lo riportammo a te dal-la terra di Ghanaan : ecome dopo di ciò fia vé-ro, che noi abbiamo ru-bato di casa del tuo pa-drone oro , o argento ?
9. Presso chiunquede'tuoi servi si troviquel che tu cerchi, eglimuoia : e noi saremoschiavi del signor no-stro.
10. Quegli disse loro:Facciasi come voi ave-te sentenziato : pressochiunque si trovi, eglisia mio schiavo ; voi altripoi sarete senza colpa.
11. Gettati adunquein tutta fretta a terra isacchi, gli aprirono undopo T altro.
12. E quegli avendo-li frugati, principiandoda quel del maggiorefino a quel del più pic-colo, trovò la coppa nelsacco di Beniamino.
13. Ma quelli, strac-ciatesi le vesti, e ricari-cati gli asini, se ne ritor-narono in città.
14. E Giuda il primoentrò in casa di Giusep-pe ( perocché non era
18 *'

enim de loco abierat\omnesque ante eum pa~riter in terram corrue-runt.
io. Quibus ille aitiCur sic agere vobdsds ?an ignoratist quod nonsit similis mei in augu*randi sciektia ?
16. CniJudas\ Quidrespondebimus, inquit,domino meo 1 vel quidloquemur, aut justepoterimus obtendereìDeus invenit iniquita-tem servorum tuorum :en omnes servi sumusdomini mei, et nos , etapud quem inventusestscypììMS.
17. Respondit Jo*seph : Absit a me, utsic agam : qui furatus
fino allora uscito di lì ),e si prostrò insieme contutti i fratelli per terradinanzi a luì.
15. Egli disse loro :Per qual motivo avelevoi voluto trattar cosi?non sapete , che nissu-no è simile a me nellascienza <T indovinare ?
16. E Giuda a lui:Che risponderem noi,disse, al signor mio? ov-vero che diremo, o qualporteremo giusta scusa?Dio ha scoperto l'ini-quità dei tuoi servi: ec-co che noi siani tuttischiavi del signor no*stro, e noi, e quegli,presso di cui si è trova-ta la coppa.
17. Rispose Giusep-pe : Guardimi il cielodai far così : colui che
Vers. »5. * Nella scienza d'indovinare. Nella scienza de-gì' indovinamenti.
Vers. 16. Dìo ha scoperta P iniquità de* tuoi servi: ec. Giudaconoscendo, die la presunzione del furto era contro Beniamino ,qppahuujue motivo abbia di dubitare della verità dello stesso fur-to, vuol piuttosto prendere «opra di sé, e sopra de'suoi fratellila colpa, ebe mostrare sospetto verso di alcun altro. Ma si osser-vi e quéste passo l'umiltà, e la carità di questi fratelli, e come ilcuor loro è mutato da quel ch1 era prima. Qual tenerezza versodel padre ! qual impegno per riaver Beniamino ! Della grandeeloquenza, di quella eloquenza, cha parla al cuore, e lo muove,e lo sforza, di quest'eloquenza il primo esemplare ella è la pa-rola dettata da Dio.

est scypkum , ipse "sitservus meus% vos autemabite liberi ad patremvestrum.
18. Accedens autempropius Judas confiden-teraitì Oro, domine mìtloquatur servus tuusverbum inauribus tuis^et non irascaris famulotuo : tu^ es enim postPharaonem
19. Dominus meus.(i) Interrogasti priusservos tuos : Uabetìspatrem, autfratrem ?
20. Et nos respondi-mus tibi domino meo :Est nobis pater senex,et puer parvulus> tini insen&ctute illius natusest, cujus uterìnus fra-ter mortuus est : ipsumsolum hale^matersua^pater vero tenere diligiteum.
21. Dìxistique servistuis : Adduci te eum adme , et ponam oculosmeos super illum.
22. Suggessimus do-mino meo : Non potestpuer relìnquere patrem
ha rubalo la mia coppaei sia mio schiavo ; voipoi andalevene franchial padre vostro.
18. Ma fattosi piùdappresso Giuda animo-samente disse : Concedidi grazia , signor mio ,al tuo servo , ch' egli tiparli, e non li adirarecol tuo schiavo : peroc-ché tu dopo Faraone sei
19.11 signor mio. Tudomandasti già a'tuoiservi : Avete il padre, oaltro fratello ?
20.E noi rispondem-mo a te , signor mio :Abbiamo il padre vec-chio, e un fanciullo più.piccolo, il quale è natoa lui in sua vecchiaia,di cui un fratello uteri-no morì : e quf sti solorimase di sua madre; eil padre lo ama tenera-mente,
21 «E tu dicesti aHuoiservi : Conducetelo ame, e io lo vedrò volen-tieri.
22. Noi replicammoal signor nostro : Nonpuò il fanciullo scostar-
(i} Snpr. fc> ii. et 13.

suum*, si enim illum di"miseriti morietur.
23. Et dixistì. servistuìs: Nisi veneritfratervester minimus vobis-cum, non videbitis am-plius faciem meam.
Supr. P- 3. et 5.a 4- Cum erS° ascen-
dissemus ad famulumtuum patrem nostrum,narravimus ei omnia,quae locutus est domi'nus meus.
28. Et dixit pater no*ster.Revertimìnì, eterni-te nobis parum tritici.
26. Cui diximus: Iren&npossumus\ si fra-ter noster minimus [de-scenderli nobìscum >proficiscemur simul: a-liof/uin illo absente^ nonaudemus viderefaciemviri,
27. Ad quae ille re-spondit : Vos scitis,quod duos filios genue-rìt mihi uxor mea.
28.- Egressus estunus, etdixistis: (i) Be-stia devoravit eum ; etfoucusf/ue non comparci
si dal suo padre » per*chè ove si partisse, que-gli morrà.
23. E tu dicesti a'tuoiservi : Se non verrà ilfratello vostro minorecon voi, non vedretepiù la mia faccia.
24. Essendo noi dun-que arrivati a casa deltuo servo il padre no-stro, raccontammo a luitutto quello che il si-gnor mio avea detto.
26. E nostro padre cidisse : Tornate a com-prare un poco di grano,
26. Dicemmo a lui:Non possiamo andare :se il fratello nostro piùpiccolo verrà con noi,partiremo insieme : al-trimenti senza di luinon abbiamo ardire dimirar la faccia di quel-1' uomo.
27. A questo egli ri-spose: Voi sapete, comedue figli partorì a mequella mia moglie.
28. Uno usci di casa,e mi diceste : Una fieralo ha divorato : e {inoranon compare.
(i) Supr. 3-, 20. ei 33.

2 g. Sì tulerids etistum , et aliquid ei invia contìgerit, deducetiscanos meos cum moero~re ad in/eros.
30. Igitur si intrave-ro ad servurn tuum pa-trem nostrum, et puerdefuerit ( cum anima il-lius ex hujus ànima pen-deat)t
31. Videritque , eumnon esse nobiscum, mo-rìe tur , et deduce n i fa-muli fui canos ejus cumdolore ad inferos.
32. Ego proprie ser~vus tuus sint, qui inmeam hunc recepì fi-dem , et spopondi di-censi (i) Nisireduxeroeum , peccati reus eroin patrem meum omnitempore.
33. Manchò itaqueservus tuus pro puero
29. Se vi pigliate an*che questo, e che qual-che cosa succeda a luìpel viaggio, precipite-rete con la tristezza lamia vecchiaia nel sepol-cro.
30. Se io pertantotornerò al padre nostrotuo servo, e che man-chi il fanciullo ( sicco-me dall'anima di que-sto pende l'anima dilui),
31. Veggendo egli,che questi non è connoi, morrà, e i tuoi ser-vi precipiteranno col-1' afflizione la sua vec-chiaia nel sepolcro,
32. Sia io stesso tuoproprio schiavo, io, chesulla mia fede ho rice-vuto questo garzone, ene entrai mallevadore ,dicendo : Se io noi ri*conduco, sarò per sem-pre*reo di peccato con-tro del padre mio.
33. Resterò adunqueio tuo servo a* servigi
fi j Supr. 43. 9-
Vers, 3o. * DalV anima, dì questo pende Vanitila, iti lui Dalla•vila di questo pende la vita di lui.

'ìn ministèrio domìnimei i et puer ascendatcurii Jratribus suis.
54- Non enimpossumredìre ad patrem meum,absente puero j ne cala"mitatist quae oppressu-ra est patrem meum, te-stìs assistane
del signor mio in luogodel fanciullo : e questise ne vada co9 suoi fra-telli.
34. Perocché non pos-s'io tornare al padremio senza il fanciullo :non volendo essere te-stimone della miseria,che opprimerà il padremio.
• : - -G A P O XLV.
Giuseppe si dà a conoscere affratelli, e sbigot-titi , carne erano, gli abbraccia , e li bacia.Faraone pieno di allegrezza con tutta la suacasa ordina, che rifaccia venire il padre contutta la sua famiglia in Egitto. La stessa co»sa ordina Giuseppe : e fatti molti doni ai fra-teile ± tì rimanda al padre.
1. x\ on se poteratultra cohibere Joseph,multis coram astanti"bus : unde praecepit,ut egrederentur cune fiforas, et nullus interes-f<et alienus agnizionimutua*. %
2. JLlevavitque vocemcumfletu : quam audie-runt AEgyptii, #mnis-que domus Pìì,araonis.
1. IN on poteva piùcontenersi Giuseppe,molti essendo d'intornoa lui : per la qual cosaordinò, che tutti si ri-tirassero, affinchè nis-suno straniero fosse pre-sènte , mentre ad essisi dava a conoscere.
2. E piangendo alzòla voce : e fu udita da-gli Egiziani, e da tuttala casa di Faraone»

3. Et dixlt fratribussuis : Ego sum Joseph:adhuc patermeus vivitiNon poterantresponde-refratres nimio terroreperterriti.
4. Ad (JUQS ille eie-menter: Accedite, in-quit , ad me. Et cumaccessissent prope :( i ) Ego sum, alt, Jo-sephfrater vester, q uemvendidistis in AEgy-ptum.
5. Nolite pavere, ne-que vobis durum essevideatur, quod vendidi-stìs me in his regioni-bus : (2) pro salute e-nim vestra misit meDeus ante vos inAEgy-ptum.
3. E disse a1 suoi fra-telli : Io son Giuseppe :vive tuttora il padremio ? Non poteano dar-gli risposta i fratelli per1' eccessivo sbigotti-mento.
4. Ma egli con beni-gnità disse loro : Ap-pressatevi a me. E quan-do gli furon dappressosIo sono, disse, Giusep-pe vostro fratello, chevoi vendeste per l'E-gitto.
5. Non temete, e nonvi sembri dura cosa l'a-vermi venduto per que-sto paese: perocché pervostra salute mandom-mi Dio innanzi a voi inEgitto.
(~i) Act. 7. \3. (»} Infr. 5o. ao»
Vers. 3. Io son Giuseppe. Chi può spiegare la confusione^ Iostordimento, il terrore, che dovette cagionar questa vóce nelcuore di que' poveri fratelli ? Ma Giuseppe fa quanto può perincoraggiarli. Cosi Gesù Cristo dopo la sua risurrezione facendo-si vedere ammantato di gloria a' suoi amici gli Apostoli, i quali10 aveano già abbandonato e negato, dice : son io], non temete,Lue. xxiv. 36.
Vers. 5. E non vi sembri (tura cosa V avermi venduto, ec.Giuseppe non proibisce a'fratelli di affliggersi, e d'avere un giu-sto orrore del loro fallo; ma teme gli eccessi, e cerca di mitigare11 loro dolore col far vedere il bene, che ha saputo trarre laProvvidenza dalla loro scelleraggine, per ragion del qual bene

6. Bienniumestenim,quod coepitfames essein terra : et adhuc quin-que anni restant, qui-bus nec arari poterit,nec meti.
7. Praemisitque meDominus, utreservemi-ni super terram>etescasad viventium haberepossitis.
8. Non vestro consi-lio , sed Dei voluntatehuc missus sumt qui
6. Imperocché sonodue anni, che la fameha principiato nel pae-se : e rimangono ancorcinque anni , ne'qualinon sì potrà arare , nèmietere.
7. E il Signore mimandò innanzi, affinchèvoi siate salvati sullaterra , e possiate avercibo per conservare lavita.
8. Non per vostroconsiglio sono statomandato qua, ma per
fu permessa da Pio la vendila, che avean fatta di Ini. Cosi ilPrincipe degli Apostoli parlando del secondo Giuseppe , Aiti n.a3, »4 ec. dice: Questi per determinalo consiglio e prescienzadì Dio essendo stalo tradito, voi trafiggendolo per le manidegli empii lo uccideste... Questo Gesù lo risuscito Iddio ,..Esaltalo egli adunque, e ricevuta dal Padre la, promessadello Spìrito Santo, lo ha diffuso, quale voi lo vedete, e udi-te ... Sappia adunque tutta la casa d1 Israele, che Dio ha co-stituito Signore, e Cristo questo Gesù, il quale voi avete cro-cifisso. Ma tornando a Giuseppe, il Crisostomo così interpreta lesue parole: Quella servitù mi ha meritato questo principato ;la vendila mi ha innalzalo a questa gloria; quella afflizione,e stata per me causa di tanto onore ; quell'invidia mi ha par-torito tanta grandezza. Ascolliamo noi queste cose, anzi nonle ascoltiamo solamente ; ma imitiamole, e consoliamo quelliche ci han recato afflizione, non imputando loro quel chehan fatto contro di noi, e ogni cosa sopportando con grancarità^ come quest'uomo ammirando. Hora. 64>
* Per vostra salute mandornmi Di&. Ancora nel Sal-mo CIV. v. 17. si legge: Mando avanti di loro un uomo. Giu-seppe fu venduto per ischiavo.
Ver». 6. Non ti potrà arare, ne mietere. Si è già oaservatqr,che ne'luoghi più bassi e umidi presso al Nilo si-seminava, equalche cosa si raccoglieva. Vedi cap. XLVH. \y, ma eiò era sì po-ca cosa, che Giuseppe noi contava per un soccorso.

fecit me quasi patremPharaonìs% et dominumuniyersae domus ejus,ac principem in omniterra AEgypti.
9. Festonate, etascen-dite ad patrem meum,et dicetis ei: "Haec man-dat filius tuus Joseph :Deus fecit me dominumuniversae terraeAEgy-pti : descende ad me ;ne moreris.
10. Et habitabìs interra Gessen, erisquejuxta me tu, et filii tuitet filii filiorum tuorum,oves tuae, et armeniatua, et universa, quaepossides*
11. Ibique te pascam( adhuc enim quinqueanni residui sunt fa-mis ), ne et tu pereas,
volere di Dio , il qualemi ha renduto quasi ilpadre di Faraone, e pa-drone di tutta la suacasa, e principe di tut-ta la terra d'Egitto.
9. Speditevi, e anda-te a mio padre, e dite-gli : Queste cose ti man-da a dire Giuseppe tuofiglio : Dio mi ha fattosignore di tutta la ter-•ra d'Egitto: vieni dame ; non porre indugio,
10. E abiterai nellaterra di Gessen, e saraivicino a me tu, e i tuoifigliuoli, e i figliuoli de'tuoi figliuoli, le tue pe-core , e i tuoi armenti,e tutto quello che pos-siedi.
11. E ivi ti sostente-rò (perocché vi restanotuttora cinque anni difame ), affinchè non pe-
Vers. 8. Quasi il padre dì Faraone. Cosi iFre di Tiro dà alMIO principal consigliere il titolo di padre suo, 2. Paralip. n. 13.,e Aman è chiamato padre di Artaserse. Esther. xn. 6., e gì' im-peratori Romani davano il titolo di padre al prefetto del pretorio.
Vers. io. Abiterai nella terra di Gessen. Secondo s. Girola-mo il nome di Gessen viene da una voce, che significa pioggia,perchè in quell'angolo vicino all'Arabia cadeva della pioggia, loche non avveniva in tutto il resto dell'Egitto, La città principaledel paese di Gessetì eja Ramesse,

et domus tua et omnia,quae possides*
12. En oculi vestri,et oculi fratris mei Be-niamin, vident, quodos nteu/n loquatur advos.
13. IV'untiate patrìmeo universum gloriavimeam , etcuncta, quaevidistis inAEgypto\fe-$ tiriate > et adduciteeumad mei
ìtlìVumgueamplexa-tus recìdissetin colluttiBen iamin ffatris suiftévitt illo quoque siifd-(itéffiente Super colluttieju3.~
16. Osculatusque estJoseph omnes fràtressuos, et ploravit supersingulos: post quae au-si sunt loqui ad eum»
16. Auditumque estet celebri sermone vukt
risca tu , e la tua casa,e tutto quello che pos-siedi,
12. Ecco che gli oc-chi vostri, e gli occhidel fratello mio Benia-mino veggono, che sonio, che di mia bocca viparlo*
13. Raccontate al pa-dre mio tutta la miagloria , e tutto quelloche veduto avete inEgitto : affrettateiri, econducetelo a me.
14. E lasciandosi ca-der sul collo del suo fra-tello Beniamino pianse,piangendo ugualmenteanche questi sul collodi ìui.
i 6. E baciò Giuseppetutti i suoi fratelli, epianse ad uno ad unocon essi: dopo di ciòpreser fidanza di par a-re con lui.
16. E si sentì dire, edivulgossi di bocca in
Vera., ta. e 16. Tatto questo ragionamento di Giuseppe spirauna bontà .di cuore così grande, è divina, che per questo lato an-cora egli merita di rappresentare Colui, il quale non ebbe a sde-gno di essere chiamato l'amico de' peccatori, e di dichiarare, cheper questi egli era venuto dal ciclo in terra.
'* Di-mia bocca vi parlo. Non più per interprete, come ioera solito, quando voleva tenervi in timore ed alla mia autoritàsottomessi.

gatum in aula regis:J^enerunt fratres Jo-seph: et gapisus estPharao, atque omnis
familia ejus.
17. Dixitque ad Jo-seph , ut imperare t fra-tribus suis, dicens : O-nerantes jumenta ite interroni Chanaan\
18. Et tollite inde po»trem vestrum^ et cogna*tionem, et venite adme : et ego dabo vobisomnia bona AEgyptì,ut comedatis medullamterrae.
19. Praecipe edam,ut totlant plaustra deterra AÉgypti ad sub-vectionem parvulorumsuorum , ac conjugum,etdicitoi Tollite patremvestrum , et properate,quantocius venientes.
20. Nec dimittatisquidquam de supelle-etili vestra; quia o-mnes opes AEgypti ve-strae erunt*
21. Feceruntque filiiIsrael ut eismandatum
bocca per la reggia diFaraone ; Sono venutii fratelli dì Giuseppe :e Faraone, e tutta lasua famiglia ne provògran piacere.
17.Sdisse a Giusep-pe , che comandasse, edicesse ai suoi fratelli :Caricate i vostri giu-menti , e andate nellaterra di Ghanaan ;
18. E di là prendeteil padre vostro, e la suafamiglia, e venite dame : e io vi darò tuttii beni dell'Egitto , e vinutrirete del midollodella terra.
19. Ordina ancora,che prendano carri dal-la terra di Egitto pertrasportare i piccoli lo*rotigli, e le donne, edirai loro : Prendete ilpadre vostro, e affret-tate vi, e venite con_ tut-ta eelerità.
20. E non vi datepena di non portarelutti i vostri utensili ;perocché tutte le ric-chezze dell'Egitto sa-ranno vostre.
21. E i figliuoli d'I-sraele fecero, com'era

fuerat. Quibus dedit Jo-seph plaustra secun-dum Pharaonis impe-rium , et cibaria in iti-nere.
22. Singulis quoquepro ferri jus sit binas sto-las: Beniamin vero de-dit trecentos argenteoscum quinque stolis opti-mis :
23. Tantumdem pe-cuniae , et vestium mit*tens patri suo, addenset asinos decem, quisubvéherent ex omni-bus dwitiis AEgypti, ettgtàdem asinas,triticumin itinere panesquepor-tantes*
24. Dùnisit ergofra-tres suos i etproficiscen-tibus ah : Ne irascami-niinjoia.
26. Qui ascendentesex AEgypto veneruntin terram Chanaan adpatrem suum Jacob.
lor comandato. E Giu-seppe diede loro de' car-ri, conforme avea ordi-nato Faraone, e i vive-ri pel viaggio.
22. E ordinò ancora,che fossero messe fuoridue vesti per ognunodi essi : e a Beniamindiede trecento moneted'argento con cinqueottime vesti:
26. Altrettanto dena-ro , e altrettante vestimandò a suo padre col-la giunta di dieci asini,che portavano d'ognisorta delle ricchezze d.'Egitto, e altrettanteasine cariche di granoe di pane pel viaggio.
24. Licenziò adunquei fratelli, e mentre sta-vano per partire disse :Non sieno dispute travoi per viaggio.
20. Quelli partiti dallr
Egitto giunsero al pa-dre loro Giacobbe nellaterra di Chanaan.
Ver*. «4 Won fieno tra voi. La carità di Giuseppe pensa atutto» Egli teine, che discorrendo per viaggio sopra quello cheera avvenuto, non succedessero altercazioni, cercando ognuno dicomparir innocente, o mea reo in quello che era stato fatto con-tro il fratello.

26. Et nuntiaveruntei, dicentes : Joseph fi-lius tuus vivit, et ipsedominatur in omni ter"ra AEgyptL Quo auditoJacob , quasi de gravisomno evigilans, tamennon credebat eis.
27. Illi contra refe"rebant omnem ordinemrei. Cumque vidis$etplaustra, et universa ,quae miserai, revixitspiritus ejus,
28. Et ait\ Sufficitmihi, si adhuc Josephfilius meusvivit: vadamet videbo illum ante"quam moriar.
26. E gli dieder lenuove, e dissero : Giu-seppe il tuo figlia vive,ed egli è padrone intutta la terra d'Egitto.Udita la qual cosa Gia-cobbe, quasi da profon-do sonno svegliandosi,non prestava però fedead essi.
27. Ma quelli tuttaraccontaron la serie del-le cose. E quando ebbeegli veduti i carri, e tut-te le cose, che quegliavea mandate , si rav-vivò il suo spirito,
28. E disse : A mebasta, che sia ancor invita Giuseppe mio fi-glio : anderò, e lo ve-drò prima dì morire.
C A P O XLVI.
Giacobbe, dopo avergli Dio rinnovettate le pro-messe , scende in Egitto con tutti i suoi figlie nipoti, de quali si registrano i nomi. Giù»seppe va loro incontro , e gli esorta, che dica*no a Faraone, essere pastori di pecore.
*• Jlrofectusque /-srael cum omnibus,quae habebat, venit adputeum juramentii et
i.Jtartito Israelecon tutto quello che a-veva , giunse al pozzodel giuramento ; e ivi

mactads ibi victimisDeo patrìs sul Isaac,
2. Audivit eum pervisionem nocds vocan-tem se, et dicentem si-bi i Jacob, Jacob : cuirespondit* E tee adsum.
3. Alt illi Deus : Egosum fortissimus Deuspatris lui : noli timere\descende in AEgyptum\quia in gentem magnanifaciam te ibi.
4- Ego descendamtecum illuc, et ego indeadducam te reverten-tem: Joseph quoque po~nel manus suas superoculos tuos,
5. Surrexit autemJacob a puteo juramen"ti i (i) tuleruntque eumfilii cum parvutisi et u-xoribus suis in plau-stris^quae miseraiPha-rao ad portandum se*nemt
avendo immolato vitti-me al Dio del padre suoIsacco,
2. Udì in visione dinotte tempo uno , chelo chiamava, e gli di-ceva : Giacobbe, Gia-cobbe : a cui egli rispo-se : Eccomi qui.
3. Dissegli Dio : Iosono il Dio fortissimodel padre tuo : non te-mere : va in Egitto,perocché ivi tifaròcapodi una gran nazione.
4« Io verrò teco òolà,e ti sarò guida nel tuoritorno di là : Giuseppeancora chiuderà a te gliocchi.
5. E alzossì Giacob-be dal pozzo del giura-mento: e i suoi figliuolilo misero coi bambini ele donne su' carri man-dati da Faraone pertrasportare il vecchio,
(i) Act. 7. 15.
Vers. i. Al pozzo del giuramento. A. Bersabea. Veài cap. xxi. 31.Vers. 4- E ti sarò guida nel tuo ritorno di là. Promessa adem-
piuta n«I ritorno de' posteri di Giacobbe alla terra di Chanaan.Egli stesso dopo la sua morte fu*riportato nella medesima terra.tfen.L. 5.

6. Et omnia, quaepossederai in terraChanaan: (\)ve.nitquein AEgyptum cum omnitemine suo,
7. Filii ejus, et nepo-tes ifiliae, et cuncta si-mul progenies*
8. Haec sunt autemnomina filiorum Israel,qui ingressi sunt inAEgyptum, ipse cumliberis suis : primoge-nitas Ru&en.
Exod. i. 2. et 6.14.Num. 26. 5. Par.5. i. 3.
9. Filii Ruben : He-nodi, et Phallu, et He»$ron, et Charmi.
10. FUiz Simeon: Ja-muel, et Jamin, et A-hod, et Jachin, et So-har, et S aul filius Cha»naanitidis.Exod. 6. 16. Par.4. 24.
6. E tutto quello chepossedeva nella terra diGhanaan : ed egli giun-se in Egitto con tuttala sua stirpe,
7. Co' suoi figliuoli,e coi nipoti, e figlie , etutta insieme la discen-denza.
8. E questi sono inomide'figliuoli d'Israe-le, i quali entrarono inEgitto, egli co' suoi fi-gliuoli de' quali il pri-mogenito Ruben.
9. Figliuoli di Ru-ben : Henoch, e Phallu,ed Hesron , e Charmi.
10. Figliuoli di Si-meon: Jamuel, e Jam in,e Ahod, e Jachin, e So-har , e Saul figliuolo diuaa Chananea.
(i} Jos. 24» 4 -PwZ. 104. a3. /f. 5?.. 4-
Vers. 7. E figlie. Glacobbe non avea altra figlinola che Dina-onde il plurale sarebbe messo per il singolare T come nel verset-to 9.3., e in molti altri luoghi; ovvero s'intenderà la figliuola Di-na, e le nipoti figlie de' figliuoli.
Vers. 8. Nomi de* figliuoli d'Israele, i gitali entrarono i*Egitto. S. Agostino, e molti dotti interpreti avvertono, che nonerano ancora tutti nati quelli che sono qui descritti della discen-denza di Giacobbe, per esempio parte de'figliuoli di Beniamin, equelli di Phares , i quali nacquero uell' Egitto.

11. (i) Fiai Levi iGerson, et Caath, etMerari.
12. (2) Filii Juda:Her, et Onan , et Selatet Phares, et Zara :mortui sunt autem Heret Onan in terra Cha-naan. TSatique sunt filiiPhares Hesron, et Ha-mul.
13. (3) Filii Issa-char : Thola, et Plwa,et Job, et Semron.
14. Filii Zabulon :Sared, et Elon, et Ja-helel,
15. Hi filii Liae, quos"genuit in MesopotamiaSyriae cum Dina filiasua : omnes animae fi-liorum ejus, etfiliarumtriginta tres.
16. Filii Cadi Se-phion , et Haggi, et Su-ni , et Esebon, et Heri,et Arodi , et Areli.
17- (4) Filii Aser:Jam/te, et Jesua, et Jes~sui, et Beria, Sara quo*que soror eorum. FiliiBeria : Heber, et Mei-Meli
11. Figliuoli di Levi»Gerson, e Caath, e Me-rari.
12. Figliuoli di Giu-da: Her, e Onan,e Scia, ePhares, e Zara: ma Her,ed Onan morirono nel-la terra di Chanaan. Ea Phares nacquero i fi-gliuoli Hesron, e Ha-mul.
13. Figliuòli di Is-sachar : Thola, e Phua,e Job, e Semron.
14. Figliuoli di Zabu-lon : Sared, ed Elon, eJahelel.
15. Questi sono i fi-gliuoli di Lia partoritida lei nella Mesopota-mia della Siria insiemecon Bina sua figlia :tutte le anime de'suoi fi-gliuoli e figlie trentatrè.
16. Figliuoli di Gad:Sephion, e Haggi, e Su-ni, ed Esebon, ed Heri,e Arodi, e Areli.
17. Figliuoli di Aser:Jamne , e Jesua, e Jes-sui, e Beria, e ancheSara loro sorella. Fi-gliuoli di Beria : Heber,e Melchiel.
fO i. Par. 6. i. (3J i. Par. n. ,.f2) i. Par. 2. 3. « 4. ai. (4) i. Par. 7. 3o.

1 8. Hi filii Zelphae,quam deditLabanLiaefìliae suae : et hos ge-nuit Jacob , sedecim a-qLmas*
19. Filii Racket uxo-ris Jacob : Joseph , e£Beniamin.
20. (i) Natiqtìe suntJoseph filii in terraAEgyptì) quos genuitei Aseneth, filia Puti-phare sacerdotis Helio-poleosi Manasses, etEphraifri.
21. Filii Beniamin iBela, et Bechar, et A$-àel,etGera,etNaamant
et Èchi, et Eos, et Mo-pliim , et Vphim, et A-red.
i. Par. 7. 6. ei 8. i.22. Hi filii Rachelt
quos genuit Jacob: o-tnnes animae quatuor-decim.
2 o. Filii D an-.Husim.
24- JPifit Nephtali:Jasìel, et Guni> etJeser,et Sallem.
26. Hi filii Balae^quam dedit Laban Ra-
18. Questi sono i fi-gliuoli di Zelpha datada Laban a Lia sua fi-glia: e questi li generòGiacobbe, sedici anime.
19. Figliuoli di Ra-cket moglie di Giacoh-be : Giuseppe, e Benia-tnin.
20. E Giuseppe ebbeper figliuoli nella terradi Egitto Manasse, dEphraim partoritigli daAseneth, figliuola diPutifare sacerdote dìHelìopoli.
21. Figliuoli di Be-tiiamìn : Bela , e Becbor,e Asbel, e Gera , e Naa-mart, ed Ecbi, e Ros, eMophim , e Ophim, eAred.
22. Questi sono i fi-'gliuoli di Racbele, e diGiacobbeùn tutto quat-tordici anime.
23. Figliuoli di Baii:Husim.
2/1. Figliuoli di Ne-pblali : Jasiel, e . Guni,e Jeser, e Sallem.
26. Questi sono fi-gliuoli di Baia data da
(i) A-«7».4i.Ko./n/r.48.5.

cheli filìae suae i etJiosgenuit facob\ omnes a»nimae septem.
a 6. Cunctae animae,quae ingressae suntcum Jacob in dEgy~pium, et egressae suntde femore illius > absqueuxoribus filiorum ejus,sexaginta sex.
27. Filii autem Jo-- \sepji, qui nati sunt eiin terra AEgypti, ani-mae duae. (i) Omnesanimae domus Jacob,quae in gres s ae sunt inAEgyptum, fuere se-ptuaginta.
28. jfàisit autem Ju-Tdam ante se adjoseph,ut nuntìaret ei , ut oc-curreretin Gessen.
29. Quo cum perve-nisset, 'juncto Josephcurru suo ascendit ob"
Labari a sua figlia Ra-chele ; e questi discese-ro da Giacobbe ; in tut-to sette anime.
26. Tutte le anime,che andarono in Egittocon Giacobbe, discen-denti da lui, tolte lemogli de'suoi figliuoli,sessantasei.
27. I figliuoli di Giu-seppe nati a lui inEgitto, due anime.Tut-te le anime della casadi Giacobbe, che entra-rono in Egitto , furonsettanta.
28. È (Giacobbe)spedi avantidi sé Giudaa Giuseppe per avvisar-lo, che venisse incontroa lui in Gessen.
29. E quand'ei vi fuarrivato, Giuseppe fattoattaccare il suo cocchio
(i) Deut. io. 2 a.
Vere. a6. Tutte le anime ... sessanta, sei. Non era in questonumero nè Giacobbe, nè Giuseppe co'suoi figliuoli, che eran giàin Egitto. Si contano trentadue figliuoli discesi da Lia, sedici daZelpha, undici da Rachele, e sette da Baia.
Vers. 27. Furori settanta. Compreso Giacobbe, e Giuseppe, ei due figli di Giuseppe. I LXX. ne contano settantacinque : lostesso numero si ha negli Atti, càp. vii, 14- dove si è parlato del-la origine di tal divaria.

viam patri suo ad eum"dem locum : vldensqueeum , ìrruit super col-lum. ejus , et inter am~plexus flevit.
3<x Dixitque pateradJoseph : Jam laetusm orlar, (jula vidi fa"ciem Zuam, et supersti-te™ te relinquo.
31. At ille locutusest ad fratre s suos , etad omnem domum pa»tris sui : Ascendam, etnuntiabo Pharaonì , di-eamque ei: Fratres mei,et domus patris mei,qui erant in terra Cha-naant venerunt ad me :
Sa. T£t suntviripasto-res ovium, curamque ha"bent alendorum gre-gum ' pecora sua, et ar-menta, et omnia, quaehabere potuerunt, addu-xerunt secum.
33. Cumque vacaveritvos et dixerit : ubi estopus vestrum ?
34» Jtespondebitìs :Viri pastores sumusservi fui ab infantia
andò fino alio stessoluogo incont ro ai padre:e quando lo vide, sì la-sciò andare sul oollo dìlui, e abbracciatolopianse.
30. E il padre clissca Giuseppe : Ora iomorrò contento, perchèho veduta la tua faccia,e ti lascio dopo di me.
31. Ma quegli dissea'suoi fratelli, e a tuttala famiglia del padresuo : Anderò a recar lanuova a Faraone, e glidirò : 1 miei fratelli, ela famiglia del padremio, che erano nellaterra di Chanaan, sonovenuti da me :
32. E sono uominipastori di pecore, e sioccupano a mantenerede'greggi : hanno con-dotto seco il loro be-stiame, e gli armenti, etutto quello che pote-vano avere.
33. E quand'egli vichiamerà , e vi dirà :Qual mestiere è il vo-stro ?
34. Voi risponderete:Noi servi tuoi siamopastori dalla nostra in-

nostra usque in prae-sens , et nos, et patresnostri. Haec autem di*cetis, ut Jiabitare pos-sitis in terra Gesseniquia detestanturAEgy-ptii omnes pastores o*pium.
fanzìa sino a quest'ora,e noi, e i padri nostri.E ciò voi direte, affin-chè possiate abitarenella terra di Gessen :perchè gli Egiziani han-no in abbominazionetutti i pastori di pe-core*
Ver*. 34- Risponderete: hot servi tuoi siamo pastori ec. Equi molto da osservarsi l'umiltà di Giuseppe, il quale si spacciapubblicamente per fratello di pastori, professione poco men chedisonorata nell' Egitto. Ma con questa umiltà dà ancora un sag-gio di somma prudenza : i fratelli dichiaratisi pastori potrannopiù facilmente star uniti tra loro, e aver meno occasione di trat-iare cogli Egiziani, e mantenendosi nella loro semplicità non con-trarranno i costumi di quelli, potranno ottenere il paese di Ges-sen ottimo per le pasture, e comodò al ritorno nella Chananea.
CH Egiziani hanno in abborninazione tutti i pastori di"pecore. Comunemente crederi, ché questa avversione nascessedall' uso de* pastori di uccidere le pecore , e mangiarne le carni.Ora gli Egiziani le adoravano, come vedesi, Exod. vui. 26. ; man-tenevan però delle pecore (cap. XLVII. 17.), ma per avere il lat-te e la lana, e Tenderle agli stranieri.

C A P O XLVIL
Giuseppe, fatto sapere a Faraone 1 arrivo delpadre , e de* fratelli , conduce il padre co suoifigliuoli alla presenza di lui : e conceduta ad(essi per loro abitazione la terra di Gessen ±Faraone gli alimenta pel tempo della carestia*La fame preme in tal guisa PEgitto, che ven-duti i bestiami, son costretti a vendere anchei terreni • donde ne avv iene, che la quintaparte de* frutti è ceduta dre d* Egitto in per*petuo , eccettuate le possessioni de sacerdoti.Diciassette anni dopo Giacobbe diventato rie*chissimo, e vicino a morire, si fa prometterecon giuramento da Giuseppe che lo seppelliscanella Chananea.
«. Jingressus ergoJoseph nuntiavit Pha-raonì, dicens : Patermeus, etfratres, oveseorum i et 0,rmentat etcuncta, quae possident^venerunt de terra Cha»naan: et ecce consistimiin terra Gessen.
2. Extremos quoquefratrum suorum quin*que viros constituit co-ram rege :
i. A-ndò adunqueGiuseppe a dire a Fa-raone : Mio padre , e imiei fratelli colle loropecore , e armenti, econ tutto quello chehanno, sono venuti dal-la terra di Ghanaan : egià sono fermi nella ter-ra di Gessen.
a. E presentò i n sie*me al re cinque perso-ne , gli ultimi dei suoifratelli :
Yers. a. Cinque persone, gli ultimi dt? suoi fratelli. Questamaniera di parlare dinota, che Giuseppe non scelse tra'fratelliquelli di personale piìi vantaggiato; ma o prese quelli che gli ca-pitarono i primi davanti, come spiega il \atablo, e altri; ovveroprese quelli che erano men vistosi, e da dar meno nell' occhioper la bellezza del corpo, affinchè a Faraone non venisse voglia

3. Quos ille interro-tytviti Quid habetisoperisi ResponderuntiPastore^ ovium sumusservi tuì, et no$% et pa«tres nostri.
ll~Adpere§rinandumin. terra tua venimus :quoniam non est nerbagregìbus servorum tuo-rum, ingravescente fa*me in terra Chanaan :petimuscfue, ut esse nosy&beas servos tuos interra Gessen.
5. Dixit itaque rexad Joseph : Pater tuus%ètfratres tui venerimiad te.
6. Terra Aftgypti inconspectu tuo est: incptimo loco fac eos ha-bitare> et trade eis ter-ram G esse n. Quod sinostì. in eis esse virosindustrios^ constitue il-*los magistros pecorummeorum.
7. Post haec intrò*duxit Joseph patremsuum ad regem, et sta-
3. A' quali quegli do-mandò : Qual mestiereavete? Risposero : Siam,pastori di pecore tuoiservi, e noi, e i padrinostri.
4. Siam venuti a starpellegrini nella tua ter-ra: perchè non vi è er-ba pe' greggi de' tuoiservi nella terra diCha-naan, e la fame va cre-scendo : e noi preghia*mo , che comandi a noituoi servi di stare nellaterra di Gessen.
5. Disse pertanto il rea Giuseppe: Tuo padre,e i tuoi fratelli sono ve-nuti a trovarti.
6. La terra d' Egittoè dinanzi a te : fa cheabitino in ottimo luogo,e dà ad essi la terra diGessen. Che se conoscitra di loro degli uominidi capacità, eleggili so-printendenti de' mieiBestiami.
7. Dipoi Giuseppecondusse suo padre alre , e lo presentò a lui:
<U servirsene sella milizia, o alla corte ; lo die non volea Giu-seppe per timore, che i fratelli uoa prendessero le usanze degliEgiziani, fedi Perer.
Vera. 6. La terra d* Egitto e dinanzi a te. Ti offerisco tuttol'Egitto; scegli la parte, che pili ti piace.

fuit eum coram eoi quibenedicens illi>
8. Et interrogatilo abeo : Quot sunt dies an-norum vitae tuae ?
e). Respondit: Diesperegrinationis meaecentum triginta anno-rum sunt,pauci., etnia-li , et non perveneruntusque ad dies patrumm eorum , quibus pere-grinati sunt»
io. Et benedicto re-ge, egressus estforas.
n. Joseph veropatri^etfratrìbus suis deditpossessionem inAEgy-pto in optimo terrae lo-CO) Ramesses t ut prae-ceperat Pharao.
12. Et alebat eostomnem que domum pa-tris sui^ praebens ciba-ria singulis.
Giacobbe augurò a lu*ogni bene,
8. E interrogato dalui : Quanti sono i tuoianni ?
9. Rispose : I giornidel mio pellegrinaggiosono cento trent' anni,pochi , e cattivi, e nonagguagliano il tempodel pellegrinaggio dèipadri miei.
10. E augurato ognibene al re , si ritirò.
11. Giuseppe poi die-de al padre, e a'suoi fra-telli in Egitto una te-nui a in luogo buonissi-mo in Ramesses,come a-veaeomandatoFaraone.
12. Ed ei dava damangiare ad essi, e atutta la famiglia di suopadre, dando a ciascbe-duuo di che cibarsi.
Vers. C). / giorni del mìo pellegrinaggio. Letteralmente lavita di Giacobbe fu un pellegrinaggio continuo, come sì è vedu-to; ma in un altro senso, a cui mirava principalmente il santopatriarca, egli come tutti i giusti non si considerava se non co-me forestiere su questa terra , aspirando alla vera patria, che èil cielo. Vedi quello che si è detto, Heb. xi. 13. Gli anni, cheegli avea vissuto, erano pochi in'paragone delle lunghe vitedegli antichi patriarchi, ed erano stati anni cattivi, cioè pieni digrandi afflizioni.
\ers. 11. In Ramesses. In quella parte del paese di Gessen ,dove dipoi gl'Israeliti edificarono la città, cui diedero il nome dìRamesses. Cosi s. Girolamo.

13. In toto enim orbepanis deerat) et oppres-serat fames terram,maxime AEgypti, etChanaan.
i4» E quibus omnempecuniam congregavipro vendition&frumen-ti, et intulit eam in ae-rarium regis.
i S. Cumque defecis-$et emptorwus predumtvenit cuncta AEgyptusad Joseph, dicens : Danobis panes: quare mo-rimur coram tet defi-ciente pecunia ?
16. Quibus ille re-spondit: Adducite pe-cora vestra^ et dabo vo-fiis pro eis cibos, si pre*tium non habetis.
17. Quae cum addu-xissenty dedit eis ali-menta pro equìs, etovibuS) et bobus> et asi-nis : sustentavitque eosillo anno pro commuta*tione pecorum.
18. fenerunt quoqueanno secundo^ et dixe-
Ver», i». * Dando a ciaf cimo di che cibarsi. Come «e tutùfossero in età puerile. Così sembra portare l'origina,!*;.
13. Perocché manca-va il pane in tutto ilmondo, e la fame op-primeva Ja terra prin-cipalmente dell'Egitto,e di Chanaan.
14. De'qualì (paesi)Giuseppe prese tutto ildenaro pel frumentovenduto, e lo ripose nel»P erario del re.
16. E i compratorinon avendo più mone-ta , tutto l'Egitto andòa trovar Giuseppe di-cendo : Dacci del pane:per qual motivo morre-mo sugli occhi tuoi permancanza di denaro?
16. Rispose loro : Me-nate i vostri bestiami,e in cambio di questi vidarò da mangiare , senon avete moneta.
17. E quegli avendo-li menati, diede loro davivere in cambio de'ca-valli, e delle pecore, ede* buoi, e degli asini :e queli' anno li sosten-tò colla permuta de'be-stianii.
18. Tornarono anco-ra il secondo anno, e gli

runt ei : flon celabimusdominum nostrum,quoddeficiente pecunia, pe-cora simul defecerunt :nec clam te est, quodabsque corporibus, etterra nihil habeamus.
i g. Cur ergo morie-mur, te vedente ? et nos,et terra nostra tui eri*mus : eme nos in ser-vitù tem regiam, et prae-be semina, ne pereuntecultore, redigatur terrain solitudinem.
20. Emit igitur Jo-seph omnem terramAE-gypti, vendendbus sin-gulis possessiones suasprae magnitudine fa-misi subjecitque eamPharaoni,
21. Et cunctos popu-los ejus a novissimisterminis AEgyptiusquead extremosfines ejus.
22. Prae ter terramsacerdotum, quae a re-
dissero: Noi non celere»mo al signor nostro,che, mancato il denaro,sono mancati insieme ibestiami : e tu ben ve-di, che oltre i corpi, e laterra non abbiam nulla.
19. Perchè adunquemorremo noi, veggentete ? e noi, e la nostraterra saremo tuoi: com-praci per ischiavi deire, e dacci da seminare,affinchè periti i coltiva-tori , non si riduca laterra in deserto.
20. Comprò adunqueGiuseppe tutta la terrad'Egitto, vendendo o-gnuno le sue possessio-ni pel rigordèllafame:e la rendè soggetta aFaraone,
21. Insieme con tut-ti i popoli da un'estre-mità deli* Egitto sinoali' altra.
2 2. Eccettua taia ter-ra de'sacerdoti data lo-
Vers. 18. Tornarono il secondo anno. Intendesi il secondoanno dopo la permuta de'bestiami, che era il quarto, o il quintodella gran carestia.
Vers. ai. Insieme con tutti i popoli (la un'estremità del"P Egitto aW altra. Il re essendo divenuto padrone di tutte leterre, e fin de'bestiami, i popoli erano divenuti suoi schiavi, nonavendo proprietà nemmen di «n palmo di terreno. Questo stestofatto è indicato anche da autori profani.
19 *

ge tradita, fuerat eis ,quibus et statuto, ciba-ria ex horreis publicispraebebantur. et idcirconon sunt compulsi ven~derepossessiones suas.
2 3. Dixit ergo Jo*seph adpopulus-. Ent utcernitiSj et vos, et ter»ram vestram, Pharaopossidet: accipite se-mina, et scrite agros%
24. Utfruges haberepossitis. Quintam par-tem regi dabitis : qua-tuor reliquas permutovobis in sementem, etin cibumjamiliis, et li-tteris vestris.
26. Qui responde-mnt\ Sabis nostra inmanu tua est: respi-ciat nos tantum domi-nus noster, et laetì ser-viemus regi.
26. Ex eo temporeusque in praesentem
ro dal re, a' quali si da-vano da'pubblici granaii viveri, e perciò nonfuron costretti a vende-re le loro tenute,
20. Disse adunqueGiuseppe a'popoli: Ec-co che , come vedete ,Faraone è padrone divoi, e della vostra ter-ra: prendete da semina-re, e seminate i campi,
2/f Affinchè possiateraccogliere. Darete aireil quinto: le altre quat-tro parti le lascio a voiper seminare, e permantenere le famiglie,e i figliuoli vostri.
26. Risposer quelli :La nostra salute è nel-le tue mani: solamenterivolga a noi lo sguardoilsignor nostro, e servi-remo con piacere al re.
25. Da quel tempofino al dì d'oggi in tut-
Vers. 22. Eccettuata la, terra de' sacerdoti ec. I sacerdoti ri-cevendo da'granai del re il vivere in quegli anni calamiitosi, noiafuron perciò costretti a vendere le loro possessioni. E notatoche queste possessioni i sacerdoti le aveano avute dal re ; lo chanon dovrà intendersi di quel re che regnava allora, ma di alcunaltro assai più antico. Diodoro di Sicilia scrive, che il terzode' terreni del paese fu assegnato da Osiri a' sacerdoti, affinchène spendesser 1' entrate ne' sacrifizii e nel culto degli dei.
Vers. 7,5. Serviremo con piacere al rei Saremo volentierinon sudditi) ma schiavi di Faraone,

diem in universa terraAEgypti regibus quin-ta pars solvitur : et fa-ctam est f/uasiin legem,absque terra sacerdo-tali, quae libera ab haccondition e fuit.
27. Habitavit ergoIsrael in AEgypto , idest, in terra G essen, etpossedit eam, auctus-que est) et multiplica-tus nimis.
28. Et vixit in eadecern^ etseptem annis:
factique sunt omnesdies vitae illius, centum'quadraginta septemannorum.
29. Cumque appropin-quare cerneret diemmartis suae^ vocavit fi-lium suum Joseph^ etdixit ad eum : Si inve-ni gratiam in conspe-ctu tuo, (\)pone manumtuam sub femore meo :et facies mihi miseri-cordiam, et veritatem,ut non sepelias me inAEgypto;
ta la terra d'Egitto sipaga il quinto a' regi :10 che è divenuto comeIf^gge, eccettuata la ter-ra sacerdotale, che è li-bera da questa servitù.
27. Abitò adunqueIsraele in Egillo , cioènella terra di Gessen, ene fu possessore, e s'in-grandì, e moltipllcò for-misura.
28. Ed ivi egli vìsseper diciassette anni : etutto il tempo di suavita fu di anni centoquaranta sette.
SQ. E veggendo, ebesi appressava il giornodella sua morte, chiamò11 suo figliuolo Giusep-pe , e gli disse : Se botrovato grazia dinanzia te , poni la tua manosotto la mia coscia: euserai meco dituà bon-tà , e fedeltà, e non da-rai a me sepoltura inEgitto ;
(i) Slip. 24 3,
Vers. 9.6. Sì paga il quinto a* regi, Così era al tempo di Mo-sè, e cosi continuò ad essere in appre&so , come vien raccontatoda Erodoto, Diodoro, Giuseppe, e s. Clemente d'Alessandria.
Vers. ag. Poni la tua mano sotto la mia coscia. V«&

3o.Sed dormiam cumpatribus meis, et aufe-ras me de terra hac,condasque insepulchromajorum meorum. Cuirespondit Joseph : Egofaciam, quod jussisd.
31. Et ille: Jura er*go , inquit^ mihi. Quofurante, adoravit IsraelDeum conversus ad le"ctuli caput*
30. Ma io dormiròco* padri miei, e tu miterrai da questa terra,e mi riporrai nel sepolcrode'miei maggiori. Rispo-se Giuseppe: Io farò quelche hai comandato.
31. Ed egli: Fanne a-dunque a me giuramen-to. E avendo quegli giu-rato , Israele rivolto alcapo del letticciuolo] ad-orò Dia,
JVon darai a me sepoltura m Egitto. Lo stesso leggesi'cliGiuseppe, cap. L. 24. Giacobbe (come gli altri patriarchi) muo-re nella fede ; poiché eleggendosi la sepoltura nella terra diChanaan dimostra la sua ferma credenza alle promesse di Dio,delle quali rimira da lungi l'adempimento, e negli animi de'suoìposteri ravviva la stessa fede, affin di tenerli distaccati da'beni,e dagli allettameli dell' Egitto, e disposti ad udire la voce diDio, e seguirla, allorché egli vorrà ch'ei ritornino in Chanaan.Giacobbe vuol essere sepolto in quella terra , nella quale ripo-sano i piissimi suoi progenitori Àbramo e Isacco, in quella terra,nella quale sola sarà un di il vero culto di Dio, e il suo tempio ;in quella terra, nella quale egli sa, che dee nascere, morire, edessere sepolto, e risuscitare il Cristo ; in questa terra speratadalla sua fede , nella quale era una figura, e un pegno della pa-tria celeste, in questa terra volle esser sepolto. Giacobbe morto( dice un antico interprete ) diede «' vìvi V esempio che nella spe-ranza della patria celeste amassero ilpegno dell'eterna eredita.
Vers. 3 o. Ma io dormirò co? padri miei. Professione chiarissi-ma dell'immortalità dell'anima.
Vers. 31. Israele rivolto al capo del lettìccìuolo adoro Dìo :I LXX. lesserò : Israele adorò la sommità^- del bastone di lui. Equesto passo è riferito dall'Apostolo (Hebr. xi. -2.1.,) secondo que-nta versione, la quale era in uso a' suoi tempi ; e il senso di que-sta lezione egli è, che Giacobbe rendette esteriormente onore al-la potestà di Giuseppe ; ma intcriormente adorò la regia potestàdi Cristo rappresentata da Giuseppe, che ne era figura. Vedi lenote a questo luogo nella lettera agli Ebrei.
* Fanne adunane a me giuramento. Non per diffidenzache avesse del figlio , ma per rimuovere qualunque difficoltà chent>nnr«; vwitAc.* A~ P«».^«(>

C A P O XLVIIL
Giuseppe vìsita Giacobbe ammalato : e questiadotta , e benedice i due figliuoli di lui , Ma-nasse, ed Ephraìm , e benché vi sì oppongaGiuseppe, il minore antepone al maggiore. Dàfinalmente a Giuseppe una porzione di più chea fratelli.
\.JjLis itaque trans*''actis, nuntiatum estJoseph, quod aegrota-retpater suus, qui as~sumptis duobus filiis^THanasse, et Ephraimtire perrexit.
2. Dictumque est se-ni'. Ecce filius tuus Jo-seph venit ad te. Quiconfortatus sedit in le-ctulo.
3. Et ingresso ad seait : Deus omnipotens(i) apparuit mihi inLuza, quae est in terraCkanaan, benedixitquemihi ;
4. Et ait i Ego te au-gebo^ et multiplicabO) etfaciam, te in turbas po-pulorum : daboque tibiterram hanc, et seminituo post te inpossessio-nem sempiternam.
1. Uopo che questecose furono in tal guisa
avvenute,Giuseppe ebbenuova, come suo padreera ammalato : ed eglipresi con sé i due figliuo-li, Manasse, ed Ephr aim,andò in fretta da lui.
2. E fu detto al vec-chio : Ecco che il tuo fi-glio Giuseppe viene atrovarti. Ed egli ripi-gliate le forze si pose asedere sul letticciuolo.
3. E quando queglifu entrato gli disse: Dioonnipotente mi apparvea Luza, che è nella ter-ra di Chanaan, e mi be-nedisse ;
4. E disse: T'ingran-dirò , e ti moltipliche-rò, e ti farò capo di unaturba di popoli, e daròquesta terra a te , e al-la tua stirpe dopo di tein dominio sempiterno.
/,\ C.,,, «Q ,*

6. Duo ergo filii tui,qui (i) nati sunttibiinterra AEgypti, ante-quam huc venirem adte, mei erunt ; (a) Eph*raim, et Manasses^sic-ut Ruben, et Simeonreputabuntur mihi.
6. ReliguQS autem ,quos genuerispost eos,tui #runt, et nomine fra-trum suorum vocabun*tur in possessionibussuis.
7* Mihi enim quan-do veniebam de Meso~potamìa, fi) mortua estRachel in terra Cha-
5.1 due figliuoli adun-que , che ti sono natinella terra d'Egitto, pri-ma ch' io venissi a tro-varti , saranno miei :Ephraim, e Manasse sa-ran tenuti per miei co-me Ruben, e Simeon.
6. Gli altri poi, cheti verranno dopo di que-sti, saranno tuoi, e por-teranno il nome de'lo-ro fratelli nella terra,che ognun di questi pos-sederà.
7. Imperocché quan-do io veniva dalla Me-sopotamia, mi morì Ra-chele nella terra di Cha-
(i} Sup. 4*. 5o. (2) Jos. 13. 7. et 29. (3) Sup. 35. i g.
Vers. 4- •"* dominio sempiterno. I discendenti di Giacobbepossedettero la terra di Chanaan sino alla venuta del Cristo ; ifigliuoli d'Abramo, d'Isacco, e Giacobbe, secondo lo spirito, pos-sederanno in eterno quella terra, di cui fu figura la Chananea.
Notisi ancora, che queste parole, darò questa terra a te, ealla tua stirpe dopo di le in dominio sempiterno, letteralmen-te possono intendersi, che questo dominio non avrà fine sino atanto che duri la nazione, a cui questo dominio è stato promes-so; perchè se questa nazione fosse distrutta e cessasse di essertìn popolo , e una repubblica , ella non potrebbe posseder piìiquella terra : tale è il caso degli Ebrei.
Vers. 5. Saranno miei. Io gli adotto per miei figliuoli, e mieisaranno non meno, che Rufoen, e Simeon. Nomina questi comemaggiori di età di tutti gli altri; onde s'intende, che se que' fi-gliuoli di Giuseppe sono agguagliati a Rubén , e Simeon, moltopiù agli altri' Quindi eglino saranno capi di due tribù diverse,e avranno non una porzione (come sarebbe avvenuto, se si fosserconsiderati come rappresentanti la persona di Giuseppe ) ; madue porzioni distinte avranno nella terra di Chanaan.
Vers. 6. Gli altri poi ... porteranno il nome de1 loro fratelli.Saranno contati in una delle due tribù di Manasse, e di Ephraim.Non veggiam. che Giusnnn*» avp«f> =>!»,-: «~i:,.~i:

naan in ipso itinere,eratfjue vernum tempuset ingrediebar Èphra-tam, et sepelivi eamjuxta viam Ephratae,quae alio nomine appel-latur Bethlehem.
8. Viclens autem fi»lios ejus dixit ad eum :Qui sunt Isti ?
9. Respondit : Fìllimei sunt, quos donavitmihi Deus in hoc loco.Adduc, inquit, eos adme, ut benedicam illis.
10. Oculienimlsraelcaligabant prae nimiasenectute; et dare vi"dere non poterat. Ap-plidtosque ad se deo»
naan nello stesso viag-gio , ed era tempo diprimavera, stando io perentrare in Ephrata, e laseppellii presso la stra-da di Ephrata , che conaltro nome è detta Be-thlehem.
8. E mirando i suoifigli, disse a lui: Que-sti chi sono?
o,. Rispose : Sono imiei figliuoli donatimida Dio in questo paese.Fa, che si appressino ame ( diss'egli ) affinchèio li benedica.
io. Imperocché gliocchi d'Israele si eranoottenebrati per la granvecchiaia, e non poteavedere distintamente.
Vers. 7. imperocché quando io veniva dalla Mesopotamia,mi mori Rackele ec. Queste parole tendono in primo luogo arendere ragione a Giuseppe del motivo, per cui egli, che aveatanta premura di esser sepolto co' padri suoi in Hebron , avessedato altra sepoltura alla cara sua sposa, alla madre di Giuseppe,Rachele. Or egli dice, che quando ella mori nel tornar ch' ei fa-cea dalla Mesopotamia, era di primavera, nella quale stagionemalamente posson salvarsi i cadaveri dalla corruzione ; e perciòla seppellì non in Ephrata, o sia Betlemme; perchè non volle Tche fosse sepolta tra gl'idolatri, ma bensì sulla strada, che menaa Betlemme. In secondo luogo queste parole tendono a determi-nare la parte principale del retaggio, che avrà Ephraim nellaterra di Chanaan: del qual retaggio avea in certo modo presoanticipatamente il possesso la madre Rachele coli* essere sepoltain quel luogo.
Vers. 8. Questi chi sono1? Essendoseglì indebolita la vista, nonavea finora saputo discernere, che fossero Ephraim e Manas&e 1«due persone , «he eran vicine a Giuseppe.

sctilatuS) et drcumple-xus eos,
11. Dixit ad filium<suum : Non sum frali-datus aspectutuo-.insu-per ostendit mihi Deussemen tuum.
12. Cumque tuìisseteos Joseph de premiopatris, adoravitpronusin terram.
l'ò.EtposuitEphraimad dexteram suam, idest, ad sinìstram Israel;Manassen vero in sì-nistra sua, ad dexte-ram scilicet patris, ap-plicuitque ambos adeum.
14- Qui extendensmanum dexteram po-$uit super caput Eph-raim minoris fratris \sinìstram autem supercaput Manasse, quimajor natu erat, com»mutans manus.
Ma appressati cfcefhmnquegli a lui, li baciò ,e tenendoli traile suebraccia,
11. Disse al suo figlio*Non mi è stato negatodi veder te : e di piùDio mi ha fatto vederela tua stirpe.
12. E Giuseppe aven-doli ripigliati dal senodel padre , s'inchinò fi-no a terra.
13. E pose Ephraimalla sua destra, vale adire alla sinistra d'Israe-le; Manasse poi alla suasinistra, cioè alla destrad?l padre, e fece cheambedue si accostasseroa lui.
14. Ed egli stesa lamano destra, la pose suicapo di Ephraim fratel-lo minore ; e la sinistrasul capo diManasse, cheera il maggior nato,lras-ponendo le mani.
Vcrs* 11. * Non mì e stalo negato. Non avrei creduto.Vers. 12. Avendoli ripigliati dal seno del padre. Si erant*
inginocchiati dinanzi a Giacobbe ; onde aveano il capo nel senodel vecchio. ; e Giuseppe, perchè non gli dessero pena , e perchèquesti li benedicesse, li fece alzare, e K pose dinanzi a Giacobbe.
Vers. 14. Trasponendo le mani. Ovvero: incrociando le ma-"ni. Questa preferenza data al minor figliuolo era un segno, comeavvertono i Padri, della preferenza, che avrcbbono i Gentili so-

15. (ij. BenedixitqueJacob filiis Joseph, etah'. Deus, in cujus con-spectu ambulaveruntpatres mei Abraham,et Isaac, Deus, quipascit me abadolescen*tia mea usque in prae»sentem diem :
16. (2) Angelus, quieruit me de cunctis ma-lis, benedicat puerisistis : et invocetur supereos nomen meum, no»mina quoque patrummeorum Abraham, etIsaac, et crescant inmultitudinem super ter"ram.
17. Tidens autemJoseph, quod posuisset
15. E Giacobbe bene-disse i figliuoli di Giu-seppe , e disse : Dio, al-la presenza del qualecamminarono i padrimiei Abramo , e Isacco,Dio, che è mio pastoredalla mia adolescenzafino al dì d'oggi :
16. L'Angelo, che miha liberato da tutti imali, benedica questifanciulli : ed ei portinoil nome mio, e i nomiancora de'padri mieiAbramo, e Isacco , emoltiplichino sopra laterra.
17. Ma reggendoGiuseppe, come il padre
( i ) ffebr. ii . ai. fa) Slip. 3i. 29. ei 3a. 2. Mail. 18. io.
pra i Giudei. Ephraim, dice nn antico interprete, e figura diquelle nazioni, le quali per mezzo della croce di Cristo , nelquale credettero, sono preferite a Manasse, vale a dire a?Giu-dei. Vedi Terlull. de Bapt. Osservano gì' interpreti, come nelleScritture si veggono molti figliuoli di età minore men conside-rati negli occhi degli uomini, essere preferiti a' maggiori di età:così Abele a Caino, Isacco a Ismaele, Giacobbe ad Esaìi, Phare*a Zara, Giuseppe a Ruben, Ephraim a Manasse, Mosè ad Aron-ne , Davidde a' sette fratelli.
Yers. 16. L'Angelo che mi ha liberalo ec. Ovvero: e r/uelVAn-gelo. Assai comunemente i Padri per quest' Angelo intendono lostesso Dio, e il titolo di suo liberatóre dato da Giacobbe a que-st'Angelo n' è un indizio assai forte, e non è cosa inusitata nelleScritture, che Dio sia chiamato con questo nome, come pure ch«talora a un Angelo diasi il nome di Dio. A Dio adunque doman1*da Giacobbe, che ratifichi, e dia effetto alla benedizione, ch'egMcon profetico spirito darà ad Ephraim , e a Miniasse.

pater suus dexterammanum super caputE/yhraìmt gravi ter ac-cepit, et appreìiensammanum patris levareconatus est de capiteEphraìm, et trans/erresuper caput Manasse*
18. Dixitque ad pa-trem : Non ita conventi^pater ; fjum hic est pri-mogenita : pone dex-teram tuam super ca-put ejus.
19. Qui rejiuens alt:S ciò, fili miy scio: et istequidem erit in populos^et multiplicabitur : sedfrater ejus minor> majorerit illo ; et semen il-lius crescef in gentes.
20. Benedixitcfue eisin tempore illo, dicens :In te òenedicetur Israelatque dice tur : faciattiòì Deus, sicut Eph-raim, et sicut Manas-
avea posta la mano De-stra sopra il capo diE-phraim , ne ebbe penagrande , e presa la ma-no del padre tentava dilevarla dal capo di E-phraim , e trasportarlasul capo di Manasse.
18. E disse al padre:Non va bene così, o pa-dre ; perocché questi èil primogenito: poni latua destra sul capo dilui.
io,. Ma quegli ricuso,e disse : Lo so , figliuolmio, lo so ; e questi an-cora sarà capo di popo-li , e moltiplicherà: mail suo fratello minoresarà maggiore di lui : ela sua stirpe si dilateràin nazioni.
20. E allora li bene-disse, dicendo: Tu saraimodello di benedizionein Israele, e si dirà:Faccia a te Dio , comead Ephraim e come a
Ver». 18. Non va bene così, o padre ec. Dio non avea rivela-to a Giuseppe quello che avea rivelato a Giacobbe. Giuseppe«ra anch' egli profeta ; ma Dio, che dà sua porzione a ciaschedu-no secondo ch' ei vuole, discuopre talvolta ali' uno quello cheali' altro nasconde.
Vers. ij). La sua stirpe ti dilaterà in nazioni. La tribù diEphraim fu effettivamente una 'delle più numerose 7 e possentid'Israele, e.fu la pritua nel regno delle dieci tribù.

se. Consdtuìtcjue Epk*raim ante Ma/lasse.
•il. Et alt ad Josephfilium suum: E n egomorior, et erit Deus vo»biscum, reducetque vosad terram patrum VG*strorum,
22. Do tibl (i) par-tem unam extra fratrestuos>quamtulide manu(2) Amorrhaei in già"diot et arcu meo*
Manisse. E pose E-phraim avanti a Manas-se.
21. E disse a Giusep-pe suo figlio : Ecco ch'iomi muoio , e Dio saràcon voi, e vi ricondurràalla terra de'padri vostri.
22. Io do a te esclu-sivamente a'tuoi fratelliquella porzione, che ioconquistai sopra gli A-morrei colla spada , ecoli'arco mio.
(i) i. Jos. 15, 7. et. 16. i, (ij Jor. 24. 8.
Vers. ift. Quella porzione , che io conquistai sopra, gliAmorrei. Questa porzione donata specialmente a Giuseppe è ilcampo comprato da Giacobbe, cap. xxxm. iq. Ma come dice egli,che questo campo lo conquisto ec. ? La risposta , che sembra pii*semplice, e anche coerente al testo sacro, si è, che dopo la stra-ge de'Sichimiti Giacobbe temendo l'ira de'Chananei si allonta-nò da que' luoghi, onde questo campo fu occupato dagli Amor-rei: per la qual cosa convenne a lui di ricuperarlo colla forza.
Ma pongasi mente alla fermezza invariabile della fede, cheera in Giacobbe. Egli pellegrino in Egitto non solamente riguar-da come infallibile per la sua stirpe il possesso di Chanaan, edivi vuol esser sepolto ; ma dispone in favor di Giuseppe , ede' suoi discendenti di una porzione dello stesso paese , la qualporzione non dovrà entrare nella divisione della stessa terra diChanaan; senza temere, che alcuno si opponga a questo smem-bramento, o metta ostacolo all'esecuzione di questa sua volontà:egli sa, ch'è padrone di quella terra, e che può disporne, benchéin tutta la sua vita nulla vi abbia avuto del suo fuori di quelcampo comprato col suo denaro. Quanto onore ('siami permei&Q.il dirlo ) fa a Dio una tal fede!

C A P O XLIX.
Giacobine moribondo benedice ad uno ad uno ifigliuoli ; ma per alcuni la benedizione è eam»biata in maledizione, e riprensione severa*Predice ad essi le cose future, e finalmentedichiarato il luogo di sua sepoltura sen muore.
1. V ocavìt autemJacob filios $uos> et alteis i (i) Congregami'ni, ut annuntiem, quaeventura sunt vobis indiebus novissimis.
2. Congregamini, etaudite^ filii Jacob, au-dite Israel patrem ve-strum.
3. Ruben primogeni-tus meus, tufortitudomea, et principium do-lorìs mei : prior in do-nis, major in imperio.
i. ÌLJ chiamò Già*cobbe i suoi figliuoli, edisse loro : Raunatevi,affinchè vi annunzi lecose , che a voi succe-deranno ne'giorni avve-nire.
2.Raunatevi, e ascol-tate, figliuoli di Giacob-be, ascoltate Israele vo-stro padre.
3. Ruben mio pri*mogenito , tu mia for-tezza , e principio delmio dolore : il primo aidoni, il più grande inpotestà.
fi} Deut. 33. 6.
Vers. i. Chiamò Gìacobbe i tuoi figliuoli, «e. Notisi l'auti*cTiissimo costume, secondo il quale i padri prima di morire la-sciavano i loro avvertimenti e ricordi a'figliuoli, e poi li benedi-cevano:' così fece Mosè, e Giosuè, e Tobia, e Mathathia, e lo«tesso Cristo. Qui Giacobbe raunati i figliuoli annunzia loro lecose, che avverranno ne1 tempi avvenire ; vale a dire ne' tempisusseguenti,, e prossimi, e remoti, nel quale annunzio contiensi«ache un gran tesoro di salutari avvertimenti.
Yers. 3. Tu mia fortezza. Primo frutto della mia vegeta etàE principio del fnio dolore. SÌ3 perchè i figliuoli portano

4. Effusus es, sicutaqua : non crescas \quia (i) ascendisticu-bile patris fui, et macu-lasti stratum ejus.
6. Simeon, et LevifratreSy vasa iniquità-tis bellantia*
4. Tu ti sei disperso,come acqua : tu noncrescerai ; perchè seisalito sul letto del padretuo, e hai profanato ilsuo talamo.
6. Simeon, e Levi fra-telli , strumenti mici-diali d'iniquità.
(i}Sup. 35. 22. i. Par. 5. i.
"Jnolte cure e sollecitudini a' genitori, sia peli* incesto commessoda lui. L'Ebreo può dare un altro senso, e tradursi: principio dimia robustezza, dì mìa fecondila , principio dijigliuolanza,come sono tradotte le stesse parole, Deuler. xxi. 17., e come quileggono anche i LXX.
Il primo a? doni. Il Caldeo, e le altre parafrasi, e s. Girola-mo, e comunemente gl'interpreti sottintendono tu saresti stato ;onde dice Giacobbe: tu saresti stato il primo a' doni; vale a di*re, a te come primogenito dovea spettare il diritto della doppiaporzione nella terra di Chanaan, e il sacerdozio, al quale eraannesso il diritto di ricevere le oblazioni. Questi due diritti diprimogenitura son qui accennati colla parola doni: il terzo èquello ebe segue.
Il più grande in potestà. Il primogenito avea u» quasi prìn*-cipato sopra gli altri fratelli. Vedi Gen. xxvu. 20. Cosi dovea es-sere; ma pel peccato di Ruben la doppia porzione fu data a Giu-seppe, cioè a'suoi figliuoli: onde i. Parai, v. n si dice trasferitala primogenitura da Ruben in Giuseppe, il sacerdozio a Levi,l'impero a Giuda.
\ers. 4- Tu li sei disperso come V acqua. Versando da un va-so l'acqua per terra, non rimane nel vaso nessun segno di quel-lo ebe ivi fn : cosi $ dice Giacobbe, tu, o Ruben, hai perduta tut-ta la tua dignità e grandezza , e nulla te n' è rimaso ; perchè tiabbandonasti ad una brutale passione, e facesti oltraggio allamoglie del padre tuo. Si potrebbe forse tradurre : ti sei svapo-rato , come acqua : come acqua, che bolle , e svapora fino a ri-dursi a nulla, còsi tu per la tua indegna passione ti sei svapora-to , e quasi annichilato in paragone di quello che eri.
JVbn crescerai. La tua libidine sarà punita anche colla ste-rilità. Quindi la tribù di Ruben fu sempre poco stimata, e discarso numero. Vedi Deuler. xxxu. 6.

6. In consilium eorumnon veniat anima mea,et in coetu illorum nonsit gloria mea; (i)quia in furore suo occi-derunt virum, et in vo-luntate suasuffoderuntmurum*
7. "Maledìctus furoreorum, quia pertinax,et ìndignatio eorum,quia dura 1(2) dividameos in Jacob, et disper»gam eos in IsraeL
6. Non abbia parte ailoro consigli l'animamia, e la mia gloria nonintervenga alle loro a-dunanze ; perchè nel lo-ro furore uccisero 1' uo-mo , e\iel loro mal ta-lento atterrarono la mu-raglia.
7, Maledetto il lorofurore perchè ostinato,e la loro indegnazione,perchè inflessibile: io lidividerò in Giacobbe, eJi dispergerò in Israele.
(i} Slip. 34. a5. (i) Jos. 19. i. et 21. i. etc.
Vers. 5. Simeon, e Levi fratelli. Simeon, e Levi umilissiminella fierezza, e nella crudeltà, sono fratelli nel male.
Strumenti micidiali <P iniquità. In tre parole descrive ilfurore, e la frode usata da questi contro de'Sichimiti.
Vers. 6; Non abbia parte alloro consigli V anima mia. Dete-stai, e detesto tuttora i perfidi, e crudeli loro disegni. ^
E la mia gloria non intervenga ec. La mia gloria e quil'istesso, che l'anima mia, come in varii luoghi de'Salmi.(Ps. xxrx. 13., xv. 9., vii. 6.} Ripete con maggior forza il senti-mento precedente": io sono stato, e staro sempre lontano dalleloro conventicole, nelle quali potè ordirsi una sì orribil tragedia.
Uccisero V uomo. 11 singolare pel plurale: ma qui questosingolare ha forza particolare: parlasi tuttora della strage diquei di Sichem.
E nel loro mal talento atterrarono la mitraglia. Nonperdonarono nemmeno alle mura delle case, e de'palagi, ovveroalle mura stesse della città.
Vers. 7.. Io li dividero in Giacobbe, e lì dispergerò in Israe-le. La loro unione nel mal fare la punirò col dispergerli nellaterra d'Israele, e nella eredità di Giacobbe , e separarli gli «nidagli altri. La tribù di Levi fu dispersa pelle città assegnatea'Leviti nelle terre dell' altre tribù ; e alla tribù di Simeon toc-cò per sua parte tm angolo nella tribù di Giuda, e quando quel-li di Simeon crebbero di numero, andarono a cercarsi delle ter-re nel deserto parte a Gador, e parte a Scir. Fedi i. Paralip. iv.

8. Judo,) te laudabuntfratres tui\ manus tuain cervicibus inimico*rum tuorum : adorabuntte filii patris tui.
g. Catulus leonis Ju-da : ad praedam , filimi, ascendisti : requie"scens accubuisti) ut leo,et quasi leaena : quissuscitabit eum ?
8. Giuda , a te daranlaude i tuoi fratelli : tuporrai la tua mano sullacervice dei tuoi nemi-ci : te adoreranno i fi-gliuoli del padre tuo.
9. Giuda giovin lio-ne tu , figliuol mio , seicorso alla preda : poi ri-posandoti ti sei sdraia-to , qual lione , e quallionessa : chi anderà astuzzicarlo ?i. Par. 5. 2.
87. 3t). 4^. Gli Ebrei dicono , che gli scribi, è i maestri de' fan-ciulli venivano quasi tutti da questa tribù, e per guadagnarsi davivere andavano chi in un Inogo, *ì chi in un altro a fare scuola.Cosi la dispersione de* Leviti, e anche di quelli della tribù diSimeon tornò in vantaggio della religione, e della pietà ; ondela profezia di Giacobbe per un certo lato è una benedizione.
Vers. 8. Giuda, a te daranno laude i tuoi fratelli. Allude alnome di Giuda, che vale, lodare , confessare. La madre aveaposto a lui questo nome per significare, che questo figliuolo eraper lei argomento di dar lode a Dio: Giacobbe dice ora, ch' eglimerita questo nome, perchè sarà lodato, e celebrato da tutti ifratelli. Vedremo in quante occasioni questa tribù si distinse so-pra le altre. Da questa nacque Davidde, e Salomone, e gli altrire fino alla cattività di Babilonia, e Zorobabele condottiere delpopolo nel suo ritorno della cattività, e finalmente ella è oltre-modo gloriosa per essere nato di lei il Cristo.
Tu porrai la tua mano sulla cervice de1 tuoi nemici. Perprostrargli, gettargli a terra.
Te adoreranno i filinoli del padre tuo. Non 'dice i fi-gliuoli di tua madre, ma i figliuoli del padre tuo per significare,che tutti quanti i figliuoli di Giacobbe renderanno a lui onore,e ossequio, come a primogenito. Rigorosamente parlando questaprofezia non ebbe il suo pieno adempimento, se non in Cristonato del sangue di Giuda, adorato da tutti gli uomini, come Dio,e Salvatore.
Vers. p. Giurìa., giovin lione: tu,fìgliuol mio, tei corso alla,preda. l'aria qui de'posteri di Giuda: quale è Giuda tra gli altrifratelli, tale dice che sarà la tribù di Giuda traile altre tribù;ciò si verificò principalmente sotto Davidde principe bellicoso,

io.(i)NONÀUFE-EETUR sceptrum deJud^ et dux de femoreejus,, donec veniat, quimittendus est, et ipseerit exspectado gen-tium.
io. Lo scettro NONSARÀ' TOLTO da Giù*da, e il condottiero del-la stirpe di lui, fino atanto che venga coìui,che dee esser mandato,ed ei sarà l'espeltàzioiiedelle nazioni.
Ci} Malt, 2. 6. Joan* i. 4$.
e conquistatore, e a lui, e alla sua tribù è ottimamente adattatila similitudine d'un giovin lione.
Poi riposandoti ti sei sdraialo, qual lione, e qual liones-sa. 11 regno di Salomone fu un regno pacifico , ma rispettato etemuto da tutti ; come un lióne o una lionessa non lasciano d'in*cuter terrore ; benché satolli di preda si stieno sdraiati per terra;
Vers. io. Lo scettro non sarà tolto da Giuda ...fino a tantoelle venga, colui, che dee èssere mandalo. Che ih queste parolesi contenga una certissima predizione del Messia, e un' epoca in-fallibile di sua Venuta, consta dalla tradizione non solamentedella Chiesa cristiana <, ma anche della Sinagoga. Tutte le para-frasi Caldaiche convengono nel senso di questa profezia; e i piùcelebri Rabbini non solo antichi, ma anche i moderni.
Noi vedremo la tribù di Giuda godere una speciale premi-nenza sopra le altre tribù,, prima che fosse re in Israele. VediIVurn. x. 14., xi. 3., vii. la., Josiie xvi. i., Jud. i. i. Dà Daviddefino alla cattività di Babilonia tutti i re di Gerusalemme furonodella stirpe di Giuda. Nel tempo della cattività troviamo de'giu*dici della medesima stirpe. Dan. MH. 4- Dopo il ritorno di Ba-bilonia questa tribù ebbe tal predominio, che diede il tiome atutta la nazione degli Ebrei, e i suoi ottimati ebbero autorità su-periore nel sinedrio, magistrato supremo, il quale, benché conAutorità limitata da'Romani, governò la nazione fino agli ultimitempi. Se i Maccabei, che èrano della tribù di Levi, governaro-no un tempo, e se i capi del sinedrio furono talora della stessatribù * la potestà^ che ebbero questi, venne in essi trasfusa dallatribù di Giuda ; la quale non perde perciò il suo impero, comenoi perde un popolo libero , che si elegga de' consoli, e de' ret-tori di altra nazione, i quali coli' autorità ricevuta da lui logovernino.
E anche da osservare, che dopo il ritorno dalla cattività imiseri avanzi dell' altre tribù si unirono, e s' incorporarono conGiuda, e fecero con esso un sol popolo. Cos; iu Giuda rimase lo

11 .Ligansadvineampullum suum, et ad vi*tem , o fili mi, asinamsuam. Lavabit in vinos totam suam, et in san-guine uvae palliumsuum.,
12. Pulchriores suntoculi ejus vino , et den-
11. Egli legherà allavigna il suo asinelio, ela sua asina, o figlio mio,alla vite. Laverà la suaveste col vino , e il suopallio col sangue del-1' uva.
12. Gli occhi suoi son,più belli del vino, e i
scèttro fino alla, venuta del Siloh, o, come traduce il Caldeo ,fino alla venuta del Messia , a cui il regno appartiene. DaGesù Cristo in poi Giuda non ha più nè stato , nè scettro , n>">autorità, e non è più un popolo. Gesù nato di quella tribù fon-da il suo nuovo regno , in cui raduna i Giudei fedeli, e le nazio-ni , le quali lo adorano come loro re , e loro Dio. Egli è il veroSiloh , cioè il Messo , o sia Ambasciatore spedito da Dio conautorità suprema, e a questo suo titolo alludesi in moltissi-'*ni luoghi dell'Evangelio, e di tutto il nuovo testamento. VediJoan. ix. 7., ec.
Ed ei sarà P espettazione delle nazioni. Le nazioni corre-ranno a lui, come se tutte lo avessero aspettato, e desiderato.Alcuni traducono 1' Ebreo: a lui obbediranno le genti: altri: alui si congregheranno, e si aduneranno le genti: cosi in Aggeo,cap. n. 8., i 1 Messia dicesi il desideralo da tutte le nazioni.
Vers. t i . Egli legherà alla vigna il suo asinelio, e la sua.àsina ... alla vite. I_Padrì generalmente prendono queste parolecome spettanti al Messia, dì cui nel versetto precedente; ed èforza di confessare , che non parlandosi qui di Giuda , come ap-parisce da quest' apostrofe : Egli legherà ^ vfigliuol mio ( oGiuda), ad altra persona non può piìnnrturalmente applicarciquello che qui si dice, se non a quella, di cui erasi già comin-ciato a parlare, cioè al Siloh. Del Messìa adunque con figure
rofetiche ragiona Giacobbe, e dice, ch'egli legherà col vincoloella fede il popolo Gentile alla sua vigna , vale a dire alla
Chiesa, la quale de' credenti Giudei fu primamente formata ; ela sua asina , vale a dire il popolo Ebreo avvezzo già al giogodella legge, legherà alla sua vite , vale a dire a sé stesso; peroc-ché egli è vera vite, come sta scritto , Joan. xv. i.
Laverà la sua veste col vino, e il suo pallio col sanguedelVuva. Vino, e sangue dclVuva sono la medesima cosa. Que-sto vino significa il sangue di Cristo sparso da lui in tanta copia ,che ne fu lavata non solo la veste interiore, cioè la carne di lui,ma anche l'esteriore veste, ciò?: la Chiesa.
Peni. Vol L 20
pd

tes ejus lacte candidio-res.
io. Zabulon in litto-re moris habitabìt, etin stallone navium per-fin gens usque ad Si»donem.
14- Issachar asinusfortis accubans interterminos.
io. Vìdit requiemquod esset bona, et ter-ram quod optima : et
suoi denti più candididel latte.
13. Zabulon abiteràsul lido del mare, e do-ve le navi hanno stazio-ne, si dilaterà fino aSidone.
i4« Issachar asino for-te giacerà dentro i suoiconfini.
15. Egli ha conside-rato , come buona cosaè il riposo, e che la sua
Vers. i a. Gli OócJii suoi son pili "belli elei vino, e ì suo! den-ti pììt candidi del latte. Descrivcsi la sovraumana bellezza delCristo, e particolarmente dopo la sua resurrezione.
Vers. 13. Zàbulon abiterà sul lido del mare, ec. Dugento an-ni prima della conquista della terra di Chanaan predice Giacob-be i luoghi, che dovean toccare in sorte a' suoi posteri ; e Mosèche tutte queste cose racconta, non entrò nè pur egli nella terrapromessa, la quale solamente dopo la sua morte fu conquistata,e divisa. Zàbulon più giovine è benedetto prima d'Issachar mag-giore di età ; e ciò da alcuni interpreti si crede fatto in graziadel Messia , il quale fu concepito inNazareth, e dimorò moltotempo in Capharnaum, che erano l'una e l'altra di questa tribù.
Si dilaterà sino a Sidone. Intendesi non sino alla città diSidone nella Fenicia, ma sino a'confini della provincia chiamataSidone nelle Scritture , dal nome della città capitale. Il paese diZàbulon a occidente finiva al mare Mediterraneo, e ad orienteal mare di Tiberiade.
Vers. 14-e 15. Issacha. asino forte ec. Questa comparazionea* tempi nostri parrebbe poco graziosa ; ma «n eroe da Omero èparagonato a uij asino per la fortezza, e per la pazienza ne' tra-vagli ; II. xii. È notato qui il naturale robusto e laborioso diquelli della tribù d'Issachar : e soggiunge, cn' ei si contenteran-no dì restare ne'loro confi.!», e lavorare in pace i loro buoni ter-reni, agando anche un tributo a'nemici piuttosto che far guerraper liberarsene. Vedi \. Paralìp.iin. 31 Alcuni spiegano un po'di-versamente, e dicono, che Issachar amò meglio di pagare un tri-buto al re d'Israele, che andar a servire nella milizia, la qualegodea l'esenzione dal tributo. Il paese, che toccò alla tribù d'Is-sachar, era maravigliosamente bello, e fertilissimo.

supposnìt TiJimerumsuum ad portandum,factusfjue est tributisserviens.
16. Danjudicabit po*pulum suum, sicut etalia tribus in Israel.
17. Fiatfiancoluberin via , cerasies in se-mita, mordens ungulasequi, ut cadat ascensorejus retro,
18. SALUTAREtuum expectabo, Do-mine. *
terra è o! lima: e ha spie-gato i suoi omeri a por-tar pesi, e si è soggetta-to al tributo.
16. Dan giudicherà ilsuo popolo , come qua-lunque altra tribù d'I-sraele.
17. Divenga Dan unserpente sulla strada,nel sentiero un ceraste,che morde l'unghie delcavallo per far cadere ilcavaliere ali'indietro.
18. LAvSALUTE tuaaspellerò io, o Signore.
Vers. 16. Dttn giudicherà, il mio popolo, come ec. È come sedicesse: il giudice farà giudizio, ec., alludendosi qui al nomedi Dan. Vedi cap. xxx. G. La tribù «li Dan avrà de'gin dici delipopolo d'Israele, come avere li possa qualunque altra tribù. Nonmancherà a lei quest'onore; benché Dan sia figliuolo di un' an-cella, e la sua tribù non sia delle più grandi. Gli Ebrei, e s. Gi-rolamo, e molti dotti interpreti vogliono, che qui sia accennatoSansone, e che di lui si parli anche nel Versetto seguente: egliera di questa tribù, e fu uno de'giudici d'Israele.
Vers. l'j. Divenga Dan un serpente sulla strada, Dan, cioèSansone, sarà come un serpente, il quale nascosto lungo la stra-da assalisce improvvisamente i passeggieri.
Nel sentiero un ceraste, che morde ec. Il ceraste è un serpen-te del color dell'arena, cornuto, (donde il nome di ceraste), ilquale non potendo offendere il cavaliere morde nel piede il ca-vallo per far cadere il cavaliere, e ucciderlo. Tedi Plin. IH). P.cap. 9,p. Così vuol significarsi, che Sansone opererà cose grand ianche più coli'astuzia, che colla forza. Vedi il libro de'Giudici!.Non debbo però tacere, che questo versetto da molti Padri è in-teso dell'Anticristo, il quale debba nascere da questa tribù , ecombattere la Chiesa non tanto colla forza, quanto coli' astuzia ,e colle frodi, e con ogni maniera di seduzione. Vedi quello cheabbiamo detto al capo vii. dell'Apocalisse, vera. f\.

io.. G ad accinctuspraeliabitur ante eum :et ipse accingetur re*trorsum.
20. Aser pìnguis po.-nìs ejus , et praebebitdeUcias regibus.
21. Nephtali, cervusemissus.etdans eloquio,pulchritudinis.
19. Gad armato ditutto punto combatte-rà dinanzi a lui: e si al-lestirà per tornare all'ia-dietro.
20. Grasso è il panedi Aser, e sarà la deliziade're.
21. Nephtali, cèrvomesso in libertà, eglipronunzia parole gra-ziose.
t Vera. 18. LA SALUTE tua aspetterò io, o Signore. Tene-rissima aspirazione di Giacobbe, il quale pieno di fede, di spe-ranza nel veto Liberator d'Israele dall'aver rammentato Sansoneil terrore de' nemici del popol suo prende occasione di volgersinuovamente a Dio per domandargli quella vera salute, ovveroquel Salvatore, che viene da lui, ch' egli manderà. Il Caldeo pa-rafrasò ia-tal guisa: Io non aspeltp la saltile di Gedeone fi-gliuolo di Joas, la quale e sol per un tempo, ne la salute diSansone figliuolo di Manne, la quale e transitoria; tna aspet-to la redenzione del Cristo figliuolo di David, il quale verràa chiamare a se i figliuoli (V Israele: la redenzione di lui ebramata daWanima mìa. Non è inutile 1' osservare in qual mo-do gli antichi Ebrei intendessero le Scritture , prima che lo spi-rito di cecità e di errore s'impossessasse della sinagoga.
"Vers. ip. Gad armato dì lutto punto combatterà dinanzi alui. Cioè^dinanzi, ovvero innanzi ad Israele, di cui vers. 16.Sembra che si accenni quello che leggiamo ne'Numeri, cap. xxxii.17., dove vedesi, come la tribù di Gad, e que'dì Ruben, e unaparte della tribù di Manasse, essendo stata loro assegnata la por-zione di là dal Giordano , si offersero a passare quel fiume in-nanzi a,tutti i loro fratelli per conquistare la terra di Chanaan.
E si allestirà per tornar alV indietro. Collocate le altretribù ne'luoghi, che ad esse erano destinati, se ne tornerannoque* di Gad finalmente alle loro stanze. Vedi Jo sue xxn., e s.Girolamo.
Vers. io. Grasso e il pane di Aser. Giacobbe commenda igrani del paese, che toccherà ad Aser. Mosè aggiunge C Deli-ter. XXXIH. 24) ch'egli abbonderà di olio prezioso; e si sa anco-ra, che avea de'vini eccellenti: tutto questo è espresso nobil-mente con dire, che i frutti di quel paese saran la delizia de*re.

22. (i) Filius accre-scens Joseph, filius ac-crescens, et decorusaspectu : filiae discur»rerunt super murum.
23. Sed exasperave»runteum^etjìtrgati sunttinvideruntque illi ha-bentes jacula.
22. Figliuolo crescen-te Giuseppe , figliuolocrescente , e bello di a-spetto: le fanciulle cor-sero sulle mura.
23. Ma lo amareggia-rono e contesero conlui, e gli portarono in-vidia i maestri di tirarfrecce.
(\) Par. 5. i.
Vers. ai. Nephtalì, cervo messo in libertà, ec. Gli Ebrei, econ essi alcuni interpreti riferiscono queste parole a Barach, cheera di questa tribù, il quale ebbe da principio la Umidità delcervo ; ma di poi nel perseguitare i nemici imitò il cervo stessonella celerilà. Le graziose parole, ch'ei pronunziò, sono il canti-co cantato da lui, a da Debora. Vedi Jud. iv. I LXX. lesserò :Ifephtali e come una pianta , che getta de* nuovi rami, e lemesse di cui sono buone. Nephtali avea quattro soli figliuoli,quando andò in Egitto, e la sua tribù era di quattrocento cin-quantatrè mila, e quattrocento uomini capaci di portar 1' armi,quando uscì dell'Egitto : gran moltiplicazione è questa in pocopiìi di dugenla A*mi.
Vers. aa. Figliuolo crescente Giuseppe, figliuolo crescen-te, ec. Giacobbe si diffonde con particolare affetto nel benedireGiuseppe; lo che egli fa non Unto per la tenerezza, ch' egli aveaverso questo figliuolo diletto, quanto per riguardo a colui, delquale fu sì bella ed espressa figura Giuseppe e ne' patimenti, enella gloria. Alludendo qui al nome di lui si dice , ch' egli è unfigliuolo, che va sempre di bene ia meglio, prospera, e si avan-za; e così sarà della sua tribù, o piuttosto delle due tribù, cheda lui avranno origine, Ephraim, e Manasse: egli soggiunge, chele fanciulle egiziane prese dall'avvenenza di lui correvano su'ter-razzi, quand'ei passava, affili di vederlo. Questa particolarità nonparrebbe degna della gravità patriarcale di Giacobbe, s'ella nouservisse a profeùzzare l'ardore, e l'impegno, con cui correrannoa Cristo le nazioni mosse dalle attrattive del più specioso tra' fi-gliuoli degli uomini, Psalm. 44-
Vers. a3. Ma lo amareggiarono, e contesero con lui. L'Ebreopuò tradursi: lo amareggiarono, e lo trafissero; nondimeno lanostra Volgata dà un ottimo senso: amareggiarono Giuseppe, evennero in rotta con lui que' maestri di frecce , quegli arcieri:così Giacobbe uoiiuaa quei suoi figliuoli, i quali co' delti morda-

»4- Sedit in fortiarcus ejus> et dissolutasunt vincula bracino-rum et manuum illiusper manus potentisJacob : inde pastor e-gressus estt lapis /-sraeL
2 b.Deuspatris lui eritadjutor tuus, et Omni-potens benedicet tibiòenedicdonibus coelidesuper, benedictioni-èus abyssi jacentis de-orsum, benedictionibusuberum> et vulvae.
24. L* arco di lui siappoggiò sul (Dio) for-te, e i legami delle brac-cia e delle mani di luifurono disciolti per ma-no del possente ( Dio )di Giacobbe: indi uscìegli pastore, e pietrad3Israele.
26. Il Dio del padretuo sarà tuo aiutatore,e 1' Onnipotente ti be-nedirà colle benedizionidi su alto del cielo, collebenedizioni dell'abisso,che giace giù basso, col-le benedizioni dellemammelle, e degli uteri.
ci, colle derisioni, e colle calunnie afflassero l'anima di Giusep-pe, e finalmente lo gettaron nella cisterna, e lo venderono; cosìcontro Cristo adoperaron le frecce della lingua gli Ebrei, e col-la spada della lingua 1' uccisero prima che Filato lo facesse cro-cifiggere: e a Cristo hanno relazione queste parole del patriarca.
"Vers. a4' L'arco di luì fi appoggiò sul (Dio) forte. Per l'ar-co inteudesi frequentemente la difesa: cosi qui dicesi: la difesadi Giuseppe posò tutta sopra l'assistenza del forte per eccellen-za, cioè Dio. Fedi Joab, XLIX. 20.
E i legami delle braccia e delle mani dì lui furono di-sciolti. Giuseppe tra le catene non fu dimenticato da Dìo : lasapienza eterna non abbandono il giusto venduto, e incate-nalo. Sap. cap, x. La mano del possente Dio di Giacobbe fuquella che spezzò le catene di Giuseppe.
Indi egli usci pastore, e pietra a' Israele. Per questo, per-ehè la mano dell'Onnipotente era con lui, per questo eglida' suoi combattimenti e travagli uscì rettore di popoli, e pie-tra fondamentale d'Israele, cui egli salvò dalla fame, e lo stabilìin ottima terra. Giuseppe fu il sostegno della nazione, guidade'fratelli, fermezza del popolo, come si ha, Ecclesiastici xux.17. Tutto ciò infinitamente meglio conviene a Cristo liberatodalla morte, e risuscitato per essere pastore del nuovo popolo,e pietra fondamentale della nuova Chiesa,

26. Benedictionem pa^iris tuicoìfortatae suntbenedicticnibuspatrumejus; donez veniret de-siderium ollium aeter-norumi fieni in capiteJoseph, & in verticeTSazaraei inter fratres$uo$.
26. Le benedizionidel padre tuo sorpassa-no quelle dei padri dilui ; fino al venire di luì.,che è il desiderio deicolli eterni: posino.«Ilesul capo di Giuseppe ,sul capo di lui Nazarenotra* suoi fratelli.
Vers. a5. Cóle benedizioni di su alto del cielo. Colle bene-dizioni, che venjono di lassù, cioè dal cielo.
Colle benedizioni delV abisso , che giace già basso. Sicco-me colle benediioni del cielo s'intendono le pioggie, cosi collebenedizioni dell'iusso s'intendono le sorgenti, le quali da' lun-ghi sotterranei soijono fuori, e scaturiscono ad irrigare, e fecon-dare la terra.
Colle benedizioni delle mammelle, e degli uteri. Intende-sì la fecondità dellelonne, e anche de'bestiami, e l'abbondanzadel latte nelle madri per nutrire*! loro parti : imperocché tuttoè dono, tutto è bentjizione di Dio, il quale dona ad ogni mo-mento ali' uomo anch\ quello che secondo le leggi della naturaordinate da lui fin da principio stabilì di concedergli. Tutte lebenedizioni, che può da>e il Cielo, tutte le benedizioni, che puòricever la terra, convenga a Cristo, in cui piacque al padre,che abitasse corporalmen,e tutta la pienezza della divinità , eda cui ricevè la Chiesa si^ sposa queli' ammirabile fecondità ,per cui è celebrata cotanto In Isaìa, cap. 4Q- e Co.
Vers. 26. Le benedizioni <*£ padre tuo sorpassano ec. Tra levarie sposizioni di questo luoj^ questa mi è paruta la più sem-plice, e anche più adattata al w$to originale. Le benedizioni, cheio do a te (dice Giacobbe), sor^ssano quelle, onde io fui bene-detto da'padri miei: tu sarai ben-detto P*ù & me» «opra di me,e di me più felice.
Fino al venir di lui, ch' e iliesiderìo de1 colli eterni: ec.Debbo osservare , che dove nella ncxtra Volgata si ha adesso do-nec veniret, in varii antichi luanosojtti di essa si ha donec ve-niat. Tutte queste benedizioni vengaUy sopra Giuseppe, sopra dilui, ch'è Nazareno tra'suoi fratelli, fino^ tanto che venga colui,ch'è il desiderio de'colli eterni, il quale amplissima benedizioneporterà a' posteri di Giuseppe, e al moi^0 tutto. Cristo è quichiamato il desiderio de'colli eterni; vale indire degli Angeli, edi tutte le creature spirituali: in lui, dice I\p0sioio Pietro, de-siderano gli Angeli di fissare lo sguardo^ Giuseppe è dettoNazareno tra1 suoi frateilit che vuol dir serrato, ovvero co-

27. Benlamin lupusrapax, mane comedetpraedamì et vespere di-videi spotia.
28. Omnes ìli in tri-àubus Israel duodecim.Haec locutus est eis p a-ter suuó, benedixitquesingulis benedizioni-bus propriis.
29. Et praecepit eis,dicens\ Ego congregorad popuhim meum\ se-pelite me cum patribusmeis in spelunca du-plici , quae est in agroEpkron Jfethaeì,
27. Beniamino luporapace, la mattina divò^rerà la preda, e la seraspartirà le spoglie.
28. Tutti questi capidelle dodici iribù d'I-sraele. Queste cose dis-se loro il pacre , e eia-scheduno diessi bene-disse colla rropria suabenedizione.
29. Diede poi loro or-dine, diceido : Io vo adunirmi al mio popolo:seppellitegli coi padrimiei nelle doppia caver-na, che è nel campo diEphronHetbeo ,
ronato , e distìnto tra' suoi fratelli ; egl f« separato e distintoper la sua innocenza, e per l'esimia vi>ù, e fu coronato, vale adire ebbe suprema potestà in Egitto Questo nome istesso cirappella il Cristo , di cui fu figura Giuseppe, il Cristo, che por-tò il nome di Nazareno, e fu segregato da tutti gli uomini, econsacrato a Dio, e unto re, e ponile.
Vers. 27. Beniarnin lupo rapac -, l& mattina ec. Descrivesi ilnaturale indomabile e fiero di qu-'i della tribù di Beniamin colritratto di un lupo, il quale al pattino si divora la preda, e lasera torna a spartirne della nuo^- Questo carattere de'Beniaruitiapparisce in quello che di essi accontasi, Jud. cap. xx.
Quasi tutti i Padri Latin'con s. Girolamo e s. Agostino, ealcuni anche de' Padri Grec' intendono queste parole di PaoloApostolo nato di questa tri'u, il quale la mattina, cioè ne' suoiprimi anni, fu lupo rapace» persecutor della Chiesa ; la sera poi,vale a dire ne' tempi veggenti dopo la sua conversione, arricchìla Chiesa di molte confate.
Vers. 28. CiaschetUno dì essi benedisse ec. Giacobbe nondiede qui veruna ben«dùtione a Ruben, nè a Simeon, nè a Levi;ma la riprensione, A'ei fece loro, tiene luogo di benedizione,in quanto per quest> nome s' intendono i sentkueuti, e i ricordidi un padre vicino a morire,

3 o. Contra Mambrein terra Chanaan , ( i )quam emit Abrahamcum agro ab EphronHethaeo in possessionnem sepulchri.
31. Ibi sepelierunteumì et Saram uxoremejus : ibi sepultus estIsaac cum Rebecca con-juge sua: ibi et Liacondita jacet,
32. Finitisque man-datìs , quibus fdios in-struebat, collegit pe-des suos super lectu-lum, et obiit: appositus-que est ad populumsuum.
5o. Dirimpetto aMambre nella terra diChanaan , la quale A-bramo comprò insiemecol campo da EpbronHetheo per avervi unsepolcro.
31. Ivi fu sepolto e^gli, e Sara sua moglie :ivi fu sepolto Isacco conRebecca sua moglie: ivifu sepolta anche Lia.
32. Finiti poi gli av-vertimenti dati da luiper istruzione de fi-gliuoli , raccolse i suoipiedi nel letlicciuolo, esi mori : e andò ad u»nirsi al suo popolo.
Vers. 3a. Raccolse i suoi piedi nel letticcìuolo. Egli nel tem-po, che parlava a'figliuoli, sedeva sopra un lato del letto co'pie-di in fuora: finito che ebbe di parlare raccolse i piedi nel letto,e rendè lo spirito. Questa è la descrizione di un nomo, il qualedisponendosi a pigliar sonno accomoda le su« membra in quelsito, che pili gli pare ; ma la morte del giusto non è altro, cheun dolce sonno^ Abbiamo in varii luoghi osservato, come questogran patriarca nella sua vita laboriosa, e piena di patimenti e diaffanni fu una figura di Gesù Cristo l'uomo de' dolori, e provatone'travagli come chiamollo Isaia: quello, che io desidero, che sinoti particolarmente in lui, si è la fede immobile, e fermissimaalle promesse di Dio. Egli vede il figliuolo quasi re in Egitto,vien dato a lui in quel regno un paese fertilissimo , e pienod'ogni bene: tutto questo non è capace d'intiepidire in lui il de-,siderio di quella terra, nella quale volea Dio stabilita la sua di-scendenza: egli non vuole nemmeno , che le sue ossa restino inEgitto; ma ordina che sieno portate nella terra di Chanaan,della quale non solo conferma ad essi il dominio con questa dis»
(i) Slip. 2 3. in.

C A P O L.
Giuseppe fatto imbalsamare il corpo del padre ,ve fatto il duolo funebre s va co1 seniori d'Egit-to a seppellirlo nella terra di Chanaan\ e aven»do compiuta la cosa con grande solennità, ab*braccia benignamente, e consola i fratelli,che temevan di sé a motivo delle passate in»giurie. Egli dopo aver ordinato^ che neWuscirdaW Egitto portin seco le sue ossa nella ter»ra di Chanaan s riposa in pace.
1. \^/uod cernensJoseprTruit super fa*ciem patris fiens 3 etdeosculans eum.
2. Praecepitcjue ser-vis suis medicis.ut aro*matibus condirent pa*treni.
3. Quibus jussa ex*plendbus, transieruntquadraginta dies : istee/uippe mus erat cada*
1. v^iò avendo ve-duto Giuseppe si gettòsulla faccia del padrepiangendo, e bacian-dolo.
2. E ordinò a'm edicisuoi servi, che imbalsa-massero il padre.
3. £ quaranta giornipassarono, mentre que-gli eseguivano puntual-mente il suo comando:
posizione, ma molto più colla divisione delle parti di essatra' suoi figliuoli.
Vers. a. Ordino a? medici... che imbalsamassero ce. L' usod'imbalsamare i cadaveri fu comunissimo presso gli Egiziani,da'quali lo presero gli Ebrei. Si vede, che questo mestiere d'im-balsamare dovea es&erVfiroprio de' medici, i quali erano in nu-mero grandissimo nell' Egìitp, dove ogni specie di malattia aveai suoi medici, che non s'impafceiai^iuv se nonjdLjjuella. La ma-niera tenuta nell'imbalsamare è descritta da Erodoto e da Stra-bene. È notissimo, come i corpi imbalsamati all'egiziana si con-servavano anche per molti secoli: anzi fino al dì d'oggi si trova-uo di questi cadaveri, o mummie conservate assai bene.

verum conditorum : fle-vitque eum Mgyptus se-ptuaginta diebus,
4. Et expleto pian-eius tempore, locutusest Joseph ad familiamPharaonis : Si invenigratiam in conspectuvestro^ loguimini in au«ribus PharaoniSy
5. Eo quod patermeus adjuraverit z/ze,dicens : En morior ; insepulchro meo ( i ),guodfodi mihi in terra Cha**naan> sepelies me» A"scendam igitur, et $e-peliam patrem meum,ac revertar.
imperocché cosi porta-va il costume riguardoall'imbalsamare i cada-veri: e l'Egitto fu inlutto per settantagiorni.
4* E finito il tempodel duolo, disse Giusep-pe alla famiglia di Fa-raone : Se io ho trovatograzia dinanzi a voi,insinuate à Faraone,
5. Che il padre mìofacendomi giurare diobbedirlo, mi disse : Iomi muoio : tu mi sep-pellirai nella mia sepol-tura, che mi scavarnel-la terra di Chanaan.Anderò dunque a sep-pellire il padre mio, epoi tornerò.
(i).Sup. 47. 29.
Vers. 3. E V Egitto fu in lutto per settanta giorni. Il luttode' re d'Egitto non durava, se non due giorni di più, cioè settan-tadue giorni. Si vede da ciò, come fosse onorata la memoria diGiacobbe. I riti, o sia le stravaganze, che si osservavano dagliEgi-ziani nel lutto de' privati, e de' re, sono descritte da Erodete», daPomponio Mela, e da Diodoro.
Vers. 4- Disse alla famiglia di Faraone, ec. Credesi, cheGiuseppe usasse di tal mezzo per far intendere il suo desiderioa Faraone, perchè il tempo del lutto finito per gli altri, non es-sendo finito per lui, nè dovendo finire, se non dopo la sepolturadel padre, non poteva egli contro il costume presentarsi in abitodi duolo dinanzi al re. Vedi cap~ XLI. 17.
Vers. 5. Nella mia sepoltura, che mi scavai ec. Si vede, chenella doppia caverna Giacobbe si era preparato il luogo, doveavea da riporsi il suo corpo,

6. Dixitque ei Pha-rao: Ascende, et sepelipatrem tuum, sicut ad'juratus es.
7. Quo ascendente,ierunt cum eo omnessenes domus Pharao-nis, cuncdque majoresnatu terras AEgypti:
8. Domus Josephcum fratriòus suis, abs-que parvulis, et gregi-bus, atque armentisquae dereliquerant interra Gessen.
g. Habuit quoque incomitatu currus, et e-quites-. et facta est tur-ba non modica.
io. Veneruntque adaream Atad, quae sitaest trans Jordanem :ubi celebrantes exse-quias planctu magno,atque vehementi, im-pleverunt septem dies.
6. E Faraone gli dis-se : Va, e seppellisci ilpadre tuo, come pro-mettesti eoa giura-mento.
7. Ed egli andò, eandaron con lui tuttigli anziani della casa diFaraone, e tutti i prin-cipali della terra d1
Egitto :8. E la casa di Giu-
seppe co'suoi fratelli,lasciando ji fanciulli, ei greggi, e gli armentinella terra di Gessen.
9. Ebbe ancora ac-compagnamento di car-ri, e di cavalieri, e fuuna non piccola turba.
10. E giunsero all'aiadi Atad, che è situatadi là dal Giordano: doveimpiegarono sette di acelebrare il funeralecon duolo grande, eprofonda»
Ver», y. Gli anziani della cata dì Faraone. Il titolo di an»alano riguarda non tanto l'età, come la dignità.
Vers. io. Giunsero &W aia di Atad. La Volgata sembra, cheabbia preso Atad per nome di un uomo, se non debbe inten-dersi: giunsero^ alV aia detta Atad, o sia delle spine. S. Girola-mo dice, etc questoluogo ebbe dipoi il nome di Bethagla.
Situata di là dal Giordano. Sulla riva occidentale delGiordano.

11. Quod cum vidìs-$ent habitatores terreteChanaan dìxerunt iPlanctus magnus estiste AEgyptiis. Et idcir-co vocatum est nomenloci illius Planctus AE-gypti.
12. Fecerunt ergo fi-lii Jacob, sicut praece-perat eis.
13. Etportantes eumin terram Chanaan, se-pelierunt eum in spe-lunca duplici, ( i ) quamemerat Abraham cumagro in possessionemsepulchri ab EphronHethaeo contra faciemMambre. Act. 7. 16.
14- Reversusque estJoseph in AEgyptumcum fratribus suis , etomni comitatu, sepultopatre.
16. Quo mortuo , ti-mentes fratres ejus , etmutuo collofjuentes: Neforte memor sit inju-riae, quam passus est,et reddat nobis omnemalum, quod fecimus\
(i) Sup. f.3. 16.
11. Lo che osservatoavendo gli abitatoridella terra di Chanaatidissero : Gran duolomenano gli Egiziani.E per questo fu chia-mato quel luogo il Duo-lo dell'Egitto.
12.Fecero adunque ifigliuoli di Giacobbe,come egli avea lor co-mandato.
13. E portatolo nellaterra di Chanaan, loseppellirono nella dop-pia caverna^ la qualeAbramo avea compratainsieme col campo di-rimpetto a Mambre daEphron Hetheo perfarne una sepoltura.
i4»E Giuseppe tornòin Egitto co'suoi fratel-li , e con tutto il suoaccompagnamento, se-polto che fu il padre.
16. Dopo la mortedel quale vivendo intimore i fratelli, e di-cendo tra di loro : Chisa, ch'ei non si ricordidell'ingiuria sofferta, enon voglia renderci tut-to il male, che a lui fa-cemmo ?

16. Ittandaverunt ei'dicentes : Pater tuuspraecepit nobis ante-quam moreretur^
17. Ut haec tibi ver-bis illius diceremus iObsecro, ut oblivisca-ris scelerisfratrum tuo-rum, et peccati atquemalitiae, quam exer-cuerunt in te', nos quo-que oramus, ut servisiDei patris lui dimittasiniquitatem hanc. Qui-bus auditiS) flevit Jo-seph.
18. Veneruntque adeumfratres sui et pro-ni adorantes in terram,dixerunti Servi lui su-mus.
19. Quibus ille re-spondit : N'olite amereinum Dei possumus re-sìstere voluntatis
16. Mandarono a dir-li : II padre tuo primadi morire ci comandò,
17. Glie a nome suoti dicessimo : Di graziaponi in dimenticanzala scelleraggine de'tuoifratelli, e il peccato, ela malizia usata da lorocontro di te : noi pureti preghiamo di perdo-nare questa iniquità a'servi del Dio di tuopadre. Udito questo,pianse Giuseppe.
18. E andarono atrovarlo i suoi fratelli,e prostrati per terraadorandolo, dissero :Noi siam tuoi servi.
19. Rispose loro :Non temete : possiamnoi resistere al voleredi Dio ?
Vcrs. 16. Mandarono ci dirgli : il -patire tuo èc. Credési, chel'imbasciata la portasse Beniamin, il quale non avea avuto veru-na parte a quello clic era stato fatto a Giuseppe : e credesi an-cora , che il timore faccia dire a questi fratelli una menzogna.Giacobbe conosceva assai bene la mansuetudine, e la carità diGiuseppe; onde non temè, ch'egli potesse giammai pensare avendicarsi
Vers. ip. Possiamo noi resìstere al volere dì Dio ? Giuseppeper consolare e rianimare i fratelli vuole, clic in tutto quello
, ch' è avvenuto riguardo a lu i , considerino le sole disposizionidella Provvidenza divina, la quale permise il loro odio, e la lo-ro persecuzione contro di lui, per trame quel gran bene, ch' essivedevano; vale a dire perchè egli fosse la salute di molti popoli ,

2 o. Vos cogitastis deme malum • sed Deusvertit illud in bonum,ut exaltaret me, sicutin praesentiarum cer-nitis, et salvos faceretmultas populos.
Sup. 46. 5.21. Nolite limerei ego
pascam vos , et parvu-los vestros. Consola»tusque est eos, et blan-de , ac leniter est locu*tus.
Sup. 4?. 12.22. Et Jiabitavit in
'AEgypto cum omni do-mo patris sui", vixitquecentum decem annis.Et viditEphraimfiliosusque ad tertiam gene-rationem. (\) Filii quo~que Macliirfilii Manas-se nati sunt in genibusJoseph.
23. Quibus trans a»ctis^ (2) locutus est fra-
20. Voi faceste catti-vi disegni contro dime ; ma Dio li convertìin bene affine di esal-tarmi, come vedete dipresente, e salvar mol-ti popoli,
21. Non temete : ionutrirò voi, e i vostripargoletti. E gli conso-lò, e parlò loro con dol-cezza, e mansuetudine.
22.Ed egli abitò^iell5
Egitto con tutta la fa-miglia del padre suo :e visse cento dieci an-ni. E vide i figliuoli diEphraim fino alla terzagenerazione. I figliuoliancora di Machir fi-gliuolo diìVIanasse furonposti sulle ginocchia diGiuseppe.
23. Dopo tutte que-ste cose disse egli a'
(i) Num. 3a. 3g. (•>.) Hébr. 11. 12.
e principalmente fie' suoi stessi persecutori. E in questo ancoraegli è simile a quel divino originale, di cui fu vivissima copia intutto il tempo di sua vita.
* Possiam noi resistere al volere dì Dio? Ritorna la stes-sa frase del cap. XXX. v. ?-. E con essa vuol significarsi, che nonè possibile 1' alterare le divine disposizioni, per cui il delittode'fratelli di Giuseppe sarebbesi convertito in loro profitto.

tribus suis: Post mor-tem meam Deus vìsita-bit vos*) et ascenderevos faciet de terra istaad terram , quam jura-vit Abraham^ Isaac, etJacob.
24- Cumque adjuras-set eos, atque dixisset:Deus visitabit vosi (i)asportate ossa mea vo-biscum de loco ìsfo:
26. Mortuus est, ex-pletis centum decem vi-tae suae annis. Et con"ditus aromatibus re-positus est in loculo inAEgypto.
suoi fratelli : Dio vi vi-siterà dopo la mia mor-te, e faravvi passM^daquesta terra alla teìPrapromessa con giura-mento ad Abramo, adIsacco, e a Giacobbe.
24* E fattili giurare,dicendo : Quando Diovi visiterà, portate convoi da questo luogo lemie ossa:
20. Si mori, compiu-ti i cento dieci anni disua vita. E imbalsama-to fu riposto ia unacassa nell'Egitto.
(ij Exod. 13. io. Jos. 24. 32.
FINS DEL LIBRO DELLA. GENESI,
Ver*. «4- * Portate con vói le mie ossa. Imita Giuseppe lapietà e la religione de'padri suoi, ma si adatta a'tempi, ed ècontento che le ossa sue vengano trasferite d'Egitto, quando aDio piacerà visitarvi il sno popolo. Confida intanto, che queste,depositate nel luogo della sua morte, renderan bene affetti gliEgiziani a Israele, qual monumento de' benefizii divini lor com-partiti per mezzo suo.