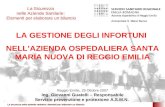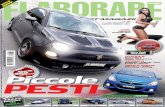file · Web viewCorso di formazione per docenti . Materiale tratto dal Master Università Roma 3 ....
Transcript of file · Web viewCorso di formazione per docenti . Materiale tratto dal Master Università Roma 3 ....

Corso di formazione per docenti
Materiale tratto dal Master Università Roma 3
Di fronte ad una tale situazione è necessario dunque elaborare strategie e risposte educative all’altezza dei problemi del presente. I processi di globalizzazione in atto e la configurazione in senso multiculturale delle odierne società interrogano profondamente i sistemi educativi e formativi che devono oggi mirare alla formazione dei cittadini del mondo. La formazione interculturale degli insegnanti occupa, in tale prospettiva, un posto di tutto rilievo: è solo a partire da una corretta impostazione del lavoro educativo nella scuola che si può sperare di diffondere una sempre più necessaria “cultura della convivenza”. Non si tratta di un obiettivo facile: insegnanti ed educatori per primi sono chiamati a rimettere in discussione i propri paradigmi di riferimento con l’obiettivo di attenuare il tasso di etnocentrismo presente nel nostro sistema educativo
. E’ possibile affermare, tuttavia, che la ricerca educativa e le pratiche interculturali si muovono sostanzialmente lungo due assi principali. In primo luogo fare educazione interculturale significa lavorare per individuare, progettare e sperimentare le strategie educative e didattiche più idonee per favorire un positivo inserimento degli stranieri ( ma la scuola e i servizi socio-educativi e formativi in questo compito non possono essere lasciati soli) (MIUR, 2006, 2014 e 2015). Ciò implicala predisposizione delle condizioni necessarie per garantire a tutti i soggetti (autoctoni e immigrati) di ottenere gli stessi tassi di successo scolastico (Santerini, 2010).
L’accoglienza si compone di diversi aspetti: burocratici, organizzativi, affettivo-relazionali, educativo-. - insegnamento dell’italiano come L2: questo aspetto è assolutamente centrale (Vaccarelli, 2001; Favaro, 2002; Vedovelli, 2002; Favaro, 2011). Le competenze linguistiche sono alla base di ogni processo di integrazione ed è necessario insegnare l’italiano in modo diverso a chi è alfabetizzato in un’altra lingua; e, tuttavia, tale insegnamento non può che avvenire all’interno delle normali classi scolastiche, evitando la costruzione di luoghi separati di apprendimento; tale scelta non è messa in discussione da pratiche di divisione in gruppi, per brevi periodi e per specifici apprendimenti (laboratori linguistici). Il punto centrale dell’azione di inserimento è proprio la possibilità, per l’alunno straniero, di entrare in contatto con i coetanei, dai quali, in modalità formali e non formali, apprenderà non solo le forme

linguistiche più immediate, ma anche le forme della comunicazione e le regole del gruppo di accoglienza
valorizzare il plurilinguisno dando visibilità alle altre lingue e ai vari alfabeti, scoprendo i “prestiti linguistici” tra le lingue ecc.; • il plurilinguismo individuale: il mantenimento della lingua d’origine è un diritto dell’uomo ed è uno strumento fondamentale per la crescita cognitiva, con risvolti positivi anche sull’Ital2 e sulle LS studiate nella scuola
assumere una prospettiva interculturalmente connotata significa impegnarsi rispetto all’obiettivo di favorire abiti di accoglienza negli italiani. Ciò può e deve tradursi nella revisione, nella rivisitazione e nella rifondazione dell’asse formativo della scuola che non deve mirare solo alla formazione del cittadino italiano, ma soprattutto alla formazione del cittadino del mondo
il passaggio alla didattica interculturale delle discipline che consiste nella revisione dei curricoli e dei programmi di insegnamento scolastici (Brunelli, Cipollari, Pratissoli, 2007; Fiorucci, 2011c; Luatti, 2009; Santarone, 2012 e 2013). Per fare qualche esempio: nell’insegnamento della storia vi sarebbe da rivisitare il tema della scoperta/conquista dell’America (Todorov, 1992; Todorov, Baudot, 1997) e degli incontri tra popoli nell’età di Colombo (Abulafia, 2008); vi sarebbe da riconsiderare la vicenda delle crociate anche attraverso il punto di vista degli storici arabi (Gabrieli, 1957; Maalouf, 1989), vi sarebbe da riscoprire la storia stessa del“Mediterraneo” (Braudel, 1977; Riccardi, 1997) come spazio di dialogo e di incontro tra civiltà; sarebbe importante rileggere lo stretto rapporto che lega Europa e Asia e quello che è stato definito il “furto della storia” (Goody, 2008 e 2010), così come sarebbe necessario rivisitare l’esperienza coloniale italiana (Di Sapio, Medi, 2009; Tomasello, 2004; Labanca, 2015; Ertola, 2017); per l’insegnamento della geografia si pensi al ruolo che potrebbe svolgere la conoscenza anche di altre rappresentazioni cartografiche del mondo come, per fare un esempio, quella proposta da Arno Peters (1988; Grillotti Di Giacomo, 2011); per l’insegnamento della matematica (Cappelletti, 2000a e 2000b; Ascher, 2007;Supino, 2011) e della filosofia (Bernal, 1997; Melchiorre, 2014; Nkafu, 2003) si pensi alle molteplici influenze culturali che ne hanno determinato lo sviluppo, ecc.; per la musica si pensi alla dimensione interculturale del jazz, del blues e della world music;per l’economia si pensi alle forti correlazioni esistenti fra migrazioni e globalizzazione economica

Per progettare in maniera efficace l’accoglienza dei bambini stranieri può essere, ad esempio, predisposto un “protocollo d’accoglienza”, in cui confluiscono l’insieme degli interventi, delle strategie, delle strutture operative di cui gli istituti decidono di dotarsi, tra cui essenzialmente: - le procedure messe in atto al momento dell’iscrizione; - le strategie per “la prima conoscenza”; - i criteri per l’assegnazione dell’allievo alla classe; - altri dispositivi d’accoglienza, quali gli strumenti offerti da centri di documentazione interculturale o la destinazione di risorse professionali apposite. In questa fase può, inoltre, essere importante raccogliere la storia personale del bambino straniero, ottenendo così informazioni anche sul sistema scolastico di provenienza, costruendo, altresì, una comparazione con quello italiano, ponendo attenzione ai modelli.
Il lavoro per gruppi sotto la guida del docente è quello più indicato, poiché è necessario sviluppare continuamente il confronto delle opinioni, dal momento che il rapporto con il “diverso” implica un coinvolgimento psicologico influenzato anche da luoghi comuni e da agenti esterni alla scuola
. Gli esempi, tratti anche da autori molto noti, sono numerosi: Edmondo De Amicis, conosciuto soprattutto per il libro Cuore, ha affrontato nel romanzo Sull’oceano (1889) il tema dell’emigrazione italiana in Argentina negli anni Ottanta dell’Ottocento; Carlo Levi, in Cristo si è fermato ad Eboli (1945),descrive in un capitolo l’emigrazione lucana negli Stati Uniti durante il periodo fascista; Leonardo Sciascia 14 La produzione di Tahar Ben Jelloun è molto ampia. Tra i suoi romanzi, però, Nadia (2002) e A occhi bass
Nella fase iniziale si può fare ricorso a strumenti e figure di facilitazione linguistica (cartelloni, alfabetieri, carte geografiche, testi semplificati, strumenti audiovisivi o multimediali, ecc.) promuovendo la capacità dell’alunno di sviluppare la lingua per comunicare. Successivamente va prestata particolare attenzione all’apprendimento della lingua per lo studio perché rappresenta il principale ostacolo per l’apprendimento delle varie discipline.
… I minori stranieri vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo… che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: dell’ordinamento degli studi nel Paese di provenienza, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica; del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza; del titolo di studio eventualmente posseduto;

dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione”. La stessa normativa richiede che il collegio dei docenti formuli proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi, evitando la costituzione di classi in cui risulti predominante la loro presenza ai fini di una migliore integrazione
La relazione interculturale opera il riconoscimento dell’alunno con la sua storia e la sua identità, evitando, tuttavia, ogni fissazione rigida di appartenenza culturale e ogni etichettamento. Formare in senso interculturale significa riconoscere l’altro nella sua diversità, senza tacerla, ma neanche creando “gabbie etnico/etno culturali”, esprimendo conferma e attivando canali di comunicazione senza riduzionismi.
La classe interculturale si presenta, in sintesi, come un luogo di scambio con l’esterno, uno spazio di costruzione identitaria di tutti gli alunni, ed in particolare di quelli immigrati, dove compito dell’insegnante sarà quello di favorire l’ascolto, il dialogo, la comprensione nel senso più profondo del termine. Allo stesso tempo, si favorisce la socializzazione degli alunni anche nello spazio extra-scolastico e nei gruppi di pari
L’educazione interculturale come “educazione alla diversità” deve tendere a svilupparsi su due dimensioni complementari. La prima è mirata ad ampliare il campo cognitivo, fornire informazioni, promuovendo la capacità di decentramento, con l’obiettivo di mostrare la varietà di punti di vista da cui osservare una situazione, organizzandone lo scambio
di riposta positiva e di possibili collaborazioni tra scuola e territorio, segnaliamo tre necessità e attenzioni. La prima necessità è quella di portare a sistema e di diffondere la conoscenza delle situazioni positive e consolidate, in termini di: modalità di collaborazione interistituzionale (protocolli tra enti locali e scuole, vademecum operativi); azioni realizzate; integrazione delle risorse; elaborazione e diffusione di materiali e strumenti; coinvolgimento delle associazioni, delle comunità immigrate, delle famiglie straniere; coinvolgimento dei mediatori culturali, formazione degli operatori e dei docenti
Per favorire il processo di inclusione dei minori stranieri nelle città e nelle comunità, la scuola e il territorio devono lavorare in maniera congiunta, fianco a fianco, per far sì che i luoghi comuni diventino davvero luoghi di tutti

E’ necessario, sin dall’iscrizione, una chiara ricognizione del pregresso scolastico dell’alunno per interventi specifici e la stretta collaborazione della famiglia per la definizione del suo percorso formativo. • La documentazione All’atto dell’iscrizione, devono essere richiesti i documenti appresso elencati e compilata la domanda di iscrizione predisposta dall’istituto
Documenti sanitari Il documento attestante le vaccinazioni obbligatorie effettuate deve essere tradotto in italiano. Di recente è stato chiarito che i dirigenti degli istituti di istruzione statale, o non statali, sono tenuti ad accertare se sono state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione. Se il minore ne è privo, la famiglia può rivolgersi ai servizi sanitari perché rilevino la situazione vaccinale ed eseguano l’intervento sanitario eventualmente necessario. In ogni caso, la mancanza di vaccinazioni non può precludere l’ingresso a scuola, né la regolare frequenza.
Utile a tal proposito potrebbe essere un foglio informativo, tradotto nelle diverse lingue, che spieghi l’organizzazione della scuola e le diverse opzioni educative; riporti il calendario degli incontri scuola-famiglia ed una breve sintesi delle modalità di valutazione delle competenze.
La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese a un anno, in relazione all’età, alla lingua d’origine, all’utilizzo in ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche. Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità dell’apprendimento e della vita scolastica degli alunni stranieri, con attività di laboratorio linguistico e con percorsi e strumenti per l’insegnamento intensivo
Per il consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell’anno scolastico – per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare - diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa” si prendono in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno

In sede di accordo è necessario che i dirigenti scolastici: realizzino un bilancio delle capacità di intervento presenti; creino le condizioni per la collaborazione tra docenti esperti e per la socializzazione delle esperienze; finalizzino in modo puntuale gli interventi di formazione in servizio degli insegnanti; prevedano l’impiego in comune di risorse professionali e strumentali; valorizzino le informazioni che sia il Sistema nazionale di valutazione
Ribadire il diritto all’inserimento immediato degli alunni neoarrivati. Il diritto/dovere di tutti alla scuola non può più essere compromesso, come talora avviene, dalle inaccettabili difficoltà di inserimento immediato dei bambini e ragazzi stranieri che arrivano ad anno scolastico iniziato. E’ necessario che l’amministrazione scolastica acquisisca per tempo dalle Prefetture tutte le informazioni utili sugli arrivi dei minori “ricongiunti”; è necessario che in tutte le aree territoriali più interessate dai flussi migratori la formazione delle classi eviti i livelli di saturazione che impediscono l’accoglienza dei neoarrivati
Rendere consapevoli dell’importanza della scuola dell’infanzia. La mancata partecipazione di quasi un quarto dei bambini c o n o r i g i n i m i g r a t o r i e , fra i 3 e i 5 anni, residenti in Italia, alla scuola per l’infanzia, un luogo educativo cruciale ai fini dell’apprendimento linguistico e di una buona integrazione, deve essere contrastata
La valutazione di fine anno deve essere coerente con i piani personalizzati e tener conto dei progressi effettivi registrati a partire dalle situazioni in ingresso. Definire in maniera chiara - e coerente con “l’adattamento del programma” previsto dalla normativa - le modalità di valutazione per gli allievi di recente immigrazione, prevedendo, ove necessarie, deroghe dalla normativa standard e apposite flessibilità agli esami di fine ciclo per gli allievi inseriti per la prima volta
Accompagnare con cura i passaggi da un tipo di scuola all’altro. 5. Organizzare un orientamento efficace alla prosecuzione degli studi. Investire sul protagonismo degli studenti. Le ragazze e i ragazzi c o n b a c k g r o u n d m i g r a t o r i o tendono a proseguire gli studi iscrivendosi (o sono orientati a farlo) in larga maggioranza, anche per chi ha ottenuto buoni risultati negli esami di terza media, ai p e r corsi o agli istituti professionali. È opportuno quindi che sia attivato un orientamento agli studi più efficace

È importante inoltre sviluppare e promuovere modalità di coinvolgimento diretto degli studenti, italiani e di background migratorio, attraverso esperienze di peer education, ricorrendo, per esempio, a studenti delle seconde generazioni come tutor di studenti neoarrivati, per sostenerli nei laboratori, nell’apprendimento dell’italiano, nell’orientamento. Informare
Coinvolgere le famiglie nel progetto educativo per i loro figli. Le scuole devono diventare presidi di socialità, luoghi di scambio e di confronto. Il dialogo costante fra la scuola e le famiglie di origine straniera deve inoltre essere denso e ravvicinato nei momenti topici della scolarità dei figli: l’ingresso, i momenti della valutazione, l’orientamento e le scelte. Ma un’attenzione costante va data alle interazioni quotidiane e di routine, che devono essere quanto più inclusive e facilitate: attraverso i messaggi plurilingue, attraverso strumenti formali o informal
Per sostenere questi compiti è utile che in ogni scuola si istituisca La commissione “Accoglienza”, come gruppo di lavoro e articolazione del collegio. ! la commissione rappresenta l’istituto e sarà composta dal dirigente scolastico, da alcuni docenti e eventualmente dai docenti che operano nei corsi di alfabetizzazione degli adulti immigrati. ! le competenze del gruppo di lavoro hanno carattere consultivo, gestionale e progettuale. ! la commissione si riunisce nei casi d’inserimento di alunni neoarrivati, per progettare azioni comuni, per monitorare i progetti esistenti, per operare un raccordo tra le diverse realtà
LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA DELLA SCUOLA effettua tempestivamente un colloquio con la famiglia coinvolgendo un’insegnante per modulo, sezione o classe che presumibilmente accoglierà il nuovo iscritto, raccoglie una serie d’informazioni sul ragazzo, sul suo percorso scolastico, sulla sua biografia linguistica, articola un colloquio con il bambino, utilizzando anche tecniche non 10 verbali, se necessario, compila un’iniziale biografia scolastica dell’alunno, facilita la conoscenza della nuova scuola
Il curricolo scolastico deve tendere ad una “economia curricolare”, coordinando la progressione delle competenze attraverso i diversi insegnamenti, identificando le competenze trasversali e favorendo la coerenza (verticale e orizzontale) tra gli apprendimenti. La competenza plurilingue e interculturale viene definita come la capacità di usare un ampio e diversificato repertorio di risorse linguistiche e culturali per soddisfare bisogni comunicativi

INIZIARE UN PROCESSO DI COSTRUZIONE DEL CURRICOLO La stesura di curricoli per l‟educazione plurilingue e interculturale implica che si definiscano le relazioni tra i programmi (o “indicazioni”) delle diverse materie scolastiche fino ad oggi generalmente elaborati indipendentemente gli uni dagli altri (lingue di scolarizzazione, lingue straniere, le altre discipline, ...). Questo rende la costruzione dei curricoli evidentemente più complessa. In termini pratici, il miglior approccio per l‟elaborazione di un curricolo che corrisponda alle finalità e agli obiettivi dell‟educazione plurilingue e interculturale non sta probabilmente nel cambiare radicalmente il curricolo esistente, ma nel modificarlo a piccole tappe, di solito nel medio o lungo termine
La rimozione delle barriere tra le discipline linguistiche ha come conseguenza la necessità di formare gli insegnanti (della lingua di scolarizzazione, delle lingue classiche, delle lingue straniere, delle lingue regionali / minoritarie, delle lingue della migrazione e delle altre discipline scolastiche) a modalità e forme di cooperazione didattica, di condivisione di tecniche, progetti interdisciplinari, modalità e criteri di valutazione; - la scelta delle forme che prenderà la verifica degli apprendimenti degli alliev
I dati (di tipo sia quantitativo che qualitativo) utili per avere un quadro della situazione sociolinguistica del contesto riguardano, generalmente - le varietà linguistiche presenti nel territorio: lingua/e nazionale/i, lingue regionali, lingue minoritarie, lingue dell‟immigrazione; lingua/e e varietà sociolinguistiche (in particolare della lingua nazionale o regionale o di scolarizzazione) usate dagli allievi in famiglia e nel loro ambiente sociale; lingue delle regioni di frontiera; lingue accessibili attraverso i media; - la rappresentazione che delle lingue (utilità, facilità di apprendimento, qualità estetiche, prestigio, via d‟accesso alla modernità, al benessere, ecc.) e del plurilinguismo (rappresentazione delle competenza nativa, del bilinguismo, della diversità delle lingue, ecc.) hanno gli apprendenti, gli insegnanti, gli altri attori del sistema scolastico (fra cui i dirigenti scolastici) e le famiglie
Organizzazione degli insegnamenti Insistere sulle trasversalità tra disciplina e disciplina – che rappresentano una delle caratteristiche dell‟educazione plurilingue e interculturale – non significa in alcuno modo considerare come necessaria la scomparsa delle discipline scolastiche attuali (corsi di lingua “nazionale” / “regionale”, di lingue di migrazione, di lingua straniera...) in funzione di un insegnamento globalizzante e indifferenziato. Le attività precedentemente

richiamate possono collocarsi in qualsiasi corso, in particolare di lingua. Ma si può anche cercare di organizzarle in tecniche di insegnamento, in un insieme coerente di attività come, ad esempio: - incoraggiare l‟alternanza delle lingue nell‟insegnamento della lingua di scolarizzazione, della lingua regionale / minoritaria o della lingua di migrazione e delle lingue straniere; - usare supporti plurilingui (come film o programmi televisivi in lingua originale sottotitolati) in tutte le materie linguistiche (nel ciclo secondario); - l‟organizzazione di corsi “plurilingui” centrati su una competenza comunicativa (ad esempio, intercomprensione in due o più lingue vicine o affini (soprattutto lingue straniere)
Infine, una caratteristica fondamentale del curricolo plurilingue dovrebbe essere quella di prevedere una offerta delle lingue straniere aperta in modo che si possa invitare e incoraggiare con ogni mezzo gli apprendenti a non limitare la propria scelta alle lingue ritenute più utili alla vita professionale o a quelle che si ritiene più facili da apprendere
accogliere la pluralità linguistica, aprire le menti dei bambini alla diversità culturale, stabilire lo statuto della lingua di scolarizzazione e familiarizzare i bambini alle sue convenzioni più comuni, aiutandoli a padroneggiare e a sviluppare il suo potenziale in modo informale e con l‟aiuto di esposizioni e attività diversificate
tra le culture e tra i modi di apprenderle; - la prima lingua straniera (e anche la seconda) viene utilizzata, almeno occasionalmente, nell'insegnamento/apprendimento di discipline non linguistiche e/o in progetti pluridisciplinari; - gli allievi possono essere coinvolti in scambi e progetti internazionali (in particolare a distanza e virtuali) e a corrispondere in rete con stranieri nell‟una e nell‟altra lingua straniera. Queste iniziative vanno attentamente pianificate, implementate e monitorate per assicurare che le lingue straniere apprese (non solo la prima) e la lingua di scolarizzazione siano usate per affrontare temi che possano sollevare domande, ricerche, discussioni, interventi di carattere interculturale.
Non si può passare sotto silenzio la situazione dei Rom, distinta da quella dei migranti “ordinari”. Resi sedentari (ma generalmente non o male integrati) in alcuni paesi europei, restano nomadi (o lo ridiventano) in altri (o negli stessi). Queste popolazioni sono oggetto di rifiuto e di esclusione, nonostante le campagne nazionali e soprattutto internazionali che si prefiggono lo scopo di migliorare la loro condizione, in particolare attraverso l‟istruzione dei bambini e degli adolescenti.

Questa istruzione, ancora aleatoria nella maggior parte dei casi, è ostacolata non soltanto (come si sente, forse, troppo spesso dire) da stili di vita, tradizioni culturali, modelli di conoscenza e modalità di trasmissione tra le generazioni che sono in parte o totalmente in contrasto con la prassi scolastica normale, ma anche per l‟ostracismo sociale di cui soffrono le popolazioni rom e per il fatto che molte scuole trattano i loro figli come se fossero portatori di handicap o di deficienze mentali. Council of Europe - Italiano LinguaDue, 2011. Guida per lo sviluppo e l’attuazione di curricoli per una educazione plurilingue e pluriculturale. 117 - le moderne tecnologie rendono possibili diverse forme di scambio con i paesi d‟origine dei bambini o con paesi in cui si parla la loro stessa lingua e che le famiglie e le comunità possono, se lo desiderano, alimentare e mantenere così il contatto con la diversità linguistica e culturale del loro primo ambiente
Iscritti in tale prospettiva, i diritti ad una istruzione e ad una formazione di qualità e le componenti linguistiche di questi diritti comportano, per tutti i bambini scolarizzati nelle società europee contemporanee, che siano o no di recente migrazione, una duplice esigenza che, a prima vista, può sembrare paradossale o contraddittoria: - da una parte, il diritto ad una educazione che fornisca a ciascun apprendente gli strumenti per il suo successo scolastico e lo prepari a diventare un membro autonomo, responsabile e attivo di una determinata comunità; la padronanza della lingua maggioritaria ufficiale, tanto nelle sue norme e generi scolastici che nelle sue varietà ed usi sociali, è ovviamente determinante; - dall‟altra, il diritto ad una educazione che prepari alla mobilità, ad operare superando le frontiere e a passare in altri ambienti culturali e linguistici e che rispetti e contribuisca a preservare gli apporti esterni che la mobilità introduce nella scuola. Esigenze, dunque, che possono creare tensioni che solo forme di educazione plurilingue ed interculturale sono in grado di affrontare, evitando di nasconderle, e di gestirle al meglio e di trarne vantaggio.
Il generale diritto ad una educazione linguistica plurilingue ed interculturale deve essere garantito a tutti i gruppi che frequentano la scuola. Si declina secondo diritti più specifici che non sempre possono essere fra loro compatibili e il cui esercizio dipende dalle politiche di insegnamento delle lingue, esse stesse variabili a seconda dei contesti. Poiché, in linea di principio, è trasversale e variamente applicata nella pratica, l‟educazione plurilingue e interculturale non è né riservata a specifici gruppi di discenti né caratterizzata da rigide metodologie

Minori stranieri non accompagnati L’aumento, negli ultimi anni, degli alunni cni di recente immigrazione (i cosiddetti NAI) e di conseguenza neoentrati nel sistema scolastico italiano, in un contesto di generale rallentamento della crescita di alunni stranieri, è influenzato anche dall’incremento del numero dei minori stranieri non accompagnati (Msna). L’aumento progressivo di questi minori, a partire dall’anno 2013 con i numerosi arrivi via mare, pone nuove questioni organizzative e didattiche alle scuole che si occupano della loro accoglienza e integrazione. Si tratta di un fenomeno complesso e multiforme i cui dati generali, ricavati dall’ultima registrazione disponibile, sono i seguenti: 11.921 Msna presenti al dicembre 2015, di cui solo 550 femmine
. Il Miur, Direzione generale per lo studente, con il bando n. 830 del 24 luglio 2015, ha messo a disposizione delle scuole o reti di scuole, risorse per progetti di accoglienza e integrazione di minori stranieri non accompagnati. In totale sono stati selezionati 60 progetti, in 11 regioni, e sono stati coinvolti circa 800 studenti minori non accompagnati. Non c’è una rilevazione statistica nazionale su quanti Msna siano iscritti nelle scuole italiane, però abbiamo a disposizione alcune indagini territoriali: la rilevazione fatta dall’Ufficio scolastico regionale della Toscana con l’Università degli studi di Firenze, Dipartimento Scienze della Formazione e Psicologia, da cui risultano 112
Molti minori stranieri non accompagnati provengono da contesti sociali drammatici e da esperienze dolorose e traumatiche.
Le scuole che stanno già lavorando su questo tema si sono poste l’obiettivo di promuovere o di far emergere capacità di resilienza, ovvero resistere e adattarsi a contesti di particolare vulnerabilità, a situazioni stressanti e traumatiche con la convinzione che sia possibile far fronte alle avversità con successo
Un’altra indicazione che viene dalle pratiche didattiche delle scuole è l’utilizzo e il potenziamento dei linguaggi non verbali, dall’arte alla musica, al teatro, allo sport, anche in collaborazione con le associazioni e gli operatori delle comunità di accoglienza. Il gruppo di lavoro di studenti, docenti e ricercatori della Scuola di italiano per stranieri dell’Università di Palermo, per esempio, definisce “un’immersione nel territorio” la necessità di uscire dal modello del corso di lingua in classe, con uno spazio/tempo limitato e chiuso. Ci vogliono momenti di incontro dentro e fuori la scuola, contesti di relazioni che spezzino il sentimento di estraneità di chi è sopravvissuto a drammi collettivi e individuali. Serve un “bagno linguistico”, nei tanti linguaggi della città e della vita reale, questa è l’indicazione didattica che viene dall’esperienza palermitana

. Nell’intento di valorizzare il patrimonio di conoscenze di cui gli studenti sono portatori e di rafforzare la creazione di legami tra di loro, in alcune pratiche scolastiche sono state incentivate le esperienze peer-to-peer, valorizzando le relazioni interpersonali tra studenti. Risulta anche necessario coinvolgere i mediatori culturali e costruire intese e percorsi con strutture della formazione professionale del territorio per far acquisire ai minori competenze spendibili velocemente nel mercato del lavoro
Alunni stranieri con disabilità Gli alunni con disabilità (con questa definizione si considerano coloro che hanno una disabilità certificata) nell’a.s. 2014/15 sono in totale 233.486. L’aumento è di 4.805 unità rispetto all’anno precedente. Gli alunni con disabilità e di cittadinanza non italiana sono 28.117 (di cui femmine 8.921). L’aumento rispetto al precedente anno è di 1491 unità. L’incidenza media degli alunni stranieri con disabilità sul totale degli alunni con disabilità è del 12% (+0,4 rispetto al precedente anno). Quello dei Msna è un tema nuovo per certi aspetti. È emersa chiaramente la necessità di accrescere la consapevolezza e la sensibilità degli insegnanti attraverso momenti e strumenti di formazione, in collaborazione e d’intesa con enti e strutture coinvolti nelle problematiche dei minori. Un primo seminario nazionale di formazione per insegnanti, dirigenti scolastici, operatori delle strutture di prima accoglienza è stato organizzato a Firenze dal Ministero dell’istruzione.
Allievi rom In quest’ultimo paragrafo, si presentano i dati riferiti alle iscrizioni a scuola di bambini e ragazzi rom che possono quindi discostarsi molto dal dato sulla effettiva frequenza scolastica, non rilevato a livello nazionale. È innegabile inoltre che il numero dei rom iscritti a scuola sia molto inferiore al numero dei minori rom in età di scuola dell’obbligo. Il numero complessivo degli alunni rom, nell’a.s 2014/15, è di 12.437, +780 rispetto all’anno precedente, dunque in controtendenza rispetto alla progressiva diminuzione degli ultimi anni. Prendendo in considerazione i diversi ordini scolastici si rileva l’iscrizione di 2.179 bambini rom nelle scuole dell’infanzia (+ 292 sull’anno precedente); 6.441 nella scuola primaria (+309); 3.569 nella secondaria di primo grado (+95); 248 nella secondaria di secondo grado (+74). Sono da evidenziare gli aumenti di iscrizioni nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole secondarie di secondo grado
L’integrazione dipende da molti fattori: la numerosità degli insediamenti rom, le condizioni abitative, la distanza dalla scuola, la presenza di servizi sociali, la preparazione di insegnanti e dirigenti, la collaborazione tra le diverse agenzie del

territorio Nonostante l’aumento delle iscrizioni scolastiche registrate nell’a.s. 2014/15, rimangono aperte alcune questioni strutturali sulla scolarizzazione dei minori rom. I bassi livelli di istruzione dei gruppi rom, comprese alcune situazioni di analfabetismo, sono uno dei fattori che ostacolano l’inserimento sociale e nel mercato del lavoro. Mancano dati nazionali sulla effettiva frequenza e regolarità della presenza a scuola; mancano dati sui percorsi scolastici e sugli esiti; manca un quadro di dati sui minori rom in età di scuola dell’obbligo. Manca inoltre una distinzione per cittadinanza: una parte dei minori rom è di cittadinanza italiana, si stima almeno la metà
Italia, paese di immigrazione ed emigrazione 5 milioni di cittadini stranieri che risiedono in Italia, aumentati di sole 12.000 unità nel 2015 5,2 milioni i cittadini italiani che risiedono all’estero, aumentati di 200.000 unità nel 2015 - 5,5 milioni di stranieri regolarmente presenti (Stima di Idos) 60 milioni i cittadini stranieri di origine italiana sparsi nel mondo 1 milione di cittadini italiani di origine straniera in Italia Una rete importante per le prospettive commerciali, turistiche ed economiche del paese. Dossier Statistico Immigrazione 2016 – IDOS/CONFRONTI/UNAR Variazione dei residenti in Italia (saldo migratorio e saldo naturale): -130mila nel 2015 Secondo l’Istat, per mantenere l’equilibrio demografico l’Italia dovrebbe assicurarsi, tra il 2011 e il 2065, un saldo migratorio netto positivo inizialmente di 300.000 unità e alla fine del periodo di 175.000 unità.
Il nuovo contesto delle pratiche interculturali Per garantire l'uguaglianza delle opportunità formative: comprensione di nuovi bisogni e caratteristiche della popolazione immigrata; ➢ diffusione di conoscenze che consentano percezioni corrette del fenomeno migratorio. Modello di costruzione di una didattica interculturale sulla base di una revisione curricolare DIDATTICA INTERCULTURALE Livello macropedagogico Livello micropedagogico Curricolo esplicito Curricolo implicito - stile di insegnamento - clima scolastico moduli e unità didattiche interculturali curricolo “aperto” Strategie operative dell’educazione interculturale
L’educazione interculturale si connota nella prassi quotidiana con strategie operative caratterizzate dai seguenti elementi fondamentali: la selezione di tematiche interculturali nell’insegnamento disciplinare; lo svolgimento di interventi integrativi alle attività curricolari; l’attenzione ad un clima di apertura e di dialogo, nonché a una riflessione sullo stile di insegnamento; l’adozione di strategie mirate, in presenza di alunni stranieri con particolari necessità. Pratiche Sperimentazione di dispositivi didattici volti: all’inserimento degli allievi stranieri (protocollo di accoglienza, insegnamento

dell’italiano come L2, sportelli di informazione) al riorientamento della didattica in senso interculturale (percorsi didattici interculturali, Commissione/referente per l’intercultura, percorsi formativi per gli insegnanti, percorsi di sensibilizzazione per il personale scolastico, mediatori interculturali
Formazione interculturale del personale scolastico (docente e non docente) Ribadire il diritto all’inserimento immediato degli alunni neoarrivati. È necessario che in tutte le aree territoriali più interessate dai flussi migratori la formazione delle classi eviti i livelli di saturazione che impediscono l’accoglienza dei neoarrivati; è necessario che i dispositivi di ricerca delle scuole e delle classi in cui inserire i nuovi alunni non comportino “liste di attesa” e trasferimenti da una scuola all’altra che fanno perdere tempo, motivazione, fiducia nelle istituzioni. • Nelle situazioni in cui si registra da tempo, e dunque si può prevedere per il futuro, un rilevante flusso di alunni stranieri, alleggerire il numero degli alunni per classe per consentire l’inserimento immediato dei nuovi arrivati. • In queste zone e per queste scuole prevedere un organico funzionale aggiuntivo anche per lo sviluppo di laboratori di L2 per i neoarrivati. 2) Rendere consapevoli dell’importanza della scuola dell’infanzia. La mancata partecipazione di quasi un quarto dei bambini con origini migratorie, fra i 3 e i 5 anni, residenti in Italia, alla scuola per l’infanzia, un luogo educativo cruciale ai fini dell’apprendimento linguistico e di una buona integrazione, deve essere contrastata.
Non costituisce motivo sufficiente di deroga alla normativa la non conoscenza dell’italiano dell’alunno neoinserito per il quale occorre, anzi, prevedere piani didattici personalizzati finalizzati al riallineamento con i comuni obiettivi di apprendimento. • Aggiornare e diffondere indicazioni normative chiare, coerenti e prescrittive sulle modalità di inserimento e di valutazione degli alunni stranieri neoarrivati. • Attivare, per i neoarivati in periodo prescolastico, interventi di formazione linguistica prima dell’ inserimento scolastico. • Predisporre un sito dedicato sul tema dell’inserimento degli alunni neoarrivati contenente: normative, protocolli di accoglienza; progetti esemplari e buone pratiche efficaci; esempi positivi di modalità organizzative, materiali didattici e plurilingue. 4) Accompagnare i passaggi; adattare il programma e la valutazione. Si osservano esiti scolastici negativi da parte dei bambini e dei ragazzi con origini migratorie, anche se nati in Italia, soprattutto alla fine del primo anno della scuola secondaria di primo grado e della secondaria di secondo grado. Ogni istituto scolastico deve essere “allenato”, in questi passaggi nevralgici, alla predisposizione di piani personalizzati che comportino, se necessario, anche modifiche transitorie e non permanenti dei curricoli. La valutazione di fine anno deve essere coerente con i piani

personalizzati e tener conto dei progressi effettivi registrati a partire dalle situazioni in ingresso. •
Accompagnare con cura i passaggi da un tipo di scuola all’altro. 5) Organizzare un orientamento efficace alla prosecuzione degli studi. Investire sul protagonismo degli studenti. Le ragazze e i ragazzi con background migratorio tendono a proseguire gli studi iscrivendosi (o sono orientati a farlo) in larga maggioranza, anche per chi ha ottenuto buoni risultati negli esami di terza media, ai percorsi o agli istituti professionali. È opportuno quindi che sia attivato un orientamento agli studi più efficace attraverso l’informazione plurilingue alle famiglie sulle caratteristiche dei percorsi di studio e, dove occorre, attraverso misure di diritto allo studio
È importante inoltre sviluppare e promuovere modalità di coinvolgimento diretto degli studenti, italiani e di background migratorio, attraverso esperienze di peer education, ricorrendo, per esempio, a studenti delle seconde generazioni come tutor di studenti neoarrivati, per sostenerli nei laboratori, nell’apprendimento dell’italiano, nell’orientamento. • Informare in maniera accurata (anche con opuscoli plurilingue) le famiglie e gli alunni con origini migratorie sul sistema scolastico italiano e sulle opportunità di istruzione superiore. • Organizzare la fase di orientamento e delle scelte scolastiche coinvolgendo anche i mediatori linguistico-culturali e giovani tutor di origine migratoria. 6) Sostenere l’apprendimento dell’italiano L2, lingua di scolarità
Attivare dentro le scuole corsi opzionali di insegnamento delle lingue d’origine, anche in collaborazione con i governi dei Paesi di provenienza. • Sperimentare l’insegnamento a tutti gli alunni di lingue straniere non comunitarie (cinese, arabo, russo). • Conoscere, riconoscere e valorizzare le forme di bilinguismo presenti fra gli alunni della classe. • Formare i docenti sul tema della diversità linguistica e del plurilinguismo.
Prevenire la segregazione scolastica. Si riscontrano in alcune scuole fenomeni di concentrazione della presenza di alunni con origini migratorie. Oltre al dato demografico e residenziale, legato agli insediamenti abitativi delle famiglie migranti in un determinato territorio, possono avere un peso le preoccupazioni dei genitori italiani sulla qualità dell’apprendimento nelle classi (troppo) multiculturali. Si tratta di agire con tutti gli attori coinvolti per garantire in tutte le scuole una buona qualità
Coinvolgere le famiglie nel progetto educativo per i loro figli. Le scuole devono diventare presidi di socialità, luoghi di scambio e di confronto. Il dialogo costante fra la scuola e le famiglie di origine straniera deve inoltre essere denso e ravvicinato nei momenti topici

della scolarità dei figli: l’ingresso, i momenti della valutazione, l’orientamento e le scelte. Ma un’attenzione costante va data alle interazioni quotidiane e di routine, che devono essere quanto più inclusive e facilitate: attraverso i messaggi plurilingue, attraverso strumenti formali o informali di mediazione linguistico-culturale e soprattutto attraverso gli atteggiamenti di vicinanza
• Incoraggiare la rappresentanza dei genitori stranieri. • Attivare opportunità di apprendimento dell’italiano per i genitori di origine straniera, con particolare attenzione alle madri che non lavorano e hanno minori occasioni di socialità. 10) Promuovere l’educazione interculturale nelle scuole I giovani di oggi hanno bisogno di esperienze relazionali e di strumenti culturali per imparare ad interagire senza timori e con mentalità aperta con una cultura, un’informazione, un’economia sempre più contrassegnate dalla duplice dimensione del globale e del locale. Le classi multiculturali sono un contesto prezioso per abituare tutti, fin dai primi anni di vita, a riconoscersi ed apprezzarsi come uguali e diversi. La presenza degli studenti con background migratorio, se valorizzata da un approccio educativo interculturale, offre opportunità importanti alla modernizzazione e all’arricchimento del profilo culturale della scuola italiana. • Sensibilizzare tutti gli insegnanti sul tema della pedagogia e della didattica interculturale. • Sperimentare percorsi di educazione alla concittadinanza.
Cos’è il tutoring Nell’ambito del processo di insegnamento/apprendimento il tutoring è una tecnica didattica basata sulla cooperazione, che stimola l’interazione verbale e la prossimità fisica tra un tutor (chi accompagna) e un tutee (chi viene accompagnato). Da dove nasce il tutoring? Si sviluppa alla fine del XVIII secolo nel mondo anglossassone, viene ripreso poi nel XX secolo in Europa, Urss e Usa per fare fronte alla scarsità di insegnanti: nelle classi molto numerose, il gruppo si suddivideva in sottogruppi omogenei e si impiegavano i bambini per insegnare ad altri bambini (peer tutoring). Cosa si ottiene con il tutoring? Non è solo una risposta alla mancanza di risorse economiche, ma vi è anche la ricerca di gratificazioni, senso di adeguatezza e migliori risultati nell’apprendimento
Secondo l’approccio interculturale, l’ordine organizzativo non è più dato per scontato, ma viene reso noto a tutti gli utenti attraverso strumenti comunicativi adeguati (informazioni dirette, scritte, on line, ecc.) e l’uso di traduzioni multilingue. Esempi: Cartellonistica plurilingue Orario delle lezioni plurilingue Codice di comportamento degli insegnanti Patto di corresponsabilità genitori-insegnanti e studenti-insegnanti Mansionario del personale di vigilanza Statuto delle studentesse e degli studenti della

scuola secondaria docente/non docente lezioni/intervalli e relax/attività integrative aule/laboratori/spazi comuni/spazi docenti saluti/feste/premiazioni/ coinvolgimento delle famiglie programmate/progettate/improvvisate
Esempi: Lezioni frontali di uno o più docenti Lezioni individuali o a piccoli gruppi Lezioni a distanza Esercitazioni pratiche Giochi e simulazioni Test, valutazioni didattiche Peer tutoring, mentoring Utilizzo dei libri di testo L’approccio interculturale all’educazione comporta un’attenzione particolare a come vengono presentati i contenuti di apprendimento per valutare gli effetti possibili su ogni tipo di utente ed evitare di innescare meccanismi taciti di esclusione. Esempi: Tutti i genitori sono al corrente di cosa si insegna? Tutti gli alunni sanno cosa significhi lavorare in gruppo? Tutti gli alunni hanno familiarità con i test a risposta chiusa? Tutti gli alunni capiscono cosa ci si aspetta se si chiede loro un commento critico? Tutti gli alunni considerano autorevoli le fonti artistiche? . …alle pratiche didattiche Il tutor di scuola si affianca al team di progettazione per lanciare nuove idee, anche trasferite da altre istituzioni ed esperienze didattiche. Questa è la «coprogettazione» L’approccio interculturale permette di rivisitare e problematizzare i contenuti tradizionali delle discipline, ad esempio, sviluppando uno sguardo decentrato e una mobilità cognitiva che favorisce l’integrazione di diverse tradizioni culturali. Esempi: Confini e frontiere Letterature extraeuropee Scienze in chiave critica: a chi giovano le scoperte scientifiche? Inoltre propone nuovi contenuti di insegnamento/apprendimento, ricavati da esperienze valide di «educazione globale», che nelle pratiche ordinarie non trovano spazio sufficiente. Esempi: Curricolo multiculturale Insegnamenti bilingue Prevenzione del razzismo e della discriminazione Diritti umani e antropologia culturale
La scelta strategica di questa scuola consiste nel sciogliere la Commissione Intercultura: i docenti impegnati nell’accoglienza e integrazione degli alunni stranieri partecipano alle altre commissioni della scuola, al fine di diffondere la sensibilità interculturale tra tutti i colleghi. Dopo anni di esperienza nella progettazione interculturale, si è maturata infatti la consapevolezza di dover aumentare il livello di condivisione all’interno del corpo docenti e il grado di coinvolgimento dell’intera scuola, con un investimento specifico sulla comunicazione, sulla programmazione condivisa, sui momenti di scambio di pratiche e di confronto tra i plessi appartenenti alla DD e con tutte le altre scuole e realtà del territorio. Il risultato raggiunto è l’acquisizione di uno stile comune in tema di intercultura, utile riferimento per l’inserimento di nuovi insegnanti e per fare memoria delle acquisizioni raggiunte. DALLA DELEGA ALLA COMMISSIONE INTERCULTURA AD

UNA SENSIBILITÀ INTERCULTURALE DI TUTTI I DOCENTI = APPRENDIMENTO DEI SINGOLI E TRASFORMAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE, VERSO UNA RESPONSABILITÀ CONDIVISA
Autobiografia degli incontri interculturali Bruxell 2009
L’Autobiografia può essere utilizzata in classe in modo formale o anche informalmente nel momento e nel luogo scelto dallo studente Può essere usata come uno strumento didattico per lavorare in gruppo o individualmente, con la guida del docente – come supporto all’insegnamento e all’apprendimento. Può essere usata dai singoli apprendenti, come una sorta di diario che rimane riservato – in questo caso è uno strumento per l’autovalutazione. Il modo d’uso dipenderà da uno o più fattori: • l’intenzione del docente di introdurre l’Autobiografia in un corso di studi; • l’esigenza di riservatezza dell’apprendente; • l’età degli apprendenti e il fatto che necessitino o meno di aiuto per la compilazione. Di seguito vengono presentate alcune possibili situazioni in cui si potrebbe utilizzare l’Autobiografia: Dopo un viaggio d’istruzione Dopo un viaggio d’istruzione in cui gli studenti sono stati lontani da casa – magari in un altro paese o in un’altra regione del loro paese, oppure per un’esperienza scuola natura – l’Autobiografia può essere utilizzata con gli alunni di scuola primaria per incoraggiarli a riflettere su un’esperienza specifica che hanno avuto durante il viaggio d’istruzione
. L’incontro Titolo Dai all’incontro un titolo che lo riassuma… Descrizione Che cosa è successo quando hai incontrato questa persona/queste persone ? Tempo Quando è successo? Luogo Dove è successo? Che cosa stavi facendo lì? Si trattava di … (barrare una o più voci)… studio tempo libero vacanza lavoro scuola altro Perché hai scelto questa esperienza? Perché … (barrare una o più voci)… Mi ha fatto riflettere su qualcosa su cui non avevo mai riflettuto prima ... E’ stata la mia prima esperienza di questo genere … E’ stata la mia più recente esperienza di quel genere ... Mi ha sorpreso Mi ha deluso Mi è piaciuta Mi ha fatto arrabbiare Mi ha cambiato Puoi aggiungere altre reazioni usando le tue parole e spiegare che cosa pensi abbia provocato la tua reazione 2. L’altra persona o le altre persone Chi altro era coinvolto? TEORIA – Riconoscimento delle identità Se lo sai, indica il nome della persona o delle persone … Scrivi qualcosa su di loro … Quale è stata la prima cosa che hai notato di loro? Che aspetto avevano? Che abiti indossavano? Erano maschi/femmine oppure più vecchi/più giovani di te, oppure appartenevano ad una diversa nazionalità, religione o regione, oppure qualsiasi altra cosa che li riguarda e tu ritieni sia importante. 3. I tuoi sentimenti Descrivi come ti sei sentito in quel momento, completando le seguenti frasi I miei sentimenti o le mie emozioni in quel

momento erano … I miei pensieri in quel momento erano … Quello che ho fatto in quel momento è stato … (per esempio, hai fatto finta di non notare che c’era qualcosa di strano? Hai cambiato l’argomento della conversazione che era diventata imbarazzante? Hai fatto domande su quello che ti sembrava strano?) …
I sentimenti dell’altra persona Mettiti nei panni dell’altro… Come pensi si siano sentite le altre persone in quella situazione e in quel momento? Può essere difficile, ma prova ad immaginare quello che essi hanno provato in quel momento. Erano felici o turbati/tesi oppure ...? Come facevi a saperlo? Che cosa pensi stessero pensando in quel momento? Pensi che lo trovassero strano o interessante oppure ...? Scegli una o più voci o aggiungine alcune tue e spiega la tua scelta. TEORIA – Tolleranza dell’ambiguità Per loro è stata un’esperienza di tutti i giorni / un’esperienza insolita / un’esperienza sorprendente / un’esperienza traumatizzante / perché.
La pluriculturalità si riferisce alla capacità di fare esperienza dell’alterità culturale e di utilizzare questa esperienza per riflettere su temi che solitamente sono dati per scontati all’interno della propria cultura e del proprio ambiente. L’interculturalità comporta l’essere aperti e interessati, curiosi ed empatici verso persone che provengono da altre culture e utilizzare questa accresciuta consapevolezza dell’alterità per valutare i propri modelli quotidiani di percezione, pensiero, sentimento e comportamento, al fine di sviluppare maggiore conoscenza e comprensione di sé. L’interculturalità permette perciò alle persone di svolgere il ruolo di mediatori tra persone di culture differenti, di spiegare e interpretare i diversi punti di vista. Essa permette anche di operare efficacemente e di raggiungere obiettivi interazionali e transazionali in situazioni caratterizzate da alterità e differenze culturali. E’ da notare che, secondo questa definizione, l’interculturalità non comporta l’identificazione con un altro gruppo culturale o l’adozione delle pratiche culturali dell’altro gruppo.
Per poter affrontare un dialogo interculturale sono necessarie numerose competenze interculturali che non vengono acquisite spontaneamente; infatti, come è stato evidenziato dal Libro Bianco sul Dialogo Interculturale del Consiglio d’Europa, esse devono essere esplicitamente insegnate ed apprese, quindi praticate e mantenute per tutto l’arco della vita. L’Autobiografia degli Incontri Interculturali è stata espressamente pensata per favorire lo sviluppo di queste competenze. Essa intende fornire agli individui competenze specifiche necessarie per vivere attivamente scambi con persone che provengono da altri contesti etnici, culturali, religiosi e linguistici, ed è stata pensata

in modo tale da sollecitare gli individui ad impegnarsi in azioni successive che possano aiutarli a comprendere meglio altre pratiche culturali e altri punti di vista. In questa parte vengono descritte le diverse competenze interculturali che l’Autobiografia intende supportare e sviluppare. Il fondamento della competenza interculturale sta nell’atteggiamento di un individuo che interagisce con persone di un’altra cultura. Ciò significa disponibilità a sospendere i propri valori, le proprie credenze e i propri comportamenti, non presupponendo che essi siano gli unici possibili e giusti, e la capacità di vedere come essi potrebbero essere considerati dal punto di un’altra persona che ha valori, credenze e comportamenti diversi. Questa potrebbe essere definita come capacità di ‘decentrarsi’.
FILM e LIBRi • Snowman • Segreti e bugie • Welcome • East is east • The reader – A voce alta • Il bambino dal pigiama a righe Libri • A. Aluffi Pen4ni Bluo e verdola • Cuore - il ragazzo calabrese • A. Lakhous - Scontro di civiltà per un ascensore a piazza Vi8orio • T. Morrison L’occhio più azzurro
Zizioli Scelti per voi Romanzi ■ Fabio Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli, Baldini Castoldi, Dalai, Milano 2010. ■ CMarie - Aude Murail (2005), Cécile. Il futuro è per tutti, Giunti editore, Firenze 2010. ■ Cecilia Bartoli, Gli amici nascosti, Topi pittori, Milano 2014. ■ Guss Kuijer (1999), Per sempre insieme, amen, Feltrinelli Kids, Milano 2012. ■ Patrizia Rinaldi, Mare Giallo, Sinnos, Roma 2012. ■ Ubah Cristina Ali Farah, Il comandante del fiume, 66th and 2nd, Roma 2014. ■ Pina Varriale, Yusuf è mio fratello, Mondadori, Milano 2015. ■ Manuel Salvi (a cura di), illustrazioni di Cristina Spanò, A braccia aperte. Storie di bambini migranti, Mondadori, Milano 2016. ■ AA.VV., Centrifuga. Fughe, ritorni e altre storie, Sinnos, Roma 2016. Fiabe ■ Vinicio Ongini, Chiara Carrer, Le altre Cenerentole. Il giro del mondo in 80 scarpe, Sinnos, Roma 2009. Elena Zizioli - Università Roma Tre Scelti per voi (2) Graphic novel ■ Fabio Stassi, Federico Appel, La leggenda di Zumbi l’immortale, Sinnos, Roma 2015. Albi illustrati • Viorel Boldis, Antonella Toffolo, Il fazzoletto bianco, Topi pittori, Milano 2010. • Claude K. Dubois (2012), Akim corre, Babalibri, Milano 2014. • Chiara Lorenzoni, illu. Paolo Domeniconi, Amali e l’Albero, EDT, Torino 2016. Silent book ■ Paola Formica, Orizzonti, Carthusia, Milano 2015. ■ Mariana Chiesa Mateos, Migrando, Orecchio Acerbo, Roma 2010. ■ Shaun Tan (2006), L’approdo, Elliot edizioni, Roma 2008. Per i nuovi racconti che tematizzano la migrazione e per i silent vedere le tre edizioni della mostra di Lampedusa e consultare costantemente la Rivista Sesamo Giunti Scuola, inserite entrambe come risorse didattiche nella sezione Tra storie e progetti.Partire da un libro per contrastare i rischi della «colonizzazione» e promuovere l’empowerment • I nuovi prodotti (specie i silent books) consentono e favoriscono

un’orizzontalità di rapporto, mirano alla co-costruzione delle storie, valorizzano i sapere nascosti, stimolano il pensiero divergente….. • Proporre un libro in questo caso significa aprire orizzonti e insieme tessere la trama, scoprire il valore della rilettura, animarla, renderla una relazione educativa e sostenere modelli emancipativi e non conformativi. • Forza evocativa delle immagini che contrastano l’omologazioneBuone pratiche nei territori a rischio di povertà educativa • Lettura animata dei testi • Incontri con scrittori per ragazzi • Laboratori su diritti e cittadinanza • Laboratori narrativi (vd l’esempio riportato nella selezione dal libro I Tesori….inserita in piattaforma nella sezione: Tra storie e progetti. • Spazio per la restituzione delle storie….si parte da un libro per formare una Repubblica dell’immaginazione, così come recita il titolo del testo della scrittrice iraniana Azar Nafisi.
Vinicio Ongini STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE INTERCULTURALE Banca dati dei progetti di educazione interculturale dell’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità della Regione Lombardia / Fondazione Ismu a cura di Maddalena Colombo (responsabile della Banca dati Orim dei progetti interculturali in Lombardia) A seguito di un’intensa attività di raccolta dati e approfondimento teorico ed empirico sulla progettazione nell’area interculturale, iniziata nel 2000, il Gruppo Scuola dell’Orim-Lombardia ha messo a punto una “cassetta degli attrezzi” rivolta agli operatori scolastici ed extrascolastici, per facilitare i compiti di progettazione, realizzazione e valutazione degli interventi sul campo. Il Kit si compone di tre volumi (tutti scaricabili da www.orimregionelombardia.it). • Guida ai progetti di educazione interculturale. Come costruire buone pratiche (di Colombo M., 2007) che contiene indicazioni sull’iter progettuale tipo e sui fattori chiave per una migliore garanzia di riuscita del progetto: ad esempio l’attenzione alle risorse umane e alla coltivazione della sensibilità interculturale negli operatori; la necessità di sviluppare un serio lavoro in rete, con livelli diversificati di assunzione di responsabilità e di benefici; l’analisi del contesto locale; la documentazione per garantire tracciabilità all’esperienza; l’attenzione alla valutazione dei risultati dell’azione interculturale, per definire, con procedimento deduttivo o induttivo, se e in che misura la pratica posta in essere può essere considerata “buona
La ricerca educativa qualitativa in ambito interculturale Marco Catarci, Università degli Studi Roma Tre.
Metodologie educative adottate Nel corso dell’indagine, gli intervistati hanno descritto un’ampia gamma di metodologie educative adottate nelle iniziative di formazione rivolte agli immigrati (lezioni frontali, gruppi di lavoro, didattica laboratoriale, attività ludiche ed espressive, etc.). In generale, nello svolgimento della didattica vengono

privilegiate attività indirizzate prioritariamente all’acquisizione di abilità comunicative nel contesto quotidiano di vita e di lavoro. L’offerta formativa si caratterizza, così, per un approccio orientato alla comunicazione, mediante attività di conversazione, scrittura e comprensione linguistica: “In classe viene utilizzato principalmente l’approccio comunicativo, le lezioni prevedono per una buona parte conversazione e dialogo su vari input, sia forniti dall’insegnante che dagli studenti stessi. Il restante tempo è dedicato ad attività […] come lettura e scrittura in italiano, esercizi sulla grammatica. È favorito un approccio integrato che stimoli le facoltà comunicative degli studenti a partire dalla propria esperienza e dall’esperienza comune. Sono previste attività pratiche che permettano agli studenti di associare la lingua ad un’esperienza diretta e ad attività di ascolto e comprensione di storie e canzoni
Molto interessante è, in questa prospettiva di didattica laboratoriale, l’utilizzo della visita didattica “nei luoghi di vita quotidiana (poste, mercato, etc.) e […] ai monumenti di Roma” . Tale approccio assume una doppia valenza di promozione sia culturale sia socio-economica, come racconta una intervistata: “Abbiamo cercato di fare delle cose fuori [dalla scuola], di portarli a vedere dei luoghi della città che loro non conoscevano, sia culturali sia che potessero essergli utili dal punto di vista del lavoro. Per esempio siamo andati a visitare un centro di orientamento al lavoro, che era una cosa che ci avevano chiesto, li abbiamo portati all’Auditorium, alle Catacombe […], e questa cosa mi sembra che piaccia molto”
La ricerca azioneSviluppata negli Stati Uniti negli anni Quaranta del Novecento per opera di Kurt Lewin (1890– 1947), che conia il termine “Action Research”, la Ricerca Azione si propone non solo di acquisire informazioni per arricchire il quadro conoscitivo rispetto ad un determinato oggetto di indagine, ma anche di analizzare le pratiche del contesto indagato per introdurre innovazioni. Anna Aluffi Pentini osserva che si tratta di un metodo che coniuga teoria e prassi, poiché indirizza la ricerca direttamente ad un’azione, nel quadro di una trasformazione da realizzare in contesti educativi, psicologici e sociali, in base a specifici criteri che consentono di essere consapevoli delle caratteristiche dell’innovazione introdotta, nonché di monitorarla e valutarla, in vista di una sua eventuale ridefinizione (Aluffi Pentini, 2001: 1).
Nel caso di adulti, si fa ricorso a lezioni frontali e gruppi di lavoro” Molto interessante è, in questa prospettiva di didattica laboratoriale, l’utilizzo della visita didattica “nei luoghi di vita quotidiana (poste, mercato, etc.) e […] ai monumenti di Roma”. Tale approccio assume una doppia valenza di promozione sia culturale sia

socio-economica, come racconta una intervistata: “Abbiamo cercato di fare delle cose fuori [dalla scuola], di portarli a vedere dei luoghi della città che loro non conoscevano, sia culturali sia che potessero essergli utili dal punto di vista del lavoro. Per esempio siamo andati a visitare un centro di orientamento al lavoro, che era una cosa che ci avevano chiesto, li abbiamo portati all’Auditorium, alle Catacombe […], e questa cosa mi sembra che piaccia molto”
A scuola: rendiamo presenti e attivi i corpi attraverso giochi, canti, laboratori manuali, materiali grammaticali manipolabili; accogliamo e stimoliamo le narrazioni dell’esperienza presente e accogliamo e stimoliamo la memoria attraversando quei temi antropologici universali che tendono ad accomunare le persone in condivisione di esperienze; non scindiamo mai l’analisi grammaticale dal senso del discorso, dal linguaggio vivo e comunicativo degli studenti e studentesse presenti qui e ora; stimoliamo l’immaginazione e l’identificazione attraverso storie e miti; stimoliamo l’espressione e la condivisione con immagini e oggetti” .
A questo proposito, una docente spiega l’efficacia della didattica cooperativa, nella quale il processo di apprendimento viene attivato all’interno di una interazione cooperativa tra i discenti, che acquisiscono saperi e competenze in un’esperienza collettiva: “[L’approccio] cooperativo è molto efficace […]. Abbiamo fatto dei lavori manuali, […] utilizzando i pennarelli, ritagliando i giornali, perché abbiamo cercato lavoro, abbiamo […] forse anche trovato lavoro; abbiamo fatto delle lettere di […] candidatura […]. E quindi forse questo li ha portati anche a collaborare, a scrivere, a fare proprio insieme” In molte scuole, il tema della cittadinanza emerge, così, spontaneamente all’interno delle attività didattiche, come nel caso di un laboratorio di digital storytelling, nel quale vengono utilizzati strumenti digitali multimediali per dar vita ad una narrazione, consentendo così ai partecipanti di rappresentare ed elaborare criticità significative del proprio vissuto biografico: “[Stiamo] provando ad attuare [...] un laboratorio di digital storytelling, in cui, attraverso un lavoro in gruppi sulle immagini e la realizzazione di un filmato, i ragazzi possono esprimere le loro storie
Ogni anno alla fine dei corsi si organizzano pic-nic con le classi e uscite culturali per conoscere la città di Roma. Gli studenti, insieme alle insegnanti, scelgono una quartiere da visitare: attraverso una lezione dedicata, viene distribuita una mappa della città di Roma e vengono illustrate le caratteristiche dei territori di maggiore interesse […]. Poi la classe sceglie il quartiere da visitare e le insegnanti organizzano l’uscita
“I prodotti finali di ogni corso sono in genere cartoline, dove vengono scritti i
pensieri positivi di fine corso, che vengono raccolte in una scatola in formato
anonimo; oppure la raccolta di ricette culinarie in lingua madre e relativa

traduzione in lingua italiana, sempre presentate a fine corso in occasione del buffet
finale della festa per la consegna degli attestati di partecipazione” Un’altra
intervistata racconta: “Alla fine dei corsi vengono fatte delle uscite didattiche nella
città. Una delle modalità di visita è la ‘caccia ai tesori della città’. Il materiale che
ne risulta viene raccolto, lavorato e regalato agli studenti a fine corso”
Alcuni materiali prodotti dai partecipanti riguardano poi “cartelloni e disegni fatti dagli alunni, oltre che la presentazione di elementi della cultura di provenienza (musica, tradizioni, etc.) portati dagli alunni stessi”. I prodotti finali realizzati nei percorsi formativi sono rappresentanti, infine, anche da testi narrativi e rappresentazioni teatrali: “
Cristolini EUROPA La ricerca europea evidenza come i giovani che mostrano un atteggiamento positivo verso la partecipazione civile e politica sono quelli che hanno avuto a scuola insegnamenti di educazione civica e alla cittadinanza per almeno 45 minuti a settimana da parte dell’insegnante di classe L’influenza positiva dell’insegnamento cresce con l’esperienza maturata in situazioni educative interessanti per gli studenti Le scuole raggiungono rilevanti successi nell’apprendimento di comportamenti positivi da parte degli alunni, in senso etico, sociale e civico, quando l’insegnamento è inserito nel curricolo L’inserimento nel curricolo conduce gli alunni a conoscenze e apprendimenti socialmente positiviGlottodidatticaHocus & Lotus è un sito dedicato all’apprendimento linguistico dei bambini (2-10 anni) contenente numerosi materiali per discenti e insegnanti Aiuta i piccoli ad apprendere le basi della lingua (italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco) grazie alle avventure di Hocus e Lotus, mezzodinosauri e mezzo-coccodrilli http://www.hocus-lotus.edu