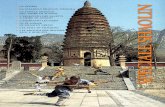Introduzione · Web viewIntroduzione La storia costituzionale italiana, pur nella sua relativa...
Transcript of Introduzione · Web viewIntroduzione La storia costituzionale italiana, pur nella sua relativa...

Storia costituzionale. Appunti dalle lezioni(Prima parte)*
Paolo Passaglia
Indice
Introduzione.................................................................................................................2
Prima lezione – Le origini della storia costituzionale unitaria.......................................4
Seconda lezione – La forma di Stato nel periodo monarchico-liberale......................19
Terza lezione – La forma di governo nel periodo monarchico-liberale.......................38
* Testo inedito.

Introduzione
La storia costituzionale italiana, pur nella sua relativa brevità – constatabile soprattutto
allorché la si compari con quella di altri Stati europei, quali, ad esempio, Inghilterra o
Francia – è segnata da una serie di avvenimenti fortemente caratterizzanti, non solo sul
piano istituzionale, ma anche su quello politico, economico e sociale, che suggeriscono la
successione di fasi diverse, connotate da elementi di più o meno marcata discontinuità.
Alla luce di tale constatazione, appare opportuno tratteggiare una periodizzazione che,
nella misura in cui non venga ad essa attribuito valore euristico, può offrire un utile
orientamento preliminare.
Per tradizione consolidata (cui non sembra dato derogare, tanto più in un caso, come il
presente, nel quale la finalità perseguita è esclusivamente quella didattica), le fasi della
storia costituzionale italiana sono così individuate:
1] un primo periodo, denominato «monarchico-liberale», copre i decenni che vanno
dall’unità (salvo quanto si dirà tra breve in ordine allo strutturarsi delle istituzioni) sino
all’avvento del regime fascista;
2] segue il periodo corrispondente alla dittatura fascista, il cui dies a quo è solitamente
indicato nel 28 ottobre 1922 (data della c.d. «marcia su Roma»), sebbene sia preferibile
argomentare nel senso dell’esistenza di una fattispecie a formazione progressiva, che da
quella data prende avvio;
3] la fine dell’esperienza fascista, storicamente datata 25 luglio 1943 (allorché il Gran
Consiglio del Fascismo ebbe «sfiduciato» Mussolini), apre il c.d. «periodo costituzionale
provvisorio» (o «transitorio»);
4] finalmente, l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, il 1° gennaio 1948,
introduce una fase nuova, nella quale stiamo tuttora vivendo.
La quadripartizione appena accennata non esclude – anzi, implica, vista almeno la
durata di alcune fasi – la possibilità di individuare sottoperiodi, senza che, tuttavia, essi
inficino una fondamentale unitarietà delle esperienze dei quattro segmenti temporali
indicati: in quest’ottica, la trattazione che segue – di cui si pubblica la prima parte –
cercherà di rimarcare l’esistenza di continuità, discontinuità e «micro-discontinuità»,
suggerite dall’evoluzione della forma di Stato e della forma di governo. Tali ultime nozioni
orienteranno il metodo della ricerca, tesa ad isolare i caratteri essenziali dell’una e
dell’altra nelle singole fasi di cui si compone la storia costituzionale italiana.

Prima di entrare in medias res, due ulteriori premesse sono peraltro necessarie. In
primo luogo, una particolare attenzione dovrà essere dedicata all’origine dello Stato
italiano ed all’iniziale suo assetto istituzionale, al fine di cogliere i rapporti sussistenti tra il
Regno di Sardegna ed il Regno d’Italia. In secondo luogo, lo studio storico dell’esperienza
costituzionale italiana consiglia di concentrarsi «sul passato», trasferendo l’esame più
approfondito della fase attuale all’esame degli istituti di diritto positivo, auspicabilmente
condotto anche in chiave diacronica.
– 3 –

Prima lezione – Le origini della storia costituzionale unitaria
1. La formazione dello Stato italiano
La penisola italiana, nella prima metà del XIX secolo, era percorsa da un diffuso anelito
all’unificazione dei vari Stati ivi presenti, onde giungere ad una congruenza, personale e
territoriale, tra la Nazione italiana e lo Stato italiano: altrimenti detto, era radicata la volontà
di accomunare gli italiani all’interno di un unico Stato, indipendente dalle potenze straniere
egemoni (e segnatamente da quella austriaca).
Nel pensiero politico, questa volontà si tradusse in prefigurazioni teoriche
dell’unificazione sussumibili in due grandi categorie, l’una comprendente i fautori dell’unità,
l’altra i sostenitori della necessità e/o dell’opportunità di una federazione tra gli Stati
esistenti.
A teorizzare la formazione di uno Stato unitario fu, innanzi tutto, Mazzini, auspice di
un’insurrezione democratica al termine della quale raggiungere il duplice obiettivo
dell’unità e della repubblica. Analogamente, ma con un seguito assai esiguo in termini
numerici, il pensiero socialista-rivoluzionario propugnava una rivoluzione che associasse
all’unità un diverso assetto degli equilibri tra le classi (ciò che implicava, tra l’altro, la
necessità di una rivoluzione promossa direttamente dalle masse lavoratrici ed il connesso
rifiuto di una insurrezione di stampo mazziniano, condotta da intellettuali e borghesi).
Alle impostazioni insurrezionali si affiancò, ma solo dopo il 1848 (e per le ragioni che
vedremo tra breve), l’idea, che risulterà vincente, di una unità come frutto di un processo
guidato dall’«alto», ispirato dal liberalismo moderato sotto l’egida del Regno di Sardegna.
La difficoltà pratica di ipotizzare la creazione di un unico Stato, testimoniata anche dal
tendenziale fallimento dei tentativi di insurrezione che costellarono l’età della
Restaurazione e che culminarono con gli avvenimenti della Prima guerra di indipendenza
(1848-1849), alimentò approcci teorici diversi, accomunati dall’idea di creare una
federazione tra gli Stati esistenti. In questo ambito teorico si muovevano il federalismo
cattolico, il federalismo laico ed una impostazione che potremmo definire – mutuando il
lessico corrente negli studi di storia dell’integrazione europea – come «funzionalista».
Quest’ultima era propria essenzialmente dei teorici del libero scambio, che vedevano un
primo passo verso l’unificazione nel superamento di quelle divisioni giuridiche e materiali
che si frapponevano tra i diversi Stati: nella prospettiva di addivenire, in tempi
relativamente rapidi, ad una federazione, si propugnava, quindi, la formazione di un

mercato unico delle merci, attraverso l’eliminazione dei dazi interni (sull’esempio
dell’unione doganale – lo Zollverein – sviluppatasi a partire dal 1818 tra gli Stati tedeschi),
ma anche attraverso l’unificazione dei codici di commercio e del sistema monetario,
nonché – al precipuo fine di rendere più agevoli le interazioni tra le comunità – la
creazione di una rete ferroviaria unificata. A questa impostazione potevano ascriversi
anche i nove congressi degli scienziati italiani tenutisi tra il 1839 (a Pisa) ed il 1847.
Attorno agli anni quaranta dell’Ottocento, si sviluppò un federalismo di impronta
cattolica, veicolato dal c.d. «neoguelfismo», che vedeva la necessità di affermare un
cattolicesimo liberale che favorisse l’indipendenza nazionale, anche attraverso riforme
interne agli Stati, tese a rendere possibile una confederazione di Stati posta sotto la guida
ideale e, poi, politica del Papato. Questa fusione di sentimento religioso e sentimento
nazionale, sancita dalla attribuzione al Papa della presidenza della confederazione, che
significativamente ribaltava l’ottica di Machiavelli (per il quale era proprio il Papato a
costituire l’ostacolo principale all’unità italiana), poneva in evidenza la circostanza secondo
cui, in un contesto nel quale la penisola era egemonizzata da una potenza straniera
fortemente ancorata alla religione cattolica, la Chiesa sarebbe stata l’unico organismo
capace, per autorità morale, di imporsi sull’Austria.
Il massimo esponente del pensiero neoguelfo fu Gioberti, il quale immaginava una
sinergia tra l’autorità pontificia e la forza politica del Piemonte sabaudo, destinato ad
essere lo Stato guida della confederazione per la sua superiorità (anche militare) rispetto
agli altri. Gli avvenimenti del 1849, con la fine della Repubblica romana, imporranno,
tuttavia, allo stesso Gioberti una rivisitazione di quanto teorizzato nel suo Del primato
morale e civile degli Italiani (1843).
Se per Gioberti la guida spirituale pontificia avrebbe permesso una confederazione
anche con la perdurante presenza austriaca nella Lombardia e nel Veneto e restando
immutati i confini territoriali dei diversi Stati, il presupposto di coloro che propugnavano un
federalismo in chiave laica era proprio l’allontanamento dell’Austria dal territorio italiano.
La polemica anti-austriaca era però uno dei pochi elementi di comunanza tra le diverse
teorie, sovente molto divergenti: alla visione sabaudo-centrica della federazione di un
liberale moderato come Cesare Balbo, si opponevano – pur se con minore successo in
seno all’opinione pubblica – il federalismo con forti accentuazioni sociali(ste) di Ferrari e la
concezione gradualistica, nell’ottica di una forte autonomia municipale, propria di
Cattaneo, avverso tanto al regime dispotico austriaco quanto a quello – ritenuto
culturalmente e politicamente arretrato – del Piemonte.
– 5 –

La poliedricità di queste impostazioni (qui solo sommariamente evocata, tacendo di
molte altre posizioni pur autorevolmente espresse) venne ricondotta ad unità dalla azione
del Regno di Sardegna, che, sotto la guida del Re Vittorio Emanuele II e di Camillo Benso
Conte di Cavour, riuscì ad egemonizzare il panorama politico, convogliando lo sforzo per
l’unificazione sotto le insegne sabaude, nella prospettiva di una unità istituzionale di tutta
la penisola, strutturata sui modelli propri del regno subalpino.
La centralità assunta, nel processo di unificazione, dallo Stato sabaudo pone, sul piano
giuridico, il problema fondamentale dei rapporti che sussistono tra questo Stato e quello
che risulterà dopo che la penisola sarà stata unificata. In altri termini, il giurista è chiamato
ad interrogarsi sulla riscontrabilità di una continuità di fondo tra ciò che precede e ciò che
segue la proclamazione del Regno d’Italia ovvero sulla necessità di marcare un discrimen.
A tal riguardo, sono state avanzate fondamentalmente due tesi, l’una detta della fusione
(ANZILLOTTI), l’altra, prevalente, della incorporazione-annessione (SANTI ROMANO).
Secondo la prima, la progressiva riunione dei territori del Regno di Sardegna con quelli
degli altri Stati (o con province degli altri Stati) presenti nella penisola sarebbe stato il
risultato di una fusione tra ordinamenti giuridici diversi tesa a produrre l’esistenza di un
ordinamento giuridico nuovo ed il contestuale dissolversi di quelli preesistenti. Di contro, la
tesi della incorporazione (di Stati) – annessione (di territori appartenenti ad altri Stati)
postula la continuità del Regno di Sardegna, che si sarebbe esteso territorialmente a
scapito delle altre entità giuridiche sino a coprire (quasi) tutta la penisola (con l’eccezione,
fino al 1866, della provincia di Mantova e del Veneto, e, fino al 1870, del Lazio), ciò che
avrebbe reso il Regno d’Italia nulla più che la continuazione, con un nome diverso, dello
Stato sabaudo.
Onde prendere posizione sul tema, le indicazioni provenienti dai vari procedimenti di
unificazione territoriale del biennio 1859-1860, per quanto significative, non appaiono
conclusive, principalmente per la loro eterogeneità. Di seguito, se ne fornisce, comunque,
una sintesi.
a) La Lombardia (con l’esclusione della provincia di Mantova) venne ceduta dall’Austria
(per il tramite della Francia) con il trattato di Zurigo (10 novembre 1859). Il passaggio delle
province dallo Stato asburgico a quello sabaudo non venne subordinato ad alcuna
manifestazione di volontà popolare, essendosi – invero, opinabilmente – ritenuto valido nei
suoi risultati il plebiscito svoltosi nel 1848, con il quale, però, la volontà di far parte del
Regno sabaudo era stata manifestata nel quadro della espressa previsione di una
– 6 –

assemblea costituente incaricata di stabilire le basi di un nuovo Stato, di cui la dinastia
sabauda avrebbe avuto la corona.
b) Il Granducato di Toscana venne annesso a seguito di un plebiscito indetto, per l’11
marzo 1860, da un governo provvisorio; il quesito che si poneva si sostanziava nella
dichiarazione di volontà di unirsi al Regno di Vittorio Emanuele.
c) Del tutto analogo (e pressoché contestuale, essendosi i plebisciti svolti il 12 marzo
1860) fu il procedimento che condusse alla riunione dei territori dei Ducati di Modena e
Parma e delle Legazioni pontificie di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna.
d) Il 21 ottobre 1860 si tennero, sotto il governo provvisorio di Giuseppe Garibaldi, i
plebisciti nei territori del Regno delle Due Sicilie. Con essi il popolo si pronunciò per
«l’Italia una e indivisibile con Vittorio Emanuele Re costituzionale e i suoi legittimi
discendenti». Precedentemente, peraltro, lo stesso governo provvisorio, per decreto,
aveva dichiarato l’annessione dei territori al Regno di Sardegna.
e) Finalmente, il 4 novembre 1860, plebisciti il cui quesito era identico a quello redatto
per il Granducato di Toscana e per i territori emiliani vennero tenuti, sotto l’autorità dei
commissari del Regno sabaudo, nelle Marche e nell’Umbria.
Ora, confrontando i diversi procedimenti seguiti, possono rintracciarsi tanto elementi a
favore della tesi della fusione quanto elementi a favore della tesi opposta: a titolo
esemplificativo, possono citarsi, nel primo senso, i quesiti dei plebisciti svoltisi in
Lombardia e nel Regno delle Due Sicilie, mentre, nel secondo senso, gli altri quesiti e, in
certi casi, anche l’organizzazione dei plebisciti direttamente da parte di agenti del Regno di
Sardegna.
Per sciogliere dunque l’alternativa tra la fusione e l’incorporazione-annessione non
possono non prendersi in esame una pluralità di altri fattori.
In favore della tesi della fusione, e della conseguente soluzione di continuità tra Regno
di Sardegna e Regno d’Italia, milita certamente la constatazione delle profonde differenze
tra i due riscontrabili in ordine a due degli elementi costitutivi dello Stato, quali il popolo ed
il territorio.
Ad una osservazione più compiuta, tuttavia, gli argomenti che fanno propendere per la
tesi dell’incorporazione-annessione, e dunque per la continuità tra Regno di Sardegna e
Regno d’Italia, risultano preponderanti.
Innanzi tutto, la fusione non è astrattamente configurabile per tutti i casi di riunione di
territori, bensì soltanto per quelli che hanno visto una unione tra due entità statuali (Ducati
– 7 –

di Modena e Parma, Granducato di Toscana, Regno delle Due Sicilie), altrove trattandosi
necessariamente di trasferimenti di frazioni di territorio e di popolazione di uno Stato
(Austria, nel caso della Lombardia; Stato pontificio, per le Marche e l’Umbria) ad un altro
(Regno sabaudo).
Anche così delimitata la sua valenza, la tesi della fusione si scontra con la circostanza
che i plebisciti furono, in ogni caso, atti non di diritto internazionale ma di diritto interno,
riconducibili agli Stati destinati ad estinguersi oppure al Regno di Sardegna, che li aveva
indetti facendo dipendere dal loro esito la continuazione della situazione di fatto venutasi a
creare con l’occupazione militare da parte dell’esercito sabaudo.
Se i plebisciti furono atti di diritto interno, appare assai problematico far derivare da essi
tutti gli effetti che postula la tesi della fusione: la manifestazione di volontà di una
popolazione, infatti, avrebbe avuto il triplice effetto di far estinguere lo Stato preesistente
(ad esempio, il Granducato di Toscana), di far estinguere il Regno di Sardegna, per come
esso era fino al momento del plebiscito, e di creare uno Stato nuovo, risultante dai primi
due. In buona sostanza, si sarebbe attribuito alla volontà di una popolazione estranea
(sino a quel momento) al Regno di Sardegna il potere di far dissolvere il Regno di
Sardegna, ciò che pare – quanto meno – difficilmente argomentabile. Aggiungasi che, in
tal modo, si sarebbe in presenza di una successione – quasi un tourbillon – di Stati nati e
morti nel giro di poco tempo, nell’intervallo tra un plebiscito e l’altro (giungendosi anche a
recensire uno Stato durato lo spazio di un giorno, tra l’11 ed il 12 marzo 1860, data dei
plebisciti toscano ed emiliani).
Oltre che dai problemi che emergono a seguire la tesi opposta, la tesi della continuità
(come conseguenza della incorporazione-annessione) è poi suffragata da tutta una serie
di ulteriori elementi formali e sostanziali di non trascurabile rilievo.
Per quanto attiene agli elementi formali, viene in evidenza, in primo luogo, la
formulazione dei reali decreti emanati al fine di dichiarare, prendendo atto dei plebisciti,
l’avvenuta annessione delle province di volta in volta interessate allo Stato sabaudo (da
notare è, peraltro, che, nei decreti più recenti, quelli cioè relativi al Mezzogiorno, alle
Marche ed all’Umbria, si faceva espresso riferimento, a testimonianza dell’avvenuta
percezione del successo dell’opera di unificazione, allo «Stato italiano»).
Altro aspetto rilevante per la qualificazione giuridica in termini di continuità è la forma
che ha assunto la proclamazione del Regno d’Italia. La legge 17 marzo 1861, n. 4671, alla
quale si riconduce tradizionalmente la proclamazione ufficiale del «nuovo» Regno, si
limitava a prevedere, nel suo articolo unico, che «Vittorio Emanuele II assume[va] per sé e
– 8 –

per i suoi successori il titolo di Re d’Italia»: la continuità con il Regno di Sardegna è qui
dimostrata dalla laconicità di un testo che parrebbe quasi tendere a risolvere l’intero
procedimento di unificazione nell’attribuzione al sovrano sabaudo di un nuovo titolo.
Puramente formale, ma non per questo da trascurare aprioristicamente, nella misura in
cui si inserisce nel contesto appena descritto, è la decisione che fu assunta di mantenere
inalterata la numerazione ordinale del Re ed anche quella delle legislature, che fece sì che
la prima legislatura del Parlamento post-unitario fosse connotata dal numero ordinale
«VIII», a segnare il continuum rispetto alle sette legislature del Parlamento subalpino (dal
1848).
Relativamente agli aspetti di sostanza che indicano uno stretto legame tra ciò che
precedette e ciò che seguì l’unificazione istituzionale della penisola può sottolinearsi la
circostanza che, nei rapporti internazionali, rimasero fermi soltanto i trattati stipulati dal
Regno di Sardegna, cadendo invece quelli stipulati dagli altri Stati.
Ad essere veramente dirimente è, peraltro, la spiccata continuità normativa tra il Regno
subalpino ed il Regno italiano, prodotto di una generale estensione del complesso del
diritto positivo piemontese all’intera penisola, simbolizzato dalla estensione a tutta la
penisola della vigenza dello Statuto albertino (su cui, v. infra) e veicolato, altresì, dalla
legge 20 marzo 1865, n. 2248, sull’unificazione amministrativa del Regno, comprensiva di
sei allegati, concernenti, rispettivamente, la legge comunale e provinciale, quella di
pubblica sicurezza, quella sulla sanità pubblica, quella sul Consiglio di Stato, quella sul
contenzioso amministrativo e quella sui lavori pubblici. L’insieme di queste normative (e di
altre, precedenti e successive), per quanto esse potessero apparire parzialmente nuove, si
caratterizzava per il forte legame con il diritto piemontese (non a caso significativamente
innovato nel 1859, nella prospettiva dell’ampliamento della sua sfera territoriale).
Non è dunque casuale che, per argomentare sul piano teorico la tesi
dell’incorporazione-annessione, chi – come MORTATI – ha preso spunto da questa
continuità normativa, ha potuto constatare il mancato mutamento della c.d. «costituzione
materiale», testimoniato dal fatto che «l’estensione al resto della penisola del complesso
normativo vigente in Piemonte fu espressione del predominio delle forze accentrate
intorno alla monarchia, che riuscì a frustrare l’aspirazione di quelle élites le quali, sotto la
guida spirituale di Mazzini, tendevano a realizzare un ordinamento del tutto diverso che si
adeguasse alle nuove esigenze».
– 9 –

2. L’antefatto istituzionale: lo Statuto albertino
La conclusione cui si è giunti in tema di continuità della costituzione materiale tra il
Regno di Sardegna ed il Regno d’Italia rende indefettibile, ogniqualvolta si vadano ad
analizzare le istituzioni post-unitarie, un flashback che consenta di tratteggiare la struttura
delle istituzioni subalpine, destinate a divenire le prime dell’Italia unita.
In una indagine siffatta, valido punto di partenza può essere quello della promulgazione
dello Statuto concesso dal Re Carlo Alberto ai regnicoli sardi il 4 marzo 1848, e destinato
a reggere lo Stato italiano almeno per tutto il periodo monarchico-liberale (sulla perdurante
validità dello Statuto in epoca fascista, v. infra).
Per cogliere appieno la natura di questa carta costituzionale, conviene esaminare
partitamente il contesto nel quale essa venne redatta e le sue caratteristiche formali.
2.1. Quando l’ondata rivoluzionaria del 1847-1848 scosse l’Europa continentale, il
Regno di Sardegna era ben lungi dal potersi considerare come uno Stato politicamente e
socialmente avanzato. Il regnante, Carlo Alberto, una volta salito al trono nel 1831, aveva
abiurato le giovanili simpatie «liberali» (che lo avevano condotto ad appoggiare, durante i
moti del 1821, i militari rivoltosi) in favore della conservazione di istituzioni monarchiche
largamente ispirate al modello assolustico di Ancien régime.
Sul finire del 1847, tuttavia, la penisola italiana veniva percorsa da aliti riformistici
(soprattutto nello Stato pontificio, dopo l’avvento al soglio di Pio IX, e nel Granducato di
Toscana), riverberatisi, all’interno del Regno di Sardegna, in dimostrazioni e moti di
piazza, che, tra il settembre e l’ottobre, si verificarono a Genova ed a Torino, e che
indussero il monarca sabaudo a licenziare i più reazionari tra i suoi ministri ed a concedere
alcune, pur timide riforme (annunciate il 30 ottobre e consistenti, tra l’altro, nell’abolizione
di alcuni tribunali straordinari, nell’introduzione di una limitata libertà di stampa e nel
passaggio della polizia, già incardinata nel Ministero della guerra, al Ministero degli
interni).
Con il 1848, e la deflagrazione di una ondata rivoluzionaria che finirà per coinvolgere
l’intero continente, le riforme albertine si appalesarono insufficienti a soddisfare una
opinione pubblica profondamente colpita dal proclama del 29 gennaio con il quale il
sovrano di un regno notoriamente arretrato sul piano politico, quale quello delle Due
Sicilie, promise la concessione di una Costituzione, poi effettivamente promulgata il 12
febbraio, sulla base del modello rappresentato dalla costituzione francese del 1830 (la
– 10 –

Costituzione c.d. orleanista).
La decisione del Re di Napoli ebbe vasta eco negli Stati della penisola, tanto che, nel
giro di poche settimane, costituzioni vennero concesse anche nel Granducato di Toscana
(17 febbraio) e nello Stato pontificio (14 marzo).
È in questo contesto che, su pressione dell’opinione pubblica, il Re di Sardegna si aprì
alle istanze riformatrici. Qualche giorno dopo il proclama del Re di Napoli, Carlo Alberto
convocò (3 febbraio) un «Consiglio di conferenza» (l’organo corrispondente, in larga
misura, a quello che verrà poi denominato Consiglio dei ministri), in cui discutere della
concessione di una costituzione.
Quale fosse l’atteggiamento della monarchia e dei ministri e quali fossero le intenzioni
che li animavano è ben rappresentato dalla frase con cui il Ministro dell’interno, Borelli,
argomentò la propria posizione (peraltro condivisa da tutti i colleghi) in merito alla
promulgazione di una costituzione: «bisogna concederla, non farsela imporre; dettare le
condizioni, non riceverle» [T.d.A.]. In buona sostanza, tutti i ministri di Carlo Alberto,
professandosi ostili, in astratto, ad ogni limitazione dell’autorità regia, si pronunciarono
nondimeno a favore della costituzione, ché essa veniva percepita alla stregua di un «male
minore», se non addirittura come un passo ineluttabile (dirà, ancora, Borelli: «la
costituzione è un male […]. Ma questo inconveniente sarebbe meno grande dell’altro. È
dunque meglio […] adottare un rimedio che sarà forse una sventura, che cadere in un
male più grande. […] questo rimedio è una costituzione» [T.d.A.]).
All’esito della riunione del 3 febbraio conseguì una nuova convocazione del Consiglio di
conferenza, allargato ad una decina di personalità di diverse tendenze, per il 7 febbraio.
La discussione allora svoltasi si concluse con una conferma degli intendimenti già espressi
e con la decisione di emanare un «proclama reale» che, unitamente all’annuncio della
concessione della costituzione, enucleasse quelli che ne sarebbero stati i caratteri
fondamentali.
Il giorno seguente, venne pubblicato un proclama con il quale Carlo Alberto dichiarava
di voler concedere «un compiuto sistema di governo rappresentativo», che si fondasse su
una serie di principi contestualmente enunciati in quattordici articoli. Tra i cardini del nuovo
sistema si segnalavano, in particolare: il riconoscimento della religione cattolica come
religione ufficiale dello Stato (gli altri culti essendo «tollerati», conformemente a previsioni
legislative); l’irresponsabilità del Re, il quale sarebbe comunque rimasto l’unico titolare del
potere esecutivo; l’attribuzione del potere legislativo al Re ed a due camere, di cui una
elettiva e l’altra di nomina regia; l’esercizio della giurisdizione, nel nome del Re, da parte di
– 11 –

giudici inamovibili; la garanzia della libertà personale; la libertà di stampa (salva la
previsione di leggi repressive).
Così tracciati gli assi cartesiani del testo costituzionale che doveva essere redatto, il
Consiglio di conferenza in composizione integrata si riunì nuovamente il 10 febbraio e,
dopo sole cinque sedute, presentò al sovrano uno «Statuto», promulgato il 4 marzo e
pubblicato in duplice lingua (in italiano a Torino, in francese – lingua in cui le sedute del
Consiglio di conferenza si svolsero – a Chambéry, in Savoia).
Le vicende che seguirono, con la radicalizzazione dell’ondata rivoluzionaria, videro le
iniziali vittorie dei liberali successivamente annichilite dal ritorno delle forze moderate e
reazionarie, sì che tutte le costituzioni quarantottesche erano, alla fine del 1849, solo un
ricordo. Tutte, tranne una: lo Statuto del Regno di Sardegna era, infatti, sopravvissuto alla
disastrosa guerra tra Piemonte ed Austria. Da quel momento, lo stato sabaudo restò
l’unica entità politica italiana nella quale non fosse stato restaurato un regime di stampo
prettamente reazionario; su di esso, dunque, si concentrarono – come si è accennato – le
speranze di molti fautori dell’unificazione.
2.2. Il frangente in cui lo Statuto venne redatto caratterizzò fortemente il testo, per ciò
che attiene sia al suo significato storico-politico originario che ai suoi aspetti formali, oltre
che, ovviamente, ai contenuti in esso trasfusi.
Tralasciando, per il momento, l’analisi dei contenuti, pare di poter dire che il contesto in
cui la carta vide la luce e l’arrière-pensée dei redattori costituiscono una efficace chiave di
lettura per spiegare, quanto meno con buona approssimazione, (a) la denominazione che
alla carta venne data, (b) la scelta dei modelli di riferimento, ma anche (c) il tipo di
costituzione che ne risultò.
(a) Alla luce dell’evoluzione del diritto costituzionale posteriore alle rivoluzioni francese
ed americana, il nomen «Statuto fondamentale del Regno» suona anacronistico, se è vero
che le carte fondamentali dei regimi ottocenteschi si definiscono tutte (o quasi)
«costituzione».
La diversa denominazione fu scelta essenzialmente per la sua alienità da ogni afflato
rivoluzionario, generalmente veicolato, nell’età della Restaurazione, dalla «lotta per la
costituzione» che animava la nascente classe borghese italiana ed europea. L’utilizzo di
una sorta di vox media si coniugava dunque assai meglio, rispetto a denominazioni
politicamente più impegnative, con l’intenzione di tenersi ben distanti da un sovvertimento
– 12 –

dell’esistente (è indubbio, lo si è visto, che si volesse concedere «quanto necessario», ma
pur sempre «il meno possibile»).
L’individuazione in concreto della vox media da utilizzare fu suggerita dalla necessità di
proporre un nome che avesse comunque una qualche valenza evocativa: in tal senso, lo
«Statuto» appariva particolarmente adatto in ragione del suo richiamare l’esperienza
comunale del Basso Medioevo, idealizzata ad un tempo come simbolo della lotta contro
l’autocrazia imperiale e come espressione di una età gloriosa per la penisola italiana.
(b) In ordine ai modelli cui il Consiglio di conferenza si rifece nel redigere la carta
albertina, è ampiamente attestata la forte influenza che sui redattori dello Statuto
esercitarono le carte costituzionali francesi del 1814 e del 1830. La prima, in particolare,
rappresentava il ritorno ad una monarchia limitata dopo il periodo rivoluzionario, nel
quadro di una Restaurazione che, da moderata, sarebbe divenuta, ma solo con il tempo
(specie con l’ascesa al trono di Carlo X, nel 1824), apertamente reazionaria. La
Costituzione orleanista, nel 1830, rappresentava un aggiornamento – a tratti, una
riproposizione – della carta precedente, modificata essenzialmente nella base di
legittimazione (la sovranità popolare sostituiva la legittimazione dinastica del potere), più
che nella struttura delle istituzioni.
Lo Statuto albertino fu modellato, in buona parte, su questi esempi (in taluni casi anche
attraverso una mera traduzione delle disposizioni), rivisitati però in chiave più tradizionale
e conservatrice, come dimostrava, tra l’altro, l’ordine degli argomenti trattati: ad esempio,
le carte del 1814 e del 1830 si aprivano con un breve elenco dei diritti dei francesi (l’art. 1
sanciva il principio di eguaglianza formale), mentre lo Statuto sanciva, all’art. 1, il carattere
confessionale dello Stato, per poi soffermarsi lungamente sulla figura del Re e – ma in
modo più sbrigativo e solo dall’art. 24 – sui diritti degli individui.
La preponderanza dell’influenza delle carte francesi non venne intaccata che molto
parzialmente dalla Costituzione belga del 1831, ritenuta troppo «avanzata» dai redattori
dello Statuto. Pressoché nessuna eco ebbe, invece, la tradizione costituzionale britannica,
solo sommariamente (ed in modo approssimativo) conosciuta, mentre del tutto ignorata fu
la Costituzione americana.
In definitiva, lo Statuto albertino si poneva in linea di stretta continuità con la
Restaurazione francese e, paradossalmente, lo faceva proprio negli stessi giorni in cui,
con l’insurrezione parigina del 22 febbraio 1848, la monarchia orleanista crollava e si
instaurava una repubblica che, dopo un periodo di assestamento, si sarebbe dotata, il 4
novembre, di una costituzione affatto nuova.
– 13 –

(c) Dall’aver seguito un modello che si era appena rivelato «vecchio», e dall’averlo fatto,
oltretutto, limandone alcuni degli aspetti più progressisti, risultò un tipo di legge
fondamentale che, per i caratteri suoi propri, si inseriva a pieno titolo nell’alveo delle
costituzioni sino ad allora esistenti. In particolare, lo Statuto albertino, alla stessa stregua
della maggior parte delle carte del primo Ottocento, poteva definirsi come una costituzione
(i) ottriata, (ii) bilancio, (iii) flessibile e (iv) breve.
i) È stato sin qui evidenziato come lo Statuto fosse stato promulgato su iniziativa del Re
di Sardegna e dei suoi consiglieri, sul presupposto dell’assoluta libertà, sul piano giuridico,
in merito all’an della promulgazione. Il preambolo della Carta era, in tal senso,
inequivocabile, là dove Carlo Alberto affermava: «con lealtà di Re e con affetto di padre
Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai nostri amatissimi Sudditi, col
Nostro proclama dell’8 dell’ultimo scorso febbraio […]. […] di Nostra certa scienza, Regia
Autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di
Statuto e Legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue
[…]».
Una lettura superficiale di questi passi del preambolo rende palese il carattere ottriato
(da octroyer, «concedere») dello Statuto: era il monarca, sino a quel momento assoluto,
che decideva di concedere la costituzione, utilizzando – per l’ultima volta – la formula
tradizionale degli atti sovrani («di Nostra certa scienza, Regia Autorità»). La
partecipazione popolare era del tutto assente dal procedimento di formazione; era ignorata
dal preambolo ogni pressione proveniente dall’esterno del palazzo reale; ogni possibile
sollecitazione diversa dal moto spontaneo del sovrano, per il fatto stesso di essere taciuta,
era confinata al piano degli antefatti – giuridicamente irrilevanti – di natura politica e
sociale.
Ad una analisi più attenta, tuttavia, il preambolo suggerisce l’opportunità di scindere il
piano formale da quello sostanziale. Se, infatti, formalmente la constatazione che si tratti
di una costituzione ottriata è inoppugnabile, sul piano sostanziale non deve essere
sottovalutato il riferimento all’acquisizione del parere del Consiglio di conferenza né quello
al proclama reale di un mese prima. Entrambi questi elementi richiamavano una sorta di
implicito patto tra il sovrano, da un lato, e, dall’altro, la classe dirigente ed il popolo tutto,
un patto «costituzionale» con cui il Re andava incontro alle richieste liberali (incentrate
sull’introduzione di un «governo rappresentativo», non a caso enfatizzata nel proclama
dell’8 febbraio), affinché i beneficiari della concessione rinunciassero alla mobilitazione di
piazza e finanche al sovvertimento dell’ordine costituito (in tal senso, le parole di Borelli
– 14 –

citate in precedenza sono quanto mai significative).
In definitiva, la qualificazione dello Statuto fondamentale del Regno è duplice:
formalmente ottriata, sostanzialmente pattizia (o, forse meglio, «cripto-pattizia»).
ii) I termini del citato patto costituzionale rendono palese la configurabilità dello Statuto
alla stregua di una costituzione-bilancio, una costituzione, cioè, che non si propone un
programma di innovazione della società e delle istituzioni che si estenda nel futuro, ma
che, viceversa, tende a fare il punto sulla situazione presente, per come essa si è venuta
configurando, in funzione di una sua conservazione e di una sua razionalizzazione.
La monarchia sabauda, conscia dell’impossibilità di mantenere istituzioni ereditate
dall’Ancien régime, cedette (per quanto fosse indispensabile) alle pressioni liberali,
riallineando in tal modo le istituzioni alla società. Il fine dichiarato era, ovviamente, quello
di consolidare lo status quo, lungi restando l’idea di proseguire nel solco appena tracciato.
L’evoluzione, per certi versi profonda, che il sistema conoscerà sarà resa possibile da
una diversa interpretazione dello Statuto propugnata, negli anni a venire, da (buona) parte
del ceto politico; per Carlo Alberto, e per i suoi consiglieri, la costituzione concessa doveva
essere – come si sottolineava nel preambolo – «perpetua ed irrevocabile».
iii) L’origine e le finalità dello Statuto ebbero profonde ripercussioni anche sulla
collocazione della carta costituzionale nel sistema.
Per tradizione consolidata, lo Statuto albertino è definito come una costituzione
flessibile (anzi, come un esempio tipico di costituzione flessibile), all’uopo potendosi
addurre sia l’assenza di un procedimento di revisione costituzionale, sia – e soprattutto –
l’ampio ricorso, già nei primi mesi della sua vigenza, a modificazioni tacite e, sia pure in
minor misura, esplicite da parte di fonti legislative ordinarie.
Tra le modificazioni tacite, si segnalano, per solito, la profonda modifica dell’assetto
della forma di governo e la perdurante vigenza della carta anche dopo il mutamento della
forma di Stato durante il ventennio fascista (su entrambi i temi, v. infra).
Tra le modificazioni esplicite possono distinguersi quelle che hanno avuto l’effetto di
espressamente derogare pro futuro a disposizioni costituzionali da quelle che si sono
sovrapposte alle medesime disposizioni, giungendo in qualche caso a svuotarle di
significato.
Nel primo senso, può citarsi il proclama di Carlo Alberto del 23 marzo 1848 con cui,
meno di tre settimane dopo la promulgazione dello Statuto, si ordinava che le truppe
impegnate nella guerra contro l’Austria sostituissero la bandiera dello Stato di cui all’art. 77
– 15 –

con quella tricolore. Qualche giorno più tardi, il regio decreto 11 aprile 1848 imponeva di
issare la nuova bandiera su tutte le navi militari e mercantili.
Tra le sovrapposizioni normative, invece, possono citarsi, per un verso, tutte quelle
leggi che, di volta in volta, ampliarono o restrinsero i margini di libertà statutariamente
riconosciuti agli individui, e, per l’altro, la successione di leggi che piegarono la natura
confessionale dello Stato ai canoni liberali dal Cavour sintetizzati nel motto «libera Chiesa
in libero Stato».
Gli argomenti, che parrebbero univocamente diretti a suffragare la tesi della flessibilità
dello Statuto, sono stati recentemente contestati da chi (come PACE) ha evidenziato che,
in realtà, lo Statuto era nato come rigido (anzi, iper-rigido) e che flessibile lo era poi
diventato.
In favore della tesi della originaria rigidità della carta sarda militerebbero, per un verso,
l’affermazione della sua perpetuità e della sua irrevocabilità e, per l’altro, l’assenza di ogni
previsione in merito al procedimento di revisione costituzionale, dalla quale dovrebbe
desumersi, non già la modificabilità con semplice legge ordinaria, bensì la radicale
immodificabilità delle disposizioni statutarie. Ponendosi in quest’ottica, il carattere flessibile
dello Statuto sarebbe il frutto del mutare della situazione socio-politica, tale da provocare
un precoce invecchiamento di un testo che, per parte sua (in ragione di quanto sopra
accennato relativamente ai suoi modelli), già era nato un po’ «attempato».
La tesi ora menzionata, condivisibile nell’analisi del procedimento che ha condotto ad
una perdita di autorità dello Statuto sul piano politico, non lo è altrettanto, almeno così
pare, nel suo presupposto di partenza. Se l’iper-rigidità corrispondeva certamente alle
intenzioni del sovrano, essa non era stata tuttavia pienamente tradotta in termini normativi
(a tal riguardo, potrebbe magari impiegarsi la constatazione, da GIANNINI formulata ad altro
proposito, secondo cui la carta «non [era] un capolavoro di tecnica giuridica»).
Per quanto attiene alla definizione dello Statuto come «Legge fondamentale perpetua
ed irrevocabile della Monarchia», a prescindere dalla problematica attribuzione di effetti
giuridici ad una affermazione contenuta non nell’articolato ma nel preambolo, può
sottolinearsi come la posposizione del genitivo («della Monarchia») all’aggettivazione
(«perpetua ed irrevocabile») suggerisse una lettura dell’inciso in chiave non oggettiva, ma
soggettiva. Altrimenti detto, la perpetuità e l’irrevocabilità non erano da riferirsi allo Statuto,
quanto piuttosto all’atto di concessione del sovrano: lo Statuto parrebbe, cioè, essere stato
una concessione che Carlo Alberto avrebbe fatto ai suoi sudditi, una concessione
vincolante per sé e per i suoi successori, una concessione che avrebbe sigillato l’implicito
– 16 –

patto costituzionale con le forze liberali. Nel preambolo, dunque, nulla veniva detto in
ordine al potere di queste ultime di modificare lo Statuto; si diceva soltanto che il sovrano
assoluto si auto-limitava pro futuro, impegnandosi di fronte al popolo a non revocare –
formalmente o per facta concludentia – la carta costituzionale, ciò che invece sarebbe
stato fatto, di lì a poco, da tutti gli altri sovrani della penisola italiana, sull’esempio del Re di
Napoli (che già il 15 maggio 1848 aveva inaugurato la svolta reazionaria).
Ad analoghi esiti conduce l’assenza di un procedimento aggravato di revisione
costituzionale. Lungi dal significare un implicito divieto di ogni revisione (peraltro
prontamente smentito, come detto, dallo stesso Carlo Alberto), tale assenza doveva
essere contestualizzata alla luce dello stato della dottrina costituzionalistica ottocentesca,
ancora fortemente ancorata – almeno in Europa – al dogma dell’onnipotenza del
legislatore, con il che, là dove un procedimento ad hoc facesse difetto, non poteva che
applicarsi la regola generale che vedeva nella legge un atto idoneo a recare qualunque
contenuto, con la conseguenza di far rifluire il procedimento di revisione costituzionale
nell’alveo del procedimento legislativo ordinario. Prova ne sia il fatto che quei costituenti
europei che, in quegli anni, intesero redigere una costituzione rigida (come quella belga)
ebbero cura di esplicitarlo attraverso la previsione di un procedimento che rendesse la
revisione più ardua rispetto all’approvazione di una qualunque altra legge. Negli altri casi
(come, ad esempio, in Francia), la legge restò sovrana.
In quest’ottica, la definizione dello Statuto albertino come «legge fondamentale», pure
contenuta nel preambolo, doveva essere letta ponendo l’enfasi non sull’aggettivo (onde
argomentare la sua diversità rispetto alle altre leggi), ma sul sostantivo (onde accomunarlo
agli altri atti di rango legislativo). La «fondamentalità», semmai, si tradurrà in una maggiore
autorità (rectius, autorevolezza) meta-giuridica rispetto alle altre leggi, la quale fece sì che,
nel corso dei decenni, lo Statuto venisse sovente invocato per opporsi o per sostenere
determinate posizioni e determinate leggi, ma ciò sempre nella dialettica politica e mai (o
quasi: v. infra) nelle sedi propriamente giudiziarie.
Questa ricostruzione, d’altra parte, è quella che, meglio delle altre, sembra coniugare il
carattere della irrevocabilità ex parte principis dello Statuto con la natura «cripto-pattizia»
dello stesso. Sul presupposto della modificabilità da parte del legislatore, infatti, il Re si
sarebbe, sì, privato della possibilità di «tornare indietro», ma si sarebbe al contempo
salvaguardato dal vedersi imporre riforme ulteriormente progressiste, se è vero che,
nell’impianto statutario (poi parzialmente superato nella prassi), il potere legislativo doveva
essere esercitato congiuntamente dalle due camere (con l’approvazione delle leggi) e dal
– 17 –

Re (con la sanzione e la promulgazione): il patto costituzionale era dunque garantito
dall’equilibrio tra i due contraenti.
iv) Sul piano strutturale, lo Statuto fondamentale del Regno di Sardegna è da
annoverarsi tra le costituzioni brevi, tipiche del XIX secolo. Nel caso dello Statuto, in
particolare, la brevità si apprezzava sotto un duplice punto di vista.
Per un verso, l’articolato si concentrava essenzialmente sull’assetto istituzionale,
limitandosi ad un sintetico e lacunoso catalogo di diritti di libertà (collocato nel titolo «Dei
diritti e dei doveri dei cittadini»: articoli 24-32). Il numero di articoli, relativamente ridotto
(ottantaquattro, di cui tre disposizioni transitorie) era dunque specchio della distanza
rispetto alle costituzioni novecentesche, la cui lunghezza sarà generalmente
manifestazione di una più compiuta enucleazione dell’insieme dei diritti e dei doveri degli
individui.
Per altro verso, la brevità poteva essere intesa nel senso che la sintetica formulazione
di molte disposizioni rese le medesime tanto laconiche da fornire nulla più che una cornice
assolutamente minimale all’interno della quale l’attività dei pubblici poteri avrebbe dovuto
svolgersi. In tal senso, ben può dirsi che lo Statuto albertino, sorvolando su taluni aspetti
anche essenziali, si mostrò «lacunoso» e, recando non poche formulazioni generiche, si
mostrò «elastico» nei suoi contenuti. Entrambe queste caratteristiche agevoleranno una
costante opera di interpretazione e di reinterpretazione cui la carta sarà sin da subito
soggetta.
In parallelo con la sua flessibilità, lo Statuto vide le sue disposizioni, formalmente
immutate per decenni, divenire norme sempre più orientate in senso evolutivo. Ciò
contribuì in modo decisivo alla sopravvivenza della carta albertina, sancendone, quanto
meno sino all’avvento del fascismo, la capacità di adattarsi alle mutevoli esigenze storiche
che segnarono i primi decenni dell’Italia post-unitaria. Incapaci di orientare in modo rigido
la prassi costituzionale, le disposizioni redatte nel 1848 la assecondarono, fino al
momento in cui risultarono, di fatto, definitivamente superate.
– 18 –

Seconda lezione – La forma di Stato nel periodo monarchico-liberale
Per fornire un inquadramento generale della forma di Stato propria del Regno italiano
nei decenni successivi all’unità, possono essere individuati alcuni criteri di riferimento,
onde analizzare partitamente la natura delle istituzioni e dei rapporti tra queste e la società
civile alla luce delle forme di esercizio della sovranità, delle modalità di tutela dell’interesse
generale nei rapporti economici e sociali, dell’applicazione del principio pluralistico in
chiave territoriale e della tutela giuridica apprestata alle situazioni giuridiche soggettive.
In relazione ai quattro criteri appena enucleati, il Regno d’Italia può essere definito,
rispettivamente, come uno Stato [A] elitario a tendenza democratico-rappresentativa, [B]
liberale, [C] unitario e [D] di diritto.
[A] Uno Stato elitario a tendenza democratico-rappresentativa. – La storia del periodo
monarchico-liberale può essere utilmente esaminata in base alla tensione tra la
conservazione dei postulati tradizionali della sovranità e l’introduzione di forme più o meno
avanzate di legittimazione del potere: fu, in effetti, costante il confronto – talvolta ai fini di
una composizione, talaltra ai fini di una contrapposizione – tra la sovranità di matrice
dinastica, traslitteratasi nella egemonia di una ristretta cerchia di impronta oligarchica, e la
sovranità popolare. Questo confronto rimase, nel corso dei decenni, fondamentalmente
irrisolto, sebbene il principio democratico (con la connessa sovranità «dal basso») fosse
andato acquisendo un peso ed uno spazio crescenti.
In ragione di questa considerazione liminare, può dirsi che, per quanto il principio
democratico non sia mai giunto ad una definitiva affermazione sul piano effettuale (da ciò
la possibile definizione di «Stato a-democratico»), esso ha segnato una linea di tendenza
ben rintracciabile, almeno nel lungo periodo (da ciò, forse, la possibilità di aggiungere
quale definizione secondaria quella di «Stato tendenzialmente democratico»).
Il riferimento al concetto di «tendenza» appare particolarmente adeguato, nella misura
in cui può essere declinato, ad un tempo, come una «propensione verso» e come un
«mancato raggiungimento» di un obiettivo, e può perciò riassumere sia la dinamica in
base alla quale l’istanza democratica divenne progressivamente preponderante rispetto ad
un impianto istituzionale (e ad un anelito mai sopito) di segno opposto sia l’assenza di una
compiuta affermazione della sovranità popolare come fonte di legittimazione dell’azione
dei pubblici poteri.

Senza pretesa di completezza, possono qui prendersi in considerazione due processi
connessi, entrambi convergenti nel senso sopra indicato: (1) l’estensione del diritto di
suffragio, da un lato, e (2) la rilevante crescita, negli equilibri della forma di governo, degli
organi riconducibili alla volontà popolare. L’importanza di questi due processi giustifica,
almeno così pare, il riferimento, nella definizione proposta, alla rappresentatività: nella
pressoché totale assenza di strumenti partecipativi e, men che meno, di democrazia
diretta (lo svolgimento dei plebisciti «di annessione», per la loro eccezionalità, non è tale
da inficiare questa affermazione), il principio democratico fu veicolato esclusivamente nella
forma della rappresentanza, giocandosi dunque essenzialmente in termini di capacità
elettorale e di incidenza della selezione degli eletti sulla vita delle istituzioni.
1) È stato già ripetutamente sottolineato come lo Statuto albertino fosse nato con la
precipua finalità di conservazione – nei limiti del possibile – degli istituti tradizionali, nel
quadro di un allargamento assai temperato della partecipazione alla cosa pubblica, la
quale, da monopolio della Corona e dell’aristocrazia, veniva ad aprirsi anche alle classi
dirigenti borghesi, sostituendo in tal modo uno Stato assoluto di Ancien régime con uno
Stato a matrice (fortemente) elitaria. A questa prima apertura ne sarebbero seguite altre,
in parallelo con i mutamenti indotti, dapprima, dall’estensione territoriale del Regno di
Sardegna (che comportò la necessità di integrare le élites dei territori via via entrati a far
parte dello Stato) e, poi, dalla ridefinizione degli assetti sociali che – a partire dalla fine del
XIX secolo – fece emergere come soggetti politici autonomi – da integrare nelle istituzioni
per garantire ad esse la sopravvivenza – le classi operaia e contadina, secondo modalità
tali da associare queste ultime a politiche comunque guidate dall’alto.
Una tale dinamica trova una significativa testimonianza nell’estensione del diritto di
elettorato attivo e passivo per la Camera dei deputati (una estensione analoga, sebbene
operata in tempi diversi, si ebbe anche per gli organi elettivi di comuni e province). Sul
punto, lo Statuto albertino si mostrava quanto mai «elastico», all’art. 39 prevedendo che
«la Camera Elettiva [era] composta di Deputati scelti dai Collegi Elettorali conformemente
alla Legge», e rinviando così integralmente a fonti successive l’intera materia elettorale.
Astrattamente, qualunque soluzione poteva essere adottata: anche quelle sperimentate
dai governi rivoluzionari del 1848, i quali, a Milano come a Venezia, in Toscana come a
Roma, avevano introdotto il suffragio universale maschile. La soluzione fu seguita, nel
caso del Regno di Sardegna e, poi, del Regno d’Italia, soltanto in occasione dei plebisciti
che scandirono il processo di unificazione della penisola: ciò, evidentemente, al fine di
meglio esplicitare il sostegno popolare a questo processo. Per le elezioni politiche, però, il
– 20 –

suffragio universale venne escluso ab initio – e per lungo tempo – in conseguenza di una
diffidenza, assai diffusa nel notabilato, nei confronti delle masse, derivante dal pregiudizio
in ordine alla corruttibilità del «povero» e dell’«ignorante», ma anche dal timore di veder
messo a repentaglio l’ordine costituito, sia creando uno Stato che superasse, in chiave
progressista, la visione della classe dirigente, sia affidando le istituzioni alla
preponderanza numerica di una massa ritenuta (sia nella componente maschile che, ed in
maggior misura, in quella femminile) troppo facilmente strumentalizzabile ad opera delle
forze clerico-reazionarie in funzione anti-risorgimentale.
La scelta del sistema censitario venne sancita con il regio decreto 17 marzo 1848, n.
680, il quale delineò una composizione del corpo elettorale che restò giuridicamente quasi
inalterata anche dopo l’avvenuta unificazione. I diritti politici venivano riconosciuti ai
maschi che avessero compiuto i venticinque anni, che fossero alfabetizzati e che fossero
assoggettati ad una imposta diretta annua pari alla ragguardevole cifra di quaranta lire. La
somma era dimezzata per tutta una serie di categorie, individuate su base territoriale (gli
abitanti della Liguria, di Nizza e della Savoia), culturale (i laureati) o professionale (i notai,
gli avvocati, i direttori di stabilimenti industriali di medio-grandi dimensioni, i capitani
marittimi, determinati impiegati civili a riposo, etc.). Il censo era escluso dai requisiti
legittimanti l’esercizio dei diritti politici per alcune altre categorie, in gran parte riconducibili
alle élites culturali (i membri di alcune accademie, i docenti di scuole regie e di università),
militari (gli ufficiali di rango superiore) o professionali (i membri delle Camere di
commercio).
Una volta raggiunta l’unità, la legge 17 dicembre 1860, n. 4513, estese a tutto il
territorio nazionale le previsioni contenute nel decreto del 1848 (emendato nel 1859, ma
solo su aspetti di dettaglio), con il risultato che la già esigua percentuale di elettori rispetto
alla popolazione si assottigliò ulteriormente (in ragione della maggiore arretratezza
economica di alcune parti della penisola rispetto al Piemonte), attestandosi attorno al 2%.
Negli anni settanta, la Sinistra, ancora all’opposizione, pose con forza la questione
dell’allargamento del suffragio, proponendo di agire su due dei tre requisiti fondamentali,
vale a dire abbassando l’età minima da venticinque a ventuno anni (corrispondente alla
maggiore età civile) ed eliminando drasticamente il requisito censuale.
Giunta al governo nel 1876, la Sinistra impiegò però sei anni per approvare una riforma
elettorale che corrispondesse, sia pure solo parzialmente, ai propri intendimenti iniziali. La
legge 22 gennaio 1882, n. 593, abbassò, in effetti, il limite anagrafico per l’elettorato attivo
a ventuno anni; il requisito censuale, tuttavia, venne eliminato solo per coloro che
– 21 –

sapessero «leggere e scrivere» (l’alfabetizzazione divenendo, in tal modo, un requisito
alternativo a quello censuale) e per alcune categorie ulteriori rispetto a quelle per le quali
già era escluso, mentre, per la generalità degli individui, venne soltanto dimezzato
(l’imposta annua da corrispondere venne fissata a poco meno di venti lire). Con questa
riforma (c.d. Zanardelli, dal nome del proponente), la consistenza del corpo elettorale
risultava triplicata; l’allargamento non era comunque tale da poter evocare, neppure da
lontano, il suffragio universale (maschile), se è vero che gli aventi diritto al voto si
aggirarono, dal 1882 in poi, attorno al 7% del totale della popolazione.
La crescita di una classe operaia ed il ruolo politico assunto dai partiti espressione dei
ceti subalterni rese improrogabile la necessità di dare una adeguata rappresentanza a
questi nuovi soggetti. Fu il quarto Governo Giolitti a far approvare la legge 30 giugno 1912,
n. 665, con cui agli aventi diritto ai termini della legge del 1882 si aggiunsero tutti coloro
che – anche analfabeti ed anche privi dei requisiti censuali – avessero già prestato
servizio militare e tutti coloro che avessero superato il trentesimo anno di età
(prescindendo da ulteriori condizioni). Da allargato, il suffragio divenne quasi universale
(pur se ancora unicamente maschile), andando a coprire quasi un quarto dell’intera
popolazione.
Il testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, sancì la definitiva affermazione del diritto di
voto a tutti i maschi maggiorenni, allargando così ulteriormente le basi di legittimazione
delle istituzioni (per il suffragio femminile si dovrà, tuttavia, attendere sino alle elezioni
amministrative del 1945).
All’estensione del diritto di elettorato attivo non corrisposero evoluzioni di particolare
rilievo relativamente al diritto di elettorato passivo. L’art. 40 dello Statuto albertino stabiliva
che «nessun Deputato [poteva] essere ammesso alla Camera se non [era] suddito del Re,
non [aveva] compiuta l’età di trent’anni, non gode[va] i diritti civili e politici, e non riuni[va]
in sé gli altri requisiti voluti dalla legge». Oltre all’abbassamento della soglia anagrafica a
venticinque anni, l’innovazione più importante, quanto meno sul piano politico, si ebbe con
la citata legge n. 665 del 1912, la quale, insieme con l’estensione dell’elettorato attivo,
introdusse una indennità a titolo di rimborso spese (e la franchigia ferroviaria) a beneficio
degli eletti, garantendo in tal modo, attraverso un aggiramento sul piano formale
dell’espresso divieto di corrispondere una retribuzione ai parlamentari (art. 50 dello
Statuto), l’ingresso in Parlamento anche a deputati che non fossero benestanti.
2) Parallelamente all’estensione dei diritti politici, le istituzioni andarono strutturandosi
secondo moduli tali da attribuire un ruolo vieppiù influente a quegli organi che, per il loro
– 22 –

essere elettivi, si ponevano come interpreti della volontà popolare: la Camera dei deputati,
ovviamente, ma anche, in qualche misura, il Governo, che traeva (recte, poteva trarre) la
propria legittimazione dal sostegno della maggioranza dei deputati.
Rinviando a quanto verrà più diffusamente argomentato in relazione alla forma di
governo, ciò che in questa sede rileva è come, se per lo Statuto albertino pochi dubbi
potevano nutrirsi in merito alla titolarità formale della sovranità in capo al monarca, già con
alcuni atti (e, più ancora, con la prassi instauratasi) la teoria legittimista (e trascendente)
abbia subito contaminazioni non trascurabili, non solo ad opera dell’idea elitaria della
riserva di esercizio del pubblico potere a beneficio della sanior pars (in tal senso, valga
quanto detto con riguardo alle resistenze opposte all’estensione del suffragio), ma anche –
e più incisivamente, sul piano teorico – ad opera del principio della sovranità popolare (o,
secondo la definizione allora corrente, della «sovranità della Nazione»).
Di tutte le manifestazioni di questa contaminazione, può assurgere a paradigma quella
contenuta nell’articolo unico della legge 21 aprile 1861, n. 1, che stabilì la formula con cui
dovevano essere intestati tutti gli atti in nome del Re d’Italia, prevedendo che al nome del
Re seguisse la definizione seguente: «per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re
d’Italia».
Il contemporaneo riferimento a due diversi titoli di legittimazione del sovrano, che sino a
quel momento si era sempre basata sulla trascendenza (l’intestazione dello Statuto del
1848 così recitava: «Carlo Alberto, per la Grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro e di
Gerusalemme, […]»), dimostra che una qualche attenzione al volere dei sudditi venne
tributata sin dall’inizio del Regno d’Italia. Un’attenzione che, nel 1861, non era altro che
formale, ma che, in seguito, acquisì tutt’altro rilievo, man mano che la posizione del Re si
faceva più defilata nel quadro istituzionale, lasciando il campo alla preminenza del circuito
Governo – camera elettiva.
L’elasticità dello Statuto non fece ostacolo ad una sua lettura in chiave progressiva, alla
stregua cioè di un diaframma verso il passato ma non verso il futuro: con obiettivi e con
toni anche molto diversi, da Cavour a Zanardelli, da Giolitti a Turati, numerosi furono gli
statisti che lessero le disposizioni costituzionali come aperte ad una evoluzione in senso
liberale (i primi tre) o anche democratico (il quarto e, forse, anche in parte il terzo), rigido
essendo soltanto l’impedimento a tornare ad una struttura istituzionale di Ancien régime.
Non mancarono, è vero, interpretazioni conservatrici, che tesero a propugnare una
rigorosa attinenza alla lettera delle disposizioni, magari anche attraverso un «ritorno allo
Statuto» che avesse ragione delle interpretazioni «devianti» sedimentatesi (emblematico è
– 23 –

l’articolo di Sonnino, datato 1897, dal titolo Torniamo allo Statuto). E le interpretazioni
conservatrici e finanche reazionarie ebbero anche momenti di successo (si pensi all’età
crispina o alla c.d. «crisi di fine secolo»). Ad una visione generale del periodo, tuttavia, non
può sfuggire una tendenziale progressiva accentuazione delle tesi di segno opposto.
[B] Uno Stato liberale. – La definizione della forma di Stato del Regno d’Italia nei
decenni successivi all’unità appare pressoché scontata, allorquando si ponga mente alla
denominazione di «fase monarchico-liberale» che del periodo è propria per convenzione
dottrinale.
Ad una osservazione più approfondita, tuttavia, la natura di Stato liberale del Regno non
manca di creare qualche difficoltà, e rende comunque necessaria qualche precisazione,
concernente principalmente l’accezione nella quale l’aggettivo «liberale» venga impiegata.
Se, infatti, esso fa riferimento alla filosofia cui si rifacevano le élites politiche, poche sono
le obiezioni che all’impiego del termine possono opporsi, se non forse quella – ai presenti
fini, di scarso rilievo – di una non costante coincidenza fra la teoria e la prassi. Meno
pacifica è l’attribuzione al liberalismo di una accezione prettamente giuridica: ciò, innanzi
tutto, per (1) il non compiuto recepimento di questa ideologia nell’articolato statutario, ma
anche per (2) il forte dinamismo che ha caratterizzato la storia costituzionale e che ha
visto un prevalere tendenziale delle idee liberali rispetto ad altre (senza però che queste
ultime venissero – specie in taluni momenti – neglette), nonché per (3) il problematico
rapportarsi dello Stato italiano alla Chiesa cattolica ed al fenomeno religioso in generale.
1) Lo Statuto albertino presentava un catalogo di diritti e di doveri che segnava, in linea
generale, un indubbio avvicinamento ai postulati dello Stato liberale. Vi si riconoscevano,
infatti, i principali diritti civili (la garanzia della libertà individuale, art. 26; l’inviolabilità del
domicilio, art. 27; la libertà di stampa, art. 28; l’inviolabilità della proprietà, art. 29; la
legalità dei tributi, art. 30; la garanzia del debito pubblico, art. 31; il diritto di riunione, art.
32), oltre ai diritti politici basilari (il diritto di voto, art. 39; il diritto di elettorato passivo, art.
40; il diritto di petizione, art. 58). Si sanciva il principio di eguaglianza formale (art. 24) e,
parallelamente, il principio di proporzionalità delle imposte (art. 25). Tra i doveri
costituzionali, al fianco della soggezione alla tassazione, si poneva l’obbligo di leva, la cui
disciplina era peraltro integralmente rimessa alla legge (art. 75).
Nell’elenco appena fornito spicca l’assenza di alcuni tipici diritti di libertà, come, ad
esempio, la libertà di manifestazione del pensiero ed il diritto di associazione (quest’ultimo
in ossequio, presumibilmente, alla diffidenza, tipicamente liberale, nei confronti dei «corpi
– 24 –

intermedi» tra il cittadino e lo Stato). Al di là di queste lacune, peraltro generalmente
colmabili, e colmate, in via interpretativa (entrambi i diritti indicati vennero ritenuti
implicitamente garantiti, rispettivamente, dall’art. 28, concernente la libertà di stampa, e
dall’art. 32, sulla libertà di riunione), da evidenziare era l’assenza di ogni riferimento a diritti
sociali, a dimostrazione della rigorosa aderenza ai paradigmi politico-costituzionali
dell’Ottocento.
Anche in ordine ai diritti riconosciuti, tuttavia, deve riconoscersi come le affermazioni
statutarie presentassero un alto grado di laconicità, associata a generici rinvii alla
disciplina legislativa e, talora, alla previsione di limiti potenzialmente assai estesi. Con ciò
si riproponeva la tematica dell’elasticità propria delle disposizioni statutarie, giustificando
ex ante il dinamismo che, in tema di diritti, sarà proprio di tutto il periodo monarchico. Così,
ad esempio, il principio di eguaglianza era costruito in modo tale da legittimare il
legislatore a porre le più ampie deroghe («tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e
sono ammessibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi»:
art. 24, secondo comma), come testimoniava, solo per citare un caso, la condizione
femminile. Del pari, l’inviolabilità della libertà personale e del domicilio rischiava di essere
vanificata dai limiti che la legge era abilitata a prescrivere (articoli 26, secondo comma, e
27). Ancora, la libertà di riunione era riconosciuta solo per le adunanze «pacifiche e
senz’armi» (art. 32, primo comma) ed era radicalmente esclusa per «le adunanze in luoghi
pubblici od aperti al pubblico, i quali riman[evano] intieramente soggetti alle leggi di
polizia» (art. 32, secondo comma).
2) Sulla scorta di previsioni costituzionali di tal fatta, non mancarono provvedimenti
legislativi (od anche, contra statutum, amministrativi) volti a limitare considerevolmente il
raggio di operatività dei diritti riconosciuti. Ciò si verificò soprattutto durante i periodi
«eccezionali», nei quali vennero sovente attribuiti al Governo i c.d. «pieni poteri» (v. infra)
al fine di fronteggiare crisi interne (dal brigantaggio ad ondate di protesta popolare) o
guerre. Considerando che, almeno fino al 1870, il Regno di Sardegna e, poi, d’Italia
dovette affrontare le guerre di indipendenza, e, negli intervalli tra l’una e l’altra, varie crisi
internazionali (si pensi alla guerra di Crimea, ma soprattutto agli attriti con la Francia di
Napoleone III derivanti dalle spedizioni garibaldine contro lo Stato pontificio), si ha la
misura del margine di compressione che i diritti individuali potessero subire su tutto il
territorio nazionale o su una parte di esso. Analogamente, forti limitazioni saranno
imposte, più tardi, dalla partecipazione alla Prima guerra mondiale.
A periodi segnati da una certa vena «progressista» si sono dunque alternati periodi di
– 25 –

ripiegamento, tali da revocare in dubbio le acquisizioni raggiunte; in taluni casi, nel volgere
di qualche tempo, si assistette all’approvazione di provvedimenti di significato politico
opposto: ad esempio, ad una conquista di civiltà come il codice penale Zanardelli (1889),
che eliminò dall’ordinamento la pena di morte, fece seguito un testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza fortemente repressivo della libertà di stampa e di quella di riunione.
Senza diffondersi su questi aspetti, onde dimostrare la caducità delle conquiste liberali
può essere sufficiente porre mente alla dinamica legislativa della seconda metà degli anni
novanta dell’Ottocento: dalla repressione dei Fasci siciliani, ordinata dal Governo Crispi ed
agevolata dalla proclamazione dello stato di assedio, fino alla «crisi di fine secolo», in cui
le repressioni ordinate dal Governo di Rudinì, prima (a Milano, nel maggio 1898, le truppe
comandate dal generale Bava Beccaris fecero ottanta morti e più di quattrocento feriti tra i
manifestanti), e dal Governo Pelloux, poi. Sul piano parlamentare, di particolare rilievo
furono i disegni di legge che il Governo di Rudinì presentò contemporaneamente alla
repressione dei moti di piazza: in essi si prevedevano, tra l’altro, lo scioglimento di
associazioni ed il divieto di ricostituire associazioni disciolte, la militarizzazione dei
ferrovieri e dei postelegrafonici, la possibilità di censurare preventivamente i giornali e di
sospenderne la pubblicazione sino a sei mesi. Di fronte all’opposizione della Camera dei
deputati, il Governo non riuscì a far approvare questi provvedimenti, rassegnando pertanto
le dimissioni. Il successivo Governo Pelloux, ripresentò – modificati in senso
maggiormente repressivo – i medesimi disegni di legge; all’ostruzionismo opposto, per la
prima volta nel Parlamento italiano, dai banchi della Sinistra e dell’Estrema (sinistra), il
Governo reagì trasfondendo il contenuto di parte dei disegni di legge nel regio decreto 22
giugno 1899, n. 227. La battaglia parlamentare si concentrò allora sulla conversione di
questi decreti, che non venne da Pelloux ottenuta neppure attraverso la modifica del
regolamento della Camera dei deputati. La crisi che ne derivò portò, nel giugno 1900, a
nuove elezioni, dalle quali la compagine governativa uscì sconfitta.
Le elezioni chiusero simbolicamente la «crisi di fine secolo», aprendo una fase affatto
diversa, corrispondente alla c.d. «età giolittiana», in cui, per un verso, si ripristinarono le
libertà «statutarie» (può constatarsi, per incidens, come l’insistito richiamo allo Statuto, da
parte dell’opposizione al Governo Pelloux, dimostrasse l’autorità meta-giuridica che la
carta albertina ancora conservava) e, per l’altro, si diede luogo ad una serie di innovazioni
legislative tese ad introdurre regimi giuridici di protezione per i lavoratori e, in generale, per
le classi meno abbienti, approfittando della felice congiuntura economica.
La legislazione sociale del Governo Zanardelli-Giolitti (1901-1902) disegnò un quadro
– 26 –

che, lungi dal poter essere accostato a quello di un moderno Stato sociale, mostrava una
spiccata attenzione per il miglioramento delle condizioni di lavoro operaie e contadine, per
la tutela in caso di infortuni sul lavoro, per l’assicurazione contro l’invalidità e la vecchiaia,
per il lavoro femminile e minorile, per l’edilizia popolare. A questa prima fase riformistica
fecero seguito, nel corso dei successivi dieci anni, il miglioramento del trattamento
salariale e pensionistico per gli impiegati, per i maestri elementari, per i pescatori.
Contemporaneamente, venne impostata una politica di industrializzazione, diretta a
favorire lo sviluppo delle aree economicamente depresse (il Mezzogiorno, in primis) e si
procedette alla nazionalizzazione delle ferrovie.
Alle venature «sociali» dei governi Giolitti si associò una impostazione autenticamente
liberale relativamente all’attitudine di fronte alle proteste popolari: contrariamente a quanto
accaduto in precedenza, il Governo mantenne una tendenziale neutralità nei conflitti tra
lavoratori e proprietari industriali ed agricoli; lo sciopero venne «tollerato», così come il
diritto di associazione e quello di riunione non furono più oggetto di limitazioni legislative
né, per solito, di repressioni fattuali. I frequenti scioglimenti dei nascenti partiti e sindacati,
che avevano caratterizzato la fine del XIX secolo, vennero sostituiti da un riconoscimento
de facto del rilievo politico del Partito socialista (oltre che di altri partiti, di matrice non
classista, come il Partito repubblicano) e delle organizzazioni di tipo sindacale, alla cui
azione i lavoratori affidavano la propria tutela.
Alle soglie della Prima guerra mondiale, il Regno d’Italia pareva dunque giunto, dopo
vistose oscillazioni, a potersi definire a pieno titolo come uno Stato liberale. La guerra, con
i sacrifici imposti su questo piano, interromperà questa esperienza, la quale, maturata
tardivamente, non aveva ancora avuto modo di consolidarsi sul piano culturale. Gli eventi
succedutisi negli anni immediatamente seguenti al conflitto lo dimostreranno
drammaticamente.
3) Il dinamismo della prassi (quanto meno di quella inveratasi sino alla Grande guerra)
consentì di superare finanche le disposizioni dello Statuto dettate in stridente contrasto
con i principi di uno Stato liberale. L’esempio più lampante è certamente quello dell’art. 1,
ai sensi del quale, come accennato, il Regno di Sardegna si configurava come uno Stato
confessionale («la Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello
Stato»: primo comma), tale da discriminare i culti diversi dalla religione cattolica,
meramente «tollerati conformemente alle Leggi» (secondo comma). A suffragare questa
scelta, si ponevano anche l’art. 28, secondo comma, che subordinava la stampa di bibbie,
catechismi, libri liturgici e di preghiere al preventivo permesso del vescovo, e l’art. 33, n. 1,
– 27 –

che poneva gli arcivescovi ed i vescovi tra le categorie di designabili al laticlavio.
Ancor prima dell’unità d’Italia, l’insieme di queste disposizioni venne profondamente
rivisitato, alla luce di tutta una serie di atti normativi, volti, da un lato, a parificare i non-
cattolici ai cattolici, relativamente al godimento dei diritti civili e politici e, dall’altro, a
separare la dimensione religiosa da quella pubblica, attraverso le c.d. leggi Siccardi (la
legge 9 aprile 1850, n. 1013, che eliminava il diritto di asilo religioso ed il privilegio del foro
per gli ecclesiastici; la legge 5 giugno 1850, n. 1037, che imponeva una autorizzazione
amministrativa per tutti gli atti di acquisto dei corpi morali, civili o ecclesiastici) ed altre
leggi successive (la legge 23 maggio 1851, n. 1184, che aboliva ogni immunità fiscale dei
beni ecclesiastici; la legge 29 maggio 1855, n. 878, che sopprimeva le corporazioni
religiose prive di utilità sociale).
Questi provvedimenti culminarono con la legge 13 maggio 1871, n. 214, c.d. «delle
guarentigie», che, dopo la conquista di Roma, consolidò la situazione di fatto,
riconoscendo al Pontefice una serie di prerogative connesse alla sua qualità di capo di
uno Stato estero e improntando – sia pure in modo non sempre efficace – i rapporti tra lo
Stato italiano e la Chiesa cattolica al modello separatista (si noti che la legge pareva aver
abrogato tacitamente anche l’art. 28, secondo comma, dello Statuto albertino).
Più ancora delle discipline legislative, a favorire una scissione tra la sfera pubblica
(rectius, politica) e quella religiosa fu però l’atteggiamento tenuto dalla curia romana in
conseguenza, dapprima, dell’unità d’Italia e del ridimensionamento entro i confini del Lazio
del potere temporale del Pontefice e, poi, del suo tendenziale annichilimento (eccezion
fatta per l’esiguo territorio dello Stato del Vaticano) dopo il 1870.
Era del 1864 la condanna di Papa Pio IX del liberalismo, stigmatizzato attraverso
l’elenco di «errori» enucleato nel Sillabo (in appendice all’enciclica Quarta Cura) ed era di
dieci anni successivo il non expedit, cioè la bolla papale con cui si faceva divieto per i
cattolici sudditi del Regno d’Italia di partecipare alle elezioni del Parlamento.
Nei primi decenni post-unitari, lo Stato dovrà dunque affrontare l’elemento doppiamente
destabilizzante di una Chiesa chiusa ad ogni dialogo e di una componente politica clerico-
reazionaria – minoritaria ma non trascurabile quanto a forza e seguito – volta a rimettere in
gioco le scelte a suo tempo operate per uno Stato laico ed una politica che non fosse
asservita alle gerarchie ecclesiastiche.
Sarà soltanto sul finire dell’Ottocento che la Chiesa ammorbidirà la propria posizione
(anche allo scopo di arginare il seguito del nascente Partito socialista), fino a revocare,
– 28 –

con Papa Pio X, in occasione delle elezioni politiche del 1904, il non expedit, passando
così da un atteggiamento di pregiudiziale rifiuto («né eletti né elettori») ad uno di cauta
accettazione delle istituzioni italiane («cattolici deputati sì, deputati cattolici no»).
Si dovrà attendere, tuttavia, il c.d. «patto Gentiloni» (1913) per constatare l’assunzione,
da parte dei cattolici, di un esplicito ruolo nel circuito parlamentare: impegnandosi a far
convergere i voti degli elettori cattolici sui candidati liberali, la Chiesa (ché il patto venne
con ogni probabilità autorizzato dal Pontefice) riceveva in contropartita l’impegno degli
eletti a perseguire una politica che si conformasse al volere della curia (ad esempio,
attraverso la garanzia dell’insegnamento religioso nelle scuole, la tutela delle
congregazioni religiose, etc.).
Parallelamente, i cattolici rafforzavano la propria presenza in Parlamento, prima che
questa, dopo la Prima guerra mondiale, venisse ad essere massiccia e, soprattutto,
incardinata nell’appartenenza al Partito popolare, nel frattempo fondato.
La «questione romana» si avviava in tal modo all’epilogo, sancito definitivamente con i
Patti Lateranensi del 1929.
[C] Uno Stato unitario. – Una caratteristica incontestabile della forma di Stato nel
periodo monarchico-liberale è quella relativa alla tendenziale concentrazione nella capitale
(Torino; dal 1864, Firenze; dal 1871, Roma) del potere politico: sebbene esistessero
istituzioni «periferiche», quali province e comuni, queste venivano configurate non tanto
come enti autonomi, quanto semmai come gangli dell’amministrazione statale a livello
locale, vale a dire come apparati di semplice decentramento amministrativo.
Nello stabilire, all’art. 74, che «le istituzioni Comunali e Provinciali, e la circoscrizione
dei Comuni e delle Province [erano] regolate dalla legge», lo Statuto albertino apprestava
la duplice garanzia del riconoscimento costituzionale dell’esistenza degli enti locali e della
riserva di legge per la disciplina della loro struttura, del loro funzionamento e dei loro
poteri. Al di là del rispetto di queste garanzie, tuttavia, il legislatore godeva di un
amplissimo margine di manovra nel disegnare l’articolazione territoriale del potere.
Nel periodo intercorrente tra l’unità e la fine dell’Ottocento, il tema del decentramento fu
oggetto di frequenti dibattiti ed anche di un buon numero di interventi normativi, tutti frutto
di un confronto tra l’anima «centralista» e quella «autonomista» che convivevano nella
classe politica italiana. Sin da subito, a prevalere fu la prima, corroborata com’era dalla
tradizione giuridica, ma anche da preoccupazioni di ordine politico.
– 29 –

Sul piano giuridico, non era da trascurare la circostanza che la «colonizzazione
amministrativa» veicolata dalle truppe napoleoniche all’inizio del secolo avesse prodotto
una tendenziale aderenza di gran parte degli Stati preunitari al modello francese, basato
su un marcato accentramento del potere decisionale, associato ad una capillarizzazione
delle strutture locali in chiave rappresentativa delle singole comunità (municipali, in primis),
ma soprattutto in chiave esecutiva delle decisioni provenienti «dall’alto». Il Regno di
Sardegna, in particolare, si strutturava in larga misura sulla base di questi canoni: la sopra
ricordata continuità in termini di «costituzione materiale» tra Stato subalpino e Regno
d’Italia può dunque dar conto anche dell’estensione a tutta la penisola del modello
napoleonico.
A ciò non si addivenne, però, in virtù di una pura inerzia progettuale. La scelta del
modello di Stato accentrato rispose, infatti, alle preoccupazioni politiche di alimentare
l’autorità dello Stato appena formatosi, potenzialmente minata, o comunque limata,
dall’attribuzione di ampi poteri ad enti periferici. Parimenti rilevante fu poi l’idea che
soltanto attraverso un processo guidato «dal centro» (rectius, «dall’alto») potesse
effettivamente prodursi lo sviluppo di una società che, per larghi strati ed in vasti territori,
appariva ancora profondamente arretrata.
Alla luce di queste considerazioni non stupisce che tutti i progetti volti a ridisegnare
l’amministrazione pubblica mediante una regionalizzazione (funzionale, tra l’altro, a
conservare uno status privilegiato per quelle città che erano state le capitali degli Stati
preunitari), presentati negli anni immediatamente successivi all’unificazione, siano
decaduti (tra questi devono ricordarsi, quanto meno, i due disegni di legge presentati da
Cavour e da Minghetti, nel marzo 1861, e fatti ritirare, dopo la morte del primo, dal suo
successore, Ricasoli). L’allegato A della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sull’unificazione
amministrativa del Regno, giunse poi a sanzionare definitivamente l’opzione centralistica,
attraverso l’estensione del modello piemontese di ordinamento comunale e provinciale.
La tematica del decentramento tornò ad essere oggetto di dibattiti soprattutto a partire
dalla seconda metà degli anni ottanta dell’Ottocento. Si vennero a confrontare, allora, due
concezioni del decentramento che, accomunate dall’idea di avvicinare gli individui alle
istituzioni, rafforzando l’elemento rappresentativo, divergevano radicalmente sul piano dei
raccordi da introdurre tra il centro e la periferia.
Nella visione della Sinistra storica, allo sviluppo delle istanze partecipative e
rappresentative in sede locale, doveva coniugarsi un efficace regime dei controlli, onde
assicurare la perdurante tutela governativa sugli enti locali. Ne era testimonianza la legge
– 30 –

crispina di riforma dell’ordinamento comunale e provinciale (legge 30 dicembre 1888, n.
5865), la quale, da un lato, attribuiva a nuove categorie di individui il diritto di voto alle
elezioni amministrative e stabiliva l’elettività dei sindaci dei comuni maggiori e dei
presidenti delle province, ma, dall’altro, potenziava i meccanismi di controllo,
principalmente grazie all’istituzione delle giunte provinciali amministrative, presiedute dai
prefetti, competenti a conoscere dei ricorsi promossi dai privati avverso qualunque atto
degli enti locali (legge 1° maggio 1890).
Un diverso orientamento era manifestato in seno alla Destra: il recupero di poteri per gli
enti locali che veniva propugnato mirava, infatti, ad una traslazione dell’esercizio di parte
delle funzioni di interesse generale dalle istituzioni politiche alla società civile, nella
prospettiva di un consolidamento degli assetti sociali tradizionali, minacciati dalla crescita
delle forze popolari. A questo disegno di fondo rispondeva, ad esempio, la legge 29 luglio
1896, fatta approvare dal Governo di Rudinì, la quale introduceva il principio dell’elettività
dei sindaci di tutti i comuni: la sostituzione di funzionari amministrativi provenienti dal
potere centrale con persone espressione della comunità locale, se nei comuni più grandi
aveva l’effetto di valorizzare l’elemento partecipativo, nei comuni di più modeste
dimensioni (e soprattutto nei comuni rurali) garantiva alle élites alto-borghesi ed ai
proprietari terrieri di coagulare intorno a sé le istanze più conservatrici e, al contempo, di
veder assai meglio garantito lo status quo.
Questo intervento legislativo, come del resto i precedenti, non produsse, comunque,
altro che un assestamento della forma di Stato, che rimase ben ancorata, anche nel
prosieguo, al modello centralista.
[D] Uno Stato di diritto. – Per quanto attiene al grado ed alle forme di tutela delle
situazioni giuridiche soggettive, lo Stato italiano, durante il periodo monarchico-liberale,
può essere definito come uno Stato di diritto, con tale nozione facendosi riferimento ad
una organizzazione statuale in cui l’azione dei pubblici poteri è soggetta (non più
all’arbitrio del monarca, ma) alle norme giuridiche, ricavate principalmente dal diritto
positivo, e dalla legge in particolare (principio di legalità).
L’affermazione del principio di legalità, testimoniata in primis dal cospicuo numero di
riserve di legge contenute nello Statuto albertino ed enfatizzata dalla natura flessibile della
carta costituzionale, ebbe profonde ripercussioni, non solo su (1) la struttura del sistema
delle fonti del diritto, ma anche su (2) la concreta applicazione del principio di separazione
dei poteri, ponendosi, ad un tempo, come (3) il fondamento ed il limite intrinseco delle
– 31 –

garanzie apprestate ai diritti individuali.
1) In ossequio alle teorie giuspositivistiche largamente prevalenti nell’Ottocento, la
funzione normativa venne ad essere quasi integralmente riconducibile all’opera degli
organi politici, residuando uno spazio assai circoscritto per altre forme di produzione, la
consuetudine in special modo. Pressoché nullo fu poi il ruolo del diritto giurisprudenziale,
già «travolto» dalla polemica dei révolutionnaires francesi del 1789 contro gli organi
giudiziari tutori dell’Ancien régime (i Parlements).
La tendenziale omogeneità delle fonti di produzioni rese il sistema delle fonti piuttosto
semplice: nella struttura gerarchica del sistema potevano individuarsi essenzialmente tre
livelli, corrispondenti, rispettivamente, alle fonti primarie, secondarie e terziarie (si noti che
questa terminologia è rimasta in uso ed ha continuato a connotare le medesime fonti
anche al mutare del sistema).
La fonte primaria per antonomasia era la legge parlamentare, la quale, in un regime di
costituzione flessibile (v. supra), veniva ad essere priva di limiti materiali, potendo disporre
in deroga anche rispetto alle disposizioni statutarie.
Il potere, astrattamente illimitato, del Parlamento era, peraltro, grandemente circoscritto,
di fatto, in conseguenza dell’interpretazione invalsa del principio di legalità, inteso non in
senso sostanziale, bensì in senso puramente formale: il legislatore non era dunque
chiamato a disciplinare l’integralità di una determinata materia (con la conseguente
esclusione di altri poteri normativi e/o di ampi margini di discrezionalità per
l’amministrazione), ma semplicemente ad attribuire un potere da esercitare in capo ad un
organo o ad un soggetto, ogni altra previsione restando nella piena disponibilità del
conditor juris (che, in concreto, sul punto rimase spesso inerte).
D’altro canto, il Parlamento non poteva neppure dirsi titolare del monopolio della
normazione di rango primario. Ciò in ragione del concorrere di alcune previsioni statutarie,
da un lato, e di una prassi radicatasi praeter statutum, dall’altro.
La natura dualista della forma di governo disegnata dallo Statuto (su cui, v. infra)
trovava un preciso riscontro nell’attribuzione in via esclusiva al Re dei poteri, anche
normativi, in talune materie, c.d. – appunto – di «prerogativa regia». Salvo tornare più
diffusamente sull’argomento, è qui da sottolinearsi come, ai termini degli articoli 78 e 79
dello Statuto, il Re era l’unico titolare dei poteri normativi in tema di creazione di «Ordini
Cavallereschi» e di conferimento di nuovi «titoli di Nobiltà». Altre materie – e di ben più
ampio respiro – furono fatte rientrare, per il tramite dell’art. 5 dello Statuto, nella sfera di
– 32 –

prerogativa regia, ma, nella prassi, ad esercitare i poteri normativi non fu il Re (o, almeno,
non fu soltanto il Re), quanto (semmai) il Governo, a tal fine essendosi attribuito alla
previsione della controfirma ministeriale (ex art. 67 dello Statuto) il valore non solo di
assunzione della responsabilità in capo al ministro, ma anche di una sua partecipazione
alla determinazione del contenuto dell’atto (tra gli esempi di materie di prerogativa regia di
quest’ultimo tipo, le principali sono senz’altro quella militare e, forse, quella coloniale).
Da tutte queste materie, per previsione statutaria (o a seguito dell’interpretazione
invalsa dello Statuto), il Parlamento restava escluso, ciò che aveva, evidentemente,
l’effetto di porre dei limiti competenziali alla legge.
L’altra categoria di fonti primarie – quella individuabile praeter statutum – non
produceva limiti analoghi, ricadendo essa nello stesso ambito di competenza della legge
parlamentare: il riferimento è all’insieme degli atti normativi dell’esecutivo cui si
riconosceva forza legislativa.
Siffatti poteri traevano la propria origine da una delega da parte del Parlamento ovvero
da una autonoma iniziativa da parte del Governo, motivata dalla necessità di affrontare
situazioni di urgenza.
La delegazione legislativa, nata in funzione dell’attribuzione al Governo dei c.d. «pieni
poteri», quindi anche dei poteri normativi consoni a fronteggiare situazioni eccezionali
quali quelle belliche, si trasformò progressivamente – anche in ragione della frequenza di
periodi di «emergenza» nei primi lustri di vigenza dello Statuto – in una pratica mediante
cui il Parlamento affidò pro tempore al Governo potestà tendenzialmente illimitate, come fu
dimostrato, ad esempio, dalla grande produzione normativa di matrice extra-parlamentare
contemporanea alla Seconda guerra di indipendenza ed al processo di unificazione,
nonché da quella avutasi durante la Prima guerra mondiale.
Una prassi analogamente rivolta a potenziare il ruolo del Governo fu riscontrabile a
proposito della decretazione d’urgenza, di cui non vennero mai – almeno sino alla legge
31 gennaio 1926, n. 100 – definitivamente chiariti i fondamenti (la dottrina, in particolare,
oscillò tra la configurazione – propugnata da Santi ROMANO – della necessità come fonte
autonoma del diritto ed il riconoscimento del venire in essere di una consuetudine
legittimante l’intervento d’urgenza del Governo), ma che, specie in taluni frangenti (si
pensi, ad esempio, alla già ricordata vicenda del decreto fatto emanare da Pelloux), ebbe
un impatto notevole sul diritto vigente e, in ultima analisi, sulla struttura stessa del sistema
delle fonti.
– 33 –

A completare un quadro nel quale il Governo, astrattamente ai margini del sistema delle
fonti di produzione, esercitava un ruolo sovente preponderante, si poneva la potestà
regolamentare, intesa come potestà normativa subordinata a quella primaria (indi,
«secondaria»), per taluni (ZANOBINI) vincolata dall’indefettibilità di un esplicito conferimento
di poteri da parte del legislatore, per altri (CAMMEO), invece, addirittura connaturata alla
titolarità del potere esecutivo.
Sul terzo gradino del sistema, le consuetudini ebbero un ruolo puramente integrativo
(eccezion fatta, probabilmente, per alcuni settori, come ad esempio quello commerciale, in
cui agli usi fu riconosciuto uno spazio non trascurabile): la loro vigenza dipendeva
dall’esistenza o meno di un rinvio ad esse operato dalla legge (consuetudini c.d.
secundum legem); tendenzialmente esclusa fu, infatti, la vigenza (oltre che delle
consuetudini contrarie al diritto scritto) delle consuetudini non richiamate da disposizioni
legislative, quand’anche non sussistesse tra le due fonti un contrasto (consuetudini c.d.
praeter legem).
2) Quanto detto in ordine al sistema delle fonti è di per sé indicativo della non compiuta
affermazione del principio di separazione dei poteri, quanto meno se inteso nell’accezione
rigida propugnata da Montesquieu. A suffragare questa conclusione possono addursi
anche ulteriori argomenti.
Innanzi tutto, una commistione tra potere legislativo e potere amministrativo era
chiaramente avvertibile nella figura del monarca, nella cui persona si associavano la
qualità di legislatore (art. 3 dello Statuto) e quella di capo dell’esecutivo (art. 5).
Tralasciando, per il momento, questi profili, che rappresentano una delle chiavi di lettura
fondamentali nella ricostruzione della forma di governo nel periodo statutario, è qui
opportuno soffermarsi, sia pur brevemente, sul terzo potere, quello giudiziario.
L’idea di una separazione dei poteri era riscontrabile in nuce nella carta costituzionale,
là dove si affermava che «i giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento,
[erano] inamovibili dopo tre anni di esercizio» (art. 69). Certo, trattavasi di una
affermazione che, di per sé, non era sufficiente a dar conto di un potere giudiziario
realmente indipendente: una lettura sistematica del testo, d’altra parte, lasciava adito a
ben pochi dubbi. In primo luogo, lo Statuto non impiegava mai il termine «potere» per
connotare la funzione giurisdizionale, suggerendo semmai l’esistenza di un corpo di
funzionari circondato da garanzie particolari. Era significativo, in tal senso, che rimanesse
nell’impianto statutario l’idea che «la giustizia emana[va] dal Re ed [era] amministrata in
suo nome dai giudici ch’egli istitui[va]» (art. 68). A chiudere il cerchio giungeva poi l’art. 73,
– 34 –

il quale, nel precisare che «l’interpretazione delle legge, in modo per tutti obbligatorio,
spetta[va] esclusivamente al potere legislativo», sanciva la superiorità dell’«interpretazione
autentica» su ogni interpretazione giudiziale che aspirasse ad avere effetti erga omnes.
Le scarne disposizioni statutarie vennero attuate, in conformità alla riserva di legge di
cui all’art. 70, secondo periodo, dalle leggi sull’ordinamento giudiziario che si succedettero
nel corso degli anni e che videro, nel lungo periodo, una progressiva attenuazione
dell’influenza – peraltro sempre chiaramente avvertibile – del potere politico, e del Ministro
guardasigilli in primis, nei confronti dei giudici (la funzione dei pubblici ministeri, organi
dell’amministrazione, rimase sempre pianamente dipendente dal potere esecutivo).
Tale influenza si fondava, per un verso, su una interpretazione restrittiva del principio
dell’inamovibilità e, per l’altro, sulla regolamentazione del potere disciplinare.
Nei primi anni di vigenza dello Statuto, l’inamovibilità conobbe una disciplina
doppiamente restrittiva rispetto all’art. 69, in quanto l’eccezione in esso prevista per i
giudici di mandamento venne applicata ad un numero crescente di soggetti, una volta
inseriti in tale categoria anche i pretori; d’altra parte, per coloro cui la garanzia si
applicava, se la legge 19 maggio 1851, n. 1186, aveva previsto che il mancato accordo tra
Governo e destinatario del provvedimento di trasferimento venisse deferito alla decisione
della Cassazione, con il decreto legislativo 13 novembre 1859, n. 3781, l’intervento della
Cassazione fu limitato al caso di trasferimento-sanzione, in ogni altro caso potendo il
Governo autonomamente provvedere «per necessità di servizio». Sarà solo con il decreto
legislativo 6 dicembre 1865, n. 2215, che la lettura della inamovibilità proposta nel 1851
verrà ripristinata.
Ad interinare il rapporto di dipendenza della giurisdizione dal potere esecutivo fu allora
soprattutto la disciplina del procedimento disciplinare, la cui iniziativa spettava al pubblico
ministero e la cui decisione spettava direttamente al Ministro della giustizia. Il medesimo
esercitava poi l’alta sorveglianza su tutti i giudici ed era titolare del potere di promozione e
di trasferimento d’ufficio.
Temperamenti significativi alla subalternità dell’ordine giudiziario furono introdotti
soltanto nel primo decennio del XX secolo. Ciò non tanto con la legge 14 luglio 1907, n.
511, che istituiva il Consiglio superiore della magistratura (organo composto in modo
pressoché esclusivo da membri designati dal Guardasigilli e titolare di funzioni serventi
rispetto a quest’ultimo), quanto semmai con la legge 24 luglio 1908, n. 438, che estendeva
a tutti i giudici la garanzia dell’inamovibilità e che poneva al vertice degli organi disciplinari
la c.d. Corte suprema disciplinare: il Ministro della giustizia perdeva, così, il potere di
– 35 –

infliggere sanzioni disciplinari, conservando solo quello di iniziativa (attraverso il pubblico
ministero).
Queste riforme, che pure non consentono di affermare l’avvenuta creazione di un ordine
giudiziario autonomo ed indipendente, sono comunque testimonianza evidente
dell’allontanamento della funzione giurisdizionale da quella politica, indicando un
progressivo radicarsi, sotto questo punto di vista, del principio di separazione dei poteri.
3) Il constatato rapporto di dipendenza dell’ordine giudiziario rispetto al potere esecutivo
può contribuire a spiegare i limiti entro i quali la garanzia dei diritti venne assicurata ed il
modello di Stato di diritto che si sviluppò nel corso degli anni.
All’indomani dell’unità, la classe politica fu chiamata a delineare un sistema di tutela del
singolo nei confronti della pubblica amministrazione che superasse la molteplicità di regimi
riscontrabili nei vari ordinamenti preunitari.
Con l’allegato E della precitata legge 20 marzo 1865, n. 2248, la scelta compiuta fu
quella dell’attribuzione al giudice ordinario della quasi totalità delle controversie nelle quali
venisse in gioco un «diritto» individuale. Per taluni, limitati casi, si previde la giurisdizione
di giudici amministrativi speciali (segnatamente, il Consiglio di Stato, oltre alla Corte dei
conti), mentre, per la tutela di tutte le altre situazioni giuridiche soggettive che non
assurgessero al rango di diritto, si ritenne sufficiente la predisposizione di procedimenti
interni agli organi di amministrazione attiva.
L’opzione per una applicazione tendenzialmente generale del principio di unità della
giurisdizione avrebbe potuto condurre il giudice ordinario a porsi quale vero e proprio
«controllore» dell’attività dei pubblici poteri, in funzione di protezione dei privati. Nei fatti,
ciò non avvenne se non molto parzialmente, in quanto i giudici ordinari intesero sovente in
senso restrittivo il ruolo che una normativa di non agevole interpretazione riservava loro;
ne derivarono ampie «zone franche» dal sindacato giurisdizionale, che minarono la piena
esplicazione dei principi propri dello Stato di diritto.
Alla luce di questa constatazione, assume dunque una importanza non trascurabile la
legge 31 marzo 1889, n. 5992, che istituì la IV sezione del Consiglio di Stato, attribuendole
la cognizione di tutte le controversie che coinvolgessero interessi legittimi (e non diritti
soggettivi) dei privati nei loro rapporti con l’amministrazione. Tale innovazione segnò, in
effetti, una tappa fondamentale nel radicarsi di uno Stato di diritto, proprio nella misura in
cui sostituì, nella tutela in vasti settori di attività, agli organi dell’amministrazione attiva un
organo giurisdizionale, in posizione pressoché paritaria rispetto al giudice ordinario.
– 36 –

La giustizia nell’amministrazione rappresenta il punto di tutela più avanzato raggiunto
dal Regno d’Italia per le situazioni giuridiche soggettive. Il passaggio ulteriore, quello cioè
del radicamento di uno Stato costituzionale di diritto, non venne mai compiuto, a ciò
opponendosi, sul piano teorico, la struttura del sistema delle fonti (ed in particolare la
natura flessibile della carta costituzionale) e, in concreto, il mancato sviluppo di un
consistente indirizzo giurisprudenziale che ritenesse possibile operare un controllo della
validità (recte, dell’esistenza) delle fonti normative primarie, sul modello del sistema
statunitense di controllo diffuso: ciò non fosse altro perché il ricavare per implicito la
configurabilità di un judicial review of legislation presupponeva una collocazione
istituzionale del potere giudiziario ben diversa da quella propria del periodo monarchico-
liberale, pregiudicata, come detto, dall’assenza della necessaria indipendenza e, a monte,
da quella di un radicato prestigio in seno alla società civile (PIZZORUSSO).
Certo, ci furono alcune prese di posizione nel senso di un sindacato, specie in ordine ai
requisiti formali che integravano la perfezione (ergo, l’esistenza) dell’atto legislativo,
tuttavia esse vennero in definitiva soverchiate da pronunzie di segno opposto. Qualche
maggiore spazio lo si ebbe in ordine al controllo degli atti normativi di rango primario che
provenissero dall’esecutivo (si ricordano, in particolare, la declaratoria di inesistenza del
decreto «liberticida» Pelloux da parte della Corte di cassazione, oltre ad alcune prese di
posizione in ordine al vizio di eccesso di delega dei decreti legislativi), ma, anche a tal
proposito, l’evoluzione giurisprudenziale fu così lenta da condurre ad alcuni frutti
significativi soltanto nei primissimi anni venti, all’alba, cioè, di un mutamento di regime che
avrebbe, anche su questo profilo, imposto una profonda rivisitazione (id est, un definitivo
ripiegamento dell’opera delle giurisdizioni).
– 37 –

Terza lezione – La forma di governo nel periodo monarchico-liberale
La caratteristica principale della forma di governo dello Stato italiano durante il periodo
monarchico-liberale è probabilmente quella del «dinamismo», riscontrabile in tutto l’arco
temporale che va dal 1848 al 1922. Ciò in ragione, da un lato, de [A] l’estrema elasticità
(constatata con riferimento a molti aspetti della vita istituzionale, ma particolarmente
pronunciata per quello che qui interessa) delle disposizioni dello Statuto albertino e,
dall’altro, de [B] l’evoluzione sociale, economica, ma anche politica ed istituzionale che ha
connotato i decenni post-statutari.
[A] Ad una prima lettura degli articoli più caratterizzanti dello Statuto, la conclusione che
pare scontata è quella in base alla quale la forma di governo ivi disegnata fosse quella di
una monarchia costituzionale pura. A tal proposito pareva inequivocabile il disposto
dell’art. 5, primo periodo, ai sensi del quale «al Re solo [apparteneva] il potere esecutivo»,
e dell’art. 65, secondo cui «il Re nomina[va] e revoca[va] i suoi ministri».
Da queste proposizioni sembrava sostanzialmente necessitato (specie allorché si
ponesse l’accento sui termini che si sono sopra posti in corsivo) un assetto istituzionale
caratterizzato dall’esercizio da parte del monarca del potere esecutivo, sul presupposto di
una sua indipendenza dal Parlamento, titolare del potere legislativo, e dagli organi cui
spettava il potere giurisdizionale. A sancire l’accoglimento di questo modello poteva
addursi ulteriormente l’assenza di una qualunque previsione concernente il Governo in
quanto organo costituzionale, fatta eccezione per un fugace – ed incidentale – accenno
agli «atti del Governo» contenuto nel secondo periodo dell’art. 67: finanche le disposizioni
relative al vertice della struttura amministrativa erano raggruppate in un titolo – peraltro
molto esiguo, essendo composto di soli tre articoli – dedicato a «i Ministri», ciò che non
risolveva il dubbio se i ministri fossero «ministri del Re» oppure membri di un organo
complesso, autonomo rispetto al monarca.
Per quanto improntata al modello costituzionale puro, la forma di governo statutaria
presentava, comunque, alcune peculiarità difficilmente riconducibili al genus di
importazione britannica.
Era, in primo luogo, avvertibile una certa quale enfatizzazione del ruolo della Corona,
che poteva porsi come vero architrave del sistema, con pregiudizio del principio di
separazione dei poteri che connotava la (ideale) forma di governo cui Montesquieu si era

ispirato nell’elaborare la propria teoria istituzionale. In tal senso, assumeva un particolare
rilievo l’art. 5, il quale, nell’individuare la difesa e la politica estera come materie di
«prerogativa regia», introduceva un significativo sbilanciamento dei poteri a beneficio
dell’esecutivo ed a scapito del legislativo, tendenzialmente escluso dal circuito decisionale
in ambiti di particolare importanza (esclusione che conosceva una sola significativa
eccezione in quanto previsto dal terzo periodo dell’art. 5, ai sensi del quale «i trattati che
importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non [avrebbero
avuto] effetto se non dopo ottenuto l’assenso delle Camere»).
A suffragare la primazia dell’istituto monarchico nelle istituzioni si ponevano, poi, alcune
previsioni che consentivano al Re di condizionare pesantemente il funzionamento del
potere legislativo. Il condizionamento era avvertibile già in ragione della struttura del
potere legislativo, essendo il Parlamento composto di due camere, l’una – la Camera dei
deputati – elettiva e l’altra – il Senato – composta «di membri nominati a vita dal Re, in
numero non limitato», ed appartenenti ad una delle ventuno categorie di persone
contemplate dall’art. 33 dello Statuto (ai termini dell’art. 35, spettava al Re anche il potere
di nomina del Presidente e dei vicepresidenti del Senato).
Anche sul piano funzionale, peraltro, l’incidenza del Re non appariva – quanto meno in
astratto – irrilevante: era il Re a convocare le Camere, a scioglierle ed a prorogarne le
sessioni (art. 9); al Re spettava, alla stessa stregua di ciascuna camera, presentare
progetti di legge (art. 10); ancora, il Re aveva il potere di sanzionare e di promulgare le
leggi (art. 7), potendosi configurare la sanzione come una vera e propria terza
approvazione del testo e, conseguentemente, l’approvazione regia come quella di una
«terza camera».
Oltre alle disposizioni dalle quali emergeva una certa quale preponderanza del Re
rispetto agli altri organi, non potevano trascurarsi gli elementi di obiettiva ambiguità nella
costruzione della forma di governo, concentrati essenzialmente nel primo periodo dell’art.
67 dello Statuto, il quale, nell’affermare che «i ministri [erano] risponsabili», non
specificava nei confronti di chi lo fossero né indicava le modalità attraverso cui la
responsabilità potesse essere messa in gioco, con ciò non essendo da escludere né una
responsabilità nei confronti del Re (il che ben si coniugava con l’aggettivo possessivo
presente nel precitato art. 65) né una responsabilità nei confronti del Parlamento.
Tale ultima lettura veniva rafforzata dal secondo periodo dell’art. 67 medesimo, il quale,
nel porre l’obbligo di controfirma degli atti del Re, sembrava addirittura avvicinare la forma
di governo ad un sistema tipicamente parlamentare, in cui il monarca, irresponsabile (l’art.
– 39 –

4 recitava: «la persona del Re è sacra ed inviolabile»), «regna ma non governa».
Ora, ponendo a sistema tutte le sopra menzionate previsioni contenute nello Statuto
albertino, sarebbe stato assai arduo individuare con assoluta certezza una forma di
governo «pura», tale da mantenere costanti nel tempo i propri attributi fondamentali. Da
questa constatazione, è stata talvolta dedotta l’impossibilità di formulare una qualunque
definizione che, per il suo essere astratta, prescindesse dalla prassi istituzionale
instauratasi anche solo qualche mese dopo l’entrata in vigore dello Statuto.
A ben vedere, tuttavia, l’importanza che hanno avuto i comportamenti degli attori politici
in chiave conformativa della forma di governo non impedisce di cogliere almeno alcuni
caratteri che, in linea teorica, possono evincersi dal testo costituzionale. Tra questi,
l’elemento di maggior significato è il dualismo intrinseco che dall’insieme delle previsioni
emerge e che, non a caso, si è costantemente mantenuto nel corso dei decenni.
Tale dualismo discende, come è chiaro, dalla duplicità delle fonti di legittimazione degli
organi costituzionali: da un lato, la fonte «dinastica», dall’altro quella «elettiva» (siffatta
definizione risultando assai più appropriata – per quanto visto sopra – rispetto ad altra che
faccia riferimento alla «democrazia»), la prima impersonata dal Re (e, sia pure in minor
misura, dal Senato) e la seconda espressa dalla Camera dei deputati.
Teoricamente ben definiti, i contorni del dualismo sono venuti ben presto a sfumarsi in
conseguenza della non compiuta definizione della posizione istituzionale del Governo
(rectius, del collegio dei ministri), tanto che la causa prima del «dinamismo» della forma di
governo può forse essere individuata nella variabilità della collocazione di questo organo,
talora «appiattito» sul versante dinastico talaltra più propenso ad un collegamento con la
camera elettiva (e, conseguentemente, ad una certa autonomia dal monarca).
Se quanto sin qui detto è vero, la ricerca di una definizione della forma di governo
statutaria che possa dirsi valida anche per tutto il periodo monarchico-liberale conduce ad
evidenziare come il sistema si sia configurato (praticamente ab initio) come «dualista» (nel
senso detto prima), «ad esecutivo bicefalo» (in ragione dell’autonomizzarsi – effettuale o
potenziale – del Governo dal Re) ed «a geometria variabile» (in rapporto alle contingenze
politiche e storiche).
Così ricostruita la forma di governo, si ritiene che non possa essere condivisa, quanto
meno nella sua versione più radicale, la tesi – peraltro assai diffusa, specie nella dottrina
più risalente – secondo cui il regime si sarebbe trasformato assai rapidamente, già nei
primi tempi del regno di Vittorio Emanuele II, in un regime parlamentare, e che tale
– 40 –

trasformazione sarebbe stata «definitiva». In realtà, per quanto non siano mancati periodi
in cui il sistema ha funzionato come se fosse parlamentare, essi sono sempre stati segnati
dal tacito accordo dei principali attori istituzionali a far funzionare il sistema in quel modo
anziché in un altro (id est, secondo quanto previsto dallo Statuto), accordo sempre
negoziabile, tendenzialmente revocabile (da parte del Re, in primo luogo) e, comunque,
mai definitivo.
A rendere ulteriormente problematica l’adesione alla tesi della «immediata
parlamentarizzazione» del sistema, deve poi sottolinearsi come la «variabilità» della forma
di governo possa essere constatata non solo in relazione ai mutevoli equilibri politico-
istituzionali, ma anche in rapporto al contesto storico-sociale. In particolare, sono da
distinguere nettamente i periodi di «emergenza» (derivanti da guerra interna o da disordini
sociali generalizzati) da quelli di relativa «normalità». Nei periodi di emergenza, infatti, le
considerazioni svolte in ordine alla non ben definita collocazione istituzionale del Governo
perdono gran parte del loro valore, nella misura in cui l’intero assetto del sistema era
fortemente permeato dalle previsioni del secondo periodo dell’art. 5 dello Statuto, secondo
le quali il Re «[era] il Capo Supremo dello Stato: comanda[va] tutte le forze di terra e di
mare; dichiara[va] la guerra; fa[ceva] i trattati di pace, d’alleanza, di commercio ed altri,
dandone notizia alle Camere tosto che l’interesse e la sicurezza dello Stato il
permett[ev]ano, ed unendovi le comunicazioni opportune».
La prerogativa regia in tema di difesa e forze armate, e dunque di conduzione della
guerra (quanto meno allorché essa avesse come teatro la penisola), restò incontestata
durante tutto il periodo monarchico-liberale, così come restò incontestato il potere del Re,
in quanto Capo dello Stato, di assumere i poteri decisionali supremi ogni qual volta si
verificassero situazioni tali da porre a repentaglio la sopravvivenza dello Stato stesso (e
quindi, non necessariamente in caso di guerra, ma anche, ad esempio, in caso di disordini
interni che avessero una diffusione tale da cagionare un potenziale sovvertimento
dell’ordine costituito).
Questo «potere di riserva» garantiva al Re ampia possibilità di scelta relativamente alle
modalità attraverso cui affrontare la situazione: egli poteva così decidere di condurre le
operazioni belliche in prima persona, recandosi presso il fronte e lasciando nella capitale
un suo luogotenente (è ciò che avvenne nella maggior parte dei casi: si pensi, in
particolare, alle guerre d’indipendenza o alla Prima guerra mondiale), oppure delegare
(come nel caso delle guerre coloniali) ad altri la gestione delle operazioni di guerra o di
ordine pubblico.
– 41 –

D’altra parte, l’eccezionalità di queste situazioni faceva sì che l’intera dinamica
istituzionale fosse da queste profondamente condizionata (se non addirittura ad esse
funzionalizzata): come logica conseguenza, sul piano fattuale veniva ad essere
sterilizzato, in questi periodi, il dualismo della forma di governo a beneficio esclusivo del
pilastro dinastico della stessa.
In definitiva, è soltanto nei periodi di «normalità» che le istituzioni funzionavano
(potevano funzionare) concretamente secondo i canoni dualistici che si sono descritti (e
che, in taluni frangenti, potevano effettivamente richiamare il regime parlamentare), per
quanto il disposto del secondo periodo dell’art. 5 dello Statuto fosse ben lungi dall’entrare
in uno stato di quiescenza (prova ne sia il fatto che, per quasi tutto il periodo monarchico-
liberale, il Re ebbe il potere di imporre propri fiduciari come titolari dei ministeri della
guerra e della marina, mentre i ministri degli esteri ebbero tutti almeno il suo gradimento).
[B] Le premesse di ordine generale che precedono dovrebbero a questo punto essere
corredate da una analisi più dettagliata dei profili più caratterizzanti della forma di governo.
Onde procedere in tal senso, è forse opportuno operare una periodizzazione (per quanto
essa non possa non rivelarsi almeno per certa parte criticabile, se non anche arbitraria),
alla luce della quale procedere ad una analisi di tipo eminentemente diacronico.
I periodi individuabili nell’arco di tempo compreso tra il 1848 ed il 1922 sono
essenzialmente cinque: (1) la fase di prima applicazione dello Statuto; (2) la fase della
«prima parlamentarizzazione»; (3) la fase della svolta autoritaria; (4) la fase della
«seconda parlamentarizzazione»; (5) la fase della crisi dello Stato liberale.
(1) La fase di prima applicazione dello Statuto. – All’indomani dell’entrata in vigore dello
Statuto albertino, il sistema istituzionale parve concretamente strutturarsi secondo i moduli
teorizzati in sede di redazione della carta costituzionale. Il Re si collocò, infatti, al centro
della scena politica, ponendosi come il dominus incontrastato nella scelta dei ministri, ivi
inclusa quella del Presidente del Consiglio. Carlo Alberto fece largo uso dei poteri che lo
Statuto gli attribuiva, designando al Governo personalità a lui vicine, anche a prescindere
da (e talora persino contro) gli orientamenti maggioritari in seno all’assemblea elettiva. Ne
derivò una rapida successione di ministeri, ben sei nei dodici mesi successivi al marzo
1848. Ciò che più conta, si procedette, già nel gennaio 1849, ad uno scioglimento della
Camera dei deputati, finalizzato essenzialmente a rafforzare in seno ad essa la compagine
– 42 –

politicamente più affine a quella espressione del «Governo del Re», ormai in procinto di
riprendere le ostilità contro l’Austria, superando in tal modo l’armistizio di Vigevano del 9
agosto 1848.
La sconfitta patita in questa seconda parte della Prima guerra di indipendenza indusse
Carlo Alberto all’abdicazione in favore del figlio, Vittorio Emanuele II. L’uscita di scena del
monarca che aveva promulgato lo Statuto non spostò comunque in modo significativo gli
equilibri istituzionali. Anzi, non appena salito al trono, il nuovo Re, chiamato a gestire la
difficile fase del secondo armistizio (poi concretizzatosi con il Trattato di Milano dell’agosto
1849), non esitò a sostituire il Presidente del Consiglio in carica (al de Launay subentrò
Massimo D’Azeglio) ed a sciogliere (solo poche settimane dopo lo scioglimento
precedente) la Camera dei deputati.
Ma più dell’atto di scioglimento in sé, ad assumere un particolare rilievo ai fini della
configurazione del sistema istituzionale è il proclama reale del 3 luglio 1849, nel quale si
invitavano i sudditi a «non rendere la libertà impossibile né impraticabile lo Statuto» (di cui,
evidentemente, il monarca era il primo garante): all’uopo, si esortavano gli elettori a
designare deputati che – contrariamente alla maggioranza della Camera sciolta, ancora
propensa alla prosecuzione delle ostilità – consentissero al Re di sottoscrivere un
armistizio con l’Austria, ritenuto indispensabile per garantire la sopravvivenza del Regno.
Lo scioglimento si configurava, dunque, come un appello al popolo rivolto direttamente
dal Sovrano, nella sua qualità di supremo reggitore dello Stato, che si ergeva al di sopra
delle «fazioni» politiche per il perseguimento degli interessi generali.
Lo scarso riscontro ottenuto nelle elezioni del 15 luglio (che videro, addirittura, un
rafforzamento del gruppo «democratico», ostile all’armistizio), indussero ad un ulteriore
scioglimento, corredato da un secondo appello al popolo, con il proclama di Moncalieri del
20 novembre 1849. In quest’ultimo, il Re ribadiva l’invito ai sudditi ad associarsi alla sua
politica, onde salvare lo Statuto ed il paese dai pericoli che lo minacciavano; all’invito
seguiva, stavolta, un monito («ma se il Paese, se gli elettori Mi negano il loro consenso,
non su Me ricadrà ormai la responsabilità del futuro; e ne’ disordini che potessero
avvenirne, non avranno a dolersi di Me, ma avranno a dolersi di loro») dal quale si
evinceva – in caso di mancata rispondenza dell’esito elettorale alla politica regia – una
possibile rottura della legalità statutaria, che sola avrebbe consentito di salvaguardare
l’integrità dello Stato.
Il proclama di Moncalieri, che da molti commentatori contemporanei venne letto come
una grave intromissione del Re nella dinamica elettorale, in violazione dei canoni
– 43 –

essenziali del regime «rappresentativo» che lo Statuto aveva inteso sancire in modo
definitivo, è sintomatico del ruolo assunto dall’istituto monarchico nell’ambito della forma di
governo, un ruolo assolutamente incompatibile con quello di un Re che «regna ma non
governa».
D’altra parte, una volta che lo scopo, nella successiva consultazione elettorale, fu
raggiunto, il Re prese a ritrarsi progressivamente dalla scena, in concomitanza – non a
caso – con la fine della situazione «eccezionale» provocata dagli avvenimenti bellici,
facendo così emergere sempre di più il Governo, allora guidato da un uomo di sua fiducia
quale il D’Azeglio, come soggetto (almeno parzialmente) autonomo, capace di instaurare
una propria dialettica con la Camera dei deputati.
Si creavano, in tal modo, le basi per una parlamentarizzazione della forma di governo
che, fino a quel momento, era stata resa impossibile dalle circostanze storico-politiche,
che avevano reso episodici gli accadimenti che pure avrebbero suggerito l’inizio della
transizione: il riferimento va, in particolare, a quei casi (datati addirittura 1848) nei quali il
Governo si dimise a seguito della constatata ostilità della Camera elettiva (non rilevando,
invece, la posizione dell’altra assemblea, essendosi affermato sin da subito il principio
secondo cui «il Senato non fa crisi»). Non erano ancora, evidentemente, manifestazioni
dell’instaurarsi di un vero e proprio rapporto di fiducia (le dimissioni rappresentavano,
probabilmente, nulla più che un invito al Re a determinarsi in ordine al modo attraverso cui
superare le difficoltà politiche inveratesi), ma le basi per un potenziamento dell’istanza
rappresentativa nel quadro delle istituzioni erano gettate. Con l’avvento di Cavour alla
Presidenza del Consiglio, nel 1852, se ne sarebbero avute ampie conferme.
(2) La fase della «prima parlamentarizzazione». – Questa fase può essere suddivisa in
tre segmenti temporali, corrispondenti (a) all’età cavouriana, (b) al periodo del governo
della Destra storica e (c) a quello del governo della Sinistra storica.
a) La designazione del Conte di Cavour alla guida del Governo segnò una svolta di non
trascurabile rilievo negli equilibri istituzionali del Regno di Sardegna.
In qualità di Ministro dell’agricoltura e delle finanze, Cavour aveva già avuto modo di
segnalarsi per le sue doti politiche, che lo avevano reso uno degli esponenti di spicco della
compagine governativa (a tratti anche in competizione con il Presidente D’Azeglio) e,
soprattutto, uno dei punti di riferimento principali delle forze liberali, maggioritarie in seno
alla Camera dei deputati.
– 44 –

Una volta divenuto Presidente del Consiglio, l’innovazione principale che Cavour operò
rispetto ai predecessori fu quella di non rivolgersi al «pilastro dinastico» per alimentare la
legittimazione del suo Governo, prediligendo la ricerca di una maggiore saldatura tra il
Governo e la maggioranza parlamentare. Altrimenti detto, Cavour non si configurò come
fiduciario del Sovrano, quanto piuttosto come esponente della maggioranza parlamentare,
che, nell’esprimere propri uomini alla guida del paese, rispondeva agli imperativi fondanti
di quel «sistema rappresentativo» che Carlo Alberto, già nel proclama dell’8 febbraio 1848,
aveva ritenuto essere il cardine del nuovo ordine costituzionale.
Alla visione della monarchia costituzionale come forma di governo espressa nello
Statuto si sostituiva quella di una monarchia tendenzialmente parlamentare, in cui il
rapporto fiduciario consentiva di collocare nel circuito Governo – camera elettiva il fulcro
del sistema: non a caso, il modello ripetutamente invocato fu quello britannico, in cui il
Prime minister, leader della maggioranza parlamentare, rappresentava la più efficace
saldatura tra potere esecutivo e potere legislativo.
Certo, profonde erano le differenze tra la forma di governo consolidatasi a Londra e
quella propria del Regno di Sardegna. Innanzi tutto, profondamente diversa era la
collocazione della Corona, la quale, confinata oltremanica ad un ruolo poco più che
cerimoniale (come ben avrebbe illustrato, di lì a poco, Bagehot nel suo saggio su The
English Constitution), giocava a Torino un ruolo politico attivo, specie nelle materie che
rimasero indiscutibilmente di prerogativa regia: non può trascurarsi, a tal riguardo, la
sostituzione del Cavour con il La Marmora nel secondo semestre del 1859, in seguito al
dissenso manifestato dal primo nei confronti della scelta di Vittorio Emanuele II di firmare
con l’Austria l’armistizio di Villafranca.
In secondo luogo, su un piano eminentemente giuridico il rapporto fiduciario che legava
il Cabinet londinese con la House of Commons poteva solo approssimativamente essere
paragonato a quello instauratosi tra il Governo sardo e la Camera dei deputati:
tecnicamente, infatti, non era dato parlare di un rapporto di fiducia, bensì – al più – di una
non-sfiducia, prescindendosi dalla sussistenza di un appoggio parlamentare esplicito al
ministero e facendo comunque salva la possibilità per i deputati di manifestare un
dissenso che, vista l’opzione operata in termini di fonte di legittimazione del Governo, non
poteva che essere pregiudicante per il perdurare nella carica della compagine ministeriale
(come si ebbe a constatare in occasione della c.d. «crisi Calabiana» del 1855, allorché
l’opposizione al disegno di legge sulla soppressione degli ordini religiosi costrinse Cavour
alle dimissioni, dimissioni cui seguì, dopo una settimana, un nuovo incarico allo statista,
– 45 –

una volta riscontrata l’impossibilità di convogliare su altri esponenti politici il sostegno della
maggioranza dei deputati).
Del modello britannico non si recepiva, infine, neppure l’idea di un confronto tra forze
politiche alternativamente investite delle responsabilità di Governo. L’avvertita necessità di
puntellare la legittimazione del Governo al di fuori di ogni tutela dinastica si tradusse,
infatti, nel tentativo, riuscito, di dar corpo, con il c.d. «connubio» tra la Destra moderata
cavouriana e la Sinistra riformatrice guidata da Urbano Rattazzi, ad una vasta
maggioranza politica che, nell’occupare il centro dello schieramento, si poneva come forza
egemone in sede parlamentare (tagliando fuori le ali estreme di sinistra e di destra) e
come base di riferimento sicura per il Governo, al riparo dai rischi insiti in un appoggio
numericamente esiguo da parte dei deputati.
Un possibile argine posto all’azione governativa avrebbe potuto essere quello costituito
dal Senato regio, il quale, per le sue modalità di composizione, pareva assai poco
adattarsi al mutato contesto istituzionale. Anche da questo punto di vista, tuttavia, l’età
cavouriana segnò un momento di svolta, attraverso l’affermazione del principio secondo
cui la nomina a senatore era solo formalmente riconducibile al Monarca, spettando però la
decisione, sul piano sostanziale, al Governo (e, in primis, al Presidente del Consiglio).
Ottenuta questa prerogativa, il Presidente del Consiglio seppe farne un uso consono ai
propri fini (in ciò largamente imitato dai successori), procedendo alle c.d. «infornate», cioè
a nomine di esponenti vicini al ministero, in numero tale da neutralizzare l’eventuale
opposizione della camera alta. La mancata previsione di un numero massimo di senatori e
la relativa libertà nella scelta dei designabili (dovuta alla genericità dei requisiti richiesti)
resero possibile una prassi di questo tipo, che, nel rafforzare invariabilmente il Governo,
non mancò, tuttavia, di dimidiare il ruolo politico (e, in ultima analisi, la legittimazione) del
Senato.
Proprio l’assenza di efficaci contropoteri di origine parlamentare disegnò un sistema in
cui il circuito Governo – Parlamento vedeva una preminenza del secondo che era
esclusivamente formale, il primo organo assumendo dunque una posizione di assoluta
centralità. D’altra parte, un contributo fondamentale al fine di rendere il rapporto
fortemente sbilanciato fu giocato dal potere di scioglimento della Camera dei deputati, che
il Governo sovente impiegò (recte, riuscì a far impiegare da parte del Re) come minaccia
al fine di rendere «mansueta» una assemblea dei deputati che si mostrasse recalcitrante
su alcuni provvedimenti.
Ciò detto sul piano dei rapporti tra esecutivo e legislativo, non stupisce che il Governo,
– 46 –

in quanto tale, assumesse connotati di autonomia sempre più marcati rispetto al Re, ben
rappresentati da quei casi in cui il Cavour sentì di potersi confrontare con Vittorio
Emanuele II, propugnando visioni politiche anche profondamente divergenti (è
emblematica, in tal senso, ancora la «crisi Calabiana», in cui l’opposizione al disegno di
legge governativo trovò un convinto riscontro nel volere del Monarca). Le divergenze
videro non di rado prevalere il Presidente del Consiglio (che, non a caso, in nove anni
restò escluso dal Governo per soli sei mesi), tanto da far comprendere il lapsus in cui il
Cavour incorse quando, durante la Seconda guerra di indipendenza, ebbe ad esclamare:
«il re? Il vero re sono io!» (l’episodio è ricordato da MARTUCCI).
Questa esclamazione è di per sé significativa non solo ai fini della ricostruzione dei
rapporti tra Corona e Governo, ma anche per chiarire quali fossero i rapporti interni alla
compagine ministeriale, nella quale la preminenza di Cavour appariva incontestata, in
ragione del carisma dell’uomo politico e del suo essere il vero leader della maggioranza
parlamentare, ma anche in conseguenza delle scelte operate in sede di formazione dei
governi, tutti caratterizzati dalla presenza di un buon numero di uomini direttamente
collegati al Presidente del Consiglio e dall’assunzione da parte di quest’ultimo dell’ interim
di alcuni ministeri-chiave, onde corroborare con tali «portafogli» la primazia assicurata
dalla presidenza del collegio. Il concorrere di tutti questi elementi stenterà a riproporsi
nelle esperienze di governo successive alla prematura morte di Cavour, all’indomani
dell’unità (6 giugno 1861).
b) Contrariamente a quanto avvenuto nel decennio precedente, gli anni sessanta del
XIX secolo si caratterizzarono per una forte instabilità ministeriale, derivante
principalmente dall’assenza di un capo riconosciuto della maggioranza dei deputati. La
scelta dei presidenti del Consiglio da parte del Re cadde, per lo più, su esponenti della
Destra, che rappresentava, non solo la forza politica numericamente più cospicua, ma
anche la compagine che più adeguatamente garantiva il rispetto delle istituzioni
monarchiche (alcuni settori della Sinistra mostrando una certa contiguità con i
repubblicani).
Nel rapido succedersi dei governi, tuttavia, non mancarono gli incarichi affidati a uomini
della Sinistra moderata (Urbano Rattazzi fu per due brevi periodi a capo del Governo), ma
– ciò che più conta – non mancarono i c.d. «governi del Re», governi, cioè, che – come
era avvenuto sovente in epoca pre-cavouriana, ed ancora nel 1859 – non poggiavano la
propria legittimazione su una salda maggioranza parlamentare, bensì sul pilastro dinastico
(o sul c.d. «partito di corte»): tali, ad esempio, furono il secondo Governo del generale La
– 47 –

Marmora ed il Governo del generale Menabrea, due dei gabinetti più longevi del periodo (il
primo durò in carica quasi due anni, tra l’autunno 1864 e l’estate 1866, ed il secondo
superò il biennio, tra la fine del 1867 e tutto il 1869).
Questa tipologia di governi suggerisce una riacquisita centralità del Re nel quadro
istituzionale, centralità ulteriormente testimoniata dai casi di «revoca» del Presidente del
Consiglio (si pensi al Governo Minghetti, nel 1864) e da una spiccata inclinazione alla
nomina alla Presidenza di personalità vicine alla Corona (il riferimento va, in particolare, ai
due governi presieduti da Rattazzi, nel 1862 e nel 1867), nonché da qualche intervento
diretto nei lavori parlamentari (si noti che durante il periodo di governo di Menabrea si
ebbe l’unico caso di rifiuto della sanzione regia di una legge, nella fattispecie riguardante
la concessione della cittadinanza italiana agli italiani residenti nei territori peninsulari non
ancora posti sotto la sovranità del Regno d’Italia).
Al ritorno della compagine ministeriale sotto l’egida della monarchia si associò un
depotenziamento della figura del Presidente del Consiglio. Privi del carisma di Cavour,
quei capi del Governo che cercarono di emanciparsi dalla tutela della Corona
perseguirono il disegno di normativizzare la loro preminenza all’interno del Consiglio dei
ministri, ispirandosi, ancora una volta, al modello britannico. A riuscire nell’intento fu
Ricasoli, il quale, nella sua seconda esperienza governativa, fece approvare il regio
decreto 27 marzo 1867, n. 3629, sulle attribuzioni del Presidente del Consiglio. Il decreto
ebbe tuttavia vita breve: emanato quasi al termine dell’esperienza governativa del barone
toscano, il decreto venne prontamente abrogato sotto il Governo successivo, quello di
Rattazzi (sarà poi largamente riesumato da Depretis nel 1876).
Sul finire degli anni sessanta, dopo la caduta del Governo Menabrea, il sistema tornò a
strutturarsi secondo forme più prossime a quelle di un governo parlamentare. Ciò avvenne
allorché il Re designò, nel 1869, alla guida del gabinetto Lanza, il leader parlamentare
della Destra dopo la morte di Cavour. Il nuovo Governo, nel quale si segnalò soprattutto il
Ministro delle finanze, Quintino Sella, per la sua politica di risanamento dei conti pubblici,
si trovò a gestire con successo l’occupazione di Roma e, anche grazie ai buoni risultati
macroeconomici, ottenne un discreto successo elettorale, nel 1870, tanto da esser
confermato in carica fino all’estate 1873. In questo periodo, terminata la fase
dell’emergenza dovuta al succedersi degli episodi bellici finalizzati alla completa
unificazione del territorio italiano, fu più agevole procedere ad una certa rivitalizzazione
dell’istituzione parlamentare, dalla quale il gabinetto traeva la propria legittimazione,
nell’ottica di una dialettica sempre più viva tra la Destra al potere e la Sinistra
– 48 –

all’opposizione, ma in costante crescita di consensi.
Un voto contrario al Governo su un disegno di legge in materia di oneri fiscali segnò la
caduta del ministero Lanza, al quale subentrò un altro esponente della Destra, Minghetti
(alla sua seconda esperienza come capo del Governo). Sarebbe stato l’ultimo Presidente
del Consiglio espresso dalla Destra storica prima del 1891.
c) Il voto del 18 marzo 1876, con cui la Camera respinse una proposta governativa,
innescò l’avvicendamento al potere tra la Destra e la Sinistra storica, guidata da Depretis.
Questo ribaltamento dei ruoli tra la maggioranza e l’opposizione è stato sovente definito
dalla trattatistica come la manifestazione di una «rivoluzione parlamentare». L’utilizzo di
questa espressione non pare, tuttavia, condivisibile. Ciò per una molteplicità di argomenti:
in primo luogo, la Sinistra, sebbene episodicamente, già aveva rivestito, con alcuni suoi
esponenti, responsabilità ministeriali, ed il suo leader, Rattazzi, aveva addirittura ricoperto
la suprema carica governativa; in secondo luogo, l’idea di «rivoluzione» sarebbe forse
stata idonea ad illustrare un ipotetico avvicendamento compiuto quando la Sinistra era
ancora maggioritariamente attestata su posizioni mazziniane (o comunque anti-
monarchiche), ma non lo era più nel 1876, quando cioè poteva dirsi compiuta ormai da
tempo una piena accettazione dei postulati statutari (paradigmatico, in tal senso, può
essere l’abbandono della pregiudiziale anti-monarchica del garibaldino Crispi, risalente al
1865).
Certo, sulla Sinistra erano state convogliate diffuse istanze di rinnovamento (ben
corrisposte dal discorso di Depretis tenuto a Stradella nel 1875), le quali, però, si
inquadravano nell’ambito di una normale alternanza tra schieramenti politici, già
ampiamente sperimentata in altri ordinamenti (e segnatamente in quello britannico): a
fugare ogni dubbio in tal senso poteva essere addotta la sostanziale omogeneità della
base sociale della Sinistra rispetto a quella della Destra.
Da queste considerazioni non può, però, trarsi l’impressione di una piena continuità tra
il Governo Minghetti ed il Governo Depretis. A cambiare erano, innanzi tutto, gli uomini:
l’avvento al potere della Sinistra segnò da questo punto di vista una cesura, ché pose in
primo piano una classe politica che non era più fondamentalmente ancorata, come la
Destra, al notabilato piemontese, ma che, viceversa, era maggiormente rappresentativa
dell’intero territorio nazionale e che proveniva da esperienze politiche assai eterogenee (vi
figuravano mazziniani e garibaldini, liberali e radicali, etc.). Ma a cambiare era, soprattutto,
il rapporto con la Corona: definitivamente accettato sul piano costituzionale, l’istituto
monarchico veniva osservato con un certo distacco e nella prospettiva di una chiara
– 49 –

delimitazione di quali fossero le attribuzioni del Re rispetto a quelle del Governo, onde
scongiurare ogni ingerenza di quello negli affari di questo. Almeno per un decennio,
Depretis e gli altri esponenti della Sinistra non manifestarono esitazioni nel riconoscere
nella (sola) Camera dei deputati la fonte di legittimazione del proprio potere, superando in
tal modo i tentennamenti che sul punto avevano caratterizzato la Destra nel periodo post-
unitario.
Proprio al fine di rendere evidente l’autonomia del Governo dalla tutela dinastica,
Depretis pose sin da subito il problema della preminenza del Presidente del Consiglio sugli
altri ministri, nell’ottica del mantenimento di un indirizzo politico unitario. Il problema non
appariva di agevole soluzione, per quanto fosse indiscutibilmente in Depretis che la nuova
maggioranza riconosceva il leader: la Sinistra si presentava, infatti, non come un partito
nel senso moderno del termine, e neppure come un gruppo politico dotato di una certa
coesione, bensì come un insieme di «circoli» di deputati, più o meno ampi, ciascuno
facente capo ad uno degli esponenti più eminenti (Depretis, Cairoli, Zanardelli, Crispi,
Nicotera, etc.).
Alla luce di ciò, il Presidente del Consiglio era chiamato a mediare tra le diverse
componenti della sua maggioranza, cercando un equilibrio che gli garantisse l’appoggio
del più ampio numero di parlamentari. In quest’opera di mediazione rientravano,
ovviamente, anche le designazioni ministeriali, le quali vennero indirizzate ai vari leaders,
onde compattare la maggioranza della Camera dei deputati (per il Senato lo strumento
impiegato fu quello, ormai consueto, delle «infornate»). Ne derivò una accentuata
«ministerializzazione» del Governo, particolarmente difficile da gestire allorché uno dei
titolari di dicastero propugnasse una politica di forte autonomia dal Consiglio dei ministri (il
caso forse più noto – e più significativo – fu quello di Nicotera al Ministero degli interni).
In un contesto siffatto, neppure l’emanazione del regio decreto 25 agosto 1876, n.
3289, che recuperava, peraltro edulcorandolo, quello fatto emanare da Ricasoli sulle
attribuzioni del Presidente del Consiglio, poteva garantire una reale unitarietà dell’indirizzo
politico governativo, e ciò nonostante il chiaro disposto dell’art. 5, ai termini del quale «il
Presidente del Consiglio rappresenta[va] il Gabinetto, [manteneva] la uniformità
nell’indirizzo politico e amministrativo di tutti i ministri, e cura[va] l’adempimento degli
impegni presi dal Governo nel discorso della Corona, nelle sue relazioni col Parlamento e
nelle manifestazioni fatte al paese»: il capo del Governo restò sempre un primus inter
pares, legato ai ministri, non solo (e non tanto) dalla contiguità politica, ma anche (e,
almeno in certi casi, soprattutto) da rapporti che potremmo definire «di scambio» (da un
– 50 –

lato l’attribuzione del dicastero, dall’altro l’appoggio parlamentare dei deputati fedeli al
beneficiario).
La logica aggregativa non risparmiò neppure l’opposizione. Lo stesso Depretis non
esitò ad accettare i voti dei deputati della Destra, rilevando come non potesse escludersi
che questo comportamento derivasse da una loro «intima trasformazione». Nasceva, così,
il c.d. «trasformismo», cioè la pratica di coinvolgere nella politica governativa – secondo
moduli in certa parte riecheggianti il «connubio» cavouriano – quei deputati
dell’opposizione che accettassero di condividere le sorti del ministero in carica.
La pratica trasformistica, che ben presto si generalizzò, comportò come conseguenza la
formazione di un vasto schieramento che, da posizione mediana, garantiva al Governo un
appoggio molto ampio, disinnescando le istanze più radicali provenienti dalla destra
clerico-reazionaria e dalla sinistra anti-sistema.
Questo modo di concepire la dialettica politica pervase a tal punto le istituzioni che
divenne arduo discernere tra maggioranza ed opposizione finanche nel momento
elettorale. Sin dal 1848, il sistema elettorale adottato era stato quello del collegio
uninominale a doppio turno, che si riteneva che avesse il pregio di selezionare le
personalità migliori, nel quadro di una competizione nella quale i gruppi politici si
confrontavano per il tramite dei notabili locali. Con la riforma del 1882, che estendeva
sensibilmente il diritto di elettorato attivo (v. supra), si modificò anche il sistema elettorale,
abbandonando il collegio uninominale a beneficio di uno scrutinio di lista nell’ambito di
collegi plurinominali. L’innovazione, che nelle intenzioni avrebbe dovuto intaccare il potere
del notabilato locale, venne in molti casi utilizzata, in assenza di strutture partitiche stabili,
per proporre in sede elettorale quelle combinazioni tra esponenti politici di orientamenti
diversi, accomunati sotto un’unica lista, potenzialmente in grado di marginalizzare
ulteriormente le minoranze esistenti nel Parlamento. Il controllo governativo
sull’andamento delle consultazioni, già sperimentato nel periodo precedente, ma divenuto
particolarmente accentuato dopo le elezioni del 1876, contribuì, non senza violenze e
brogli, ad assicurare alla compagine trasformistica un notevole successo.
La perdurante egemonia sul piano parlamentare assicurò al Governo un costante
margine di autonomia dalla Corona. La frammentarietà della maggioranza, tuttavia, non
consentì una stabilizzazione ministeriale; anzi, la crisi di governo finì per essere essa
stessa utilizzata in chiave tattica: così, se i primi governi Depretis, con i due intermezzi dei
governi formati da Cairoli (nel 1878 e tra la metà del 1879 e la metà del 1881), caddero
tutti a seguito di voti contrari da parte della Camera dei deputati, i cinque governi
– 51 –

ininterrottamente guidati da Depretis tra il 1881 ed il 1887 (al momento della sua morte)
caddero tutti per crisi c.d. «extraparlamentari», derivanti principalmente dalla decisione del
Presidente del Consiglio di innescare la crisi per sostituire ministri scomodi o per far fronte
– eludendole – a difficoltà riscontrate in Parlamento.
Questa prassi, che assicurò a Depretis una longevità politica inusitata, avrebbe, a lungo
andare, contribuito a delegittimare non solo la classe politica, ma finanche l’istituto
parlamentare. La fase che si aprì nel 1887 lo dimostrò ampiamente.
(3) La fase della svolta autoritaria. – Alla morte di Depretis, il Re Umberto I (succeduto,
nel 1878, al padre Vittorio Emanuele II) designò alla Presidenza del Consiglio, nel segno
della più compiuta continuità, Francesco Crispi, Ministro dell’interno in carica.
L’ascesa di Crispi segnò tuttavia una svolta nell’evoluzione della forma di governo. Il
nuovo Presidente del Consiglio, infatti, sebbene provenisse dall’area politica depretisiana
ed avesse sovente assunto nel decennio precedente responsabilità ministeriali, mostrò
orientamenti istituzionali profondamente diversi dal suo predecessore.
Scarsa era la propensione di Crispi per la mediazione politica di cui Depretis era stato
maestro e non maggiore era la sua considerazione per quel circuito rappresentativo che,
nella ricerca defatigante di equilibri tra le varie fazioni, aveva condannato il sistema ad un
certo quale immobilismo, tradottosi, a sua volta, in una almeno parziale delegittimazione
del Parlamento agli occhi dell’opinione pubblica e, soprattutto, in una ritenuta inefficienza
nel difendere le conquiste risorgimentali contro l’incipiente eversione «rossa» (socialista) e
«nera» (anarchica).
Il contesto generale, unitamente alle convinzioni personali, condussero dunque Crispi a
perseguire una politica che, lungi dall’appiattirsi su una gestione degli affari concentrata
sulla «ordinaria amministrazione», si connotasse per i suoi tratti fortemente «decisionisti»,
prospettando una serie di riforme che contribuissero a rendere lo Stato più forte.
Per far ciò, egli non si esitò a ricercare un esplicito appoggio da parte della Corona,
relegata a partire dal 1876 ai margini del quadro istituzionale: accreditandosi come «uomo
forte», Crispi fece così leva sul Re, ridimensionando il ruolo della Camera dei deputati e
cercando direttamente nell’opinione pubblica un avallo per la propria politica.
Ne derivò un ritorno a moduli istituzionali ormai un po’ desueti, che riecheggiavano gli
equilibri disegnati dalla lettera dello Statuto, attraverso una netta separazione tra il potere
legislativo ed il potere esecutivo, nel quale ultimo il Presidente del Consiglio assumeva
– 52 –

(recte, conservava e rafforzava) la centralità operativa, ma nel quale, al contempo, il Re
veniva reintegrato a pieno titolo. Il discorso che Crispi pronunciò l’8 dicembre 1887, pochi
mesi dopo la sua investitura, alla Camera dei deputati può essere considerato, a tal
riguardo, un chiaro manifesto della sua politica istituzionale: «secondo lo Statuto vi è un
Parlamento ed un potere esecutivo. Capo del potere esecutivo come Capo dello Stato è il
Re il quale nomina e revoca i Ministri, sanziona le leggi ed i decreti per l’esecuzione delle
medesime. Il potere esecutivo è quindi una istituzione statutaria. E come i due rami del
Parlamento, il Senato e la Camera, hanno il diritto di riordinarsi e di determinare le loro
attribuzioni come meglio credono, il Re Capo del potere esecutivo, Capo dello Stato, ha il
diritto di ordinare il potere esecutivo e di fissare le attribuzioni dei Ministri».
Nei fatti, l’idea della tendenziale separazione tra i poteri giocò tutta a favore
dell’esecutivo, che condusse una politica spesso indipendente dalla volontà parlamentare,
contribuendo a menomare ulteriormente il prestigio della Camera dei deputati. Così,
quando un voto contrario su taluni provvedimenti finanziari condusse alla caduta del
secondo Governo Crispi (il primo era caduto per ragioni analoghe), l’iniziativa nella scelta
del nuovo Presidente del Consiglio ricadde essenzialmente sul Re, il quale designò,
all’inizio del 1891, il marchese di Rudinì, un esponente della Destra.
Il nuovo Governo sembrò formalmente restaurare l’autorità del Parlamento, attraverso
un più aperto dialogo tra la maggioranza dei deputati ed il Gabinetto. Ne è una
dimostrazione, probabilmente, l’abbandono (con la legge 5 maggio 1891) del sistema
elettorale a scrutinio di lista (molto criticato per le degenerazioni cui aveva dato luogo) ed
un ritorno al collegio uninominale.
Sul piano politico, tuttavia, l’azione dell’esecutivo si caratterizzò in senso marcatamente
conservatore, concentrata in modo pressoché esclusivo sul risanamento dei dissestati
conti pubblici. A tal fine, di Rudinì propugnò una riduzione delle spese militari, ponendosi
in aperto con gli ambienti vicini alla Corona: l’avvenuto recupero da parte di quest’ultima di
un ruolo centrale nella forma di governo fu testimoniato dalla circostanza che il contrasto
insorto costrinse il Presidente del Consiglio alle dimissioni a poco più di un anno dalla sua
designazione.
Gli successe Giovanni Giolitti, un uomo «nuovo» (nel senso che la sua esperienza
politica non affondava le proprie radici nel Risorgimento). Esponente della Sinistra liberale,
Giolitti formò un Governo connotato, sul piano sociale, in senso riformatore e progressista,
e, sul piano politico, teso a circoscrivere le inframmettenze della Corona. Un grave
scandalo bancario travolse, però, dopo solo un anno, questa esperienza ministeriale,
– 53 –

riaprendo la strada della Presidenza del Consiglio a Crispi.
Nella sua nuova esperienza, lo statista siciliano, chiamato a confrontarsi con i crescenti
disordini sociali (il riferimento è, in primo luogo, ai c.d. Fasci siciliani ed ai moti in
Lunigiana), radicalizzò gli orientamenti politici che erano stati tipici del suo primo periodo di
governo. In particolare, quella che era stata una scarsa attenzione nei confronti del
Parlamento divenne una politica tesa a tacitarlo: approfittando del funzionamento (non
continuo, ma) per sessioni, Crispi indusse il Re a chiudere o a prorogare ( id est,
aggiornare ad altra data) le sessioni parlamentari nelle quali l’oggetto di discussione
potesse mettere in difficoltà l’esecutivo, riconvocando le Camere anche dopo alcuni mesi,
o magari sciogliendole e ricorrendo così a nuove elezioni. La combinazione di tutti questi
strumenti raggiunse, in certi frangenti, un effetto di blocco pressoché totale dell’attività
parlamentare. Ad esempio, il 23 luglio 1894 venne chiusa la prima sessione della XVIII
legislatura; la seconda sessione, convocata per il 3 dicembre, venne prorogata al 15; dopo
undici sedute della Camera dei deputati e cinque del Senato, la sessione venne chiusa, il
13 gennaio 1895; l’8 maggio successivo intervenne il decreto di scioglimento della
Camera, che consentì una ripresa dei lavori parlamentari solo il 10 giugno, dopo le
elezioni: in oltre dieci mesi, l’assemblea elettiva aveva tenuto solo undici sedute!
Sostanzialmente costretto il Parlamento al silenzio, Crispi si mosse esclusivamente con
l’appoggio del Re, propugnando una politica che – per la netta avversione ad ogni istanza
sociale «progressiva», per l’espansionismo coloniale, per la ricerca di un consenso
dell’opinione pubblica direttamente sulla sua persona –, da «decisionista» che era stata tra
i 1887 ed il 1891, andò avvicinandosi sempre più ad una larvata dittatura personale.
La disfatta di Adua, nella guerra contro l’Impero etiope, obbligò un Crispi ormai
delegittimato socialmente e politicamente a rassegnare le sue dimissioni (5 marzo 1896).
A subentrargli fu, nuovamente, il marchese di Rudinì, che ripropose, almeno
inizialmente, un programma largamente analogo a quello presentato cinque anni prima.
Sebbene anche il Governo di Rudinì fosse stato emanazione principalmente del Re, il
Parlamento venne reintegrato nelle sue prerogative: il primo atto del nuovo gabinetto fu
infatti quello di presentarsi di fronte alle Camere per discutere circa la strategia da seguire
nel negoziato con il Negus etiope per la pace, da condurre «con prudenza e con fierezza,
ma soprattutto con la ferma risoluzione di respingere qualsiasi proposta non confacente al
nostro decoro».
Per marcare ulteriormente il distacco rispetto al Governo Crispi, di Rudinì giunse
– 54 –

persino a provocare un voto di condanna contro il suo operato da parte della Camera dei
deputati.
Sul piano politico generale, peraltro, il nuovo esecutivo non si differenziava in modo
sensibile dal precedente, accentuandone anzi gli aspetti conservatori. La deflagrazione di
una vasta ondata di insurrezioni traghettarono il Governo dalla conservazione alla più
aspra reazione, innescando una ondata di repressioni di violenza inusitata.
In questo contesto, la debolezza del Parlamento, ancora fortemente segnato dalle
menomazioni subite negli anni precedenti, non consentì una gestione equilibrata della
crisi, lasciandone al Governo (ed al Re) l’intera responsabilità. Non stupisce, allora, che
proprio in questi anni venisse proposta con forza, da uno dei leaders della Destra, Sonnino
(1897), l’idea di «tornare indietro», di tornare, cioè, ad una forma di governo aderente alla
lettera dello Statuto albertino: le degenerazioni del sistema, imputate al parlamentarismo
inveratosi nella prassi, si riteneva che potessero essere arginate attraverso un recupero
del ruolo della Corona nell’ambito di un regime monarchico-costituzionale.
L’invito a «tornare allo Statuto» fu raccolto da di Rudinì quando, superando le resistente
del Parlamento, proseguì nell’azione repressiva, appoggiandosi integralmente sull’esercito
e proponendo al Re lo scioglimento della Camera dei deputati, alla ricerca di una vittoria
elettorale che corroborasse la propria politica.
Resosi probabilmente conto della sua impraticabilità, Umberto I si ritrasse da questa
operazione, che avrebbe segnato una rottura definitiva degli schemi invalsi nella
costruzione della forma di governo. Di Rudinì, sfiduciato dalla Corona, non poté allora che
dimettersi.
Nella ricerca di una pacificazione politica, il Re chiamò al Governo il generale Pelloux,
gradito sia agli ambienti di corte sia, per le simpatie di Sinistra che gli sia attribuivano, ad
una parte consistente dei deputati.
Durante il primo anno di governo, Pelloux condusse, in effetti, una politica tesa a
mitigare gli eccessi reazionari del ministero precedente, rinunciando, tra l’altro, a quei
disegni di legge «liberticidi» che erano stati presentati da di Rudinì.
Tornato un clima di pace sociale, Pelloux ritenne però giunto il momento di dotare il
Governo di una serie di poteri che gli avrebbero consentito di reagire efficacemente contro
eventuali nuovi moti di protesta. Fu così che nel maggio 1899 varò un nuovo Governo,
fortemente orientato a destra, e riprese quei disegni di legge «liberticidi» lasciati languire
in Parlamento per oltre un anno. Lo scontro parlamentare che su di essi si accese, con
– 55 –

l’ostruzionismo dell’Estrema via via propagatosi a buona parte della Sinistra, non poté
essere domato neppure attraverso riforme del regolamento della Camera (ché, anzi,
l’ostruzionismo si spostò su di esse). L’estremo tentativo di forzare la mano con
l’emanazione degli atti nella forma del decreto soggetto a mera conversione da parte delle
Camere convinse definitivamente dell’esistenza di un tentativo di «colpo di stato» in senso
autoritario.
Nell’impossibilità di ricondurre il Parlamento ad una linea di obbedienza nei confronti
dell’esecutivo, Pelloux giocò l’ultima carta, quella elettorale. La sconfitta patita dal Governo
in carica rese sostanzialmente obbligate le sue dimissioni. Poco più di un mese dopo, il 29
luglio 1900, il regicidio simboleggiava la chiusura definitiva della c.d. «crisi di fine secolo»
e l’apertura di una fase nuova, nella quale il Parlamento, rinvigorito dalla battaglia condotta
contro i governi reazionari, sarebbe tornato a giocare un ruolo di primo piano.
(4) La fase della «seconda parlamentarizzazione». – All’indomani delle elezioni del
1990, venne incaricato della formazione del Governo il senatore Saracco, che coalizzò
intorno a sé una maggioranza piuttosto eterogenea, legata principalmente dalla necessità
di intraprendere un’azione politica volta a segnare una cesura netta rispetto alle più recenti
esperienze.
Privo di un sostegno convinto da parte di molti deputati pure formalmente ascrivibili alla
maggioranza, il Governo Saracco venne ben presto sfiduciato, nel febbraio 1901, dalla
Camera dei deputati, in ragione della politica, ritenuta troppo conservatrice, seguita in
occasione di alcune agitazioni promosse dalle organizzazioni operaie e sindacali.
Il Re Vittorio Emanuele III chiamò allora alla Presidenza del Consiglio uno dei più
autorevoli leaders della Sinistra liberale, Zanardelli, considerato – per il suo passato e per
le posizioni espresse nel corso della crisi di fine secolo – un efficace garante della reale
apertura delle istituzioni in senso progressista. Al Governo partecipava, come Ministro
dell’interno, Giolitti, destinato ad ispirare molte delle scelte più caratterizzanti del nuovo
gabinetto.
Oltre all’impostazione di alcune delle riforme sociali che caratterizzeranno anche gli
anni successivi (e sulle quali già ci si è soffermati in sede di analisi della forma di Stato), il
ministero Zanardelli-Giolitti si segnalò per il perseguimento di un’azione volta, da un lato, a
riproporre il Parlamento quale base della legittimazione del Governo e, dall’altro, a
potenziare (grazie, in particolare, al regio decreto 14 novembre 1901, n. 466), il ruolo,
– 56 –

all’interno dell’esecutivo, del Presidente del Consiglio, circoscrivendo le possibilità di
intervento della Corona, cui venne almeno in parte sottratta finanche la tradizionale
prerogativa concernente le designazioni dei ministri della guerra, della marina e degli
esteri.
Il Governo, dopo alcuni momenti di difficoltà in Parlamento, dovuti alla presentazione di
un disegno di legge che introduceva il divorzio, ebbe una vita relativamente lunga, sino a
quando, nell’ottobre 1903, la malattia dell’anziano Presidente del Consiglio condusse alle
dimissioni dell’intero gabinetto, favorendo in tal modo la nomina di Giolitti.
Prendeva così avvio il periodo comunemente definito come l’«età giolittiana», a
testimonianza della preminenza dello statista piemontese nel panorama politico italiano.
Confermando gli orientamenti di fondo, sul piano sociale e su quello istituzionale, del
ministero Zanardelli, Giolitti manifestò una chiara propensione a fare della Camera dei
deputati il centro del proprio potere, all’uopo giovandosi della sua posizione di leader
riconosciuto da parte della maggioranza e, per altro verso, dell’atteggiamento
scarsamente incline all’intervento diretto sulla scena politica con il quale il giovane Re
Vittorio Emanuele III evidenziò una netta differenziazione rispetto alle velleità paterne.
La politica giolittiana non rappresentò, peraltro, la semplice riproposizione dei moduli
istituzionali propri di una nuova «parlamentarizzazione». Furono, infatti, almeno due i
profili di novità significativi rispetto alle esperienze del passato.
Innanzi tutto, il primo decennio del Novecento vide una forte crescita della presenza
pubblica nell’ambito delle attività economiche e nella società civile. Ciò comportò, da un
lato, la necessità di una maggiore «tecnicizzazione» del dibattito politico e, dall’altro, uno
strutturarsi del sistema in modo tale da garantire alla politica un primato
sull’amministrazione. Entrambi questi fattori condussero ad uno spostamento del
baricentro del potere decisionale dalla Camera dei deputati al Governo, unico organo
capace di gestire concretamente l’interventismo statale. Questo spostamento, inizialmente
agevolato dalla posizione di preminenza di Giolitti nell’ambito dello schieramento politico
liberale, finì per essere, a sua volta, uno dei fattori che più incisivamente contribuirono a
concentrare sul Presidente del Consiglio un coefficiente di potere difficilmente riscontrabile
in epoche passate.
Un secondo fattore di novità – probabilmente il principale – fu costituito dall’apertura
programmatica che Giolitti perseguì a più riprese verso le forze politiche espressione delle
classi popolari. Il riconosciuto fallimento delle precedenti politiche di chiusura nei confronti
– 57 –

del Partito socialista (e delle altre forze dell’Estrema) indusse Giolitti, sin dal suo primo
incarico, a cercare di far entrare nella compagine governativa gli esponenti socialisti e
radicali più lontani dalle posizioni massimaliste. Il tentativo non riuscì, o meglio non riuscì
del tutto, dal momento che l’inserimento nel Governo fu possibile solo per alcuni politici di
matrice radicale e, comunque, in modo sovente transitorio. Ciò nondimeno, si
manifestarono, nel corso degli undici anni in cui Giolitti fu al potere, frequenti aperture da
sinistra a programmi di governo che si presentassero come particolarmente avanzati. In
quest’ottica, un ruolo certo non secondario sarebbe stato giocato dall’allargamento del
suffragio del quale Giolitti fu decisivo propugnatore, constatata la sua ineluttabilità al fine di
far corrispondere le istituzioni ad una società civile che, anche grazie al periodo di
notevole sviluppo economico, troppo era cambiata per continuare ad essere rappresentata
nelle forme ristrette disegnate dal legislatore del 1882.
Altra caratteristica dell’età giolittiana, che contribuì a renderla profondamente diversa da
tutte le altre, fu la relativa stabilità di governo. Giolitti guidò, infatti, il gabinetto per periodi
piuttosto lunghi: dal novembre 1903 al marzo 1905, dal maggio 1906 al dicembre 1909 (il
c.d. «lungo ministero», secondo solo – tra quelli post-unitari – a quello guidato da Lanza) e
dal marzo 1911 al marzo 1914. Ma anche nei periodi in cui lo statista di Dronero non fu a
capo del Governo, fu in lui che la maggioranza parlamentare riconobbe il proprio leader
indiscusso, e ciò non solo quando il gabinetto fu guidato da uomini di sua fiducia (come
Fortis, tra il 1905 ed il 1906, e come Luzzatti, tra il 1910 ed il 1911), ma anche, per certi
versi, durante le due effimere esperienze (entrambe di circa cento giorni) del suo più fiero
avversario, Sonnino (nel 1906 e tra il 1909 ed il 1910).
Nella prassi istituzionale, non mancarono, peraltro, alcuni elementi tali da avvicinare
l’età giolittiana ad altri periodi della storia costituzionale del Regno d’Italia. Si riproposero,
in particolare, alcune caratteristiche che erano state proprie della prima fase dei governi
della Sinistra storica.
Tra queste, può segnalarsi il ritorno su un tema invero piuttosto ricorrente, vale a dire
quello della opportunità o meno di procedere alla riforma del Senato regio, onde restituirgli
un peso che la inveterata consuetudine alle «infornate» aveva grandemente limitato.
L’argomento, caro a buona parte dei maggiori esponenti della Sinistra, venne ripreso sul
finire del primo decennio del Novecento, in non casuale connessione con la prospettata
introduzione del suffragio (quasi-)universale maschile: l’idea di rendere elettiva anche la
camera alta era infatti concepita in funzione di precostituire un potenziale argine contro le
temute derive che la camera bassa avrebbe potuto conoscere dopo l’estensione del diritto
– 58 –

di elettorato attivo. Come gli altri progetti che erano stati presentati nel passato, anche
quello elaborato dal costituzionalista Arcoleo conobbe però una sorte assai poco gloriosa,
a ciò contribuendo in maniera decisiva l’atteggiamento del Governo Luzzatti, connotato da
una certa resistenza ad ogni innovazione nella struttura del Senato che avesse possibili
ripercussioni negative sul controllo esercitato dall’esecutivo nei confronti dell’assemblea.
Altro aspetto dell’età giolittiana che può essere validamente comparato con alcuni
periodi precedenti (e segnatamente con quello nel quale Depretis aveva guidato il
Governo) fu il sistematico ricorso a crisi di governo extra-parlamentari. Tra il 1901 ed il
1914, soltanto un gabinetto (il primo Governo Sonnino) cadde in seguito ad una esplicita
votazione parlamentare: in tutti gli altri casi (facendo salvo quello, peculiare, del Governo
Zanardelli), si preferì rassegnare le dimissioni con anticipo rispetto ad un voto che avrebbe
potuto ledere il prestigio politico del destinatario. Giolitti, in particolare, fu sempre
particolarmente attento ad evitare questo tipo di censure, lasciando ad altri un ruolo di
primo piano ogni qual volta la situazione politica lasciasse emergere difficoltà non
immediatamente sormontabili, e giungendo finanche a consigliare al Re la designazione
del suo principale avversario allorché intravedeva l’impossibilità di formare un governo
stabile (non a caso, dunque, Sonnino fu chiamato il ministro «dei cento giorni»).
Gli elementi che, sopra ricordati, possono essere considerati come costanti riscontrabili
in tutto il corso dell’età giolittiana non debbono far pensare ad una tendenziale immobilità
sul piano delle dinamiche insite nella forma di governo. Specie nell’ultimo scorcio di questa
esperienza, infatti, non mancarono avvenimenti destinati ad incidere assai profondamente
sul sistema, nell’immediato ma anche nel periodo successivo. Il riferimento va, per un
verso, alla guerra di Libia e, per l’altro, alla prima sperimentazione del suffragio
(quasi-)universale.
Nell’autunno 1911, approfittando della favorevole contingenza internazionale, l’Italia si
impegnò in una guerra contro l’Impero ottomano volta a strappare ad esso la sovranità
sulla Libia. Le vicende belliche arrisero alle forze italiane, le quali costrinsero l’Impero
ottomano a sottoscrivere, nell’ottobre 1912, il trattato di pace con il quale si riconosceva la
conquista della colonia nordafricana da parte del Regno.
L’esito della guerra (così come la decisione di scatenarla) rafforzarono notevolmente la
popolarità di Giolitti agli occhi di un’opinione pubblica che vedeva il diffondersi di
sentimenti nazionalistici. Questo nuovo successo politico venne ottenuto, tuttavia,
seguendo un modus procedendi considerevolmente diverso rispetto a quello che aveva
fino a quel momento connotato la carriera politica dello statista piemontese. La necessità
– 59 –

di dichiarare guerra «all’improvviso», dopo una serie di preparativi compiuti nella massima
riservatezza, rese indispensabile una azione che non fosse concordata (ma neppure
esplicitata) in sede parlamentare: il Governo (ma, in realtà, il Presidente del Consiglio)
doveva agire al di là di ogni mandato in tal senso proveniente dalla Camera dei deputati,
appoggiandosi, dunque, esclusivamente sulla Corona (peraltro titolare di una prerogativa
in materia di politica estera e politica militare che le veniva in tal modo integralmente
confermata). Il Parlamento intervenne ex post, essenzialmente per ratificare decisioni già
assunte: nell’immediato, le obiezioni di ordine costituzionale vennero tacitate dal positivo
esito del conflitto; nel giro di qualche tempo, però, il precedente creato si sarebbe
dimostrato carico di conseguenze.
L’anno successivo alla fine della guerra di Libia, la Camera dei deputati venne sciolta.
Le elezioni che seguirono furono le prime a svolgersi dopo l’approvazione della legge
sull’allargamento del suffragio maschile. L’estensione del diritto di voto oltre i confini della
classe borghese impose un ripensamento della strategia da condurre in sede di
presentazione delle candidature e di campagna elettorale. Fino a quel momento, la
ristrettezza del circolo degli elettori aveva favorito una identificazione di essi con uno o più
notabili locali, chiara risultando la preponderanza del fattore personale nella scelta dei
deputati; con il mutamento intervenuto a livello giuridico, queste dinamiche erano avvertite
come non più attuali: in particolare, si paventava, da parte dei liberali, l’impatto che
avrebbe avuto sull’elettorato la propaganda condotta da quelle formazioni politiche
organizzate e capillarmente diffuse sul territorio, prima tra tutte il Partito socialista. I
liberali, sotto questo profilo, erano rimasti ancorati alla vecchia logica, vedendosi privi di
una organizzazione che consentisse loro di presentarsi preparati all’allargamento del
suffragio. Giolitti, forse più di altri, se ne rese conto, sebbene ritenesse di poter ovviare alle
difficoltà attraverso il suo prestigio personale, il controllo delle elezioni da parte
dell’apparato governativo (secondo una tradizione non propriamente edificante) e, last but
not least, il mantenimento (da lui tenacemente perorato) del sistema elettorale basato sul
collegio uninominale, che più si confaceva ad una rappresentanza fondata sulle persone
piuttosto che ad una scelta veicolata dall’adesione ad un partito. Nella strategia giolittiana,
doveva poi assumere un ruolo non secondario il c.d. «patto Gentiloni», contratto tra i
liberali e l’Unione cattolica al fine di far confluire il voto dei cattolici su candidati liberali che
si impegnassero in una politica gradita alle gerarchie ecclesiastiche.
I risultati elettorali dimostrarono quanto il quadro politico fosse cambiato in
conseguenza dell’allargamento del suffragio: i socialisti passarono da 25 a 50 deputati, i
– 60 –

radicali da 50 a 70, i cattolici da 20 a 30; i liberali subirono una sconfitta tutto sommato
preventivabile, e comunque non tale da porre a rischio il perdurare della loro maggioranza,
scendendo da 372 a 310 seggi nella Camera dei deputati. Il dato politico più rilevante non
fu però quello dei seggi ottenuti dalle singole formazioni, bensì la rivelazione del «patto
Gentiloni», inizialmente destinato a restare segreto, e la stima in base alla quale dei 310
seggi ottenuti dai liberali, ben 228 erano stati conquistati grazie all’appoggio determinante
dei cattolici.
La notizia, che dette la misura reale della crisi della classe politica liberale, ebbe subito
una vasta eco, ponendo in chiara difficoltà il Governo Giolitti, cui venne meno, tra l’altro,
l’appoggio dei radicali. In una situazione che appariva difficile da gestire, il Presidente del
Consiglio rassegnò le sue dimissioni, suggerendo al Re il nome di Sonnino come suo
successore. Sonnino rifiutò l’incarico, che venne allora conferito a Salandra.
Quella che poteva apparire come una nuova parentesi governativa, dopo le due che
avevano intervallato i ministeri Giolitti, si rivelò, invece, una cesura profonda nella storia
costituzionale. Si chiudeva, infatti, l’età giolittiana.
(5) La fase della crisi dello Stato liberale. – L’avvicendamento al Governo tra Giolitti e
Salandra precedette di soli pochi mesi l’assassinio a Sarajevo dell’arciduca Francesco
Ferdinando, erede al trono di Austria-Ungheria (28 giugno 1914).
Nell’ambito della crisi internazionale che sfociò nella Prima guerra mondale, il Governo
italiano oscillò lungamente tra neutralismo ed interventismo e, se del caso, tra l’entrata in
guerra a fianco degli Imperi centrali (con i quali era stata rinnovata, ancora nel 1912, la
Triplice alleanza sottoscritta nel 1882) ovvero con l’Intesa anglo-franco-russa.
Inizialmente orientato, almeno nelle prese di posizione ufficiali, per il non intervento, il
Regno d’Italia stipulò, il 26 aprile 1915, il c.d. Patto di Londra, nel quale, all’impegno a
dichiarare guerra all’Austria entro un mese dalla sottoscrizione, corrispondeva
l’assicurazione di compensi territoriali – scil., in caso di vittoria – per mezzo dei quali l’Italia
avrebbe finalmente acquisito le c.d. «terre irredente» (Trento e Trieste, su tutte), oltre ad
altri territori da tempo rivendicati (Bolzano e la costa della Dalmazia).
Tralasciando una disamina delle motivazioni che spinsero all’entrata in guerra (tra le
quali certo un ruolo decisivo ebbe la prospettiva di completare il processo risorgimentale di
unificazione sotto un’unica sovranità della nazione italiana), ciò che devesi qui evidenziare
è che il Patto di Londra venne sottoscritto in gran segreto, essendone a conoscenza
– 61 –

soltanto il Re, il Presidente del Consiglio, il Ministro degli affari esteri (Sonnino) e,
ovviamente, le alte gerarchie militari e l’ambasciatore italiano a Londra. Il Parlamento non
fu, dunque, minimamente informato, alla stessa stregua, peraltro, della grande
maggioranza dei componenti del Consiglio dei ministri.
L’atteggiamento tenuto dai vertici dell’esecutivo, che dimostrava senza infingimenti
quanto poco pesasse il potere legislativo nella condotta della politica estera, apparve di
particolare gravità anche in ragione del fatto che la maggioranza parlamentare – ed il suo
leader, Giolitti, in testa – si era ripetutamente professata neutralista.
Posto di fronte al fatto compiuto, il Parlamento non opposte, tuttavia, che una iniziale
resistenza, ben presto fiaccata anche dalla pressione di una piazza che, nelle «radiose
giornate» di maggio, si mostrò particolarmente sensibile alla propaganda interventista,
abbandonandosi anche ad atti inqualificabili, come il tentato assalto all’abitazione di Giolitti
o la «caccia al deputato dissenziente», sovente fomentati dagli accesi comizi di Gabriele
D’Annunzio.
Avvalendosi di questo clima, il Governo ebbe buon gioco nell’imporre al Parlamento
l’approvazione di una legge che gli attribuiva i pieni poteri al fine di dichiarare, preparare e
gestire l’imminente conflitto. La legge, che si ricollegava ad altre approvate, in passato, in
vista di periodi di guerra, si distingueva dagli esempi precedenti per l’entità dei poteri
trasferiti: le disposizioni legislative furono, infatti, formulate in modo tanto ampio e generico
da conferire, in sostanza, all’esecutivo l’esercizio pressoché monopolistico della gran parte
dei poteri pubblici, ivi inclusa la funzione legislativa (donde un utilizzo abnorme,
riscontrabile negli oltre quaranta mesi di guerra, della decretazione d’urgenza).
Al Parlamento restò solo la possibilità di controllare il Governo, ed anche di sfiduciarlo,
ciò che avvenne in due occasioni: nel giugno 1916, al gabinetto Salandra subentrò quello
– che vedeva la partecipazione di tutte le forze politiche tranne i socialisti ufficiali – guidato
da Boselli; nell’ottobre 1917, in concomitanza con la rotta di Caporetto, al Governo Boselli
successe il Governo Orlando (anch’esso di «unità nazionale»).
Al di là di questi avvicendamenti, il Parlamento ebbe, però, un ruolo assolutamente
marginale, anche in conseguenza della prassi invalsa di tenere le riunioni in comitato
segreto, recidendo, così, i più efficaci canali di comunicazione con un’opinione pubblica
peraltro distratta dalle pressanti esigenze belliche.
Al termine del conflitto, la vittoria non poteva nascondere le pesanti ripercussioni
economiche e sociali che la durata e l’intensità della guerra avevano avuto e che erano
– 62 –

destinate ad avere. Il problematico reinserimento degli ex-combattenti nella società civile,
le difficoltà della riconversione dell’industria alla produzione di pace, nonché le ristrettezze
imposte dalle contingenze economiche, gli scioperi, le agitazioni popolari (affrontate con
crescente preoccupazione alla luce della conquista del potere da parte dei bolscevichi a
seguito della Rivoluzione d’ottobre in Russia) ed i frequenti scontri con le forze dell’ordine
che costellarono quello che fu definito come il «biennio rosso» (1919-1920) contribuirono,
con tutta evidenza, a mantenere il paese in una situazione di tensione e di eccezionalità
sempre meno gestibile, anche in conseguenza della nascita di movimenti eversivi di
estrema destra, i c.d. Fasci di combattimento, che, guidati dall’ex-socialista Mussolini,
andavano riscuotendo una crescente simpatia tra i reduci e tra una borghesia vieppiù
intimorita dai disordini.
Sul piano internazionale, poi, le difficoltà da subito insorte nelle trattative di pace resero
evidente l’impossibilità per l’Italia di ottenere tutte le annessioni territoriali richieste con il
Patto di Londra, alimentando il mito demagogico della «vittoria mutilata», acuendo il
risentimento degli ex-combattenti ed ispirando i peggiori avventurismi, tra i quali, in
particolare, l’occupazione della città di Fiume da parte di milizie agli ordini di D’Annunzio.
A governare l’insieme di questi fattori di crisi si trovarono istituzioni uscite fortemente
segnate dall’emergenza bellica: un Parlamento delegittimato dalla scollatura rispetto alla
società civile, non ancora ricucita dopo le «radiose giornate» del 1915, e dall’implosione,
in seguito alla spaccatura tra interventisti e neutralisti, della maggioranza uscita dalle
elezioni del 1913; un Governo scarsamente coeso al proprio interno, e delegittimato dalla
condotta delle trattative per la sistemazione dell’Europa dopo la guerra. Se la pace aveva
intaccato il prestigio finanche del Presidente «della vittoria» (Vittorio Emanuele Orlando),
ad uscire rafforzati dalla Prima guerra mondiale erano dunque solo l’esercito e,
soprattutto, il Re, il primus miles cui la situazione di emergenza aveva consentito, in
aderenza all’art. 5 dello Statuto albertino, di recuperare un ruolo centrale in seno alla
forma di governo.
In questo contesto, la crisi di governo che seguì alla sfiducia pronunciata nei confronti
del Governo Orlando nel giugno 1919 (e motivata proprio dall’andamento delle trattative di
pace di Parigi) apparve di assai ardua soluzione. Su suggerimento di Giolittti, la scelta del
Re cadde su Nitti, già Ministro del tesoro nel Governo Orlando, ma dimessosi nel gennaio
1919.
Il nuovo Presidente del Consiglio riuscì a coagulare intorno a sé una maggioranza
iniziale, ma ben presto si evidenziarono le spaccature nel fronte governativo, agevolate
– 63 –

dalle tensioni sociali, dall’entrata di D’Annunzio in Fiume (12 settembre 1919) e da alcuni
provvedimenti adottati per far fronte alla situazione drammatica del bilancio statale (venne
congedato un milione di soldati) e per porre le basi di un ritorno alla normalità
(particolarmente contestata fu l’amnistia concessa per il reato di diserzione semplice, con
la quale fu drasticamente ridotta l’entità del contenzioso ancora pendente).
Per ovviare alla sostanziale impossibilità di contare su una reale maggioranza
parlamentare, Nitti ricorse agli strumenti offerti dalla tradizione, quali la proroga e la
chiusura delle sessioni, che resero lungamente inerti le Camere e che consentirono di
interinare la prassi invalsa nel periodo bellico della legislazione per decreto. A
dimostrazione della perdurante centralità della monarchia come sostegno di un Governo
privo di canali di legittimazione alternativa, in occasione della crisi di Fiume, si giunse
addirittura a convocare il Consiglio della Corona, un organo consultivo che era diretto
discendente del Consiglio di conferenza, ma che mai, dopo la promulgazione dello Statuto
albertino, era stato convocato.
Tutto ciò contribuì a marginalizzare ulteriormente il ruolo del Parlamento (con
conseguenze che non avrebbero tardato a manifestarsi), sebbene la condotta del Governo
Nitti fosse stata ispirata dalla necessità di fronteggiare un periodo di transizione, in vista di
un rilancio del sistema. A tal fine, il Presidente del Consiglio ritenne di poter consolidare le
basi popolari del regime, favorendo quell’incontro tra classe media progressista e
proletariato riformista lungamente ricercato da Giolitti, attraverso la riforma del sistema
elettorale. Il collegio uninominale venne così sostituito dal sistema proporzionale a liste
concorrenti.
La riforma non sortì gli effetti sperati. Il sistema proporzionale, infatti, favorì
grandemente i partiti che avevano una struttura organizzativa stabile, cioè principalmente
il Partito socialista ed il Partito popolare, collegato alle strutture cattoliche; i liberali erano
rimasti privi di una organizzazione, ancorati ad una visione personalistica della lotta
politica: in buona sostanza, le ragioni che avevano indotto, nel 1912, Giolitti ad opporsi
all’introduzione di uno scrutinio di lista erano ancora integralmente valide nel 1919. In
ragione di ciò, ben può dirsi che la scelta del sistema proporzionale contribuì in modo
decisivo ad accelerare la crisi in atto dello Stato liberale, senza che, però, si fossero
creare le condizioni sufficienti per il passaggio ad una forma di Stato avanzata (in tal
senso, ad esempio, militavano il ritardo e le incompiutezze nella predisposizione di un
adeguato sistema di istruzione pubblica).
A differenza di tutti i predecessori, poi, Nitti ebbe il merito, sul piano morale, di rifuggire
– 64 –

da ogni inframmettenza dell’apparato governativo sull’andamento delle elezioni,
contribuendo a rendere ulteriormente precaria la posizione dei candidati dello
schieramento liberale. I risultati delle elezioni del novembre 1919 furono, così, lo specchio
delle previsioni: i liberali (frastagliati sotto un gran numero di sigle) scesero a 252 deputati,
i socialisti salirono a 150 ed i cattolici del Partito popolare a 100; facevano la loro
comparsa anche 6 deputati esponenti di partiti eversivi di estrema destra. Per la prima
volta, i liberali non detenevano più la maggioranza assoluta della Camera dei deputati, e
ciò senza che fosse emersa una forza in grado di sostituirli. D’altra parte, l’auspicato
incontro tra liberali e partiti di estrazione popolare si dimostrò da subito assai difficile, non
solo per la scarsa unione in seno allo schieramento liberale, ma anche per le incertezze
del Partito popolare e per il massimalismo della maggior parte della rappresentanza
socialista.
Rimasto al Governo, ma ormai privo anche formalmente di una vera maggioranza, Nitti,
dopo una prima crisi nel marzo 1920, dovette rassegnare le proprie dimissioni nel giugno
dello stesso anno.
La designazione di Giolitti alla Presidenza del Consiglio ebbe il significato di un estremo
tentativo di rivitalizzare il sistema, ormai in una crisi conclamata. Giolitti elaborò un
programma molto ambizioso, diretto a reintegrare il Parlamento nelle proprie prerogative
ed a ridimensionare quelle della Corona. Nel primo senso, venne escluso il ricorso alla
legislazione per decreto, a beneficio di un ripristino della centralità delle Camere
nell’esercizio della funzione legislativa, e si propose l’eliminazione del potere governativo –
che a troppi abusi aveva dato luogo – di decidere in ordine alla proroga ed alla chiusura
delle sessioni. Nel secondo senso, si progettò l’abrogazione dell’art. 5 dello Statuto
albertino, che costituiva il fulcro delle prerogative regie in seno alla forma di governo. Su
entrambi i piani, Giolitti dovette constatare l’impossibilità di ottenere risultati significativi:
per un verso, l’assenza di una maggioranza parlamentare rendeva impossibile una
proficua traslazione di poteri dall’esecutivo al legislativo; per l’altro, la monarchia, tornata
ad avere un ruolo centrale nelle istituzioni, non pareva intenzionata ad accettare una
nuova marginalizzazione.
L’ultima carta giocata dall’anziano statista fu quella delle elezioni. Nel 1921 la Camera
dei deputati venne, infatti, prematuramente sciolta, con il pretesto di dare una
rappresentanza ai territori entrati solo di recente a far parte del Regno. La scelta dei tempi
era dettata, in realtà, dalla avvenuta scissione all’interno del Partito socialista (nel gennaio
1921, il congresso di Livorno aveva visto nascere il Partito comunista), che si riteneva che
– 65 –

potesse tradursi in un calo di consensi, e dunque in una maggiore disponibilità al dialogo
in Parlamento con le forze liberali. Al contempo, Giolitti avallò la formazione dei c.d.
«blocchi nazionali», cioè di liste unitarie di liberali, nazionalisti e fascisti, nella prospettiva
di metabolizzare all’interno del sistema liberale le forze eversive di estrema destra in forte
crescita di consensi.
I calcoli si rivelarono errati: il Partito socialista scese a 123 seggi, in parte compensati
dai 15 ottenuti dal Partito comunista; il Partito popolare incrementò la propria
rappresentanza, attestandosi sui 108 seggi; i liberali mantennero pressoché inalterato il
numero di seggi soltanto grazie ai 35 deputati fascisti eletti nei «blocchi nazionali». Questo
numero permise, però, la costituzione di un gruppo parlamentare autonomo, con il risultato
di indebolire il gruppo liberale rispetto alla legislatura precedente.
L’operazione elettorale si era dunque rivelata un fallimento, reso ancor più grave
dall’avvenuta «legalizzazione», da parte del ceto dirigente liberale, delle violenze fasciste.
La assoluta ingovernabilità che ne seguì condusse, nel luglio 1921, Giolitti alle
dimissioni. I governi che seguirono, guidati da Bonomi e, dal febbraio 1922, da Facta,
ormai incapaci di una azione propositiva in chiave di rilancio del sistema, non poterono
fare altro che registrare l’agonia dello Stato liberale.
La «marcia su Roma» del 28 ottobre 1922, resa possibile dal rifiuto del Re di firmare il
decreto sullo stato di assedio, giunse allora a sanzionare la fine di un’epoca storica: il 31
ottobre Benito Mussolini diventava Presidente del Consiglio.
– 66 –