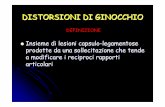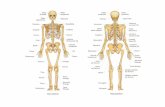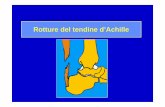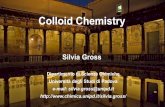Utilizzo dei fattori di crescita nelle lesioni del tendine rotuleo; Use of growth factors in...
Transcript of Utilizzo dei fattori di crescita nelle lesioni del tendine rotuleo; Use of growth factors in...

15
Introduzione
Le lesioni tendinee rappresenta-no una problematica ortopedicain continuo crescendo negli ulti-mi anni, considerando che unaquota sempre maggiore di popo-lazione partecipa ogni anno adattività fisiche o sportive [1,2].Negli Stati Uniti, per esempio,circa il 50% dei circa 33 milionidi traumi muscolo-scheletrici re-gistrati ogni anno riguarda i tes-suti molli, tra cui tendini e lega-menti [3-5]. Di questi, le lesionicroniche correlate ad attività spor-tive costituiscono circa il 30-50%[6]. Uno dei distretti maggior-mente colpiti in tale ambito è iltendine rotuleo. La prevalenza to-tale della tendinopatia rotulea èdel 14,2% secondo alcune casi-stiche [7], con incidenza mag-giore per quegli sportivi, come isaltatori, i giocatori di basket edi pallavolo, che sottopongono iltendine rotuleo a enormi stress esollecitazioni (“jumper’s knee” oginocchio del saltatore).Il tendine è l’unità dell’apparatomuscolo-scheletrico capace di tra-smettere la forza e l’energia pro-dotta da un muscolo a un seg-mento scheletrico. Lacerazioni,rotture, infiammazioni o lesionidegenerative a carico di un ten-dine possono determinare unamarcata morbilità nel paziente,ripercuotendosi sulle sue norma-li attività quotidiane o su quellelavorative e sportive.La riparazione della struttura edella funzione tendinea post-le-sionale richiede un adeguato ri-pristino dell’organizzazione e del-l’architettura delle fibre tendinee,nonché della capacità di scorri-mento del tendine stesso rispet-to alle strutture circostanti [8-10].La riparazione delle strutture ten-dinee si verifica in 4 fasi, ciascu-na caratterizzata dall’azione dispecifici fattori di crescita (GF) edal richiamo di cellule specializ-zate nel sito della lesione:1. fase dell’emostasi (1° giorno):
non appena i vasi sono lesio-nati dal processo traumatico, le
piastrine giungono nel sito pa-tologico e rilasciano diversi fat-tori di crescita, tra cui PDGF eTGF- , chemiotattici per di-versi tipi cellulari critici per ilprocesso di riparazione comei macrofagi, i fibroblasti e lecellule endoteliali [5]
2. fase dell’infiammazione (1°-4°giorno): strettamente conse-quenziale alla prima fase. Levarie cellule dell’infiammazio-ne giungono nel sito della le-sione. È possibile osservareuna infiltrazione leucocitariacon fagocitosi dei tessuti e deiresidui necrotici e un aumen-to della vasodilatazione e del-la permeabilità vascolare. I fi-broblasti reclutati comincianoa sintetizzare le varie compo-nenti della matrice extracellu-lare; contemporaneamentevengono rilasciati diversi fattoriangiogenici, tra cui il VEGF,che portano all’iniziale forma-zione di una rete vascolare. Intal modo viene assicurata unaprima e parziale stabilità e con-tinuità a livello della zona ten-dinea danneggiata [11,12]
3. fase della proliferazione (4°-21° giorno): il continuo reclu-tamento dei fibroblasti e la lo-ro rapida proliferazione nel sitodi lesione determinano la sin-tesi di grandi quantità di col-lagene, proteoglicani e altrecomponenti della matrice ex-tracellulare. Queste compo-nenti sono inizialmente orga-nizzate in maniera disordinatae casuale all’interno della ma-trice composta prevalente-mente da collagene di tipo III.Istologicamente risulta esserepresente un’estesa rete vasco-lare, mentre la ferita assumeun aspetto simil-cicatriziale.Alla fine di questa fase, il tes-suto di riparazione è quindialtamente cellulare e contieneabbondanti quantità di acquae componenti extracellulari[13,14]
4. fase del rimodellamento (21°giorno-2 anni): tale fase è ca-ratterizzata da una riduzione
della cellularità e della sintesidi matrice con collagene di ti-po III, con incremento invecedel collagene di tipo I. Le fibrecostituite da collagene di tipoI si organizzano lungo l’asselongitudinale del tendine di-ventando responsabili del re-cupero della resistenza, dellaforza meccanica e della forzatensile tendinea [15]. Nelle fa-si più tardive del processo diriparazione, i fattori di cresci-ta (quali TGF, PDGF, FGF) so-no di primaria importanza peril rimodellamento tissutale di-ventando segnali specifici didifferenziazione per ciascunalinea cellulare. Nonostantequesto, il tendine riparato nonraggiungerà mai le caratteristi-che originali del tendine sano.
Il processo di guarigione di untendine lesionato risulta essere re-lativamente inferiore, se compa-rato a quello di altri tessuti con-nettivali. La causa principalesembra essere rappresentata dal-la scarsa vascolarizzazione del tes-suto tendineo che condiziona lapossibilità di ripristino completodelle proprietà biologiche e mec-caniche, risultando pertanto inun rischio più elevato di re-in-fortunio a carico del tendine le-sionato [1,14,16]. Un altro pos-sibile fattore contribuente allaminor efficacia del processo diguarigione sembra essere rappre-sentato dalla presenza di modifi-che istopatologiche anche a cari-co delle porzioni tendinee nonapparentemente interessate daltrauma [17]. A questo si aggiun-gono le problematiche legate al-le caratteristiche del tessuto cica-triziale e alla formazione diaderenze tra il tendine e le strut-ture circostanti, che esitano in dif-ficoltà di scorrimento del tendi-ne stesso, deficit della motilità efunzionalità articolare e quindi inuna riduzione della qualità di vi-ta. Per tutte queste ragioni la ge-stione di una lesione tendinea ri-sulta particolarmente complessa epuò avvalersi di differenti strate-gie. Nel caso di rotture e lacerazionitendinee il trattamento chirurgi-co è sicuramente quello attual-mente più usato [5]; esso per-mette una riabilitazione precocee riduce i tassi di rirottura [18],ma al contempo è gravato ancheda complicanze quali infezioni,danneggiamento iatrogeno dellestrutture nervose, formazione dicicatrici che possono compro-mettere l ’“outcome” clinico[19,20]. Altri trattamenti classici sonoquelli conservativi, come il ripo-so, la terapia fisica e la terapiafarmacologica a base di FANS[21]. Si tratta di opzioni larga-mente utilizzate in caso di tendi-nopatie su base degenerativa e/oinfiammatoria; tuttavia non sem-
pre permettono di ottenere unaguarigione completa.Per tali motivazioni nelle ultimedecadi sono stati sviluppati nuo-vi approcci, come l’utilizzo di fat-tori di crescita e citochine, la te-rapia genica e l ’ ingegneriatissutale, che hanno permesso diincrementare la guarigione ten-dinea [16].Una delle nuove metodiche dimaggior utilizzo e successo è ba-sata sull’uso del PRP. Il PRP (“pla-telet-rich plasma”) rappresentaun sistema che permette di con-centrare la componente piastri-nica tramite un meccanismo dicentrifugazione, partendo dal san-gue del paziente. Le piastrine con-tengono diversi fattori di crescitache, applicati nel sito della lesio-ne, contribuiscono a innescare lacascata di coagulazione eserci-tando un effetto stimolatorio sul-la proliferazione e sulla migra-zione di diversi tipi cellulari esulla formazione di nuovi vasi. Ilconcentrato piastrinico agisce co-me coagulante della lesione e hala capacità di ridurre i tempi chi-rurgici e il drenaggio post-opera-torio; fornisce inoltre una super-f ic ie d i ades ione per i lconsolidamento dei segmenti nel-le fratture ossee [22].L’obiettivo di questo studio è ve-rificare l’efficacia dell’utilizzo delPRP nel trattamento della tendi-nopatia del rotuleo in soggetti“non responder” a precedenti trat-tamenti farmacologici e fisiotera-pici.
Materiali e metodi
Abbiamo impostato uno studioclinico prospettico osservaziona-le in cui abbiamo reclutato, tra il2010 ed il 2013, 20 pazienti (13maschi, 7 femmine) con tendi-nopatia rotulea, di età compresatra 18 e 43 anni (età media 31,25anni), che sono stati indirizzati atrattamento infiltrativo con PRP. I criteri di inclusione per l’am-missione a questo studio eranorappresentati dalla diagnosi ditendinopatia rotulea, dalla pre-senza di dolore alla palpazionedel tendine o durante attività fi-sica per una durata minima di 3mesi, confermata dalle immaginidi risonanza magnetica (MRI),precedenti i trattamenti (qualiFANS, corticosteroidi, onde d’ur-to, laserterapia) con risultati scar-si o nulli.La procedura è stata svolta comesegue. Il PRP è stato ottenuto pre-levando un campione di sangueautologo da ciascun paziente eaggiungendo quindi un anticoa-gulante (citrato destrosio A) al fi-ne di prevenire l’attivazione pia-s t r in ica pr ima del l ’usoterapeutico. Il campione è statocentrifugato 2 volte, prima perseparare i globuli rossi dal pla-sma e poi per separare le piastri-
ne dal plasma. Le piastrine sonostate poi attivate soltanto al mo-mento dell’iniezione con l’ag-giunta di calcio e trombina. Ilcampo operatorio è stato prepa-rato con adeguata disinfezionedella cute della regione del gi-nocchio, somministrazione dianestesia locale e scarificazioneeco-guidata della regione tendineadegenerata. Successivamente si èproceduto alla iniezione, tramiteun ago di 21G e sotto stretto con-trollo ecografico, di 6 ml di PRPin corrispondenza della regionetendinea degenerata. Nel periodo immediatamente suc-cessivo all’iniezione, a ciascun pa-ziente è stata concessa la possibi-lità di svolgere le normali attivitàdella vita quotidiana con l’ausiliodi un tutore. Contemporanea-mente è stata indicata l’astensio-ne da attività fisiche o sportivepesanti. Tutti i pazienti sono sta-ti inoltre avviati a un programmariabilitativo composto da 2 fasidifferenti. La prima fase (a parti-re dal 3° giorno dell’infiltrazio-ne) è caratterizzata da esercizi distretching muscolare e da eserci-zi isometrici e isotonici sulla re-sistenza, i quali favoriscono la dif-fus ione loca le de i fa t tor ipiastrinici. La seconda fase (a par-tire dalla 3a settimana) è caratte-rizzata dall’integrazione del pro-tocollo riabilitativo con esercizidi potenziamento muscolare.Tutti i pazienti sono stati poi ri-valutati a 2 e 6 mesi di distanzasia da un punto di vista clinico siada un punto di vista strumentalecon una nuova MRI.
Risultati
Al controllo a 2 mesi non abbia-mo avuto alcun “drop-out” dallostudio. Abbiamo verificato in 13pazienti su 20 (65%) la scom-parsa completa del dolore allapalpazione o dopo sforzo fisico,mentre in 6 pazienti (30%) per-sisteva un dolore di grado lieve,accentuato dalla flesso-estensionedel ginocchio (Figg. 1-2). In unsolo paziente (5%) residuava do-lore di grado moderato alla pal-pazione del tendine con limita-zione funzionale nella estensionedel ginocchio.La risonanza magnetica di con-trollo a 2 mesi ha evidenziato unacompleta risoluzione del quadrostrumentale in 16 pazienti su 20(80%); in 3 pazienti (15%) erapossibile osservare la riduzionedell’edema e dello spessore ten-dineo rispetto all’immagine pre-cedente; soltanto in un caso (5%)il quadro era invariato.
OrtopediaReumatologiae
archivio di
Utilizzo dei fattori di crescita nelle lesioni del tendine rotuleoB. Moretti, G. Vicenti, A. Abate, R. Maddalena, A. NotarnicolaUO Ortopedia e Traumatologia, Policlinico di Bari. Università degli studi di Bari
DOI 10.1007/s10261-013-0045-2
B. Moretti
ABSTRACT Use of growth factors in patients with patellar tendinopa-thy
Chronic tendinopathies represent one of the most common causes of long-term pain and physical disability. Because of poor tendon vascularity andbecause of the istopathologic changes in the damaged area, tendon healingrate is relatively low compared with other connective tissues, inducing apoor clinical and functional outcome. For these reasons, beside classic sur-gical and conservative treatments, new therapeutic approaches, such as theuse of growth factors, were developed in order to enhance biologic responseand healing processes. One of the most innovative systems is based on PRP.PRP (Platelet-Rich Plasma) is a plasma layer, separated after centrifuga-tion of an autologous blood sample, in which platelets are about 8 timesmore concentrated than in normal plasma. The rationale of this techniqueis based on scientific evidence of the importance of growth factors, con-tained in platelet granules, in the normal tendon healing process. In thisarticle we report the effects on clinical, functional and instrumental out-comes of US-guided injections of autologous PRP in 20 patients with patel-lar tendinopathy, aged between 18 and 43 years, treated in our clinicbetween 2010 and 2013.

16
logo in cui la concentrazione pia-strinica è superiore di circa 8 vol-te rispetto alla conta basale[1,21,35,36]. Il PRP estratto viene iniettato di-rettamente nel tessuto danneg-giato, con l’obiettivo di incre-mentare la guarigione della feritaattraverso l’azione dei vari fatto-ri di crescita e l’ottimizzazione
trattamento [2,28,29]. La fisiote-rapia e le infiltrazioni con steroi-di hanno dimostrato una scarsaefficacia a lungo termine [30,31].Le onde d’urto risultano più effi-cienti, tuttavia possono essere par-ticolarmente dolorose per il pa-ziente quando utilizzate nelleforme acute della patologia [32];il “debridement” chirurgico, in-
Al controllo a 6 mesi, a eccezio-ne del solo paziente in cui resi-duava il dolore e la limitazionefunzionale, e che è stato trattatochirurgicamente, per gli altri sog-getti non sono stati necessari al-tri trattamenti. In questi soggettiil miglioramento clinico è statostabile con ritorno alle loro prce-denti attività sportive.
Discussione
Il tendine rotuleo è un’importan-te e resistente struttura del mec-canismo estensore del ginocchio,che può essere interessato da le-sioni su base traumatica o su ba-se infiammatoria e degenerativa.Le rotture del tendine rotuleo so-no lesioni rare la cui reale inci-denza non è ben nota. Tuttavia es-se rappresentano la terza piùfrequente lesione del meccanismoestensore del ginocchio, dopo lefratture di rotula e la rottura deltendine del quadricipite [23-26].La tendinopatia rotulea è parti-colarmente frequente negli spor-tivi; essa costituisce una patologiafastidiosa e poco tollerabile, è ca-ratterizzata da una durata mediadella sintomatologia di circa 3 an-ni ed è responsabile, secondo al-cune casistiche recenti, dell’ab-bandono della carriera sportivada parte del 53% degli atleti af-fetti da questa condizione [7,27]. Per la tendinopatia rotulea sonodisponibili numerose opzioni di
tivatori, la presenza di WBC(“white blood cell”) e il “timing”e il numero delle iniezioni [1].Mentre Marx et al [40] hannosuggerito che una preparazionedi PRP debba contenere una con-centrazione piastrinica almeno 4-5 volte superiore rispetto ai valo-ri plasmatici per poter essereefficace, studi clinici condotti daaltri gruppi di Autori [21,41,42]hanno dimostrato un’efficacia cli-nica anche per concentrazionipiastriniche inferiori, special-mente negli sportivi. Per quantoriguarda la concentrazione diWBC, nel PRP esse sono presen-ti a concentrazioni anche 4-5 vol-te maggiori rispetto ai valori pla-smatici. Recenti studi hannotuttavia suggerito un possibile ef-fetto deleterio determinato dalleWBC nell’uso del PRP, effetto chesembra essere collegato all’azionedegradante sulla matrice indottodalle specie radicaliche dell’ossi-geno rilasciate da queste cellule[37,43]. Esistono invece pochistudi clinici comparativi circa idifferenti sistemi di centrifuga-zione del sangue autologo per l’ot-tenimento del PRP [1]. In uno diquesti, condotto da Castillo e coll.[44], non sono state riportate dif-ferenze significative tra i vari si-stemi di centrifugazione nellaconcentrazione finale di piastrine,globuli rossi, globuli bianchi,TGF- e fibrinogeno.In letteratura sono stati condottirecentemente numerosi studi sul-l’efficacia del PRP nel trattamen-to delle tendinopatie del tendinerotuleo sia in modelli animali siain pazienti. Nel 2009 Kon e coll.[45] hanno valutato l’uso del PRPin 20 atleti maschi affetti dallacondizione nota come “jumper’sknee” da almeno 3 mesi e conimaging (MRI o US) positivo perdegenerazione tendinea. I pazientisono stati sottoposti a 3 iniezio-ni a distanza di 15 giorni l’unadall’altra con un PRP caratteriz-zato da concentrazione piastrini-ca superiore del 600% rispetto aivalori plasmatici. A distanza di 6mesi gli Autori hanno trovato unmiglioramento significativo delquadro clinico-funzionale, conl’80% dei pazienti che si è di-chiarato soddisfatto del tratta-mento ricevuto. Ferrero e coll.[29] nel 2013 hanno studiato glieffetti di 2 iniezioni eco-guidate diPRP su 28 tendini rotulei appar-tenenti a 24 pazienti (14 maschi,10 femmine) eseguite a distanzadi circa 3 settimane. I pazienti so-no stati valutati tramite il VISA-P score (una scala di valutazionedel dolore e del livello di attivitàfisica) e tramite ecografie esegui-te a 20 giorni e a 6 mesi dallasomministrazione. A 20 giorni gliAutori non hanno osservato mi-glioramenti significativi né dalpunto di vista clinico né da quel-lo strumentale. A 6 mesi il VISA-P score risultava incrementato si-gnificativamente in tutti i pazienti,mentre l’imaging ecografico di-mostrava una riduzione dell’areaipoecogena in 26 tendini su 28(92,8%). Per quanto riguarda glistudi su modelli animali Lane e
coll. [35] nel 2013 hanno valutatole modifiche istopatologiche sutendini rotulei di coniglio dopoiniezione di un campione di PRPautologo. A 28 giorni gli studiistopatologici e ultrastrutturalihanno evidenziato nel sito di inie-zione un incremento del rimo-dellamento del collagene, unaipercellularità e una incrementa-ta attività metabolica tissutale, in-terpretabili come effetti positivideterminati dal PRP sul processodi guarigione tendineo. Nel nostro studio abbiamo ana-lizzato l’“outcome” clinico e stru-mentale di 20 pazienti (13 ma-schi, 7 femmine) con tendinopatiarotulea trattati con singola inie-zione ecoguidata di PRP autolo-go seguita da uno specifico pro-gramma riabilitativo. A 2 mesidalla somministrazione si è os-servato un miglioramento clinicofunzionale con scomparsa com-pleta del dolore nel 65% dei pa-zienti. Nello stesso arco di tempoè stata evidenziata una normaliz-zazione pressoché completa delquadro strumentale alla risonan-za magnetica nell’80-95% dei sog-getti esaminati.In conclusione, i risultati clinicidi questo e di altri studi sonoincoraggianti e suggeriscono chequesta nuova metodica possa es-sere utilizzata con successo sem-pre maggiore in futuro per quan-to riguarda il trattamento delletendinopatie del tendine rotu-leo. Tuttavia si rendono necessa-ri ulteriori studi a più lungo ter-mine per poter comprendere lereali potenzialità di questo siste-ma di trattamento, nonché perpoter escludere l’insorgenza dicomplicanze a livello locale e si-stemico.
Bibliografia
1. Hall MP, Ward JP, Cardone DA(2013) Platelet rich placebo?Bull Hosp Jt Dis 71:54-59
2. Järvinen TA, Kannus P, Mafful-li N, Khan KM (2005) Achillestendon disorders: etiology andepidemiology. Foot Ankle Clin10:255-266
3. Calve S, Dennis RG, Kosnik PE2nd et al (2004) Engineering offunctional tendon. Tissue Eng10:755-761
4. Butler DL, Juncosa, N, Dress-ler MR (2004) Functional effi-cacy of tendon repair proces-ses. Annu Rev Biomed Eng6:303-329
5. James R, Kesturu G, Balian G,Chhabra AB (2008) Tendon:biology, biomechanics, repair,growth factors, and evolvingtreatment options. J Hand SurgAm 33:102-112
6. Kannus P, Natri A (1997) Etio-logy and pathophysiology oftendon ruptures in sports. Scan-dinavian J Med Sci Sports7:107-112
7. Lian OB, Engebretsen L, BahrR (2005) Prevalence of jumpe-r’s knee among elite athletesfrom different sports: a cross-sectional study. American JSports Med 33:561-567
8. Schneewind JH, Kline IK, Mon-sour CW (1964) The role ofparatenon in healing of experi-
OrtopediaReumatologiae
archivio di
Fig. 1. Maschio di 24 anni, giocatore di basket, con riferita gonalgia da almeno 1 anno. a RM pre-trattamento: lacerazione parziale del tendine rotuleo cheappare in sede inserzionale prossimale discretamente slargato, disomogeneo ed edematoso. b RM dopo 2 mesi dall’iniezione di PRP: presenza, in sedeinserzionale rotulea, di lieve iperintensità con piccola borsite da esiti di intervento, sottile falda di versamento endoarticolare
Fig. 2. Donna di 18 anni, ballerina professionista, con riferita gonalgia da 3 anni. a RM pre-trattamento: discreto ispessimento tendinosico del tendine rotu-leo in sede pre-inserzionale prossimale a cui si associano fenomeni flogistici di peritendinite con reazione della borsa pre-rotulea superficiale. b RM dopo2 mesi dalla iniezione di PRP: tendine rotuleo nella norma
vece, a ottimi risultati sul pianoclinico associa svantaggi quali l’in-vasività e l’elevato costo della pro-cedura [33,34]. Recentemente so-no stati proposti nuovi sistemibasati sull’utilizzo dei fattori dicrescita col fine di promuovere esupportare la normale rispostabiologica di riparazione dei tes-suti. Durante la riparazione deitendini infatti un ruolo impor-tante è svolto da numerosi fatto-ri di crescita e citochine (PDGF,TGF- , VEGF, EGF). Tali moleco-le, contenute all’interno dei gra-nuli piastrinici, vengono rilascia-te nel sito della lesione e si leganoa specifici recettori di superficie,avviando una cascata di tradu-zione del segnale conducente al-la trascrizione di specifici geni re-golatori coinvolti nel processo diguarigione [5]. Tali evidenze han-no portato allo sviluppo della me-todica basata sul PRP. Questo èper definizione uno strato di pla-sma ottenuto per centrifugazionedi un campione di sangue auto-
teorica del microambiente lesio-nale [37]. Trattandosi di un cam-pione proveniente da sangue au-tologo, il rischio di sviluppo direazioni allergiche o l’introduzio-ne di infezioni esogene è da con-siderarsi trascurabile [38]. Unavolta iniettate, le piastrine inizia-no la secrezione attiva di GF en-tro 10 minuti e più del 95% deiGF preformati viene rilasciato en-tro un’ora dalla somministrazio-ne. Le piastrine rimangono attiveper 7 giorni, continuando a sin-tetizzare e rilasciare GF per tuttoquesto arco di tempo [39]. Unvantaggio teorico dell’utilizzo delPRP rispetto ai GF isolati purifi-cati risiede nel fatto che il PRPnon solo contiene numerosi GF,ma questi sono presenti anche inproporzioni fisiologiche, con con-seguente presenza di equilibriotra fattori di proliferazione e fat-tori di induzione [21].In letteratura esistono dati con-troversi circa la concentrazioneottimale delle piastrine, l’uso di at-

17
the knee. J Emerg Med 24:163-168
26. Siwek CW, Rao JP (1981) Rup-tures of the extensor mecha-nism of the knee joint. J BoneJoint Surg Am 63:932-937
27. Kettunen JA, Kvist M, Alanen E,Kujala UM (2002) Long-termprognosis for jumper’s knee inmale athletes. A prospective fol-low-up study. Am J Sports Med30:689-692
28. Tan SC, Chan O (2008) Achil-les and patellar tendinopathy:current understanding of pa-thophysiology and manage-ment. Disabil Rehabil 30:1608-1615
29. Ferrero G, Fabbro E, Orlandi Det al (2012) Ultrasound-guidedinjection of platelet-rich plasmain chronic Achilles and patellartendinopathy. J Ultrasound15:260-266
30. Young MA, Cook JL, PurdamCR et al (2005) Eccentric decli-ne squat protocol offers superiorresults at 12 months comparedwith traditional eccentric pro-
tocol for patellar tendinopathyin volleyball players. Br J SportsMed 39:102-105
31. Fredberg U, Bolvig L, Pfeiffer-Jensen M et al (2004) Ultraso-nography as a tool for diagno-sis, guidance of local steroid in-jection and, together with pres-sure algometry, monitoring ofthe treatment of athletes withchronic jumper’s knee andAchilles tendinitis: a randomi-zed, double-blind, placebo-con-trolled study. Scand J Rheuma-tol 33:94-101
32. Wang CJ (2003) An overview ofshock wave therapy in muscu-loskeletal disorders. ChangGung Med J 26:220-232
33. Paavola M, Kannus P, Orava S etal (2002) Surgical treatment forchronic Achilles tendinopathy:a prospective seven month fol-low up study. Br J Sports Med36:178-182
34. Orava S, Osterback L, Hurme M(1986) Surgical treatment of pa-tellar tendon pain in athletes.Br J Sports Med 20:167-169
35. Lane JG, Healey RM, Chase DC,Amiel D (2013) Use of plate-let-rich plasma to enhance ten-don function and cellularity. AmJ Orthop 42:209-214
36. Kaux JF, Crielaard JM (2013)Platelet-rich plasma applicationin the management of chronictendinopathies. Acta OrthopBelg 79:10-15
37. Anitua E, Sánchez M, NurdenAT et al (2006) New insightsinto and novel applications forplatelet-rich fibrin therapies.Trends Biotechnol 24:227-234
38. Sánchez AR, Sheridan PJ, KuppLI (2003) Is platelet-rich pla-sma the perfect enhancementfactor? A current review. Int JOral Maxillofac Implants 18:93-103
39. Marx RE (2004) Platelet-richplasma: evidence to support itsuse. J Oral Maxillofac Surg62:489-496
40. Marx RE, Garg AK (2005) Den-tal and craniofacial applicationsof platelet-rich plasma. Quin-tessence Publishing
41. Sánchez M, Anitua E, Azofra J etal (2007) Comparison of surgi-cally repaired Achilles tendontears using platelet-rich fibrinmatrices. Am J Sports Med35:245-251
42. Eppley BL, Woodell JE, HigginsJ (2004) Platelet quantificationand growth factor analysis fromplatelet-rich plasma: implica-tions for wound healing. PlastReconstr Surg 114:1502-1508
43. Tidball JG (1995) Inflammatorycell response to acute muscleinjury. Med Sci Sports Exerce27:1022-1032
44. Castillo TN, Pouliot MA, KimHJ, Dragoo JL (2011) Compa-rison of growth factor and pla-telet concentration from com-mercial platelet-rich plasma se-paration systems. Am J SportsMed 39:266-271
45. Kon E, Filardo G, DelcoglianoM et al (2009) Platelet-rich pla-sma: new clinical application:a pilot study for treatment ofjumper’s knee. Injury 40:598-603
OrtopediaReumatologiae
archivio di
mental tendon transplants. JOccup Med 6:429-436
9. Peacock EE Jr (1964) Funda-mental aspects of wound hea-ling relating to the restoration ofgliding function after tendon re-pair. Surg Gynecol Obstet119:241-250
10. Abrahamsson SO, GelbermanR (1994) Maintenance of thegliding surface of tendon auto-grafts in dogs. Acta OrthopScand 65:548-552
11. Lindsay WK, Birch JR (1964)The fibroblast in flexor tendonhealing. Plast Reconstr Surg34:223-232
12. Myers B, Wolf M (1974) Vascu-larization of the healing wound.Am Surg 40:716-722
13. Garner WL, McDonald JA, KooM et al (1989) Identification ofthe collagen-producing cells inhealing flexor tendons. Plast Re-constr Surg 83:875-879
14. Fenwick SA, Hazleman BL, Ri-ley GP (2002) The vasculatureand its role in the damaged andhealing tendon. Arthritis res4:252-260
15. Liu SH, Yang RS, al-Shaikh R,Lane JM (1995) Collagen in ten-don, ligament, and bone hea-ling. A current review. ClinicalOrthop Relat Res 318:265-278
16. Longo UG, Lamberti A, Mafful-li N, Denaro V (2011) Tissueengineered biological augmen-tation for tendon healing: asystematic review. Br Med Bull98:31-59
17. Maffulli N, Barrass V, Ewen SW(2000) Light microscopic hi-stology of achilles tendon rup-tures. A comparison with un-ruptured tendons. Am J SportsMed 28:857-863
18. Maffulli N, Longo UG, LoppiniM, Denaro V (2010) Currenttreatment options for tendino-pathy. Expert Opin Pharmaco-ther 11:2177-2186
19. Maffulli N, Longo UG, Spiezia F,Denaro V (2010) Free ham-strings tendon transfer and in-terference screw fixation for lessinvasive reconstruction of chro-nic avulsions of the Achilles ten-don. Knee Surg Sports Trauma-tol Arthrosc 18:269-273
20. Maffulli N, Longo UG, Testa Vet al (2008) VISA-P score forpatellar tendinopathy in males:adaptation to Italian. Disabil Re-habil 30:1621-1624
21. Creaney L, Hamilton B (2008)Growth factor delivery methodsin the management of sports in-juries : the state of play. Br JSports Med 42:314-320
22. Wrotniak M, Bielecki T, Ga dzikTS (2007) Current opinionabout using the platelet-rich gelin orthopaedics and trauma sur-gery. Ortop Traumatol Rehabil9:227-238
23. Milankov MZ, Miljkovic N,Stankovic M (2007) Recon-struction of chronic patellar ten-don rupture with contralateralBTB autograft: a case report.Knee Surg Sports TraumatolArthrosc 15:1445-1448
24. Nguene-Nyemb AG, Huten D,Ropars M (2011) Chronic pa-tellar tendon rupture recon-struction with a semitendino-sus autograft. Orthop Trauma-tol Surg Res 97:447-450
25. McGrory JE (2003) Disruptionof the extensor mechanism of