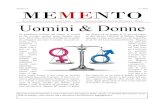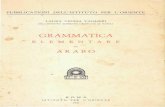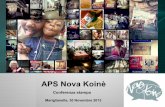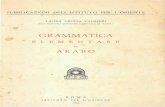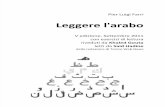Uomini di cultura nel mondo arabo
-
Upload
giulio-negri -
Category
News & Politics
-
view
35 -
download
3
Transcript of Uomini di cultura nel mondo arabo

GLI INIZI DELLA FILOSOFIA E DELLA SCIENZA ARABA
ll movimento islamico si trovò fin dai primi anni dopo l'egira (622) e la morte di Maometto (632) di
fronte al problema della espansione politica e religiosa. In pochi anni, sotto il califfato di Omar (634-644), vennero conquistati l'Egitto, la Siria, le terre dell'impero persiano. Con la successiva dinastia omeiade le truppe musulmane si spinsero nel Turkestan, in direzione dell'India, ed in
Spagna, dove crollò il regno visigoto; esse vennero fermate dagli imperatori della dinastia isaurica quando erano quasi giunte a Costantinopoli, e da Carlo Martello a Poitiers in Francia nel 732.
Valendosi di dottrine provenienti dall'ebraismo e dal cristianesimo, oltre che di culti e concezioni proprie della penisola arabica, l'islamismo, esposto da Maometto nel Corano, aveva una teologia semplice, basata sulla esistenza di un dio unico (Allah), sulla vita ultraterrena e sulla credenza nel
profeta. Malgrado ciò fin dai primi anni dispute politico-teologiche, basate sul ritenere autentiche o meno alcune parti del Corano, divisero il mondo arabo, ed alla ortodossia sunnita si oppose il
movimento sciita che, per alcune teorie, si avvicinava al culto persiano della luce. Nell'impero conquistato dagli arabi si mescolavano già da tempo le tendenze culturali più diverse; ad esempio in Persia si era venuta consolidando, sotto la protezione dei Sassanidi (la dinastia
deposta appunto nel 640), una fiorentissima scuola filosofico-scientifica, nella quale confluivano parecchi elementi dell'antica cultura ellenica con influenze della cultura indiana. I nuovi
conquistatori si fecero ben presto eredi di tali tendenze, e si può asserire che per alcuni secoli, mentre il livello generale degli studi declinava rapidamente in occidente, la filosofia e la scienza greche abbiano trovato una nuova vita nel mondo musulmano.
La maggior fioritura intellettuale islamica si ebbe con la dinastia degi Abassidi, che si impadronirono del califfato nel 750. Famiglia di tradizione persiana, e perciò particolarmente
sensibile ai valori della cultura, gli Abassidi trasportarono la capitale a Bagdad dove nell'828 venne istituito un importante osservatorio astronomico (nel quale lavorarono e insegnarono per lungo tempo valentissimi studiosi) e nell'832 venne fondata, ad opera del califfo Al-Mamun, una vera
scuola di traduttori, che si trasformò poi in università. L'istituzione ebbe una vita gloriosa per quasi quattro secoli, ma risentì del progressivo indebolimento dell'impero musulmano, dovuto sia
all'autonomia di importanti regioni (gli emirati di Spagna, dell'Africa settentrionale, d'Egitto), sia all'invasione dei turchi Selgiucidi che nel 1055 si impossessarono del califfato. L'università di Bagdad ricevette il colpo finale con l'invasione dei mongoli, che saccheggiarono e distrussero la
città nel 1258. Fra l'VIII ed il X secolo furono tradotte in arabo le opere che venivano studiate nelle tarde scuole di
Alessandria e della Siria, Dapprima i traduttori, per lo più cristiani, si valsero di versioni siriache, ma in seguito essi si rivolsero direttamente agli originali greci, elaborando, per merito del nestoriano Hunain (fine del IX secolo), dei criteri filologici di notevole livello. Loro merito è anche
la creazione della lingua filosofica e scientifica araba, la cui precisa terminologia tecnica ha influenzato profondamente le lingue scientifiche moderne.
I filosofi arabi, che non conoscevano il greco, poterono così avere familiarità con Plotino e con Galeno (alcune delle sue opere ci sono oggi conservate solo nella traduzione araba), con il Corpus ippocratico, con Euclide e Tolomeo, con gli scritti ermetici e perfino con alcuni dialoghi di Platone
(il Timeo, la Repubblica, le Leggi); il loro interesse si accentrò soprattutto sul pensiero di Aristotele, che conobbero sia nelle opere originali sia attraverso i commentari dei neoplatonici
(Filopono), di Temistio e di Alessandro di Afrodisia. Il primo pensatore arabo di rilevante importanza fu Al-Kindi, morto a Bagdad verso l'873, che scrisse un gran numero di commenti ad Aristotele. Al-Kindi interpretò l'intelletto attivo come
qualcosa di unico per tutti gli uomini, e vide l'avvicinarsi a dio come fine ultimo della filosofia. Notevoli in Al-Kindi sono anche gli interessi scientifici, che abbracciano la matematica e la fisica,
la musica e la medicina, l'astrologia e la geografia. All'inizio del secolo seguente insegnò a Bagdad un altro importante pensatore, Al-Farabi (morto nel 950) famoso anche come matematico e come medico. Come Al-Kindi, anche Al-Farabi scrisse

molti commenti ad Aristotele, che interpretò in maniera neoplatonica, tentando di accomunare il
pensiero dello stagirita a quello di Platone. Egli cercò anche di conciliare la ricerca filosofica con la religione dell'Islam; ed interpretò l'intelletto agente come unico e separato dalle singole anime, pur
senza identificarlo con dio. La metafisica di Al-Farabi pone dio come essere necessario completamente libero, la cui esistenza non si aggiunge all'essenza ma si identifica con essa. Dio non può produrre che essere eterni, e crea l'intelletto primo. Questo a sua volta genererà il secondo
intelletto e così via fino all'intelletto che genera il mondo sublunare, che è completamente contingente.
AVICENNA.
Con l'XI secolo la filosofia araba giunse al suo periodo aureo. Agli inizi del secolo; fra il 980 ed il 1036, visse Avicenna (Ibn Sina). Nato a Bukhara, di cui suo padre era governatore, Avicenna si
occupò di ogni genere di studi, oltre che di politica (fu egli stesso visir di Hamadan e di Ispahan), e fu famoso soprattutto come medico. Il suo Canone di medicina, che era studiato e pubblicato ancora in pieno Cinquecento, si ispirava alla teoria ippocratica degli umori, ed era di un'esemplare
chiarezza per la esposizione della diagnosi e delle cure delle maggiori malattie allora conosciute. Principalmente nell'Ashi-shifa (La guarigione), una specie di grande enciclopedia filosofica,
Avicenna diede un'interpretazione e rielaborazione generale del peripatetismo, sotto l'influenza dei commenti neoplatonici e dei motivi mistici della tradizione araba. Egli stesso dichiara che nell'aristotelismo non è racchiusa l'intera verità; questa consiste invece nell'identificazione mistica
dell'essenza divina con la suprema sfera celeste: tesi contenuta nel trattato La filosofia orientale, che rimase sconosciuto in occidente. Merita di venire ricordato che quattro parti dell' Ash-shifa erano
dedicate alle discipline del quadrivio; di particolare importanza quella che trattava di aritmetica nella quale -- sulla scia già aperta da Ben-Musa -- veniva ampiamente illustrata l'estrema utilità della scrittura decimale dei numeri (vi si esponeva fra l'altro la prova del 9).
Come già Al-Farabi, Avicenna distingue nettamente fra dio, essere necessario in cui si identificano essenza ed esistenza, e le cose create solamente possibili, in cui l'essenza non implica affatto
l'esistenza. Un'ampia gerarchia di tipo neoplatonico procede da dio al mondo, attraverso una serie di intelligenze motrici. Anche il mondo è eterno e incorruttibile, in quanto la sua causa è eterna: l'affermazione coranica per cui il mondo creato sarebbe posteriore nel tempo all'intelligenza
creatrice, vale solo per coloro che non sanno comprendere; in verità il mondo è solo meno sublime, perché meno vicino a dio. Coerentemente al riconoscimento del carattere necessario dell'essere,
Avicenna difese la possibilità di prevedere il futuro attraverso lo studio degli astri. Nell'ambito del problema della conoscenza infine Avicenna ritenne l'intelletto agente unico e superiore agli intelletti passivi dei singoli uomini, ed affermò che gli universali esistono ante rem, in
dio, come idee; in re, come forme sostanziali delle singole cose; post rem, nell'uomo, come concetti ricavati per astrazione dall'esperienza.
IL MISTICISMO DI AL-GHAZALI
Alla diffusione delle dottrine aristoteliche nel mondo islamico reagì, alla fine del secolo, Al-Ghazali (1058-1111), anch'egli di origine orientale. La sua polemica, rivolta particolarmente contro Al-
Farabi ed Avicenna, è esposta ne. trattato La disiruione dei filosofi. Egli si dimostra preoccupato soprattutto di salvare l'indipendenza di dio, compromessa dall'idea dell'assoluta necessità del mondo e della sua eternità. Con un'aspra critica del principio di causalità egli afferma che la volontà divina
è assolutamente libera ed imprevedibile. E' interessante notare come la polemica di Al-Ghazali sia condotta sempre con metodo strettamente
razionale, mettendo in luce la debolezza della ragione e la sua inapplicabilità ai problemi che esulano dal campo della dimostrazione. La sua critica sfocia così in un generale scetticismo verso le conquiste della ragione, che si concilia però con la fiducia mistica nei dogmi della fede.

AVEMPACE
In seguito la metafisica neoplatonica di Avicenna venne ripresa in senso mistico da Avempace (Ibn Bagiah), filosofo e scienziato arabo-spagnolo, morto nel 1138. Ad Avempace più che il movimento discendente da dio al mondo interessò quello ascendente dell'anima a dio, che egli espose nel
trattato Sul regime del solitario. Le teorie mistiche di Avempace furono sviluppate da Abubacer (Abu Bckr Ibn Tufail), medico-filosofo dei califfi di Granada, morto nel 1185. Il protagonista del
suo romanzo mistico Il vivente, figlio del vigilante è libero da ogni influenza sociale, nasce dalla terra e vive in un'isola deserta.
AVERROE'
Il maggiore filosofo della tradizione musulmana è Averroè (Ibn Rushd), nato a Cordova nel 1126, e morto nel 1198 nel Marocco, dopo aver subito persecuzioni ed esser stato esiliato per il suo
atteggiamento di pensatore libero dalla ortodossia della tradizione religiosa. Dopo avere studiato fin da giovane il diritto e la medicina (scrisse una famosa enciclopedia medica dal titolo Liber
universalis de medicina), egli si dedicò soprattutto alla filosofia aristotelica. l suoi commenti ad Aristotele lo resero famoso in tutta la posteriore filosofia occidentale come il « commentatore » per eccellenza. In questi commenti egli si propose di ritornare al significato vero dell'opera dello
stagirita, che egli riteneva « la più alta perfezione umana », e da cui si erano distaccate le interpretazioni di Al-Farabi e di Avicenna. Pur rimanendo egli pure impregnato di motivi
neoplatonici, la sua fedeltà ad Aristotele lo portò, nel suo commento all'Almagesto, a respingere l'astronomia tolemaica e la teoria degli epicicli e degli eccentrici. All'opera di Al-Ghazali, La distrazione dei filosofi, ed a coloro che, in nome della pura fedeltà al
Corano, si opponevano alle pretese della filosofia, Averroè oppose l'opera La distruzione della distruzione dei filosofi, ove cercò di dimostrare che rivelazione e filosofia, muovendosi in piani
diversi, non possono contraddirsi. La filosofia ha però un compito più elevato, quasi di religione, per gli uomini intellettualmente più preparati. Dio non è arbitrio assoluto, come afferma il misticismo di Al-Ghazali, ma principio di razionalità.
Opponendosi ad Avicenna, che concepiva il mondo come una serie di essenze, emananti una dall'altra, Averroè riteneva che le sostanze individuali siano la realtà, e che l'essenza non abbia una
realtà distaccata dall'individuo. Gli individui reali, ordinati da un identico fine, sarebbero composti di materia e forma, potenza ed atto. La forma pertanto non sarà, come per Avicenna, derivata da una forma esterna, separata, l'intelletto agente o dator formarum; non occorre in realtà introdurre nulla
di esterno nella materia, ma solo farla passare dalla potenza all'atto. Ciò presuppone che la causa di questo sia già in atto, fino ad arrivare alla causa prima, atto puro. Il mondo è per Averroè eterno
perché il principio del suo movimento, dio, è eterno ; ma il movimento non giunge al mondo sublunare direttamente dal motore immobile. Questo infatti muoverà il cielo delle stelle fisse, ed il movimento si propagherà via via per i vari cieli intermedi.
Anche la conoscenza non è che un passaggio dalla potenza all'atto, dalle immagini dei sensi ai concetti. Ma l'intelletto materiale non può giungere ai concetti se non è illuminato dall'intelletto
agente, il quale fa sì che « i concetti intelligibili in potenza passino in atto ». L'« intelletto materiale » illuminato dall'« intelletto agente » viene da Averroè chiamato « intelletto acquisito ». Per Averroè l'intelletto agente è sostanza separata unica per tutti gli uomini. Anche l'intelletto materiale
non è individuale ma unico, e si diversifica nei vari individui solo perché sono particolari le immagini che riceve dai sensi. In questa dottrina è evidente la negazione dell'immortalità
individuale, per affermare l'immortalità e la stabilità dell'inte lletto e della scienza. La filosofia di Averroè è per alcuni punti, quali ad esempio l'eternità del mondo e la negazione dell'immortalità dell'individuo, assai lontana dalla predicazione coranica. Come giungere ad una

conciliazione? Averroè afferma che la predicazione del Corano ha una validità letterale per gli
incolti, mentre la filosofia studia il senso nascosto di tale rivelazione. La ricerca filosofica deve rimanere strettamente riservata allo scienziato, in modo da non portare confusione ed eresie fra il
popolo, ma deve avere uno sviluppo pieno e libero, rinunciando ad ogni compromesso con la religione popolare. « Secondo i filosofi le religioni sono necessarie perché guidano verso la saggezza in una direzione
comune a tutti gli esseri umani; laddove la filosofia dirige alla conoscenza della felicità solo un certo numero di persone intelligenti, che devono apprendere la saggezza, le religioni mirano
all'istruzione delle masse in genere... Perciò fa parte integrante dell'eccellenza del sapiente il non disprezzare le dottrine religiose in cui è cresciuto, spiegarle nelle più lontane contrade, comprendere che queste dottrine valgono soprattutto per i loro aspetti universali, non per i particolari, e che, se
esprime un dubbio circa i principi religiosi in cui è cresciuto, o li spiega in contrasto con i profeti, scostandosi dal loro cammino, il sapiente merita più d'ogni altro di vedersi applicare la qualifica di
miscredente, ed è degno di pena per mancanza di fede nella religione in cui è cresciuto. » Gli averroisti latini parleranno a questo proposito di « doppia verità », e manterranno un ossequio del tutto esteriore ai dogmi della religione, accanto alla costruzione di teorie filosofiche e
scientifiche ormai del tutto razionalistiche.
GLI ARABI E LA SCIENZA Gli arabi cominciarono nei secoli VIII-X a compiere una serie di traduzioni dei capolavori della
scienza greca, che furono alla base della loro cultura scientifica. Una particolare attenzione essi portarono alla medicina che fu coltivata quasi da tutti i filosofi di cui si è parlato. Famoso medico fu
soprattutto Al-Rhazes (865-925), di origine persiana come molti degli scienziati e dei filosofi dell'Islam. Oltre alla gigantesca enciclopedia medica, tradotta in latino nel XIII secolo col titolo cli Continens, è celebre il suo trattato sulla rosolia e sul vaiolo.
Merito degli scienziati arabi è pure la radicale trasformazione dell'alchimia, che si proponeva di
preparare un elisir di lunga vita e di mutare i più vili metalli in oro. Ancora profondamente influenzata dalle scienze occulte alessandrine è la prima opera araba di alchimia, tradotta in latino col titolo di Turba pbilosophorum (un dialogo i cui personaggi sono tutti filosofi presocratici), e
composta verso la fine del IX secolo. A questo stesso periodo risalgono anche le opere di Geber (Gabir Ibn Hayyan), che per la teoria dei rapporti numerici - ogni corpo sarebbe l'espressione di un
rapporto numerico di equilibrio delle « nature » che entrano nella sua composizione - è stato considerato un autentico precursore della chimica moderna. Geber si occupò tra l'altro dei metodi di raffinamento dei metalli, di preparazione dell'acciaio, di colorazione della seta, ed attribuì
particolare importanza allo zolfo e al mercurio, che rappresenterebbero il fuoco e la liquidità. Ad un altro famoso alchimista arabo del XII secolo, Al-Khazini, spetta invece il merito di avere descritto
una mirabile bilancia di precisione, mediante la quale egli determinò, con buona approssimazione, il peso specifico di una cinquantina di sostanze. Agli alchimisti arabi noi dobbiamo pure le indicazioni per la preparazione di alcuni importanti acidi, come l'acido solforico e l'acido nitrico, e
la costruzione di alcuni essenziali strumenti di laboratorio (storte, alambicchi, ecc.). Questi pochi cenni possono bastare a dimostrarci come l'interesse degli arabi per le ricerche
alchimistiche si inquadrasse direttamente nel loro interesse generale per tutto quanto riguardava la pratica; vedremo fra breve che un impegno pratico è riscontrabile perfino nelle loro indagini matematiche. Proprio esso sta alla base dei notevoli progressi che la civiltà araba realizzò in
pressoché ogni campo della tecnica, e che si sforzò di introdurre sistematicamente nei paesi via via conquistati (è noto il grande incremento dell'irrigazione che i conquistatori arabi portarono in
Spagna). Oltreché nella medicina, nell'alchimia e nella tecnologia, gli scienziati dell'Islam seppero

conquistarsi un posto eminente anche nella fisica vera e propria.
Il maggior fisico musulmano fu Alhazen (Ibn Al-Hasan), vissuto in Egitto fra la fine del X secolo e
l'inizio dell'XI. Egli fu autore di un celebre trattato di ottica, ben presto tradotto in latino con il titolo Opticae thesaurus, nel quale si trova per la prima volta descritta con esattezza la struttura dell'organo della vista con le sue parti fondamentali (umor acqueo, cristallino, cornea, retina).
Alhazen dimostrò, fra l'altro, che i raggi visivi non partono dall'occhio per giungere all'oggetto luminoso, ma da quest'ultimo per giungere all'occhio. Se possiamo asserire che l'ottica geometrica
fu creata dai greci, dobbiamo riconoscere che l'ottica fisiologica risale invece agli arabi e in particolare ad Alhazen. L'Opticae thesaurus sarà largamente utilizzato in occidente da Vitellione e da Ruggero Bacone, e sarà ancora attentamente studiato nel Cinquecento dal grande keplero.
Un altro campo nel quale gli scienziati arabi si conquistarono altissimi meriti fu quello delle
discipline matematico-astronomiche, ove seppero attingere preziosi insegnamenti tanto dal grande patrimonio accumulato dagli studiosi greci quanto dalle nuove idee provenienti dall'India. Anche se non raggiunsero quasi mai una produzione ad alto livello veramente originale, il solo fatto di avere
assimilato e trasmesso due tradizioni scientifiche come quella greca e quella indiana, trovando spesso il modo di integrarle l'una con l'altra, costituisce un titolo di benemerenza che la storia della
civiltà deve loro indiscutibilmente riconoscere. In arabo furono tradotte tutte le principali opere della matematica greca, ed anzi alcune di esse - come il commento di Pappo al libro X degli Elementi di Euclide ed alcune opere di Apollonio – si
sono conservate solo nella versione araba. Per quanto riguarda i rapporti con la matematica indiana, basti ricordare che spetta agli arabi il merito di aver trasmesso alla civiltà occidentale l'uso della
scrittura posizionale dei numeri in base dieci, ricavata appunto dalla scienza indiana, scrittura di cui gli arabi seppero immediatamente comprendere la grande utilità applicandola con successo anche ai calcoli necessari per la tenuta dei registri commerciali.
Il califfo Al-Mamun, fondò nell'828 l'osservatorio astronomico di Bagdad. A questo califfo furono legate in particolare la persona e l'attività del grande matematico persiano Mohamed Ben-Musa Al-
Khowarizmi, fiorito fra l'813 e l'833, generalmente riconosciuto come l'iniziatore della matematica araba. Ed infatti è proprio per incarico di Al-Mamun, che Ben-Musa scrisse i suoi tre più importanti trattati: una raccolta di tavole astronomiche, un trattato di aritmetica e uno di algebra.
Il primo va soprattutto menzionato perché l'autore vi fa uso, nella risoluzione dei triangoli, delle funzioni seno, coseno e tangente di un arco, invece di prendere in esame (come facevano gli
astronomi greci) la sola corda dell'arco. Il secondo è importante perché spiega le operazioni aritmetiche elementari e le loro proprietà, facendo riferimento alla rappresentazione decimale dei numeri; i problemi trattati hanno per lo più un carattere pratico (sono problemi della vita comune, di
tecnica commerciale, ecc.), ma proprio questo fatto sta alla base della rapida diffusione - anche in ambito non strettamente scientifico - del nuovo sistema di scritturazione numerica. Il terzo affronta i
problemi caratteristici di quella parte della matematica che noi chiamiamo « algebra » elementare, la quale attinse il proprio nome per l'appunto dal titolo dell'opera di Ben-Musa: Al gebr al mukabala. Va sottolineato che dal nostro autore deriva pure il termine « algoritmo » (di uso comune
nell'algebra moderna), la cui radice è legata al nome Al-Khowarizmi con cui i latini useranno indicare Ben-Musa (in realtà proprio con questo nome iniziava il titolo del suo trattato di
aritmetica). Sappiamo che parecchi problemi algebrici erano già stati trattati dai matematici greci, ma la loro esposizione era svolta in termini sostanzialmente geometrici. Il nuovo modo di esporli e discuterli, usato dagli arabi, apre la via a una trattazione autonoma di essi, molto più generale e
senza dubbio più agevole (perché basata su procedure regolate da leggi ben determinate): è la via che porterà all'algebra propriamente detta.
Non ci sembra necessario soffermarci sui particolari progressi tecnici dei continuatori dell'algebra di Ben-Musa; aggiungeremo invece qualche parola sulle concezioni astronomiche degli arabi, più

direttamente collegate allo sviluppo generale del pensiero scientifico-filosofico.
Va detto innanzitutto che a base dell'astronomia (come pure della geografia) dell'Islam dobbiamo
collocare la traduzione di Tolomeo, a cui gli scienziati arabi aggiunsero nuovi calcoli ed osservazioni, che poterono compiere anche con gli importanti strumenti scientifici, come l 'astrolabio, da essi inventati o perfezionati.
Il maggiore astronomo del mondo arabo fu Albatenio (Al-Battani), vissuto in Mesopotamia all'inizio del X secolo. Pur professandosi discepolo di Tolomeo, egli fu studioso spesso originale,
attento osservatore dei fenomeni celesti, fornito di notevole senso critico, e proprio perciò disposto - ove necessario - a correggere e aggiornare l'astronomia tolemaica. Nella trattazione matematica dell'astronomia preferì - distaccandosi dai greci — far uso, come già Ben-Musa, delle funzioni
trigonometriche anziché della misurazione delle corde, e in tal modo diede un contributo decisivo alla diffusione della trigonometria nel senso moderno del termine. In base a precise osservazioni
degli astri e delle loro orbite, compose nuove carte astronomiche e calcolò nuovamente la precessione degli equinozi. Le sue ricerche furono proseguite da Abril Wafa, vissuto nella seconda metà del X secolo, autore di un proprio Almagesto, profondo cultore di trigonometria sferica
oltreché di quella piana.
Nel secolo seguente, in Egitto l'astronomo Ibn Yunus registrò le osservazioni delle eclissi lunari e solari, e in Persia l'astronomo, filosofo, matematico e poeta Omar Khayyam operò un'importante riforma del calendario introducendo gli anni bisestili.
Più geografo che astronomo fu invece Al-Biruni (973-1048), uno dei più grandi eruditi dell'Islam,
che calcolò con molta esattezza la latitudine e la longitudine di varie località, e ci lasciò una preziosa descrizione di alcune parti dell'India. Nel campo degli studi di trigonometria va ricordato che Al-Biruni scrisse inizialmente un trattato basato unicamente sulla nozione di « corda » (usata,
come sappiamo, dai greci). In opere successive mise a punto il rapporto fra tale nozione e quella di seno, illustrando criticamente i vantaggi di quest'ultima, come pure delle altre funzioni ad essa
collegate (coseno, tangente, ecc.) nello sviluppo delle indagini trigonometriche. Al-Biruni fu inoltre valente studioso di algebra, nella quale affrontò alcuni problemi di terzo grado. Ebbe diversi discepoli che proseguirono e perfezionarono la sua opera.
Va infine ricordato il forte interesse degli arabi per la storia della scienza, in particolare per la storia
della matematica e più ancora per quella della medicina. Già alla fine del X secolo un libraio di Bagdad, Ibn An-Nadim, in un famoso elenco di tutti gli autori a lui noti e dei loro scritti, aveva dato numerose notizie storiche per ogni materia; verso la metà del secolo seguente Said Ben-Ahmad, un
erudito di Toledo, scriverà una vera e propria storia della scienza, dando un interessantissimo quadro complessivo dell'attività scientifica, a lui nota, di indiani, persiani, caldei, greci, egiziani e
arabi. Il dibattito filosofico moderno nel mondo arabo
Attualmente, data la situazione sociale, le guerre e la presenza di governi oppressivi in buona parte dell’Oriente, gli uomini di cultura arabi sono sempre più rari rispetto al remoto passato, ma molti di
essi, dal Marocco alla Siria, hanno riflettuto sulla crisi storica della società, di pensiero e forse anche di identità che imperversa nel mondo arabo-islamico in senso lato. Ognuno ha cercato di analizzarla da una prospettiva diversa che va a completare sempre più un quadro analitico e
sociologico. Si passa infatti dalla volontà di comprendere il funzionamento della ragione araba e di determinare le condizioni del suo rinnovamento di Mohammed ʽAbd al-Jabri (1936-2010),
all’approccio ipertestuale di Abdallah Laroui, nel voler paragonare l’Islam con vari punti nodali quali lo stato, la libertà e il concetto di modernità. In contrapposizione al primo autore si posiziona George Tarabishi, intellettuale siriano, che ha addirittura parlato di “opportunismo epistemologico”

di al-Jabri. Secolarismo è la sua parola chiave, sostenendo che l’Islam è soltanto una religione e che
le pratiche sociali sono sempre state secolari. Teso a sostenere e a difendere il modernismo e l’illuminismo islamico, è poi Mohammed Arkoun (1928-2010), che tra Algeri e la Sorbona, ha
riflettuto su come si possa ripensare l’Islam nel mondo contemporaneo, sempre in modo equilibrato. La maggior parte degli intellettuali arabi sembra comunque concordare su una serie di punti principali. Innanzitutto essi ritengono che dopo la caduta dell’Unione Sovietica, il terzo
mondo è man mano sprofondato in un baratro senza equilibrio sia da un punto di vista militare che politico. In secondo luogo, l’ordine politico nei paesi arabi ha raggiunto un livello di squilibrio e il
margine di povertà si è allargato sempre più. Inoltre, l’avanzare della globalizzazione come fenomeno inevitabile, ha permesso alle correnti islamiste di guadagnare sempre più terreno, unendo però anche culturalmente il mondo arabo. Queste considerazioni comuni fanno però solo da sfondo
ad un panorama assai variegato, che i vari intellettuali hanno dipinto con i loro studi e le loro idee innovative e di analisi critica.
Proprio questo pensiero rivoluzionario porta spesso gli attuali uomini di cultura arabi a essere fortemente disprezzati dai conservatori, come nel caso di Hassan Hanafi, che ha creato un’idea di “sinistra islamica”, ma è stato accusato di eresia ed apostasia, e verso il quale è stata addirittura
emanata una fatwa che lo condanna come tale.