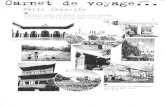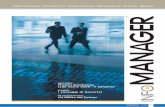UNO VALE CENTO · 2019. 12. 19. · migliorare le proprie condizioni di vita; è con quell’1% che...
Transcript of UNO VALE CENTO · 2019. 12. 19. · migliorare le proprie condizioni di vita; è con quell’1% che...

La Fiom esiste da quasi 120 anni gra-zie alle lavoratrici e ai lavoratori chesi organizzano in essa per rappresen-tare i propri interessi e condividerecomuni valori. È una partecipazione
preziosa e sempre più rara nel mondo d’oggi.Una partecipazione di idee, energie, risorse.La Fiom vive di questo, non solo idealmentema anche materialmente, perché è attraversoquell’1% del salario versato al sindacato che imetalmeccanici difendono e cercano dimigliorare le proprie condizioni di vita; è conquell’1% che noi possiamo tutelarli, perchérappresenta l’unica nostra fonte di finanzia-mento, la fonte della nostra libertà eindipendenza dalle aziende, dalle istituzioni,dalla politica.
Ma il tesseramento non è solo un essenzialecontributo economico, è molto di più. Perchéapre le porte alla partecipazione alla vita delsindacato, la possibilità di essere parte di unacomunità e di costruirne l’identità, definen-done le scelte, decidendo insieme quel che ènecessario e giusto fare. Perché la nostranatura sta nell’origine stessa della parola “sin-dacato” che letteralmente significa “insiemecon giustizia”.Per continuare ad agire insieme c’è bisognodel contributo attivo delle lavoratrici e deilavoratori, umano e materiale: questo c’è “den-tro” ciascuna tessera della Fiom, soprattutto inanni come quelli che stiamo vivendo, in cuirischiamo tutti di essere divisi e soli; e quindiimpotenti, in balia delle decisioni che altriprendono per noi, nelle imprese e nella
società. Perché nessuno da solo ce la può fare.Per questo iscriversi e fare iscrivere alla Fiom ipropri compagni di lavoro non è una noiosaincombenza di inizio anno, è un investimentosul proprio futuro.Fate uno sforzo di fantasia, pensate a comesarebbe il mondo senza il vostro sindacato:niente diritti e contratto nazionale, nessunapossibilità di contrattare salario e condizionein azienda, nessun delegato cui rivolgersi,totale insicurezza nelle fabbriche e negli uffici.Ognuno da solo davanti all’impresa e almondo. Che vita sarebbe? Non è immagina-bile. Perché da quasi 120 anni imetalmeccanici e la Fiom camminano insiemevivendo del reciproco contributo. E così saràanche in futuro.Buon anno a tutte e a tutti.
www.�om-cgil.itwwwwwwwww.www.�www.�owww.�omwww.�om-www.�om-cwww.�om-cgwww.�om-cgiwww.�om-cgilwww.�om-cgil.www.�om-cgil.iwww.�om-cgil.it
16 dicembre 2019
Mensile della Fiom-Cgil - anno VIII - numero 7Iscritto al n. 118/2019 del Registro della StampaDirettore responsabile: Gabriele PoloRedazione: Bernardino Andriani | Michela Bevere | Alessandro Geri | Claudio ScarcelliMeta Edizioni Srl | Corso Trieste, 36 - 00198 Roma | Telefono: 0685262372 | email: [email protected] | www.fiom-cgil.it
Francesca Re David
UNO VALE CENTO

2
La mia testimonianza è doppia, da immi-grato e da operaio. Sono nato nel 1946 esono arrivato a Torino nel 1962, avevo 15anni ed ero un bambino, in verità con lamemoria di allora ero un bambino strap-
pato alle sue origini e spostato in una grande realtàcome Torino.Di Torino io non sapevo assolutamente niente, qual-che nozione scolastica superficiale: città del Nord efredda – arrivando da Napoli il freddo era una carat-teristica importante – ed era la città dell’automobile– a Napoli qualche Fiat circolava. In realtà le cono-scenze di Torino da parte degli immigrati eranoscarsissime, tanto è vero che c’è una bellissimainchiesta di Goffredo Fofi – sociologo romantico, edeffettivamente l’aggettivo ci sta a pennello – realiz-zata nei primi anni Sessanta, che descriveesattamente cos’è che avviene in quegli anniquando 10 milioni di italiani cambiano residenza ecambiano residenza in una situazione difficilissima.Non va dimenticato che era ancora in vigore unalegge fascista del 1930 – o giù di lì – contro l’urba-nizzazione, che considerava gli immigrati comeclandestini: mio zio che è emigrato nel 1968, anchelui è stato membro di Commissione interna e poidelegato della Fiom in una fabbrica metalmecca-nica di Torino, e mio fratello, perito meccanico chenon trovava lavoro a Napoli, emigrati a Torino sonostati per due o tre anni clandestini. È vero che i foglidi via erano pochissimi, ma a Porta Nuova che era“l’ombrello dei poveri”, il riparo degli immigrati aTorino, la polizia tutte le sere andava a controllare idocumenti, tanto è vero che per rimanere all’in-terno della Stazione – racconta Fofi – bisognavaavere almeno un biglietto per un viaggio in treno.
Questa legge prevedeva che uno poteva trovarelavoro se era residente.La città non era accogliente, forse Milano si può rac-contare diversamente, ma la città di Torino non eraassolutamente accogliente. Io ricordo benissimo icartelli «vietato l’ingresso ai meridionali e - apertaparentesi - ai cani».Non era casuale. Torino aveva paura di una concor-renza a basso costo e vedeva messe in discussioneesattamente conquiste o ipotetiche conquiste ouno status che i torinesi avevano in qualche modoconquistato e idealizzato.L’altro cartello che ricordo è «non si affitta ai meri-dionali». La prima sistemazione che noi abbiamotrovato è stata a ridosso di un corso con una piazza,Piazza Crispi, Corso Vigevano n.4, romanticopalazzo a ringhiera di 3 piani, ma di romantico nonaveva assolutamente niente; noi – io, mio fratelloe mia sorella – eravamo al terzo piano, quattrofamiglie con un solo servizio chiuso tra assi dilegno, questo accadeva nella città dell’automobile,Torino. Torino nel 1955 aveva 750.000 abitanti, nel1965, quindi non molto tempo dopo, superò ilmilione di abitanti, quindi una città che venivasconvolta alla radice.Sono entrato in Fiat nel 1966 dopo aver avuto l’eso-nero da militare.Tutti parlavano della Fiat, in verità la Fiat ha sempreavuto un grande fascino. Avevo un’esperienza poli-tica perché arrivavo dalla Fgci, venivo da unafamiglia di comunisti, mio padre è stato consigliereprovinciale a Napoli eletto nel 1948 con la “testa diGaribaldi” – il Fronte democratico popolare – e fecidomanda alla Fiat, ma non ci speravo moltissimo,invece la Fiat mi assunse, mi fece le visite mediche
con il sistema della Malf – di molto migliore del-l’Inam – e venni assunto, avevo 20 anni.Bisogna ricordare che ai miei tempi – se mi si passail termine – si diventava “adulti” a 21 anni, quindiquando entrai in Fiat non ero ancora adulto, ma eroabile per lavorare.Mi destinarono alla SPA, che produceva veicoliindustriali, camion, e che aveva due stabilimenti,uno al centro dove ci passai i primi due giorni cheservivano per farci capire come funzionava l’orga-nizzazione del lavoro.In verità non rimasi sconvolto dalla Spa Centro per-ché mi sembrava a dimensione umana – misembrava. Dopo 2 giorni ci caricarono – in 20-25operai – su un camion: erano i camion che la Fiatutilizzava per far entrare i crumiri quando c'eranogli scioperi dell’Atm a Torino – la Fiat per i suoi ope-rai ci pensava da sola. Mi spostai quindi nelcomprensorio di Stura.Quando entrai alla porta 4 di Stura gli spazi mi fecerogirare la testa: c’era una dimensione dell’organizza-zione fordista/taylorista che faceva girareassolutamente la testa, non ero abituato, cioè erafuori dalla mia concezione proprio quel modo divedere come era organizzata la produzione, tuttogirava in aria e tutto poi però si faceva sotto, cioè c’eraun sotto che poi passava in aria per poi arrivare allaproduzione finale, e noi eravamo dei piccoli uomini.Il rapporto con il sindacato non c’era. Io ho sempreinvidiato i compagni e gli amici milanesi, ma Torinonon presentava questa realtà, non tanto nel gruppodirigente, ma all’interno della fabbrica, l’unico rap-porto che noi avevamo con la Commissione internaerano le relazioni radio ogni 15 giorni, un quartod’ora per organizzazione sindacale, dove un “eroico”compagno, amico della Fim, della Fiom, della Uilmo del Sida, lontanissimo, attraverso un microfono edegli altoparlanti comunicava le direttive, le elabo-razioni delle organizzazioni sindacali.La reazione, non mia, ma dei miei compagni di lavoronei refettori –perché la comunicazione avveniva sol-tanto durante la pausa mensa – era un casinoinfernale proprio a sancire il distacco tra operai eCommissione interna.Anche qui ci sarebbe molto da discutere, ma arri-viamo al ‘69, e non ci si arriva in verità a cavallo, senzacontraddizioni, ci si arriva man mano.Il primo marzo – lo devo ricordare perché il primomarzo ci fu lo sciopero generale della Cgil su una
DA IMMIGRATOE DA OPERAIOSilvio Canapè
Autunno caldo 1969/2019

3
proposta del governo di riforma della previdenza –io feci sciopero, ero iscritto alla Fiom “con delega”,quindi la direzione sapeva che io ero iscritto allaFiom, cosa inusitata, nel veicolo industriale, in cuitra i quasi 16.000 addetti la Fiom aveva 22 iscritticompresi i 4 membri di Commissione interna. Era-vamo pochi, non c’era una grandesindacalizzazione. Lo sciopero nel sistema indu-striale di Torino riuscì, al veicolo industriale no,fummo in 6 a fare sciopero: i 4 membri della Com-missione interna, io e Carlo Astegiani.Rientrati in fabbrica, io e Carlo Astegiani fummo licen-ziati immediatamente. Arrivarono i “guardioni” nellamia postazione molto isolata nell’officina, mi preleva-rono e mi diedero la lettera: «lei è licenziato». Me ladiedero i guardiani la lettera, non la gerarchia azien-dale, non il capo del personale, ma i “guardioni”,questo per sottolineare anche quale fosse il clima direpressione che esisteva all’interno di quel sistemafordista/taylorista con cui la “caserma Fiat” era orga-nizzata. La Fiat era organizzata come una casermaperché l’unico obiettivo era la produzione, comun-que si facesse e la produzione si faceva soltanto sec’era una disciplina repressiva, altrimenti quella orga-nizzazione del lavoro non sarebbe stataassolutamente accettabile.Passò una settimana e io naturalmente mi diedi dafare perché dovevo lavorare, non potevo vivere direndita. Feci insieme a Carlo – l’altro licenziato – ilrappresentante per le pasticche Leone, famose aTorino, ma non ne ricavammo un granché, franca-mente in due riuscimmo a mettere in piedi circa30.000 lire in un mese, non era un grande stipendio.Tramite un compagno – lo voglio ricordare –Renato Lattes, che era il responsabile per la Fiomnella terza Lega in Barriera di Milano, venni chia-mato perché c'erano le elezioni di Commissioneinterna del 1968, le ultime.Mi chiamò Sergio Musso, che era responsabile per laFiom e mi disse: «Ci dai una mano? Devi occuparti didue realtà: la Aeritalia e la Ferriera di Avigliano, sono20 anni che non ci siamo»; «Io non so niente di sin-dacato e dai a me questa responsabilità dirappresentare la Fiom?» risposi, «qui si impara a nuo-tare se l’acqua è alta, altrimenti si va da un’altra parte»fu la sua chiusura.Per capire il contesto sindacale dell'epoca bisognatener conto che il gruppo dirigente di Torino era
ancorato alla storia della sconfitta del 1955, elezionidi Commissione interna dove la Fiom perse il pri-mato all’interno della Fiat e c’era un gruppo dirigenteche – stalinista o meno – era un gruppo dirigenteche in qualche modo essendo assoluta minoranzadoveva difendersi, ma doveva difendersi proprio coni denti, perché altrimenti si perdeva il rapporto conuna realtà che stava cambiando radicalmente.Ho ricordato come cambia Torino in quegli anni mala Fiat nel 1953 produceva – siamo nella ricostru-zione – all'incirca 100.000 autovetture, nel 1973 neprodurrà 1.475.000, è sconvolgente, ma è sconvol-gente proprio la dimensione, i numeri. Noiavevamo la Lingotto con 12.000 addetti, Rivalta con16.000 addetti nata nel 1966, Mirafiori che aveva64.000 addetti; nell’arco di 10 km c’era una concen-trazione per la costruzione di automobili di 100.000persone e oltre perché a questi bisognava aggiun-gere anche l’indotto.Partirono dunque gli scioperi articolati e partirononel 1968 in contemporanea con le elezioni di Com-missione interna, ma in contemporanea anche conaltri fatti – Avola e Battipaglia – che non bisognadimenticare e insieme all'emersione della que-stione delle gabbie salariali che non riguardavanosoltanto i braccianti – le gabbie esistevano ancheall’interno della Fiat, nel mondo industriale.Le lotte partirono perché c’era un cambiamentoradicale della composizione della forza lavoro all’in-terno della Fiat; il 70% degli operai in Fiat eranooperai di terzo livello dequalificati, cioè c'era stato ilpassaggio da un’idea di produzione con l’operaioqualificato a un’idea di organizzazione del lavoroche richiedeva soltanto il lavoro dequalificato deglioperai con condizioni di lavoro pessime. Avevamocadenze di lavoro sulla linea di montaggio siaall’Iveco che a Mirafiori al di sotto dei 30 secondi, 3
minuti con il sostituto per bisogni fisiologici e sepassavano i 3 minuti venivano a chiamarti, e tuttociò faceva ribellare, perché c’era una condizione dilavoro effettivamente insopportabile.Noi arrivammo, quindi, ad avere i primi accordi conla contrattazione articolata e l’inizio del supera-mento delle Commissioni interne e nel 1968 aMirafiori nacquero i primi esperti sui tempi di lavorosulle linee di montaggio.Arrivammo al contratto nazionale con una Fiat sot-toposta a un’articolazione della lotta molto, mamolto diffusa; va ricordata l’Officina 32, le Ausiliariee senza nessuna piattaforma sindacale – la piatta-forma arriverà dopo – ci fu la questione delsuperamento del “capolavoro” per passare di cate-goria e si fece, appunto, una lotta che aveva questivalori e si arrivò all’accordo, così come con l’altra ver-tenza Mirafiori che ci portò, che ci accompagnò alcontratto nazionale di lavoro – anche noi torinesiabbiamo avuto un ruolo nella piattaforma rivendi-cativa del contratto nazionale di lavoro – quella sullelinee di montaggio dove i delegati cominciarono afunzionare e cominciarono a gestire il tabellone chestabiliva il rapporto: tante persone presenti –15% diassenteismo in quelle realtà produttive – tanta pro-duzione ti do. Prima non funzionava così, laproduzione era slegata dal numero degli operaipresenti. Cambiò quindi questo rapporto e questofu il primo elemento di potere per incidere sull’or-ganizzazione del lavoro all’interno di una fabbricacomplessa come Mirafiori.Per quanto riguarda la Piattaforma del Contrattonazionale, noi a Mirafiori e in tutta la Fiat distri-buimmo un volantino con due facciate: «cosavorresti e cosa non vorresti». «Aumento salariale: –non ci fu nessuno che sbagliò la risposta –aumentouguale per tutti», al di là di quello che pensava ilcompagno Bruno Trentin. Su questo punto ci fuuna risposta di massa diffusissima. Nessuno si sba-gliò: aumento uguale per tutti perché la parolad’ordine era verissima: «tutti abbiamo una boccasotto il naso».
*Intervento tenuto al Convegno “Roma 28novembre 1969. I metalmeccanici per tutti”organizzato dalla Fiom lo scorso 28 novem-bre 2019

4
Autunno caldo 1969/2019
Esporrò qui il pensiero elaboratoinsieme a Giordana Masotto e MichelaSpera. Il contratto del 1969 che si cele-bra oggi con le sue grandi conquiste èl’epilogo di un decennio di lotte iniziate
nel 1960 con lo sciopero degli elettromeccanici,concentrati soprattutto a Milano e nella sua pro-vincia. È stato uno sciopero importante, gestitocon grande sapienza dalla Fiom e anche dalla Fim(segretari Sacchi e Volontè). Sono venute fuori allora tre figure che domine-ranno l’intero decennio e oltre: i giovani operaipiù scolarizzati dei precedenti, le operaie e glistudenti, ragazze comprese.Questa lotta io ho avuto la fortuna di viverladall’interno. Ero infatti a Milano segretaria delCircolo A. Banfi, composto per lo più da studenticomunisti. Abbiamo iniziato subito a unirci aipicchetti operai davanti alle fabbriche, natural-
mente a quelle dove era necessario il picchetto,e volantinato all’università per dare notizie sullosciopero.La prima sorpresa è stata che l’Unione Goliardica(UGI) cioè la più forte organizzazione studentescadell’Università Statale di Milano, aderì allo scio-pero e al picchettaggio e poi iniziò anche unaraccolta di fondi per sostenere gli scioperanti.Il giorno dopo, il quotidiano l’Unità diretto daAldo Tortorella e che aveva ben due giornalistiimpegnati nella cronaca dello sciopero, intitolòin prima pagina “Operai e studenti picchettanole fabbriche”.La seconda sorpresa è stata che le operaie eranoben presenti e determinate nella lotta. Ricordoquelle ore e quegli incontri davanti alla FaceStandard e alla Sit Siemens di Milano: tra gli stu-denti la metà erano ragazze.E arrivo al punto che più mi interessa: il con-tratto degli elettromeccanici si chiuse con unaconquista che credo molte sindacaliste conside-
rano fondamentale per attenuare la sofferenzaspecifica delle donne nel lavoro: la contratta-zione di secondo livello.Infatti la contrattazione di secondo livello (inte-grativa come si diceva una volta) ha un valorequasi insostituibile. Tale valore le viene dallaconformità al linguaggio. Parlare – tra operai/ee delegati/e – è una forma di contrattazione, lapiù elementare. Voglio dire che la lingua non èuna comunicazione individuale, ma nasce dalloscambio fra parlanti e non diventa mai dominioesclusivo di qualcuno, ma resta sempre – perrestare viva – comune.La contrattazione di secondo livello, quindi, èuna pratica (tra l’altro molto simile a quella cheil movimento delle donne si è data, quella dellarelazione) che nei rapporti di valore può farvalere il di più che le donne sono, pensano evogliono. Senza la contrattazione articolata sirischia di sottrarre competenza pratica e simbo-lica a quelle donne e uomini che per vivere
Lia Cigarini*
LE DONNE, RISORSA E SFIDADEL LAVORO

5
devono mettersi sul mercato del lavoro.Nella organizzazione e nella rappresentanzainvece, la presenza femminile tende a diventarequestione di posti e quote. Nell'informatica siparla di interfaccia tra uomo e macchina. Ecco:la contrattazione realizza l’interfaccia tra econo-mico e simbolico, fra soldi e parole. Le due cosesi toccano senza confondersi.Michela Spera mi precisa che quella importanteconquista deve intrecciarsi con la necessità deicontratti collettivi. Sono d’accordo, ma ci tengoa precisare che sono due livelli distinti.Sempre per stare nella storia, sottolineo che laFiom, sindacato a grande maggioranzamaschile, è stato tra quelli dove le iscritte sonoriuscite a diventare protagoniste; e forse quelloche ha dato più spazio (in particolare sulla rivista“Inchiesta” e in importanti convegni) al pensieroe alla pratica del femminismo della differenza.Ma se vogliamo celebrare degnamente il con-tratto del 1969 dobbiamo parlare del qui e ora.La maggioranza delle donne è nel mercato dellavoro. La loro presenza è considerata un fattostabile e una realtà ovvia. Ciò è avvenuto per tanti fattori oggettivi, masoprattutto negli ultimi cinquant’anni moltis-sime donne hanno preso coscienza che l’esseredonna non è un’aggiunta o un complementodell’uomo ma apre possibilità originali alla rea-lizzazione di sé e del mondo.Dopo cinquant’anni di femminismo la diffusionedella parola delle donne è in crescita esponen-ziale. Riporto quanto scritto da GiordanaMasotto presentando il libro di Loriana Luccia-rini Doppio carico - storie di operaie: «Narrativa e politica si intrecciano e si rafforzanoper sgretolare mondi a sesso unico. L’ondata delMe-too ha chiuso con la posizione della vittimae il carnefice è rimasto solo.Prendere la parola ti trasforma in soggetto dellascena pubblica. Parla, così ti vediamo scrive Chri-sta Wolf. “Avere il diritto di farsi vedere e di parlareè il fondamento della sopravvivenza, della dignitàe della liberta”; dice la femminista americanaRebecca Solnit – che a me piace molto. Sul valore politico della parola delle donne, Gene-viève Fraisse in Il mondo è sessuato, dice che conla parola delle donne c’è sempre il rischio che siapresa per privata. Invece “l’essenziale è identifi-care ciò che è politico in questa parola”.»Questa è la scommessa che abbiamo di fronte:capire il senso politico della parola delle donne.Oggi ci sono due soggetti differenti nel lavoro enel sindacato. Invece il Novecento ha appiattitole donne sul lavoratore maschio. Evitando diaffrontare una questione: la divisione sessualedel lavoro. Dopo mezzo secolo di incremento della parteci-pazione femminile al lavoro retribuito, il temapiù generale della divisione sessuale del lavorocontinua a riproporsi come campo di confrontoaperto tra uomini e donne fino a rimettere inquestione alla radice la separazione simbolica,istituzionale e normativa tra lavoro produttivo eriproduttivo, tra lavoro per il mercato e lavorodomestico di cura. Noi abbiamo detto che biso-gnava ridiscutere questa separazione. Ci siamo riuscite.
Diciamo che è ora di riconoscere nessi, interdi-pendenze e ordine di priorità tra queste diversecomponenti del lavoro umano. Non vogliamopiù sentire parlare di lavoro, tempi e organizza-zione del lavoro, welfare e crescita, e nemmenodi lotte dei lavoratori, senza riconoscere che illavoro di riproduzione e manutenzione dell’esi-stenza umana è componente strutturale di tuttoil lavoro necessario per vivere.Oppure vogliamo lasciare che tutto ciò sia colo-nizzato dal neo-liberismo onnivoro? Che l’abbiavinta il bio-capitalismo nel suo intento di mettereal lavoro e trarre profitto dalle vite intere? No, sesi ha a disposizione una pratica e una teoria chepermette di contrattaccare. Qui mi riferiscoanche al Sottosopra “Immagina che il lavoro”pubblicato dal gruppo lavoro della Libreria.Cito a questo proposito il sociologo franceseAlain Touraine nel libro “Il mondo è delle donne“(2006) che dice: «le donne come attrici collettivecreano la posta in gioco e il campo culturale delconflitto con gli altri attori sociali ... in altreparole costruiscono se stesse riparando ciò cheè stato smembrato dalla globalizzazione, dal-l’esposizione alla deriva delle forze di mercato».Si tratta dunque di riconoscere che non è piùpossibile pensare di modificare i rapporti di pro-duzione – e i rapporti sociali che ne derivano –senza pensarli insieme a quelli di riproduzione.Una tra le conseguenze del grande incrementodell’occupazione femminile ha attirato l’atten-zione delle sindacaliste, delle studiose e deglistudiosi più attenti, vale a dire che soggettivitàe relazioni, passione e affettività, sforzo per
tenere insieme vita e lavoro, sono diventaterisorse fondamentali nel mondo del lavoro oggi.Il sindacato non può ignorarlo. È una risorsa peril sindacato. Come osserva acutamente Pamela,una delle metalmeccaniche che parlano nel librodi Loriana Lucciarini: «il mio punto di vista èdiventato una risorsa». Alla presa di coscienzadelle donne nel lavoro si è risposto, da partedella sinistra, enfatizzando solo la condizionesvantaggiata delle donne e fissando l’obiettivodella parità con gli uomini. Da qui una visioneimpoverita del movimento delle donne.Concludo con una domanda politica. Nel conte-sto del fordismo, nel glorioso trentennio di lottae di elaborazione, le donne erano poche e, perquanto attiene ai loro interessi pratici e simbo-lici, quasi mute. Ma oggi le donne voglionoesserci nel lavoro tutte intere e questo significaun intreccio inedito tra vita e lavoro, un intreccioche riguarda tutti, uomini e donne. Ci si vuolemisurare con questa differenza, che è la pre-senza femminile, che vuole dire anchecontrattare in modo diverso? E in epoca di neo-liberismo, in un contesto radicalmentecambiato, accettate la novità e cioè che le donnepossano portare nella lotta sindacale un nuovoprotagonismo più radicato nelle vite materiali ditutti, uomini e donne?
*Intervento tenuto al Convegno “Roma 28novembre 1969. I metalmeccanici per tutti”organizzato dalla Fiom lo scorso 28 novem-bre 2019

6
La “Cooperazione ingegneri e tecnici”nasce il 25 giugno da un accordo traBruno Manganaro, segretario generaledella Fiom di Genova, e Hartwig Erb,segretario generale dell’Ig Metall di Wol-
fsburg. «Di fronte ai rapidi cambiamenti cheattraversano l’industria metalmeccanica e ai relativiprocessi di trasformazione che dobbiamo affrontare– scrivono i due segretari generali – per l’Ig Metall diWolfsburg e la Fiom-Cgil di Genova è imprescindibileapprofondire e rafforzare i contatti europei e farincontrare, in un primo momento, i rappresentantidelle lavoratrici e dei lavoratori delle imprese metal-meccaniche ad alta presenza di ingegneri e tecnici diWolfsburg e Genova per sviluppare delle strategiecongiunte».La “Cooperazione” ha suscitato da subito grandeinteresse da parte dei Consigli di Fabbrica genovesi.Lo dimostrano le molte lettere arrivate all’Ufficiointernazionale della Fiom in questi mesi, provenientida aziende che, nell’insieme, rappresentano oltre lametà degli impiegati, tecnici e ingegneri metalmec-canici genovesi.La Rsu Fiom di Leonardo scrive che «il ristretto qua-dro nazionale è sempre meno in grado di risponderealle necessità di difesa di cui oggi la nostra classe habisogno, perché ormai il mercato della forza lavoroè diventato europeo. Il sindacato deve trarne le con-seguenze e lavorare sempre più nella direzione delsindacato europeo, anche guardando alle espe-rienze più avanzate, come quella tedesca». Per la Rsudi Abb, «risulta evidente come, per organizzare unadifesa efficace, serva un sindacato europeo più fortee con un radicamento effettivo nei luoghi di lavoro,anche e soprattutto tra quegli ingegneri e tecniciche, tra i lavoratori di Abb, sono ormai la maggio-ranza». Dalla Hitachi Rail Sts scrivono che «da tempola ristrutturazione dell’industria europea pone i lavo-ratori, nelle diverse imprese, nei diversi paesi europei,di fronte agli stessi problemi. La Fiom di Genova nonè rimasta attardata di fronte a questi mutamenti e hainvestito per tempo nella sindacalizzazione dei tec-nici e dei colletti bianchi dell’industriametalmeccanica. Lo stesso ha fatto l’Ig Metall, ancheprecorrendo i tempi. È tempo che queste due espe-rienze si incontrino e si confrontino sui problemi cheabbiamo davanti». Per i lavoratori «i confini nazionali di fatto non esi-stono più da tempo», scrive la Rsu di Ifm Infomaster.La Rsu Softeco aggiunge che «una collaborazionetra due sindacati europei è il primo passo per
migliorare la conoscenza di questo allargato mer-cato del lavoro e per preparare impiegati e operaialle sfide che dovranno affrontare, in qualità di lavo-ratori europei, nel prossimo futuro». La Rsu AbbMolo Giano «aderisce alla Cooperazione ingegnerie tecnici, auspicando lo sviluppo di tutte le attivitàdi collaborazione internazionale con Ig Metall». Sitratta, per la Rsu Siemens Industry Software, di«costituire una rete di collegamento sindacale inEuropa, (...) superando le vecchie logiche nazionalie localistiche».I due sindacati hanno aperto quindi un confrontosulle trasformazioni delle rispettive industrie. All’An-saldo Energia, «dal vecchio rapporto di 2 operai perogni impiegato, nei decenni si è passati al rapportoinverso di 2 impiegati per ogni operaio, tendenzacomune a molte altre realtà genovesi, italiane edeuropee». Alla Fincantieri Sestri Ponente – scrive laRsu – «a fianco ai lavoratori delle ditte di appalto(circa 2.000), la forza lavoro Fincantieri è formata dacirca 400 impiegati e 300 operai. Solo 10 anni faerano 300 impiegati e 500 operai. Di fronte a questatrasformazione il sindacato deve intervenire su tuttele stratificazioni salariate, dall’ingegnere all’operaioimmigrato».Osservano alla Nidec-Asi che «la forza lavoro conmassiccia presenza di tecnici e ingegneri non haprecluso il fatto che i lavoratori seguano attiva-mente la Rsu e il Sindacato, dando la possibilità aidelegati di portare nei direttivi e nelle sedi dellaFiom le testimonianze dei problemi e delle difficoltàche anche i cosiddetti “colletti bianchi” si trovanoad affrontare nei posti di lavoro». Per la Rsu Tenova,«una collaborazione tra due sindacati europei è ilprimo passo per migliorare la conoscenza di questoallargato mercato del lavoro e per preparare impie-gati e operai alle sfide che dovranno affrontare, inqualità di lavoratori europei, nel prossimo futuro».Il 19 novembre, presso la Camera del Lavoro diGenova, la “Cooperazione Ingegneri e Tecnici” traFiom di Genova e Ig Metall di Wolfsburg si è riunitae ha tenuto la prima sessione con i delegati deiConsigli di Fabbrica.Alla mattina, Flavio Benites, dell’ufficio internazio-nale IG Metall di Wolfsburg, e Karl Musiol, segretariopolitico Ig Metall di Ingolstadt, hanno risposto alledomande dei Consigli di Fabbrica genovesi, in unalunga sessione. I delegati hanno potuto approfon-dire nel dettaglio le caratteristiche del lavorosindacale di IG Metall tra le stratificazioni tecnico-impiegatizie dell’industria tedesca, discutere delle
grandi trasformazioni industriali in corso e confron-tare le rispettive analisi.Successivamente la Fiom ha presentato agli ospititedeschi una relazione sulla storia del sindacatogenovese e ha approfondito la conoscenza del sin-dacato tedesco. Fiom e Ig Metall concordano sullagrande utilità di questi scambi diretti tra i sindaca-listi europei e sulla necessità di allargare lo sguardoalla dimensione europea della ristrutturazioneindustriale, dalla transizione energetica dell’auto aimutamenti di Industria 4.0, per non arrivare impre-parati quando si presentano le grandi crisi aziendalio settoriali e tentare di impostare una difesacomune.La “Cooperazione Ingegneri e Tecnici” tra Fiom diGenova e Ig Metall di Wolfsburg esprime piena soli-darietà con i lavoratori dell’ex Ilva che, in questomomento, sono impegnati in una difficile battagliadi difesa. Da anni a Genova i lavoratori delle grandifabbriche, impiegati e operai, scendono in scioperoe manifestano assieme quando necessario, perdifendere il lavoro all’Ilva, alla Fincantieri, alla Leo-nardo, all’Ansaldo, alla Culmv e negli altri luoghi dilavoro cittadini. Ma occorre alzare lo sguardo e lavo-rare per l’unità dei metalmeccanici a livelloeuropeo, nel sindacato europeo. Su questi temi, la “Cooperazione” ha tenuto il suoprimo seminario con i delegati e i lavoratori geno-vesi, presso la sala del Comune di Sestri Ponente.La seconda sessione è stata fissata, nella primametà del 2020, a Wolfsburg.
Genova
FIOM E IG METALL AD ALTA COOPERAZIONE
Fiom Genova

7
Secondo i dati di Veneto lavoro, l’entedella Regione del Veneto che sioccupa del mercato del lavoro regio-nale, e in particolare leggendo il reportdel secondo trimestre 2019 sulle crisi
aziendali, il quadro che viene mostrato è quellodi una regione in ottima forma con una sensibileriduzione delle aziende in crisi, tanto da fareaffermare all’assessora al lavoro Elena Donazzanche in Veneto la lunga stagione della crisi è supe-rata, visto che l’ occupazione è tornata a sfiorare ilivelli del 2008. Secondo i dati elaborati da VenetoLavoro, l’apertura di procedure di crisi aziendalinel periodo che va da gennaio a giugno 2019,rispetto allo stesso periodo del 2018, si sonoridotte del 5% e sempre secondo i dati regionaliil tasso di occupazione è aumentato rispetto aidue anni precedenti, attestandosi al 66,4% diqualche decimale inferiore a quello del 2008.Eppure questi dati cozzano clamorosamentecon una realtà che oggi racconta la sfiducia deilavoratori e delle imprese verso l’immediatofuturo, le forti riduzioni degli ordinativi e gliannunci di chiusura di importanti siti industriali.Infatti, fermo restando che i daticitati arrivano fino a giugnoscorso, che possono essere con-dizionati da una sorta dirimbalzo positivo (già oggiesaurito) del 2018 e che ten-gono conto di tutti i settori, nonsolo del comparto metalmecca-nico, oggi tutta la filieradell’automotive è in sofferenza.L’intero settore siderurgico e lacomponentistica vedono fortiriduzioni degli ordinativi, maanche la produzione di elettro-domestici e delcondizionamento, quali la exRiello Bruciatori, oggi UTC americana, stannovivendo una condizione di sofferenza e ridu-zione dei preventivi di vendita, se non dichiusura imminente come nel caso Wanbao ACCdi Belluno. Qui ai 293 lavoratori che vi operano,la multinazionale cinese ha annunciato l’immi-nente chiusura. Una vicenda a cui leorganizzazioni sindacali si stanno opponendocon determinazione per non permettere che siripeta lo stesso destino dei lavoratori della Haierdi Campodoro, chiusa nel 2015.Le fonderie padovane e la siderurgia veronese(NLMK in CDS) fanno già ricorso alla cassa integra-zione ordinaria, così come alle Acciaierie Venete,mentre la Valbruna fa i conti con una riduzionedegli ordinativi di oltre il 20% rispetto alle aspet-tative. Stessa dinamica e preoccupazione per lacomponentistica vicentina, padovana, trevigianae veronese, in particolare quella collegata all’auto(ad esempio la Fiamm FCA di Almisano a Vicenza,la ex Fiamm di Veronella che produce batterie perauto e la Toffac di Padova).La frenata del settore dell’auto, che aveva avutoun ruolo importantissimo per la ripresa metal-meccanica veneta, si sta velocemente
diffondendo, situazione che si somma e si ali-menta anche dell’incertezza della transizioneecologica e dell’assenza di una visione strategicadelle imprese. Non si può non riflettere sullostato dell’imprenditoria veneta che, a eccezionedi pochissime realtà, risulta completamenteimpermeabile al cambiamento, come testimo-niano inequivocabilmente la carenza diinvestimenti realizzati dalle imprese metalmec-caniche venete negli ultimi 10 anni. Gli scarsi investimenti fatti, non hanno per la
maggior parte interessatol’evoluzione del prodotto, l’at-tenzione per l’ambiente, laricerca o l’innovazione, mainvece si sono focalizzati quasiesclusivamente sull’ottimizza-zione dei processi produttivi esul contenimento dei costi,percorrendo la via della com-petizione con la rincorsaall’immediato profitto.«Oggi l’impressione diffusaanche in Veneto è veramentequella del rischio che “vengagiù tutto” e che il 2020 possadiventare un ennesimo annushorribilis per i lavoratori. Sotto-
lineo per i lavoratori, perché in realtà di questo sitratta, negli anni gli effetti della crisi sono statiscaricati tutti sui lavoratori.» Ha dichiarato Anto-nio Silvestri, segretario generale della Fiom delVeneto.Un’importante ricerca commissionata dalla Fiomdel Veneto alla Fondazione Sabattini e curata daMatteo Gaddi, dimostra che negli anni della crisi,dal 2009 a oggi le imprese metalmeccanichecon più di 50 dipendenti hanno realizzato utiliimportantissimi. Fatto 100 i valori assoluti degliutili del 2009, nel 2018 gli stessi si attestano a3.799, il valore aggiunto a 164 mentre i salarirestano sostanzialmente fermi.Altri indicatori che fotografano la realtà venetaal di fuori della retorica del Veneto “ricco efelice” dipinto dal leghismo governante e non,sono i 755.000 cittadini veneti (di cui moltimetalmeccanici) a rischio povertà, i 240.000 chenon hanno accesso alla sanità, il 37% dellenuove assunzioni a part time involontario, senzatralasciare che il Veneto è la seconda regione delnord con la più ampia migrazione di giovani elaureati verso altre regioni italiane o l’estero.Dalla crisi non si è imparato nulla: scarsi investi-
menti, bassi salari, competizione sui costi, pocaattenzione all’innovazione e alla sostenibilitàambientale stanno compromettendo la timidaripresa che si intravedeva nell’ultimo triennio,mentre aumentano le diseguaglianze, con con-seguente inasprimento dei rapporti sociali.In controtendenza vanno invece i settori dell’ae-reospazio e della cantieristica. Qui Leonardo eFincantieri macinano utili e prevedono com-messe, come nel caso della Fincantieri,decennali. E non è un caso che siano entrambigruppi partecipati da una importante quota diCdp. Qui le considerazioni possono essere moltea partire dall’importanza del ruolo pubblico ineconomia e dei guasti enormi comportati dalleprivatizzazioni degli anni Novanta e Duemila,ma è necessario ricordare che i modelli organiz-zativi adottati da queste due aziende presentinel Veneto sono molto diverse. Questo certa-mente derivato dalla differenza del prodottorealizzato, ma anche sicuramente derivante dauna visione del lavoro radicalmente diversa.Quello della Fincantieri (azienda il cui utile nettonegli ultimi 10 anni è aumentato del 162%) sicu-ramente più aderente al modello dellosfruttamento intensivo caratteristico del Veneto.Infatti il modello del cantiere di Marghera si basain particolare sul decentramento produttivo esull’appalto, elementi questi abusati al fine dellariduzione del costo del lavoro e come dimo-strato dalle recenti indagini della Magistraturaveneziana, sistema altamente permeabile allosfruttamento, alla coercizione, fino alla presenzadella criminalità organizzata. Sistema in cui ilavoratori degli appalti sono le prime vittime,vessati da condizioni salariali, di diritto e dilavoro inumane e, in quanto sfruttati e a bassocosto, usati anche come dumping nei confrontidei lavoratori diretti della Fincantieri che hannovisto peggiorare anche le loro condizioni.In questo scenario difficile e complicato in cui ladimensione della crisi non è ancora del tuttoconosciuta, si colloca il rinnovo del Ccnl deimetalmeccanici. Anche per questo la piatta-forma presentata a Federmeccanica, deverappresentare un elemento di politica econo-mica che parla e rivendica quel che è veramentenecessario, non solo ai metalmeccanici, peraffrontare la crisi imminente: la riduzione dellediseguaglianze a partire da un salario dignitoso,al contrasto alla precarietà e alla definizione diun tipo di lavoro basato sulla qualità che solo laformazione e l’innovazione possono realizzare.
LA LOCOMOTIVAIN PANNE
Veneto
Sara Quartarella
Oggil’impressione
diffusa anche inVeneto è
veramente quelladel rischio che
“venga giù tutto”