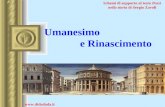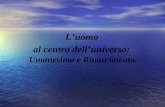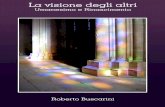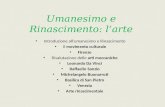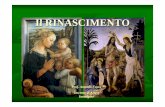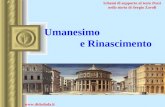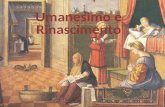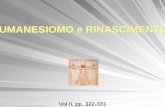Umanesimo e Rinascimento.
-
Upload
laurapiras -
Category
Documents
-
view
21 -
download
2
description
Transcript of Umanesimo e Rinascimento.

Laura Piras e Alessio Pulisci IV°F
Umanesimo e Rinascimento.
Coordinate storiche:
Vi sono alcuni eventi che nel Quattrocento e nel Cinquecento segnarono il trapasso dall'età medioevale a
quella moderna:
la fioritura delle monarchie europee;
le scoperte geografiche;
le invenzioni della stampa e della polvere da sparo;
la riforma protestante.
Tramontano le figure universalistiche di impero e papato nuovo mosaico geo-politico
rappresentato da :
regni nazionali in Europa;
stati regionali in Italia;
monarchie centralizzate e burocratizzate in paesi come Francia e Spagna (che nel Cinquecento
divenute grandi potenze daranno inizio ad un duello epocale che insanguinerà l'Europa sino alla pace di
Cateau-Cambrésis nel 1559).
Si afferma un'economia “aperta” in contrapposizione all'economia “chiusa” del Medioevo.
Situazione in Italia.
Le signorie si tramutano in principati regionali lotte interne che impediscono il
processo di unificazione frammentazione politica.
Pace di Lodi (1454) periodo di relativa stabilità.
Scontri tra i maggiori stati: Milano, Venezia, Firenze, Stato della Chiesa, Regno di Napoli.
Debolezza politica facile preda di mire espansionistiche teatro di invasioni ed
egemonia straniera per un lungo periodo sotto dominazione spagnola.
Nel Quattrocento Genova, Venezia, Firenze si affermano come grandi poli di egemonia
commerciale e finanziaria nel Cinquecento l'egemonia commerciale si sposta dal Mediterraneo
all'Atlantico l'Italia rimane ai margini dei traffici internazionali.
Umanesimo e Rinascimento.

Laura Piras e Alessio Pulisci IV°F
L'istruzione e la cultura
Medioevo scuola monopolio della chiesa.
Umanesimo scuola in mano ai laici, ovvero la borghesia cittadina :
lontana dalla mentalità plutocratica (denaro unico valore dell'esistenza);
apprezza l'arte, la storia, il bel parlare e l'eloquenza nello scrivere.
Umanista:
in un primo momento ricchi mercanti, finanzieri, giuristi (classe dirigente);
in un secondo momento uomini di varia estrazione sociale al servizio di un signore (in
questo periodo i signori cercavano di circondarsi di prestigio grazie a letterati, artisti, filosofi, scienziati).
In Italia diventano centri intellettuali:
la Firenze dei Medici;
la Napoli degli Aragonesi;
la Roma dei papi;
la Urbino dei Montefeltro;
la Ferrara degli Este;
la Mantova dei Gonzaga;
la Rimini dei Malatesta.
Nascono accademie e scuole private di arti liberali:
Guarino Veronese (1374-1460) pedagogia dell'umanesimo;
Accademia fiorentina (diretta da Marsilio Ficino, 1433-1499) tendenza platonica;
Accademia romana (diretta da Giulio Pomponio Leto, 1428-1498) carattere archeologico;
Accademia napoletana (diretta da Giovanni Pontano, 1429-1503) tendenza letteraria.
Nel Cinquecento nuove accademie letterarie e filosofiche Padova e Firenze, Cosenza.
Nel Seicento prime accademie scientifiche.
Accademie: centri di elaborazione dell'alta cultura (non istituti educativi e non università).
Umanesimo e Rinascimento.

Laura Piras e Alessio Pulisci IV°F
Rifiuto del volgare uso del latino classico e non medioevale.
Diffusione del sapere riferita ad una cerchia più ampia di individui grazie anche
all'invenzione della stampa.
Il rinascimento come “ritorno al principio”
Concetto di “Rinascimento”: origine religiosa, indica una rinascita (seconda nascita) dell'uomo
nuovo o spirituale ne parla il Vangelo di san Giovanni e le Lettere di san Paolo, più avanti
assunse un significato più vasto come rinnovamento globale dell'uomo nei suoi rapporti con se stesso, gli
altri, il mondo e Dio.
Ritorno al principio:
come concetto religioso nel neoplatonismo antico identificato con Dio ed il ritorno
a Dio con il compimento del vero destino dell'uomo poiché gli esseri umani si erano allontanati da Dio e
devono ritornare a lui lo ritroviamo nei neoplatonici ed in Lutero si identifica con il
ritorno alla cristianità primitiva;
come concetto storico assume un significato umano e storico il “principio”a cui si
deve tornare è una specifica situazione del passato della civiltà ritorno ai classici ritorno
alle comunità antiche (come intese Macchiavelli);
come ritorno alla natura vista come forza che produce e vivifica le cose nel
Rinascimento è rappresentata la sua forma autentica al di là delle immagini astratte e convenzionali
dell'arte medioevale ciò assunse significato centrale nei filosofi naturalisti del Cinquecento
Telesio, Bruno, Campanella;
comunque inteso il “principio” è quella realtà rapportandosi alla quale l'uomo autentifica se
stesso garantisce la riforma ottimale dell'uomo e del suo mondo.
Concetti di Umanesimo e Rinascimento.
Per lungo tempo i termini “Umanesimo” e “Rinascimento” sono stati usati come sinonimi per
indicare il movimento culturale che caratterizzò l'Europa durante il Cinquecento, ma:
nell'Ottocento Georg Voigt e Jacob Burckhardt li distinsero Umanesimo visto come
momento filologico-letterario Rinascimento visto come un momento filosofico-scientifico;
nel Novecento Konrad Burdach riavvicina i due termini considerando l'Umanesimo come
la prima parte del Rinascimento.
Umanesimo e Rinascimento.

Laura Piras e Alessio Pulisci IV°F
La filosofia dell'Umanesimo
Nel XX secolo:
Paul Oskar Kristeller gli umanisti non sono filosofi ma filologi poiché trascurarono il
pensiero speculativo saltando le complesse elaborazioni dottrinali del medioevo solo
l'aristotelismo del rinascimento espresse le idee filosofiche dell'epoca;
Eugenio Garin disaccordo con Kristeller gli umanisti hanno concretamente
filosofato sui vari problemi antropologici la stessa filologia umanistica porta già in se una nuova
filosofia poiché comporta un nuovo modo di rapportarsi al mondo antico e di concepire l'uomo;
Nell'umanesimo letterario è implicito un umanesimo filosofico esempio di vita negli studi classici
(latini e greci) indispensabili per educare l'uomo gli antichi hanno incarnato i massimi
valori dell'esistenza.
Ritorno al mondo classico indispensabile per dare le basi al mondo moderno bisognava
riprendere il lavoro degli antichi per riportare l'uomo alla sua vera natura.
Dottrine filosofiche del Rinascimento studi sull'uomo, sulla storia, sulla natura.
L'uomo del Rinascimento
“homo faber ipsius fortunae” (l'uomo è fabbro della propria sorte) nucleo dell'antropologia
rinascimentale: la dignità dell'uomo nei confronti degli altri esseri risiede nel forgiare se medesimo e il
proprio destino nel mondo.
Orazione “De homnis dignitate” (sulla dignità dell'uomo) Giovanni Pico della Mirandola
l'uomo è“libero e sovrano artefice di se stesso”, con la possibilità di progettare se stesso.
L'uomo del Rinascimento ritiene di dover costruire e conquistare da sé il proprio posto nel
mondo.
Nella scolastica (XI secolo) l'uomo aveva rivendicato un'autonomia sempre più maggiore della
ragione nei confronti delle maggiori istituzioni:
Chiesa;
impero.
Filosofia moderna: “l'uomo è soggetto del proprio destino” significato antireligioso.
Umanesimo e Rinascimento.

Laura Piras e Alessio Pulisci IV°F
Rinascimento: “l'uomo soggetto del proprio destino mondano coesiste con l'uomo-plasmatore come
immagine del Dio-creatore”.
Ciò non esclude che:
lo spirito del Rinascimento sia prevalentemente antropocentrico
mentre nel Medioevo Dio era al centro e l'uomo in periferia, nel Rinascimento l'uomo era al
centro mentre Dio in periferia.
Libertà umana Rinascimento l'uomo forgia se stesso ma è comunque
condizionato da una serie di forze reali, casuali e soprannaturali ma ciò non annulla la libertà
la circoscrive.
Uomo sintesi vivente del tutto creatura in cui vi sono tutte le caratteristiche degli enti
del mondo.
Rifiuto dell'ascetismo medievale e della vita vista come un'attesa dell'aldilà nuova ottica
antropocentrica esaltazione della vita terrena:
“Quant'è bella giovinezza,
che si fugge tuttavia!
Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c'è certezza. (Trionfo di Bacco e Arianna, Lorenzo De Medici)
Eudaimonìa realizzazione di tutte le possibilità umane felicità.
Denaro indispensabile.
Umanesimo e Rinascimento.