Trasmissioni via Etere
-
Upload
alessandro -
Category
Documents
-
view
24 -
download
1
description
Transcript of Trasmissioni via Etere
-
LE TRASMISSIONI VIA ETERE
B.Bortelli
Indice
0.1 Trasmissione via etere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.1.1 Le onde elettromagnetiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.1.2 Le onde radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.1.3 Modalita` di propagazione delle onde radio . . . . . . . . . . 70.1.4 Le antenne - Caratteristiche generali . . . . . . . . . . . . . 70.1.5 Il dipolo hertziano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.1.6 Il dipolo marconiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110.1.7 Le antenne Yagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.1.8 Le antenne paraboliche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1
-
INDICE 2
0.1 Trasmissione via etere
Nelle trasmissioni via etere il vettore e` unonda elettromagnetica nel campo del-le onde radio o delle microonde. Nelle trasmissioni via etere esiste e deve essere
Figura 1: Schema a blocchi della trasmissione via etere
risolto sia il problema della natura, che della frequenza, quindi nel trasmettitoreritroviamo sia il generatore di portante che il dispositivo di uscita, composto daun amplificatore di potenza e da unantenna, con funzione di attuatore.Lantenna trasmittente, dal punto di vista elettrico, e` equivalente ad un risuona-tore elettrico, cioe` ad un circuito risonante. Essa genera unonda elettromagneticacon la stessa frequenza con cui e` fatta risuonare. La forma e la lunghezza del-lantenna, quindi, sono dimensionate in modo che la stessa entri in risonanza incorrispondenza del valore di frequenza dellonda elettromagnetica che si desideragenerare.Londa elettromagnetica, trasmettendosi nelletere perde via via di intensita`, giun-gendo nei pressi del ricevitore con una intensita` di campo molto bassa, ma, se lapotenza del trasmettitore e` adeguata e la distanza non eccessiva, ancora misura-bile.Lantenna ricevente, simile per forma allantenna trasmittente ed anchessa equiva-lente ad un risonatore elettrico, quando viene investita dal campo elettromagneticosu cui e` sintonizzata, entra in risonanza e produce in uscita un segnale elettricocon frequenza pari alla frequenza del campo. Tale segnale viene amplificato edemodulato.
0.1.1 Le onde elettromagnetiche
Le onde elettromagnetiche , dette anche radiazioni elettromagnetiche, sono co-stituite da quanti di energia elettromagnetica raggiante. Un singolo quanto, chia-
-
INDICE 3
mato anche fotone, e` formato da un campo elettrico e da un campo magneticooscillanti alla medesima frequenza, perpendicolari tra loro, perpendicolari alla di-rezione di propagazione dell onda e che si irradiano nello spazio ad una velocita`pari alla velocita` della luce nel vuoto, o di poco inferiore, se lo spazio stesso non e`vuoto.
Figura 2: Onda Elettromagnetica
Si chiama lunghezza donda ,, della radiazione elettromagnetica, lo spaziopercorso dall onda nel periodo di ripetizione dei campi elettico e magnetico. Ilprodotto della lunghezza donda per la frequenza di oscillazione dei campi elettricoe magnetico, fornisce la velocita` di propagazione effettiva:
v = fA parita` di velocita`, lunghezza donda e frequenza sono inversamente proporzio-nali, ovvero quando luna e` grande, laltra e` piccola e allaumentare delluna, lal-tra diminuisce. Il quanto di energia trasportato dallonda e`, pero`, direttamenteproporzionale alla frequenza:
E = h fQuindi le radiazioni piu` energetiche sono quelle con frequenza piu` grande, ovverocon lunghezza donda piu` piccola. Esse, in relazione alla materia attraversata,sono piu` penetranti ed interagiscono con una superficie minore, la cui dimensionee` dello stesso ordine di grandezza della lunghezza donda.Invece, la densita` di potenza, S irradiata in un dato punto dello spazio, cioe`lenergia elettromagnatica trasportata attraverso una superficie unitaria, in untempo unitario, dai campi elettrico, E, e magnetico, H, e` legata ai valori delcampo stesso, essendo:
S = Eeff Heff = E H2
-
INDICE 4
Rapportando, poi, i valori di E e di H, si ricava, facendo ad esempio lanalisidimensionale, che tale rapporto ha le dimensioni di una resistenza, la quale vienechiamata: resitenza delletere ed ha il valore tipico di 377.Tutta la gamma delle onde elettromagnetiche e` stata suddivisa in fasce con carat-teristiche peculiari ordinate per valori di lunghezza donda e di frequenza.
Figura 3: Suddivisione delle OEM per fasce di lunghezza donda
ONDE RADIOLa fascia piu` bassa, meno energetica, e` la fascia delle onde radio: comprendele onde elettromagnetiche con lunghezza donda superiore a 1metro, ovverocon frequenza fino a 300MHz.
MICROONDELa fascia successiva e` quella delle microonde: comprende le onde elettro-magnetiche con lunghezza donda da 1m a 1mm, ovvero con frequenza finoa 300GHZ. Sono utilizzate soprattutto nelle trasmissioni via satellite, maanche nei ponti radio.
INFRAROSSOCon lunghezze donda inferiori al millimetro si entra nell infrarosso , ilquale occupa tutto lintervallo da 1mm a 1m, proseguendo oltre fino a
-
INDICE 5
circa 0, 7m, al limite della zona della luce visibile. La radiazione di questafascia e` essenzialmente energia termica, data dal calore emesso dai corpi perirraggiamento.
LUCE VISIBILELa stretta fascia con lunghezze donda che vanno da circa 0, 7m a circa0, 4m corrisponde alla luce visibile.
ULTRAVIOLETTOSegue la fascia dellultravioletto, il quale comprende tutte le lunghezze don-da inferiori a 0, 4m, fino allordine di grandezza del nanometro. I raggiultravioletti, pericolosi per la vita, sono schermati dalla fascia dellozono; indosi elevatete causano ustioni e tumori.
RAGGI XLa fascia successiva, quella dei raggi X, e` caratterizzata da lunghezze dondaprossime alle dimensioni degli atomi, espresse in una unita` chiamata Ang-strom (1 angstrom = 1010m). I raggi X sono molto pericolosi in quantointeragiscono direttamente con gli atomi e le molecole, spezzando i lega-mi chimici e ionizzando gli atomi. Trovando molteplici applicazioni, dallaspettroscopia, alla medicina.
RAGGI A lunghezze donda ancora minori, confrontabili con le dimensioni dei nucleidegli atomi, si entra nella fascia della radiazione nucleare, ovvero dei raggi . Lunita` di misura di riferimento dei nuclei e` chiamato Fermi (1 Fermi =1015m). I raggi sono prodotti dal decadimento delle sostanze radioattivee dalle reazioni nucleari. Essi sono estremamente pericolosi per la salute.
Esistono radiazioni con energia superiore a quella dei raggi ? La risposta e`affermativa. La terra, si sa, e` soggetta ad un flusso continuo di materia e dienergia proveniente dal cosmo. La parte di radiazione cosmica che rientra nelleonde elettromagnetiche puo` effettivamente avere energia ancora piu` grande deiraggi e, quindi, lunghezze donda minori. In realta` non vi e` un limite massimoalla energia della radiazione elettromagnetica.
0.1.2 Le onde radio
Le onde radio, corrispondenti alla fascia piu` bassa delle onde elettromagnetiche, invirtu` della loro lunghezza donda rilevante vengono generate ed intercettate facil-mente con i circuiti radioelettronici. Come vedremo, infatti, le antenne necessarieper generare o per captare le onde radio devono avere dimensioni dello stesso ordi-ne di grandezza della loro lunghezza donda e, quindi, le loro dimensioni tendono
-
INDICE 6
a diminuire fortemente allaumentare della frequenza.Esse sono ulteriormente suddivise nelle seguenti fasce:
LF: low frequencyLe onde radio con lunghezze donda maggiori, con frequenze da 30kHz finoa 300kHz, sono chiamate LF, od anche onde lunghe, per la loro lunghez-za donda particolarmente elevata. Per produrre o captare le onde lungheservono antenne particolarmente lunghe.
MF: medium frequencyDa 300kHz fino a 3MHz si hanno invece le onde medie, MF. Allinternodelle onde medie ce` la gamma di frequenze che in Italia e` utilizzata perle trasmissioni radio AM, in modulazione di ampiezza, la quale va da circa520kHz a circa 1620kHz. Per le OM si usano tipicamente antenne costituiteda un filo conduttore avvolto a spirale, con diametro della spirale di qualchedecina di centimetri, di solito collegato ad un avvolgimento su nucleo diferrite. HF: high frequencyDa 3MHz fino a 30MHz si hanno le onde corte, HF. Sono utilizzate nellecomunicazioni amatoriali ed in ponti radio a frequenze radio. LeHF vengonodi solito captate con unantenna a stilo.
VHF: very high frequencyDa 30MHz a 300MHz si ha la fascia delle VHF, allinterno della quale ce`la gamma delle trasmissioni radio FM, in modulazione di frequenza (da 88 a108MHz) ed i canali utilizzati nelle trasmissioni televisive VHF, dal canaleA al canale H1 . In questa fascia si utilizzano le antenne a stilo, soprattuttonella gamma per le trasmissioni FM , e, per i canali televisivi, le antenneYagi.
MICROONDESopra i 300MHz si entra nel campo delle microonde, diviso in tre gamme:UHF : ultra high frequency, fino a 3GHz, utilizzata per le trasmissioni te-levisive UHF, per le trasmissioni con telefono cellulare, per le trasmissioniwireless, ecc. Per questa gamma vengono utilizzate, per le trasmissioni tele-visive, le antenne Yagi o logperiodiche, mentre per le trasmissioni satellitari,le antenne paraboliche. Infatti alle frequenze di qualche gigaHz, caratteristi-che delle trasmissioni wireless, la lunghezza donda e , quindi, la dimensionedellantenna, e` di una decina di cm, o meno, per cui lelemento captente vie-ne inserito nel fuoco di una parabola, allo scopo di intercettare e concentrareuna maggiore intensita` di campo.SHF super high frequency, fino a 30GHz;EHF : extremly high frequency, fino a 300GHz.
-
INDICE 7
0.1.3 Modalita` di propagazione delle onde radio
Le onde radio si propagano in modo rettilineo,come la luce, e quindi sono in gradodi raggiungere il ricevitore se questo si trova in linea con il trasmettitore, unamodalita` di trasmissione detta modalita` ottica.Le onde radio di frequenza elevata, le onde corte, e le microonde si propaganosolo in modalita` ottica. Pertanto nei ponti radio ad alta frequenza bisogna che lantenna trasmittente e quella ricevente siano in vista l una dell altra.Le onde radio, pero`, in particolare nelle fasce delle onde lunghe e delle onde medie,si possono propagare anche per riflessione tra strati diversi dell atmosfera, adesempio tra la stratosfera e la ionosfera. Infatti essendo la loro lunghezza dondaparticolarmente elevata, esse vedono ciascun strato dellatmosfera come ununicaimmensa struttura, con una netta superficie di separazione, avente un indice diriflessione, leggermente diverso da strato a strato. Tali onde, pertanto, sono ingrado di raggiungere il ricevitore anche se lo stesso non e` in linea con il trasmetti-tore. Questa modalita` di trasmissione puo` essere sfruttata, pero`, solo nei sistemiche utilizzano basse frequenze radio, come le trasmissioni in onde lunghe.Invece, nelle trasmissioni a frequenze elevate, le ripetute riflessioni, su ostacoli fissio mobili, introducendo echi, hanno leffetto di interferire nelle trasmissioni stessee di rendere il canale via etere un canale disturbato.
0.1.4 Le antenne - Caratteristiche generali
Come abbiamo gia` detto lantenna e` un dispositivo capace di emettere oppure cap-tare le onde radio.
Si chama solido di radiazione una figu-ra in tre dimensioni, che indica le mo-dalita` di irragiamento di unantenna.Esso si presenta come una superficesolida, che racchiude lantenna, e neicui punti vi e` la medesima intensita` dicampo.
-
INDICE 8
Al lato pratico, anziche a tutto il solidodi raziazione, si fa riferimento ad unasua sezione, la quale costituisce un piu`agevole diagramma di radiazione in duedimensioni, che di solito viene tracciatopiu` volte a differenti altezze dal suolo.
Si chiama radiatore isotropico unantenna ideale che irradia il campo elettroma-gnetico con la medesima intensita` in tutte le direzioni.
Il radiatore isotropico e` caratterizzatoda un solido di radiazione uniforme, lecui superfici di equintensita` sono dellesuperfici perfettamente sferiche. Que-sta caratteristica e` poco utile, in par-ticolare nei ponti radio, in quanto le-nergia elettromametica dovrebbe essereconvogliata solo verso il ricevitore e nondispersa in tutte le direzioni.
Se indichiamo con Pi la potenza di campo irradiata dallantenna, alla distanza dla potenza irradiata si distribuisce uniformemente su una superficie sferica, da-ta da 4pid2, producendo una densita` di campo, S, data dal rapporto tra potenzairradiata e la superficie stessa:
S =Pi4pid2
Nelle antenne reali, invece, la densita` di campo cambia, a volte anche drastica-mente, in funzione della direzione verso la quale lantenna e` puntata.Tra le antenne reali, si chiama antenna direttiva unantenna capace di concentra-re ed irradiare il campo eletromagnetico in una direzione particolare, denominatadirezione di puntamento.
-
INDICE 9
Lantenna direttiva e` caratterizzata daun solido di radiazione con un lobo ac-centuato nella direzione di irraggiamen-to.La direttivita` permette alle antennereali di irradiare alla medesima distan-za con la medesima intensita` di cam-po, impegnando solo una frazione dellapotenza richiesta ad un radiatore iso-tropico. Si dice anche che lantenna di-rettiva guadagna rispetto ad radiatoreisotropico.
Piu` precisamente, considerati unantenna reale ed un radiatore isotropico, che ir-radiano la stessa potenza Pi, si definisce guadagno dantenna, G, il rapporto trala densita` di potenza S prodotta dallantenna reale nel punto del solido di radia-zione in cui lirragiamento e` massimo, e la densita` di potenza, Siso, prodotta dalradiatore isotropico nello stesso punto:
G =S
SisoG(dB) = 10 log
S
Siso
La conoscenza del guadagno dantenna ci permette di determinare la densita` dipotenza nel punto in cui si trova lantenna ricevente:
S = Siso G = 4pid2 Pi GLe antenne riceventi, per il principio di reversibilita`, hanno le stesse caratteristichedelle antenne trasmittenti, potendo esse stesse essere direttive ed avere un propriosolido di radiazione e un guadagno dantenna. Per esse acquista importanza ancheil concetto di area efficace, definita come la superficie che deve attraversare il campoelettromagnetico incidente, perche` lo stesso venga captato dallantenna.La conoscenza dellarea efficace, Aeff diventa cruciale per determinare la potenzadi segnale, Pr, ricevuta, avendosi:
Pr = S AeffLarea efficace dipende dal quadrato dalla lunghezza donda del campo elettroma-gnetico trasmesso e dal guagagno dantenna, secondo la seguente relazione:
Aeff = Gr 2
4pi
Ne consegue che: allaumentare della frequenza della radiazione elettromagnetica,larea efficace di unantenna diminuisce e quindi diminuisce anche la sua capacita`
-
INDICE 10
captante.Siamo ora in grado di scrivere la formula fondamentale delle trasmissioni via etere.
A tale scopo effettuiamo un ponte radiocon un trasmettitore caratterizzato dauna potenza incidente, Pi, ed unanten-na trasmittente avente guadagno, Gt,ed un ricevitore, posto alla distanza de caratterizzato da unantenna riceven-te con guadagno, Gr ed una potenzaricevuta, Pr.
Per quanto detto, avremo:
PrPi
= Gi Gr 2
(4pid)2
Lespressione e` fondamentale per il dimensionamento del ponte radio, consentendodi dimensionare le antenne ed in particolare lantenna ricevente, in funzione delladensita` di campo presente e delle potenze, quella irradiata dal trasmettitore equella ricevuta.
0.1.5 Il dipolo hertziano
Per ottenere unantenna si parte da uno spezzone di linea elettrica in 4, con uscita
aperta.
Come noto esso opera in regime di on-da stazionaria, presentando in uscita, unventre di tensione ed un nodo di corren-te. Essendo, pero`, la sua lunghezza pa-ri esattamente a mezza lunghezza donda,il suo comportamento in entrata e` diame-tralmente opposto, presentando un nododi tensione ed un ventre di corrente.
Pertanto la corrente assorbita dal generatore e` massima, mentre la tensione e`pressoche nulla, e` quindi il suo comportamento elettrico e` equivalente a quello diun circuito risonante serie, caratterizzato da una frequenza di risonanza data da:
fr =c
La corrente circolante nei conduttori, come sappiamo, genera nello spazio ad es-si circostante un campo magnetico, con intensita` ad essa proporzionale, e, quindi,
-
INDICE 11
massima dal lato dellentrata, mentre il potenziale produce un corrispondente cam-po elettrico.
Allontanando progressivamente i due con-duttori, i campi si disperdono nelleterecon massima intensita` nella direzione per-pendicolare ai conduttori.Se percorsi da corrente, i due condut-tori acquistano la capacita` di ricevere etrasmettere onde elettromagnetiche, nel-le direzioni ad essi perpendicolari, allamedesima frequenza di risonanza.
Continuando ad allontanare i conduttori, fino a di-sporli in direzioni opposte, realizziamo la strutturadi base di unantenna, denominata: dipolo hertzia-no in
2, costituita da due conduttori metallici, (al-
luminio, o acciaio, o rame, ecc), orientati in dire-zioni diametralmente opposte, per una lunghezzacomplessiva pari a
2.
Il dipolo hertziano non e` un radiatore isotropico, dato che il suo solido di radiazio-ne ha un massimo nelle direzioni ad esso perpendicolari, ma disperde comunque ilcampo a 360. Dato che lunghezza donda e frequenza sono inversamente propor-zionali, anche la lunghezza del dipolo hertziano decresce con la frequenza, essendoparticolarmente elevata per le LF e per le MF .
0.1.6 Il dipolo marconiano
Disponendo i due bracci del dipolo hertziano insenso verticale, se si dispone di un buon piano diterra, il conduttore inferiore puo` essere agevolmen-te sostituito dal piano di terra stesso.In questo modo lantenna si riduce ad uno stilo,costituito da un singolo conduttore di lunghezza4, denominato dipolo marconiano in
4.
Sono dipoli marconiani le antenne a stilo, ad esempio quelle montate sulle auto.Esse irradiano con massima densita` di campo nella direzione della linea di terra.
-
INDICE 12
Operano bene nel campo delle HF , ma possono essere utilizzate anche in gammedi frequenza maggiore.
0.1.7 Le antenne Yagi
Per ottenere unantenna direttiva vengono dispo-sti nella direzione di ricezione, degli spezzoni diconduttore, denominati direttori, davanti al dipo-lo hertziano. Essi sono leggermente piu` corti e adistanze pari a circa 0, 2 . Allo stesso modo, die-tro al dipolo viene inserito un ulteriore spezzone diconduttore, leggermente piu` lungo, il quale fungeda riflettore. Ciascun spezzone intercetta una par-te del campo e la riflette verso il dipolo, in modoche il campo totale sul dipolo venga intensificatoattraverso interferenza costruttiva.Sono realizzate in questo modo le antenne Yagi per la ricecione delle trasmissionitelevisive nelle bande V HF ed UHF .Una variante delle antenne Yagi e` costituita dalle antenne logperiodiche, nelle qualii direttori hanno lunghezze decrescenti allaumentare della distanza dal dipolo.Esse son antenne a larga banda, capaci di ricevere lintera gamma UHF , anzicheun singolo canale, in quanto, al variare della frequenza, varia lelemento direttoreche entra in risonanza.
0.1.8 Le antenne paraboliche
Alle frequenze nel campo delle microonde, le lun-ghezze donda sono particolarmente piccole, percui, anche se e` semplice realizzare le antenne, que-ste sono caratterizzate da una superficie di inter-cettazione molto piccola e quindi producono unapotenza molto bassa. Per ovvaire al problema lan-tenna vera e propria, lilluminatore, viene montatasul fuoco di una parabola.
La parabola consente di intercettare il campo che investe la sua superficie e loconcentra, intensificandolo, nel fuoco, dove viene captato dallilluminatore. Perevitare che lilluminatore copra una parte del campo, spesso lo stesso si trova inposizione spostata rispetto al centro ed allora la forma dellantenna e` sagomatasecondo una curva leggermente diversa.













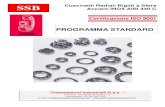




![Monitoraggio trasmissioni PRIM2.ppt [Sola lettura ... · Microsoft PowerPoint - Monitoraggio trasmissioni PRIM2.ppt [Sola lettura] [modalità compatibilità ] Author: U109080 Created](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5fc945bb0955b8159275fce7/monitoraggio-trasmissioni-prim2ppt-sola-lettura-microsoft-powerpoint-monitoraggio.jpg)
