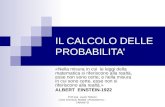Todisco
description
Transcript of Todisco
«Quaestio», 1 (2001), 245-273
Orlando Todisco
Il carattere oggettivo dell’ente scotista nella lettura di Martin Heidegger
Il problema in questione riguarda l’indole dell’ontologia di Scoto nella lettura diHeidegger e il peso teoretico che ha esercitato sul sistema metafisico della mo-dernità. Questo l’interrogativo intorno al quale ruota la presente ricerca: l’ente inquanto ente, univoco, neutrale, privo dei modi intrinseci di finito e infinito, inquale misura ha contribuito alla moderna universale pensabilità dell’essere edunque alla trasformazione dell’essere-manifestabile nell’essere-cogitabile?quale il punto di vista di Heidegger nelle due opere dove più diretto è il riferi-mento a Scoto, e cioè La dottrina delle categorie e del significato in Duns Scoto del’16 e i I problemi fondamentali della fenomenologia del ’27? Qui Heidegger si oc-cupa di Scoto, e il riferimento all’interrogativo d’apertura – presente più nella se-conda opera che nella prima – pare abbastanza esplicito. Infatti, ne I problemifondamentali di fenomenologia1, frutto del corso del semestre estivo del 1927, aproposito del conceptus obiectivus entis si legge che «obiectivum è ciò che vienegettato contro, ciò che nel nostro afferrare e nel nostro prendere ci sta di controqualcosa che può essere preso, o meglio, come l’obiectum com-preso (be-griffen),come quel che nel comprendere è compreso in quanto tale, il contenuto concet-tuale o, come anche si dice, il significato»2. Sviluppando le implicazioni del con-ceptus obiectivus, egli rileva che questa espressione (conceptus obiectivus) «è sta-ta spesso identificata nella scolastica col termine ratio, ratio entis, ancora unavolta in modo corrispondente al greco. Il conceptus, il concipere, appartengono allógov ou¬síav al concetto dell’essere, alla ratio o intentio intellecta. L’intentio do-vrebbe qui esser considerata più precisamente come intentum intellectum, come
1 M. HEIDEGGER, Die Grundprobleme der Phänomenologie, GA Bd. 24, hrsg. v. F.-W. von Herrmann,Frankfurt am Main 1975; trad. it. di A. Fabris, I problemi fondamentali della fenomenologia, il Melango-lo, Genova 1988. È l'opera con cui Heidegger ha voluto inaugurare l’edizione definitiva delle sue opere.Si tratta del corso del semestre estivo del 1927 che, al dire dello stesso Heidegger (nota 1 dell’Introdu-zione dell’opera), costituisce «una nuova rielaborazione della terza sezione della prima parte di Essere etempo».
2 HEIDEGGER, I problemi fondamentali..., 80.
246 Orlando Todisco
ciò che viene intenzionato nell’intenzione concettuale»3. Egli determina ulte-riormente il conceptus obiectivus entis, considerandolo nella sua massima astra-zione, prescindendo cioè da qualsiasi rapporto con un ente determinato. È la ra-tio abstractissima et simplicissima, il concetto più vuoto e più semplice. Dopo averdistinto l’ens come essente, e dunque come participio, dall’ens come res o essen-tia o ti esti di Aristotele, Heidegger rileva che «potremo vedere, considerando lacorrispondente terminologia greca, che una tale interpretazione della cosalità ri-manda all’impostazione ontologica del mondo antico»4. È significativo il propo-sito di interpretare il conceptus obiectivus entis al modo greco, nel quadro dell’as-sunto generale secondo cui,
«Se vogliamo in generale capire qualcosa della metafisica moderna, del suo sviluppo,della posizione di Kant e dello sviluppo dell’idealismo tedesco, dobbiamo tenere pre-sente questa connessione del concetto medievale di metafisica con l’antichità, il tota-le mascheramento del problema autentico, che in Aristotele, seppure in maniera la-tente, esiste ancora»5.
È la direzione che Heidegger imprime alla sua lettura dell’ontologia medievale,piegando verso la fonte greca, dopo la breve esperienza giovanile, quando que-sta preoccupazione, forse implicita, non pare consapevolmente affermata. Infat-ti, nel periodo dell’abilitazione alla libera docenza, egli era piuttosto intento aliberare la logica da incrostazioni psicologistiche e a ristabilire la comunionecon il Dio trascendente nel contesto della pienezza dello spirito vivente.
Nell’opera I problemi fondamentali l’interpretazione dell’oggettività dell’en-te scotista, oltre che attraverso la prospettiva greca, passa attraverso la grigliadell’ontologia di Suárez, «il pensatore che più fortemente ha influenzato la filo-sofia dell’età moderna», «il primo ad aver ordinato in un sistema la filosofia esoprattutto l’ontologia del medioevo»6, colui che ha formulato «per la prima vol-
3 HEIDEGGER, I problemi fondamentali..., 80.4 HEIDEGGER, I problemi fondamentali..., 83.5 M. HEIDEGGER, Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – Einsamkeit, GA Bd. 29/30,
hrsg. v. F.-W. von Herrmann, Klostermann, Frankfurt am Main 1983; trad. it. di P. Coriando, Concetti fon-damentali della metafisica. Mondo – finitezza – solitudine, il Melangolo, Genova 1992, 72. Il collegamentotra il concetto medievale di metafisica e Aristotele ha luogo lasciando fuori il cristianesimo. Il che non vasottaciuto, per la comprensione dell’atteggiamento heideggeriano nei riguardi dell’ontologia di Scoto.
6 HEIDEGGER, I problemi fondamentali..., 76. È significativo che Heidegger ritenga Suárez interpretepiù acuto di Tommaso d’Aquino della metafisica scolastica: «Un influsso più immediato sullo sviluppodella metafisica moderna fu esercitato da un teologo e filosofo che nel sec. XVI, sulla base di concezioniteologiche ben determinate, si assunse il compito di reinterpretare la metafisica aristotelica: il gesuitaspagnolo Francisco Suárez. Il significato di questo teologo e filosofo non viene affatto apprezzato nella mi-sura in cui tale pensatore merita, che per acume e autonomia nel formulare le questioni deve essere po-sto al di sopra di Tommaso» (HEIDEGGER, Concetti fondamentali..., 72). È quanto aveva già detto ChristianWolff: «Sane Franciscus Suarez e Societate Jesu, quem inter Scholasticos res metaphysicas profundius
Il carattere oggettivo dell’ente scotista nella lettura di Martin Heidegger 247
ta i problemi ontologici nella forma sistematica che nei secoli successivi fino aHegel avrebbe determinato la partizione della metafisica», con la suddivisionedelle discipline filosofiche in metaphysica generalis e metaphysicae speciales(cosmologia rationalis, psychologia rationalis e theologia rationalis)7. L’ontolo-gia di Suárez, apparentata a quella di Scoto, viene privilegiata perché – scriveHeidegger – «non muove dalla necessità di una possibile creazione, ma cerca dirisolvere a livello del dato effettivo stesso il problema del rapporto tra l’essenzae il modo di essere»8, legittimando la lettura dell’ontologia di Scoto non più inrapporto a Dio creatore, ma al reale nella sua effettività.
Ora, prima di esaminare l’interpretazione onto-teologica dell’ontologia scoti-sta da parte di Heidegger maturo, sotto il duplice influsso, greco e suáreziano,convergente nel lasciare in ombra il Dio creatore e libero, è opportuno richia-mare il carattere oggettivo dell’ente scotista nell’opera giovanile La dottrina del-le categorie, dove tale preoccupazione pare ancora assente o, almeno, non inci-siva né determinante.
1. L’oggettività dell’ente scotista nell’«Habilitationsschrift»
La dottrina delle categorie, che costituisce la prima parte dell’Habilitationsschrift9,pone, sia pure in modo embrionale, il problema dell’essere, come lo stesso Hei-
meditatum esse constat» (Philosophia prima sive Ontologia, edidit et curavit J. Ecole, Hildesheim, GeorgOlms 1962, 138).
7 HEIDEGGER, I problemi fondamentali..., 77.8 HEIDEGGER, I problemi fondamentali..., 94.9 È l’opera che abilitò Heidegger alla Libera Docenza e che, composta nel ’15, egli pubblica l’anno
successivo, con in più il capitolo conclusivo, composto in vista della stampa. Il titolo è Die Kategorien-und Bedeutungslehre des Duns Scotus, Tübingen 1916, ristampato in Frühe Schriften, GA Bd. 1, hrsg. v.F.-W. von Herrmann, Klostermann, Frankfurt am Main 1978. Tradotta da Florient Gaboriau e pubblicatada Gallimard, a Parigi 1970, e poi da A. Babolin per i tipi di Laterza nel 1974 col titolo La dottrina del-le categorie e del significato in Duns Scoto, l’opera non può dirsi oggetto di ampia discussione. Le cita-zioni successive si riferiscono a quest’ultima traduzione. La fonte è la Grammatica speculativa non di Sco-to ma di Tommaso d’Erfurt della scuola scotista, il cui intento era di mostrare lo stretto legame tra gram-matica e logica che colpì l’allievo di Husserl, che riteneva legittima «una grammatica pura apriori» (O.PÖGGELER, Il cammino di pensiero di M. Heidegger (1990), trad. it. di G. Varnier, Guida, Napoli 1991, 26),senza dedurre da ciò che l’uso linguistico-grammaticale derivi da leggi puramente logiche. La paternitàdell’opera è stata ristabilita da M. GRABMANN, De Thoma erfordensi auctore Grammaticae quae J. DunsScoto adscribitur speculativae, «Archivum Franciscanum Historicum», 15 (1922), 273-277. Mosso non daintenti storico-filologici, ma critico-sistematici, Heidegger ben comprese che l’opera interrompeva la tra-dizione che imparentava la Grammatica alla Dialettica ed entrambe alle arti liberali, quali strumenti di ac-cesso allo studio delle opere classiche e luogo privilegiato per l’acquisizione dell’eloquenza, sacra e profa-na. Il fatto poi che il commento ai passaggi più significativi è arricchito dai testi tratti dalle opere di Scotorende il contenuto dell’Habilitationsschrift propriamente scotista. Da precisare che, a partire dalla secon-da parte – La dottrina del significato – Heidegger si rivolge al De modis significandi di Tommaso di Erfurt,senza più citazioni delle opere di Scoto, come nella prima parte. Tra le riletture dell’opera in esame cf. I.
248 Orlando Todisco
degger, con sguardo retrospettivo e con riferimento all’opera in questione, annota:(nei miei primi scritti vi era) «un avvio allora ancora ignoto per me: nella forma delproblema delle categorie, la questione dell’essere; nella forma della teoria dei si-gnificati, la questione della lingua»10. Dunque, la dottrina delle categorie è un’em-brionale anticipazione della questione dell’essere.
Anche se ancora in forma timida, la critica si annuncia radicale nei riguardidella “tradizione metafisica” che ostacola il ritorno al soggetto come spirito vi-vente nella sua storicità. La filosofia dei valori, variamente proposta, era solol’ultima versione di tale stile, con la pretesa di selezionare e giudicare il mate-riale empirico, e soprattutto di anticipare ciò che è valido in sé e per sé.
«I difensori del metodo teleologico – scriverà nel ’19 – sono affascinati dalla separa-zione radicale di essere e valore e non si accorgono che hanno spezzato soltanto teo-reticamente i ponti fra le due sfere, per stare sconsolati in una delle due»11.
La validità – di ciò che vale in sé – è decisa aprioristicamente, senza alcun in-cisivo riferimento al mondo dell’accidentale, dell’effettivo12. Il momento teore-tico, che si era andato affermando a detrimento delle radici esistenziali, vieneriportato all’effettiva comunione con il reale. Ora, come la ricerca intorno allecategorie della grammatica scotista contribuisce al recupero della vita effettiva,all’afferramento concreto della vita stessa? La risposta è che le categorie non so-no delle invenzioni o un insieme di schemi logici entro cui sacrifichiamo i feno-meni della vita o la vita come fenomeno, bensì sono il modo con cui la vita si for-ma e si dona. O anche, le categorie sono la vita nel mentre questa perviene a sestessa. Siamo di fronte alla rilettura di un capitolo singolare di filosofia medie-vale, con l’obiettivo di ristabilire la capacità delle categorie di aprirci alla con-cretezza e complessità della cosa esperita, ricollocandoci entro il corso della co-sa stessa. Heidegger vuol porre fine a un filosofare che parte da un punto di vi-
MANZANO, La Habilitationsschrift de Heidegger sobre Escoto, «Verdad y Vida», 24 (1966), 305-325; F. A.PREZIOSO, La riscoperta semantica di Heidegger nel pensiero di Scoto, «Rassegna di scienze filosofiche»,25 (1972), 150-179, 287-302, 407-418; J.D. CAPUTO, Phenomenology Mysticism and the Grammatica spe-culativa: a Study of Heidegger’s Habilitationsschrift, «Journal of the British Society for Phenomenology»,5 (1974), 101-117. Cf. inoltre, il capitolo IV (“La dottrina del giudizio nel saggio di abilitazione su La dot-trina delle categorie e del significato in Duns Scoto”) in G. BERTUZZI, La verità in M. Heidegger. Dagli scrit-ti giovanili a Essere e tempo, Studio Domenicano, Bologna 1991, 66-128; A. SAVIGNANO, La scuola scoti-sta nell’Habilitationsschrift di M. Heidegger, in Scienza, filosofia e teologia, Levante, Bari 1993, 179-188.
10 M. HEIDEGGER, Vorwort zu: Frühe Schriften, GA Bd. 1, riportata nella Prefazione alla trad. it. de Ladottrina delle categorie..., VII.
11 M. HEIDEGGER, Die Idee der Philosophie und das Weltanschauungsproblem, in Zur Bestimmung derPhilosophie, GA Bd. 56/57, hrsg. v. B. Heimbüchel, Klostermann, Frankfurt am Main 1987; trad. it. a cu-ra di G. Auletta, L’idea della filosofia e il problema della visione del mondo, in Per la determinazione dellafilosofia, Guida, Napoli 1993, 62.
12 D. VICARI, Ontologia dell’esserci, Ed. Zamorani, Torino 1996, 26.
Il carattere oggettivo dell’ente scotista nella lettura di Martin Heidegger 249
sta offerto dalla tradizione, senza agganci al nuovo che emerge, incapace di co-gliere la problematicità originaria.
Chiedendosi cosa sia ciò intorno a cui la grammatica lavora nel senso dellascuola scotista, Heidegger si porta oltre gli oggetti specifici, verso «qualcosa diancora più radicale», verso «gli ambiti di oggetti... pertinenti a determinate sfe-re di realtà»13. Ora,
«non si può dimostrare con procedimento apriori, per via deduttiva, che esista un am-bito di realtà, e ancor più non si può provare in tal modo che se ne presentino diversi.Le entità di fatto si possono solo mostrare, esibire. Quale il senso di questo mostrarea dito? [...] Dal punto di vista della prassi conoscitiva, sussiste per noi il dovere di di-rigervi lo sguardo, di cogliere realmente tutto ciò che si può cogliere, di esaudire lapura sostanza di ciò che viene presentato. [...] Infatti, in quanto immediato, esso nonha per così dire nulla tra sé e l’atto di cogliere o apprendere (simplex apprehensio)»14.
Scoto è andato oltre il numero e la classificazione delle categorie di Aristotele,apparse piuttosto una classe di una sfera determinata, e non le categorie per ec-cellenza. I trascendentia o trascendentalia, quali massimi predicamenti del rea-le, inglobanti i concetti fondamentali di ens, unum e verum, non si ritrovano trale dieci categorie aristoteliche. Egli si dimostra chiaramente consapevole che lecategorie tradizionali valgono solo per la realtà effettuale. Come accedere al re-gno dell’intenzionalità?
«Indubbiamente la sfera delle “intenzioni” abbisogna di altre forme ordinative, essaanzi rappresenta una regione di oggetti a sé stanti, le “intenzioni” sono suscettibili edefinibili per sé. La logica stessa quindi richiede categorie proprie. Vi deve essere unalogica della logica»15.
A tale scopo si impone una supercategoria funzionale all’ampliamento del rag-gio dell’oggettività, nel quadro della netta distinzione dell’ambito logico o cate-goriale dall’ambito psichico16. Ebbene, tale supercategoria è l’ens in quantumens, privo di qualsiasi conformazione categoriale.
13 HEIDEGGER, La dottrina delle categorie..., 27.14 HEIDEGGER, La dottrina delle categorie..., 29-30.15 HEIDEGGER, La dottrina delle categorie..., 108.16 Nel ’15, quando attende alla stesura di quest’opera, Heidegger ha già difeso la tesi di Laurea (1913),
pubblicata a Lipsia nel ’14, dove aveva messo in chiaro il suo anti-psicologismo: Die Lehre vom Urteil imPsychologismus. Ein kritisch-positiver Beitrag zur Logik; trad. it. di A. Babolin, La dottrina del giudizionello psicologismo, La Garangola, Padova 1972. E nell’opera La dottrina delle categorie si legge: «Di fron-te alla concezione e soluzione dei problemi logici in senso psicologistico, tendenza che appena da brevetempo si trova in regresso, il pensiero scolastico tuttavia, per quanto spesso si limiti solo ad accenni ge-nerali, denuncia una maturità di sguardo da non disattendere né sottovalutare» (97).
250 Orlando Todisco
«L’ens significa – scrive Heidegger – il senso complessivo della sfera degli oggetti ingenere, l’aspetto di ciò che permane nell’oggettuale, è la categoria delle categorie.L’ens rimane conservato (salvatur) in ogni oggetto, comunque esso possa essere diffe-renziato nella ricchezza del suo contenuto»17.
Heidegger si sofferma su tale supercategoria, perché l’ens in quantum ens recu-pera l’universalità, propria della filosofia dei valori, e, a differenza di questa, noninterrompe la comunione con il reale effettivo. È il campo dei maxime scibilia,convertibili tra loro.
«Solo ciò che è convertibile con l’ens può essere annoverato in senso rigoroso tra i tra-scendentia. La convertibilità quindi si può considerare come criterio per decidere co-sa si debba ritenere ancora, oltre l’ens, appartenente ai trascendentia»18.
Il maxime contiene qui un’idea di valore logico-teoretico di segno trascendenta-le: «Colto nel significato detto come maxime scibile, l’ens non significa null’al-tro che la condizione di possibilità di conoscenza d’oggetti in genere»19. Un tra-scendens è ciò che non ha sopra di sé alcun genere in cui possa essere contenu-to. Questo carattere di ultimità dell’ens come oggettualità in genere è l’essenzia-le del trascendens.
Ma questo primo risultato resterebbe indecifrato se si omettesse di rilevareche tale ente in quanto ente, trascendentale supremo, è segno del carattere in-definito dell’intenzionalità della coscienza. È l’ens in anima, che è un ens demi-nutum, in quanto non è l’ente fisico e insieme non è il non-ente.
«Di fronte all’effettiva realtà della natura, esso (ens deminutum) significa un tipo d’es-sere sminuito e quindi non rientra nell’ambito degli oggetti della metafisica, che è in-contestabilmente una scienza reale»20.
L’ens in anima o ens logicum o ens deminutum allude all’orizzonte dell’anima, in-tenzionata verso tutto ciò che in qualunque modo è. La scolastica parla di primaintentio. Se l’ens extra animam indica il mondo sensibile e sovrasensibile, effet-tivamente esistente, l’ens in anima indica tutto ciò che è o può essere in quantoassunto nella sfera del senso logico. Il piano dell’intenzionalità logica, tematiz-zato nel quadro del binomio noesi-noema delle Idee di Husserl, ben rende l’a-pertura scotista della coscienza al reale. Tutto ciò che in qualunque modo è vie-
17 HEIDEGGER, La dottrina delle categorie..., 33-34.18 HEIDEGGER, La dottrina delle categorie..., 34.19 HEIDEGGER, La dottrina delle categorie..., 34.20 HEIDEGGER, La dottrina delle categorie..., 98.
Il carattere oggettivo dell’ente scotista nella lettura di Martin Heidegger 251
ne ridotto a puro correlato del mondo della coscienza, intesa questa non in sensoempirico o psicologico21. Si tratta dunque dell’orientamento della coscienza alreale, da distinguere dalla secunda intentio, che implica il concreto volgere del-lo sguardo su tutto ciò che esiste, e appartiene al mondo degli oggetti, metafisico,fisico e psichico, compresi gli oggetti matematici e persino logici. Ebbene, l’ensin anima rappresenta la prima intentio o apertura dell’intelletto a tutto ciò che inqualunque modo è o può essere, confermandosi commune omnibus.
Ora, le passiones entis, convertibili con l’ente e dunque trascendentali, comecontribuiscono a saldare il rapporto tra la soggettività dell’esperienza e l’ogget-tività della conoscenza o anche tra i fenomeni e le categorie o anche tra senso eintelletto? come si configura la vita della coscienza, in collegamento con la suaintenzionalità all’ente tamquam commune omnibus? Innanzitutto, il verum, tra-scendentale convertibile con l’oggetto, sta per rapporto formale, riferito all’am-bito oggettuale conoscitivo, come Heidegger precisa: «L’oggetto, in quanto og-getto della conoscenza, può essere chiamato oggetto vero. In esso si deve vede-re il fundamentum veritatis»22. Il conoscere poi ha luogo nel giudizio, che è «ciòche si può chiamare vero in senso proprio e autentico. Ogni conoscenza è un giu-dizio. Ogni giudizio è una conoscenza... Non a torto esso recentemente è statodesignato come la cellula della logica, la sua struttura originaria»23. Siamo sem-pre nella sfera logica, non in quella psichica.
Oltre al verum, restando nell’ambito logico, è rilevante la funzione dell’unumcome passio entis, soprattutto se si distingue l’unum come numero, il cui corri-spondente è la multitudo, dall’unum in virtù del quale ogni oggetto è un oggetto.Ma l’essere uno e l’essere oggetto, e dunque l’ens e l’unum come rapportarli tra lo-ro? Heidegger risponde: «Sicuramente l’unum significa anche qualcosa di diver-so dall’ens»24. Ma se aggiunge qualcosa di diverso dall’ens, non abbiamo forse, conogni oggetto, che è necessariamente un oggetto, due oggetti? Egli risponde preci-sando che, in quantum trascendens, l’unum non aggiunge alcuna nuova entità al-l’ens, ma si dà immediatamente come forma o determinazione della cosa. Infatti,
«l’unum trascendens è qualcosa di inerente all’oggetto, qualcosa mediante cui un og-getto diviene un oggetto, un momento o aspetto che condiziona in genere l’attualità:
21 Scrive Heidegger: «Gli atti conoscitivi non vengono considerati con procedimento oggettivizzante,come realtà effettuale, quanto invece in veste della loro funzione, della loro operazione. Così visti essi nonappartengono già più propriamente all’ambito della psicologia, come scienza reale dell’elemento psichi-co, ma appartengono alla logica, se non si vuole ordinarli entro la regione più propria della fenomenolo-gia (e più precisamente quella che di preferenza si imposta sulla “noesis”)». (Heidegger, La dottrina del-le categorie..., 105).
22 HEIDEGGER, La dottrina delle categorie..., 89.23 HEIDEGGER, La dottrina delle categorie..., 91-92.24 HEIDEGGER, La dottrina delle categorie..., 39.
252 Orlando Todisco
l’unum come numero, per contro, è esso stesso oggetto, un caso del tutto specifico dioggettualità»25.
Ma se è forma dell’ens, in che senso l’unum contribuisce alla determinatezza del-l’oggetto e al suo modo di offrirsi? Il tema del giudizio e della sua configurazio-ne sale prepotentemente al primo piano, il cui approfondimento mostra la fun-zione dell’ens in quantum ens e insieme dell’unum come passio entis.
«Con il fatto che in genere – rileva Heidegger – un alcunché (ens) sia dato alla miaconsapevolezza, che io faccio di qualcosa oggetto della mia conoscenza, è entrato infunzione il concetto della determinatezza... Si deve dire: io non ho assolutamente al-cun oggetto, vivo cieco nella tenebra totale, ma mi posso muovere intellettualmente,nel pensiero, il pensare è fermo. Con l’ens io ottengo la prima determinazione, e, inquanto ogni ens è un unum, il primo ordine nella ricchezza molteplice di ciò che hacarattere d’oggetto. La determinatezza, dunque, è qualcosa che ha natura di ordine,inerente al dato, essa lo rende atto ad essere colto, conosciuto, inteso»26.
Il contributo categoriale dell’unum alla determinazione dell’ens è dunque rile-vante, e tuttavia – come quello del verum – posteriore all’ente in quanto tale, dalmomento che si costruisce sulla sua base. La priorità dell’ente, l’indeterminatoper eccellenza, e le sue passiones salvaguardano l’apertura della coscienza alreale e la sua oggettività27.
Oltre che convertibile con l’ens e principio del numero puro, l’unum è anchenumero numerato. Ora, come è possibile passare dall’unum trascendens al nu-mero numerato, e quale supplemento di determinazione porta con sé? A questopunto interviene il concetto di “misura” o la relazione di misura e dunque, co-me sua condizione, la quantità, che Scoto a buon diritto chiama la “regina dellemisure”. Se dunque, l’unum trascendens si dice di ogni oggetto, a qualunque am-bito di realtà appartenga, e dunque anche dei numeri, «l’uno numerico ha sen-so solo nell’ambito del quantitativo»28. Ma se è in grado di dare unità alla mol-teplicità degli oggetti sensibili, il numero può forse render conto da solo dell’in-dividualità dei singoli enti? Quale il limite del suo esser “forma dell’ente inquanto ente”? Scoto ritiene che l’individualità di un qualsiasi ente comporti una
25 HEIDEGGER, La dottrina delle categorie..., 40.26 HEIDEGGER, La dottrina delle categorie..., 41-42.27 L’oggettività dell’ente e insieme la sua essenziale indeterminazione pare siano rivendicate con
estrema penetrazione. Il che ci pare incontri il favore di quella storiografia che recupera il carattere tra-scendentale dell’ente in quanto oggetto dell’intelletto. Cf. in questa direzione A. DE MURALT, La doctrinemédiévale de l’esse objectivum, nella raccolta di saggi Études thomistes, scotistes, occamiennes et grégo-riennes, E. J. Brill, Leiden 1991, 90-167.
28 HEIDEGGER, La dottrina delle categorie..., 62.
Il carattere oggettivo dell’ente scotista nella lettura di Martin Heidegger 253
complessità ontologica, per la cui spiegazione non è sufficiente né la quantità nél’unum principio del numero. La determinazione dell’ente in quanto ente fino al-l’individuazione della realtà individuale esige un percorso categoriale più lun-go, di cui Scoto è consapevole e che Heidegger ripercorre con la perspicacia dichi ha colto il tratto antipsicologistico di questo filosofo medievale, per il qualel’ambito logico-oggettuale costituisce una sorta di “mondo ontologico apriori”che non chiude il soggetto in se stesso, ma lo apre al reale e ce lo restituisce nel-la sua vivente concretezza. È questa in fondo la funzione delle categorie. Infat-ti, il tratto che va dall’ens in quantum ens all’ente singolare è coperto dalla ca-tegoria della quantità, dall’unum puro, universale, medio, e dall’ecceità (haec-ceitas), intesa come perfezione che individualizza le molte componenti del sin-golo ente sullo sfondo dell’esistenza e del tempo29. L’esse dell’esistere competeall’individuo, perché solo l’individuo esiste in senso reale.
«L’individuale – scrive Heidegger – è un’entità ultima irriducibile. Esso significa l’og-getto reale kat’e¬xocän, prout includit existentiam et tempus. Due mele sullo stesso albe-ro non hanno lo stesso “respectus” verso il cielo, ciascuna è già diversa dall’altra, fos-sero anche completamente uguali per il resto, per la sua determinatezza nello spazio.Tutto ciò che esiste in senso reale è un tale-hic-nunc. La forma dell’individualità (haec-ceitas) è chiamata a produrre una determinatezza originaria della realtà effettuale. Que-sta realtà forma una molteplicità non dominabile con lo sguardo, un continuo eteroge-neo. Questo aspetto particolare della datità immediata attualmente è stato sottolineatocon forza soprattutto da Rickert30 e fatto base della sua metodologia fondamentale»31.
La logica delle categorie dunque, è sviluppata come logica della mediazione tral’ens trascendentale e l’individuo, con l’obiettivo non di instaurare il primato del-
29 In un paragrafo, breve e pertinente, di una raccolta di studi – Heidegger interprete di Kant – Pio Co-lonnello ritiene che «Heidegger abbia operato una singolare contaminazione tra la dottrina delle catego-rie in Kant: abbia cioè inserito nell’interpretazione dello schematismo trascendentale kantiano l’elemen-to temporale che è presente in Scoto, ma assente o presente diversamente in Kant. [...] Ecco la singolaretrasposizione che riteniamo abbia operato Heidegger: la tematica del tempo, come determinazione ultimadel reale, come ciò che fa sì che il reale sia tale, è trasferita da Scoto in Kant» (Studio Editoriale di Cul-tura, Napoli 1981, 29). Il rilievo era stato già avanzato da Prezioso con riferimento all’opera Sein und Zeit:F.A. PREZIOSO, La riscoperta semantica di Heidegger nel pensiero di Scoto, «Rassegna di scienze filosofi-che», 25 (1972), 174.
30 A partire dal 1919 quando, da assistente di Husserl, incomincia a tenere seminari e lezioni intor-no alla fenomenologia, Heidegger compie quello che J. Greisch ha definito il “primo parricidio”, cioè larottura con la filosofia dei valori di Rickert, presso il quale aveva ottenuto la libera docenza con La dot-trina delle categorie e del significato in Scoto e al quale l’aveva dedicata “in riconoscentissimo omaggio”:J. GREISCH, L’hermeneutique dans la “phénomenologie comme telle”, «Revue de Metaphysique et de Mo-ral», 96 (1991), 43-76. Su questo argomento cf. l’acuto saggio di A. SAVIGNANO, L’influsso di H. Rickert ne-gli scritti giovanili di Heidegger, in M. SIGNORE (a cura di), Rickert tra storicismo ed ontologia, FrancoAn-geli, Milano 1989, 339-354. Il “secondo parricidio” riguarderà la successiva rottura con Husserl.
31 HEIDEGGER, La dottrina delle categorie..., 64.
254 Orlando Todisco
la forma sulla materia o, in genere, del teoretico, ma di rendere conto della co-munione con il reale effettivo, rispettandone la complessità. Scoto infatti,
«ha trovato in confronto agli altri scolastici anteriori, una più grande e fine vicinanza(haecceitas) alla vita reale (reales Leben), alla multiformità e possibilità di tensione del-la vita. Ma nello stesso tempo egli sa staccarsi dal piano della complessità vitale, vol-gendosi con la stessa agevolezza verso il mondo astratto della matematica. A lui sonofamiliari sia le “forme della vita” (quanto almeno questo era accessibile al medioevo)sia al “grigio nel grigio” della filosofia»32.
Senso del concreto e senso dell’astratto sono due momenti essenziali della lezio-ne di Scoto. Il carattere translogico dell’ente e delle sue passiones si impone nelquadro dell’«unità superiore di queste due “direzioni” della storia della cono-scenza (realismo e idealismo), le due più importanti e feconde d’oggi»33; così co-me lo sguardo alla struttura metafisica dello spirito vivente si impone nel conte-sto della costante coniugazione tra universale e singolare e dunque nel vivo diquella filosofia «in cui singolarità, individualità degli atti sono insieme inclusecon l’universalità, con il sussistere per sé del significato in una unità vivente». Ilche risulta più rilevante se ricondotto alla persuasione di Heidegger, secondo cuideve ritenersi impotente «una filosofia come struttura razionalistica, separatadalla vita», e senza scopo «una mistica come esperienza vissuta irrazionalisti-ca»34. L’ens in quantum ens e le categorie, che contribuiscono alla sua determi-nazione, consentono di respingere la razionalità senza vita e la vita senza razio-nalità, perché non sono il segno dell’assolutizzazione del conoscere teoretico, mamodi diversi attraverso cui viene resa e protetta la ricchezza della vita effettiva.
Non è arduo cogliere in tale spirito vivente, concepito come individuale e uni-versale a un tempo, quella soggettività in generale (anima), intesa come ciò in
32 HEIDEGGER, La dottrina delle categorie..., 15.33 HEIDEGGER, La dottrina delle categorie..., 256.34 HEIDEGGER, La dottrina delle categorie..., 253-254. Non ci pare lontano dal vero il rilievo di J. D.
Caputo, secondo cui questo saggio del ’16 pare porti dentro alcuni semi che feconderanno con l’ultimoHeidegger, se è vero, come più sopra si è ricordato, che egli stesso ha adombrato nell’analisi delle cate-gorie la questione dell’essere e nell’analisi della teoria dei significati ha intravisto la questione della lin-gua. Precisando meglio questo raccordo sotterraneo, Caputo scrive: «Tutta la discussione sull’atteggia-mento dell’anima che si protende verso il trascendente, sulla relazione primordiale dell’anima con Dionel medioevo, almeno come Heidegger la rappresenta, è profondamente simile all’ultimo pensiero di Hei-degger, simile cioè alla relazione fra il Dasein e l’Essere nelle opere che appaiono dopo il 1930». Con-cludendo, precisa che nessuno pensi a «qualcosa di così ridicolo come se Heidegger nei suoi ultimi scrit-ti fosse ritornato al realismo scotista. Non è in realtà tanto la filosofia scolastica quanto l’atteggiamentospirituale verso la vita che diede vigore a quella filosofia, come è ritratto da Heidegger, che sembra farsentire il suo effetto nelle sue ultime opere». Per i brani riportati cf. J.D. CAPUTO, Phenomenology Mysti-cism and the Grammatica speculativa: a Study of Heidegger’s Habilitationsschrift, «Journal of the BritishSociety for Phenomenology», 1 (1974), 115 e 117.
Il carattere oggettivo dell’ente scotista nella lettura di Martin Heidegger 255
cui si ritrovano le soggettività singolari, presupposte come realmente inter-agen-ti. Scoto è il filosofo dell’haecceitas e insieme dell’univocità dell’ente, in lineacon quello spirito medievale, cosciente dell’unità e impegnato a riflettere su seg-menti specifici, i quali però non vanno mai isolati o recisi da ciò che rientra inuna logica più ampia e condivisa. Lo spirito vivente, di cui parla il giovane Hei-degger, può far pensare alla soggettività in generale, in linea con l’Ego trascen-dentale che Husserl, quale erede di Kant, andava proponendo, o forse, e meglio,alla soggettività trascendentale medievale sullo sfondo di quella soggettività in-dividuale che Scoto rivendicava come presupposto essenziale per impedire chel’averroismo avesse a risorgere. Heidegger non manca di notarlo allorché, com-mentando un famoso passaggio di Scoto35, rileva che l’“essere-individuale” noncoincide con l’essere-un-oggetto-in-genere, ma con un’entità ultima irriducibi-le. L’apertura ontologico-esistenziale della soggettività storica si compie attra-verso la trascendenza dell’evento, da recuperare nella sua originaria ricchezza,senza tuttavia sottrarre spazio al Dio vivente, nel suo darsi originario, colto sen-za quelle mediazioni che ne irrigidiscono l’epifania o ne mortificano i colori.L’accenno a Hegel, con cui si chiude l’opera, è significativo di questa “adoran-te intimità con Dio”, e più ancora dell’insufficienza dell’approccio logico-cate-goriale ai fini della resa dell’effettività dell’io-storico-mondano.
Ora, il discorso fatto fin qui, Heidegger lo sviluppa ulteriormente nei Grund-probleme del ’27 o, invece, gli imprime un’altra piega, non del tutto estranea altesto del’16 e tuttavia qui non visibile né determinante, almeno a una prima let-tura?36
2. L’oggettività dell’ente scotista nei «Grundprobleme» del ’27
Il capitolo secondo dell’opera I problemi fondamentali della fenomenologia del’27 è dedicato a «La tesi dell’ontologia medievale e la sua origine aristotelica:
35 «Accipitur individuum substantia et simul totum stricte, prout includit existentiam et tempus, uthic homo existens» (IOANNES DUNS SCOTUS, Quaestiones subtilissimae in Metaphysicam Aristotelis, q. 10, n.76, ed. Wadding, Lyon 1639; da distinguere dalla Expositio in XII libros Metaphysicorum Aristotelis seuMetaphysica textualis, compresa nell’edizione delle opere di Scoto del Wadding del 1639, che la criticaattribuisce ad Antonio Andrea della scuola scotista. Cf. L. MODRIC, L’edizione critica delle “Quaestionessuper Metaphysicam” del B. G. Duns Scoto, «Antonianum», 73 (1998), 581-592).
36 M. HEIDEGGER, Mein bisheriger Weg, in Besinnung (1938/39), GA Bd. 66, hrsg. v. F.-W. von Herr-mann; Il mio cammino fin qui, in Meditazione, 412-13: «Lo scritto di abilitazione: La dottrina delle cate-gorie e del significato in Duns Scoto del 1916 – la questione delle categorie come tentativo di un accessostorico all’ontologia [...]. Ma ora posso dire che, dietro la questione – sebbene in maniera ancora incom-piuta – c’era già qualcosa in più: il primo tentativo di confronto di posizione con l’idealismo tedesco (He-gel) e questo non in direzione di un neohegelismo, ma nell’ottica: Hegel-Medioevo-Aristotele».
256 Orlando Todisco
alla costituzione ontologica di un ente appartengono il “che cos’è” (essentia) e lasussistenza (existentia)». Il punto di vista di Scoto in merito al rapporto tra es-senza ed esistenza, come elementi costitutivi dell’ontologia, viene ritenuto “dav-vero acuto”. Si tratta del rifiuto della distinzione reale tra essenza ed esistenzaa favore della distinzione modale. L’esistenza è pensata come modalità intrinse-ca dell’essenza. Tale tesi viene giudicata estremamente significativa perché ri-conduce l’esistenza al “modo” o al “come” (Wie) si offre l’essenza, che la scola-stica, presa dalla problematica teologica, non ha sviluppato. Ciò che si dà (il checosa) si dà sempre nel modo dell’«in qualche modo» (Irgendwie), con una signi-ficatività originaria. Ora, quale il compito della fenomenologia, se non quello diindagare «i contenuti modali» (Wiegehalt), non riducendoli a «contenuti ogget-tuali», per non cadere vittima della scientificità matematico-teoretica? Se l’esi-stenza indica la modalità dell’essenza o del “che cosa”, l’esistere è un muover-si o anche una motilità che è tale in se stessa e per se stessa, e cioè non riceveimpulso dall’esterno37. Heidegger lo dice chiaramente, a proposito della posi-zione di Suárez che egli ritiene la più prossima a Scoto, e cioè
«la separazione tra l’ens increatum e l’ens creatum è decisiva per una comprensione fi-losofica più approfondita della distinzione tra essentia ed existentia, prescindendocompletamente da qualsiasi orientamento teologico e quindi anche dal problema seDio esiste oppure no»38.
La prospettiva è delineata. Se l’esistenza è il “modo d’essere” o il “come” del“che cosa” o essenza, occorre occuparsi della struttura dell’ens creatum e del-l’ens increatum, lasciando cadere come irrilevante o deviante il problema di Dio.
Heidegger sviluppa questa tesi rilevando che è propriamente medievale ilproblema della distinctio e della compositio tra il carattere essenziale di un entee il modo del suo essere, tra l’essentia e l’existentia, ed è propriamente medieva-le perché collegato al tentativo di indicare i tratti che distinguono l’ens finitumdall’ens infinitum. Se l’essentia è la realitas dell’ente finito e a questa l’esistenzanon appartiene necessariamente, in che modo l’effettività di un ente si rapportaalla realtà dell’ente finito? Il problema viene posto nel contesto della distinzione
37 M. HEIDEGGER, Einletung in die Phänomenologie der Religion, in Phänomenologie des religiösen Le-bens, GA Bd. 60, hrsg. v. M. Jung u. T. Regehly, Klostermann, Frankfurt am Main 1995, 63: «Ogni espe-rienza – in quanto sperimentare di uno sperimentare – può nel fenomeno esser colta, cioè si può interro-gare: 1. secondo l’originario “cosa”, che in esso viene sperimentato (contenuto); 2. secondo l’originario“come”, in cui è sperimentato (riferimento); 3. secondo l’originario “come”, in cui il senso di riferimentoviene compiuto (compimento)». Cf. su questa tematica J. VAN BUREN, The Young Heidegger and Pheno-menology, «Man and World», 23 (1990), 239-272; R. A. MAKKREL, The Genesis of Heidegger’s Phenome-nologal Hermeneutics, «Man and World», 23 (1990), 305-320.
38 HEIDEGGER, I problemi fondamentali..., 79.
Il carattere oggettivo dell’ente scotista nella lettura di Martin Heidegger 257
tra i concetti di ente infinito e di ente finito, tra l’ente necessario, che non può nonessere, che è per essentiam, e l’ente per partecipationem, che riceve l’effettività,alla cui essenza l’effettività spetta solo accidentalmente. Il problema dunque, na-sce con una cadenza teologica, che diventa più esplicita a proposito della distin-zione reale tra essenza ed esistenza, propria della prospettiva tomista:
«Questa distinzione – scrive Heidegger – è così la condizione della possibilità chequalcosa venga creato, cioè la condizione affinché qualcosa di possibile possa diven-tar effettivo, oppure, viceversa, perché un ente finito possa cessar di esistere»39.
Quale allora è l’essere dell’ente? quale la sua realtà o la sua quidditas, «illud[...] quod primo concipitur de re», primo non cronologicamente, bensì sub ordi-ne nobilitatis? Cosa è dunque primario, quale la cosalità della cosa? La rispostaè data dalla quidditas, delimitata come forma, come eidos o come natura. E chedire dell’esistenza, l’altro termine della distinzione? Come l’essentia, anche l’e-xistentia deriva da esse e allude alla sussistenza effettiva o actualitas. Se l’es-sentia è il “che cosa” di un ente, l’esistenza è il “come” dell’ente, nel senso cheindica che quella quidditas non è solo un possibile ma un possibile che è fuoridella sua causa. Ora, quale il rapporto tra la res come possibile, che pure pos-siede un certo essere, e l’essere effettivo, in quanto cioè fuori della sua causa?l’esser-possibile occorre forse distinguerlo dall’essere effettivo, dal momento cheè anch’esso reale? E allora, questo modo d’essere che è l’esser possibile, questaentitas della res, come si modifica attuandosi effettivamente, cioè ricevendo l’ef-fettività? cosa quest’effettività aggiunge facendo sì che il possibile divenga ef-fettivo? Se la distinzione tra esser-possibile ed essere-effettivo è modale, propriadel rapporto tra l’ente e i suoi modi intrinseci40, cosa l’effettività aggiunge al-l’ente-possibile, non più solo tale, ma actu existens?
Prima di procedere alla rassegna delle risposte medievali più autorevoli, è si-gnificativo l’accenno di Heidegger al tentativo da parte della mistica medievaledi cogliere l’ente nella sua essenzialità, di trasformare
«in ente l’idea dell’essenza in generale, cioè una determinazione ontologica dell’esse-re, l’essentia entis, facendo così del fondamento ontologico dell’ente, della sua possi-
39 HEIDEGGER, I problemi fondamentali..., 88-89.40 IOANNES DUNS SCOTUS, Ordinatio (abbr.: Ord.) I, d. 8, p. 1, q. 3, n. 138, ed. Vaticana, Romae 1950 e
ss.: «Respondeo quod quando intelligitur aliqua realitas cum modo suo intrinseco, ille conceptus non estita simpliciter simplex quin possit concipi illa realitas absque modo illo, et tunc est conceptus perfectusillius rei [...]. Requiritur ergo distinctio inter illud a quo accipitur conceptus communis et inter illud aquo accipitur conceptus proprius, non ut distinctio realitatis et realitatis sed ut distinctio realitatis et mo-di propri et intrinseci eiusdem, quae distinctio sufficit ad habendum conceptum communem vel imper-fectum de eodem, quorum imperfectus sit communis et perfectus sit proprius».
258 Orlando Todisco
bilità, della sua essenza qualcosa di autenticamente effettivo. Questa singolare tra-sformazione dell’essenza in ente è il presupposto perché possa attuarsi quel che sichiama la “speculazione mistica”»41.
Dopo questo passaggio, che egli considera «un impegno concettuale in senso dav-vero eminente»42 e che prelude al privilegiamento della soluzione scotista-suáre-ziana, Heidegger procede all’esposizione della tesi di Tommaso, per il quale l’ef-fettività, l’esistenza, è una res, realmente distinta dall’essenza, cui sopravvienedall’esterno. Il raffronto con Kant, per il quale l’esistenza, l’effettività, non è unpredicato reale e non appartiene alla res di una cosa, non impedisce ad Heideg-ger di indicare la distanza di Tommaso da Kant, rilevando che per il primo l’effet-tività è una res che si aggiunge all’essentia, per il secondo non è una res ma piut-tosto una relazione con la facoltà di colui che la percepisce. Il distacco di Hei-degger dalla tesi tomista risulta dal rilievo finale circa il fatto che tale distinzionereale tra essenza ed esistenza viene presentata come condizione per render contodella creazione della creatura, essenzialmente dunque legata alla teologia. Ebbe-ne, in merito egli nota che i tomisti hanno osato dire che «negando la distinzionereale (l’opinione contraria) era costretta a negare anche la possibilità della crea-zione e quindi il principio fondamentale autentico di tutta quest’impostazione me-tafisica»43. Il che non è sostenibile, dal momento che Scoto e Suárez, che non con-dividono siffatta distinzione, non sono meno creazionisti di Tommaso.
Heidegger procede poi all’esposizione della tesi scotista-suáreziana che rein-terpreta ponendo al centro il problema della struttura dell’ente, entro la cui lo-gica viene pensato Dio, ente infinito. Infatti, per Scoto l’effettività non è un’en-tità particolare, «omnino realiter distincta ab entitate essentiae», bensì un mo-dus eius, una modalità, e cioè è in altro ex natura rei, per la natura della cosa, ilche significa che qualcosa è formaliter, stando alla sua forma, in altro, perché inciò esso permane sul fondamento della sua quidditas.
«Applicato al nostro esempio – aggiunge Heidegger – questo significa: l’esistenza, l’ef-fettività, appartiene effettivamente ad una creatura effettiva, cioè, per usare una ter-minologia kantiana, l’esistenza non ha per fondamento una relazione della res al con-cetto, all’apprensione intellettuale, ma per Scoto l’esistenza appartiene effettivamen-te all’ente effettivo, pur senza essere una res»44.
La sussistenza si dà là dove qualcosa sussiste, entro cui si trova, da cui si di-stingue in quanto ad esso appartiene, non perché abbia un contenuto essenzia-
41 HEIDEGGER, I problemi fondamentali..., 86.42 HEIDEGGER, I problemi fondamentali..., 87.43 HEIDEGGER, I problemi fondamentali..., 89.44 HEIDEGGER, I problemi fondamentali..., 89.
Il carattere oggettivo dell’ente scotista nella lettura di Martin Heidegger 259
le essente per sé, una res particolare con una propria realtà. «La distinctio for-malis scotistica – nota Heidegger – è una soluzione davvero acuta»45. Il richia-mo a Suárez è preceduto dal rilievo che la sua soluzione «sostanzialmente si ac-corda con quella di Scoto», lungo la cui direzione la distinctio tra essentia ed exi-stentia in ente creato è qualificata come «distinctio rationis ratiocinata», ossiacome distinctio rationis cum fundamento in re. Il che significa che tale distin-zione non è legata prevalentemente al modo dell’apprensione e al grado della suachiarezza, bensì alla cosa stessa. Tale distinctio è detta ratiocinata in quanto mo-tivata da ciò che nello stesso ratiocinari obicitur, viene gettato contro, per que-sto detta ratiocinata. Si comprende allora perché questa distinctio ratiocinata ri-fluisca nella distinctio modalis o formalis di Duns Scoto.
La preferenza accordata alla linea Scoto-Suárez è motivata dal fatto che que-sta ontologia non pare ad Heidegger che sia sostanzialmente legata alla pro-spettiva teologica della creazione. È possibile sciogliere la struttura dell’ente daqualsiasi accento teologico, senza con questo tradirne l’indole o non rispettarnela strategia filosofica. Il che risulta più evidente dalle riflessioni di Heidegger inmerito alla relazione Suárez-Aristotele circa alcune implicazioni della distinctiorationis ratiocinata tra l’essenza e l’esistenza.
3. Opacità teoretica della categoria della creazione
L’“essere”, allorché è attribuito a una cosa qualsiasi – nota Suárez al seguito diAristotele – non aggiunge alcunché. Così, ad es., dire homo e dire ens homo è lastessa cosa. In ogni ente, pensato come effettivo o pensato come possibile, è pen-sato anche l’essere, effettivo o possibile. Il che significa che l’esistenza, comevoleva Kant, non aggiunge alcunché all’essenza effettiva. Ebbene, questa tesiviene proposta non in funzione della creazione o produzione, bensì a chiarimentodell’ente che si offre e si dà. Tale tesi
«non muove dalla necessità di una possibile creazione, ma cerca di risolvere a livellodel dato effettivo stesso il problema del rapporto fra l’essenza e il modo di essere. [...] Ildato effettivo vale come istanza primaria. In vista di esso l’effettività non può affatto mo-strarsi a sua volta come qualcosa di effettivo e di legato effettivamente, come un ens, al-l’essentia»46.
Alla domanda perché mai i filosofi non ci abbiano offerto una più originaria in-terpretazione dell’essenza e dell’esistenza, Heidegger risponde che la ragione vacercata nel fatto che
45 HEIDEGGER, I problemi fondamentali..., 89.46 HEIDEGGER, I problemi fondamentali..., 94.
260 Orlando Todisco
«Ci si attiene all’incrollabile convinzione che l’ente debba venir compreso come crea-to da Dio. A causa di questa spiegazione ontica diviene a priori impossibile il sorgeredi una questione ontologica. Soprattutto, però, vien meno in tal modo la possibilità diinterpretare questi concetti. Manca infatti, l’orizzonte entro cui impostare la questio-ne, manca la possibilità, per dirla con Kant, di stabilire il certificato di nascita di talinozioni e di dimostrarne l’autenticità»47.
Occorre abbandonare la logica della “creaturalità” e collocarsi entro l’orizzontedella “fatticità della vita” con la conseguente deteologizzazione dell’antropolo-gia.
Dunque, l’ontologia di segno creazionista dà luogo a una sequenza di nozio-ni senza luce, perché di carattere sostanzialmente ontico. Ritenendo il tema del-la creazione deviante e improduttivo, Heidegger si accosta all’ontologia medie-vale e a quella scotista-suáreziana come a un’acuta riflessione sul dato, sullarealtà o effettività, cancellando qualsiasi traccia teologica48.
«L’effettività – scrive Heidegger – appartiene all’ente effettivo e lo rende tale pur sen-za essere essa stessa qualcosa d’effettivo. È vero che nella concezione cristiana l’ef-fettuazione dell’ente è compiuta da Dio, ma l’ente effettivo sussiste in quanto tale, perdir così, assolutamente per sé, è un ente per sé. [...] Certo, l’effettività appartiene al-l’ente effettivo, ma non è a sua volta qualcosa di effettivo, bensì è un quid entis e, inquanto tale, è un concreatum quid, ossia, anche, una dispositio entis, uno stato del-l’ente. Riassumendo, possiamo affermare: l’effettività non è una res e tuttavia non èneppure nulla. Essa non è interpretata, come accade in Kant, in rapporto al soggettodi un’esperienza, ma in relazione al creatore. Qui l’interpretazione svolta in un vicolocieco e non può più fare un passo»49.
La strada della relazione causale di segno creativo non consente di gettare lucesull’ontologia di Scoto. A tale scopo, occorre risalire alle origini greche. Ecco lavia maestra! Da Scoto verso i greci per comprendere pienamente Scoto. Il Diobiblico è inferiore agli dèi greci, perché quello in quanto creatore domina le suecreature, questi, invece, sono l’essere stesso rivolto verso gli enti. Mentre il diobiblico comanda, gli dèi greci mostrano, fanno segno.
È quanto Heidegger ribadirà nell’Einführung in die Metaphysik del ’35 a pro-posito del Logos eracliteo e del Logos giovanneo, nel cui contesto si comprende for-se meglio l’impossibilità della “filosofia cristiana”. Comparando il Logos giovan-
47 HEIDEGGER, I problemi fondamentali..., 94-95.48 HEIDEGGER, I problemi fondamentali..., 97: «Abbiamo visto che i sostenitori della terza dottrina
(Scoto-Suárez) hanno cercato di dirigere lo sguardo verso ciò che è dato, e di rinvenire e determinare l’ef-fettività sul piano dell’ente effettivo».
49 HEIDEGGER, I problemi fondamentali di fenomenologia..., 98.
Il carattere oggettivo dell’ente scotista nella lettura di Martin Heidegger 261
neo al Logos eracliteo, egli segnala innanzitutto la distanza: «Nel Nuovo Testa-mento il Logos non significa affatto, come in Eraclito, l’essere dell’essente, l’in-sieme raccolto degli antagonismi, ma un essere particolare: il Figlio di Dio. E que-sti nella sua funzione di mediatore fra Dio e l’uomo»50. Ora, ciò che va notato è for-se l’indole della mediazione che il Logos esercita tra Dio e l’uomo, ricondotta allapura trasmissione di ordini e letta nel quadro della relazione hegeliana di padro-ne-servo, sullo sfondo della chiusura preconcetta a quel “non pensato” o forse“non-pensabile” quale è appunto l’irrompere dell’infinito nella mortalità dellacarne.
«In che senso è egli (il Figlio di Dio) il lógov? Giacché lógov è nella traduzione grecadell’A.T. (dei settanta) il nome dato alla parola, e “parola” è presa qui nel significatoben determinato di ordine, comandamento; oi™ déka lógoi sono i dieci comandamenti diDio (il Decalogo). Così lógov significa: kñrux, a¢ggelov: l’araldo, il messaggero che tra-smette i comandamenti, gli ordini; lógov toû stauroû è la parola che proviene dallaCroce. Il messaggio della Croce è Cristo stesso: egli è il logos della Redenzione, del-la vita eterna: lógov zwñv. Un abisso separa tutto ciò da Eraclito»51.
A buon diritto, pare, R. Girard, dopo aver rilevato che la differenza più signifi-cativa tra Heidegger e i suoi predecessori consiste nella trasformazione della re-lazione di mutua tolleranza tra i due Logos in una relazione di segno antagoni-stico, aggiunge:
«Il Logos giovanneo non è affatto ciò che Heidegger ne fa quando l’interpreta, sullabase del Decalogo, come una specie di servo atterrito e autorizzato solo a trasmetteregli ordini di un padrone feroce [...]. Non è ammissibile vedere in Gesù l’araldo che inlui vede Heidegger, il portavoce occasionale, la semplice cinghia di trasmissione inuna macchina burocratica e autoritaria. [...] Il rapporto tra Padre e Figlio non può es-sere di subordinazione atterrita»52.
Ma quale l’origine dell’immagine del Dio creatore come Dio del comando, chenon fa segni ma dà ordini inequivocabili, di cui anche il Figlio non è che me-diatore e messaggero fedele? Seguendo Heidegger occorre forse passare dallacreazione alla produzione, o meglio ritornare alla creazione attraverso la produ-
50 M. HEIDEGGER, Einführung in die Metaphysik, GA Bd. 40, hrsg. v. P. Jaeger, Klostermann, Frank-furt am Main 1983, trad. it. di G. Masi, Introduzione alla metafisica, Mursia, Milano 1966, 143. Nel 1954,in una lettera a Kästner egli dice di preferire alla teologia cattolica, essenzialmente cristologica, la teolo-gia ortodossa, perché nel suo approccio alla Trinità muove dallo Spirito Santo, «una sorgente nascosta peril rinnovamento del pensiero teologico» (M. HEIDEGGER - E. KÄSTNER, Briefwechsel 1953-1974, hrsg. v.H.W. Petzet, Insel, Frankfurt am Main 1986, 221).
51 HEIDEGGER, Introduzione alla metafisica, 143.52 R. GIRARD, Des choses cachées depuis la fondation du monde, trad. it. di R. Damiani, Delle cose na-
scoste sin dalla fondazione del mondo, Adelphi, Milano 1983, 335.
262 Orlando Todisco
zione, e dunque procedere dai medievali ai greci, ai quali, se è estraneo il con-cetto di creazione, non lo è il concetto di produzione. Ed è questa l’operazionedi Heidegger, e cioè leggere la creazione attraverso la produzione, con il risul-tato di fare del creato un prodotto a disposizione del produttore. È l’operazioneche egli ritiene necessaria per cogliere nella sua dinamicità l’esistenza come mo-do d’essere dell’essenza. Vediamo come ciò abbia luogo. Il passaggio dall’exi-stentia e dall’essentia all’actualitas, all’actus, all’agere, rimanda al soggetto, manon, come in Kant, al soggetto dell’apprensione, bensì al soggetto come ente at-tivo o meglio come produttore. Dunque,
«l’orizzonte interpretativo dell’esistenza come actualitas [...] muovendo dal senso del-l’effettività così come era inteso nel mondo antico e nella scolastica, l’actualitas mo-stra chiaramente di esser compresa a partire dall’atteggiamento produttore dell’esser-ci. Se questo è vero, allora è necessario mostrare che anche il concetto di realtà e quel-lo di essentia, e con essi tutte quelle nozioni che abbiamo enumerato come sinonimi diessentia (quidditas, natura, definitio, forma), debbono esser comprese a partire dall’o-rizzonte dell’atteggiamento produttore»53.
Ecco la prima fondamentale virata. Ora, nell’ottica del produrre, ciò che vienprodotto appare sussistente in se stesso, disciolto cioè dal rapporto col produt-tore. L’esser-prodotto, l’effettività, in quanto esser-effettuato, si rapporta al pro-duttore, senza però che tale rapporto pregiudichi l’affrancamento del prodottodal produttore e dunque la sua sussistenza, non incompossibile con l’essere-a-disposizione-del-produttore. Sussistenza e disponibilità stanno insieme54.
A conferma della plausibilità della sua operazione, Heidegger si chiede co-me mai la filosofia greca, cui è estraneo il concetto di creazione, ma non quellodi produzione, «sia stata accolta nel medioevo dalla teologia cristiana»55. La ri-sposta è che, anche se caratterizzato dal fatto che non presupponga alcunché,l’atto creativo non è estraneo al carattere ontologico dell’atto produttivo, anzi neripete la logica. Infatti,
«l’ontologia antica, nei suoi fondamenti e nei suoi concetti-base, nonostante la sua dif-ferente origine, era, per così dire, tagliata su misura per la concezione cristiana e peril suo modo di concepire l’ente come ens creatum. Dio, l’ens increatum, era proprioquell’ente che non aveva bisogno di essere prodotto e risultava perciò la causa primadi tutti gli altri enti. [...] Grazie a una tale trasformazione attuatasi nel medioevo l’on-tologia antica, attraverso Suárez, fece il suo ingresso nell’età moderna»56.
53 HEIDEGGER, I problemi fondamentali..., 97.54 HEIDEGGER, I problemi fondamentali..., 109.55 HEIDEGGER, I problemi fondamentali..., 113.56 HEIDEGGER, I problemi fondamentali..., 113.
Il carattere oggettivo dell’ente scotista nella lettura di Martin Heidegger 263
Ecco il percorso, attraverso cui Heidegger trova sostegni alla sua ipotesi onto-teologica, preparata nel medioevo e affermatasi nella modernità. L’ontologia sco-tista-suareziana è il luogo preparatorio di quella modernità, caratterizzata dalprimato dell’ente sull’essere, nel contesto di quella desertificazione del reale, aopera del produttore supremo, nel quale soltanto si trova la ragion d’essere del-l’ens creatum. Se la ragione del creato è fuori del creato, e cioè nel creatore, adifferenza della physis greca, che ha in sé la ragione del suo essere, il mondo è,in tale logica creativa pura res e sola res. Il mondo è solo mondo57. Ma l’atto crea-tivo equivale forse all’atto produttivo? Proprio perché presuppone qualcosa, laproduzione non è forse espressione della potenza del produttore, chiamato, nel-la produzione, a dimostrare la capacità di dominare ciò che preesiste modifi-candolo? La creazione, invece, proprio perché non presuppone alcunché (ex ni-hilo sui et subiecti), non va intesa forse come atto di donazione, gratuita, senzaperché ma non senza senso? Davvero la logica della produzione aiuta a inten-dere la logica della creazione nel passaggio dal medioevo al mondo greco non siperde qualcosa di teoricamente rilevante?
4. Heidegger e Scoto teorici di una «destrutturazione» divergente
Il tentativo di riportare la creazione sul terreno della produzione rinvia all’ope-razione che nella conferenza Fenomenologia e teologia (1927)58 viene presenta-ta come propria della filosofia e cioè scavare sotto i concetti ontici perché se neintraveda il fondo ontologico. Il filosofo è fedele alla filosofia se in grado di li-berare il pensiero tradizionale da quei rivestimenti metafisici che ne soffocano
57 Dopo aver fatto riferimento alla critica di Scoto al Dio di Aristotele, perché estraneo alla concezionedell’essere, le cui proprietà fondamentali sono la causalità e la producibilità, richiamando il panorama chescaturisce da un Dio onnipotente, come quello del Dottor sottile, M. Ruggenini scrive: «Ciò che esprimenel modo più netto la distanza insormontabile che separa il pensiero cristiano da quello greco, e li fa ap-partenere a mondi collegati, ma semplicemente intraducibili l’uno nell’altro, nonostante ogni conclamatacontinuità speculativa, è proprio la riduzione della natura a prodotto dell’onnipotenza divina» (M. RUGGE-NINI, Il Dio assente. La filosofia e l’esperienza del divino, Milano, Mondadori 1997, 53). Ma allora, quale ladifferenza tra “artificiale” e “naturale”? Nella prospettiva creazionista il mondo diventa puro “artefatto”solo se si pensa Dio come un artigiano (Demiurgo) e l’atto creativo come un agire meccanico artificiale. Siè ancora fermi alle obiezioni di Plotino al creazionismo cristiano. Accennando alla “clausura” dell’Uno diPlotino, dopo averne mostrato l’efficacia teoretica, V. Mathieu rileva come fondamentale difetto, la man-canza di «un’esternità – sia pur minima e la minima possibile – rispetto all’Uno, che giustifichi l’ek o il pas-saggio. Per tale carenza Plotino non riesce a soppiantare del tutto il concetto biblico di creazione, ma soloa correggerne il carattere antropomorfico. Se non fosse che per questo, potremmo essere neoplatonici sen-za bisogno di esser cristiani (come a un certo momento si sperò, ma invano)» (V. MATHIEU, Plotino fenome-nologo dell’Uno, in V. MELCHIORRE (a cura di), L’Uno e i molti, Vita e Pensiero, Milano 1990, 215).
58 M. HEIDEGGER, Phänomenologie und Theologie (1927), in Wegmarken, GA Bd. 9, hrsg v. F.-W. vonHerrmann, Klostermann, Frankfurt am Main 1976; trad. it. a cura di F. Volpi, Fenomenologia e teologia,in Segnavia, Adelphi, Milano 1987, 3-34.
264 Orlando Todisco
ogni autentica possibilità. A questa condizione e con questo obiettivo, la filoso-fia può contribuire al chiarimento della base ontologica del discorso biblico-po-sitivo, altrimenti destinata a restare occultata. Infatti, «ogni interpretazione on-tica si muove sul fondamento, anzitutto e per lo più nascosto, di un’ontologia»59,e il discorso teologico è ontico. Anche se non può dirsi propriamente empirica,perché implica il coinvolgimento dell’esistenza con tutte le sue virtualità, la fe-de teologale resta un evento storico e la teologia una scienza ontica, incapace difavorire l’auto-interpretazione dell’essere della vita storico-fattuale e di renderepossibile una radicale esperienza di sé. Solo la filosofia indirizza lo sguardo sul-l’essere stesso, confermandosi “scienza ontologica”, in grado «di liberare e diavviare allo svelamento dell’origine specifica, cioè conforme alla fede, dei con-cetti teologici»60. Questo compito di sostegno al pensare teologico non è tuttaviaessenziale alla filosofia, che resta se stessa anche se non dà vita a tale esplora-zione. La teologia ha bisogno della filosofia, ma non viceversa61. Ora, anche Sco-to avvia una radicale de-strutturazione del pensiero ereditato, ma nella direzio-ne opposta alla logica de-costruttiva di Heidegger. La cosa va rilevata, ai fini diuna corretta valutazione dell’interpretazione heideggeriana dell’ontologia scoti-sta. Per Heidegger infatti, è l’autointerpretazione della vita (filosofia) che fungeda correttivo ontologico dei concetti propriamente teologici, per Scoto invece èl’orizzonte teologico che funge da “correttivo ontologico” dei concetti filosofici,perché costituiscano la rete che accolga la parola di Dio, senza soffocarla o tra-visarla. Se è la teologia che restituisce la filosofia a se stessa, privandola di ruo-li incongrui, come quello di indicare cosa pensare e come essere, oramai ap-pannaggio della parola di Dio, occorre dire che le scelte di fondo di Scoto nonconsentono l’intesa con Heidegger, se non su questioni marginali.
Infatti, l’ens in quantum ens, oggetto dell’intelletto, Scoto non l’interpreta co-me nuovo cominciamento del filosofare, bensì come universale disponibilità adaccogliere quanto può giunger in dono dal Dio rivelante, senza che questo com-porti un mutamento sostanziale dell’intelletto stesso. L’ens in quantum ens indi-ca questa apertura dell’intelletto, cui la filosofia greca non poteva pervenire, in-cline piuttosto a identificare l’essere con il dover essere, abbaglio inevitabile dalmomento che ignorava la successione teologica degli “stati” (di caduta e di re-denzione), e cioè che non siamo come dovremmo o come saremo62. Il processo
59 HEIDEGGER, Fenomenologia e teologia, 19.60 HEIDEGGER, Fenomenologia e teologia, 21.61 HEIDEGGER, Fenomenologia e teologia, 22: «La filosofia è il possibile correttivo ontologico che in-
dica formalmente il contenuto ontico, cioè precristiano, dei concetti teologici fondamentali. La filosofiaperò, può essere ciò che è, anche senza svolgere effettivamente questa funzione di correttivo».
62 IOANNES DUNS SCOTUS, Ord. I, d. 3, p. 1, q. 3, n. 113: «Contra: istud non potest sustineri a theologo,quia intellectus, existens eadem potentia naturaliter, cognoscet per se quiditatem substantiae immateria-
Il carattere oggettivo dell’ente scotista nella lettura di Martin Heidegger 265
di de-costruzione serve a Scoto a mostrare la distanza tra il concetto, disponibi-le nello status iste, e il reale, e a misurare l’angustia della capacità esplorativadell’intelletto rispetto ai traguardi svelati dalla parola di Dio. L’occhio del teolo-go è reso più acuto da quanto la rivelazione divina ha detto in merito al defectumnaturae e alla necessitas gratiae. La filosofia deve accogliere la lezione della ri-velazione, rispetto a cui svolgere una funzione conclusivamente ancillare63. PerScoto solo la teologia è in grado di valutare la portata dell’intelletto, perché, co-noscendo il suo futuro di gloria, ne protegge la disponibilità ad accogliere la vi-sione stessa di Dio, qualora sopraggiunga in totale gratuità. Il sapere metafisicoche, secondo il peripatetismo greco-arabo, sarebbe in grado di procurare la fe-licità, appartiene alla “metafisica in sé”, non alla metaphysica nostra”, quale èpossibile nello status iste. La conoscenza del Primo, che Aristotele riteneva for-ma suprema di felicità riservata al sapiente, non compete alla metafisica pro sta-tu isto, il cui compito non è di saldare o acquietare ma di proteggere l’aperturadel nostro essere al trascendente, qualora questo liberamente si offra e si riveli.Ebbene, l’ente in quanto ente di Scoto è il compendio del movimento decostrut-tivo nei riguardi della filosofia classica64. La controversia tra i filosofi e i teolo-gi, nel quadro dell’averroismo medievale65, Scoto tende a superarla disartico-lando i saperi, e insieme recuperando l’ontologia quale insieme di condizioni mi-nimali ma essenziali di qualsiasi sapere66. Ebbene, sono ancora tali condizioniminimali che Scoto propone come necessarie nel dibattito con Enrico di Gandai fini della spiegazione dell’atto creativo divino, gratuito e nel tempo. All’esse
lis, sicut patet secundum fidem de anima beata. Potentia autem manens eadem non potest habere actumcirca aliquid quon non continetur sub suo primo obiecto». E O. Boulnois ha scritto in modo incisivo: «Il(homme) n’est pas l’intermédiaire d’une hiérarchie, mais le centre d’une histoire» (O. BOULNOIS, Intro-duction a J. Duns Scot. Sur la connaissance de Dieu et l’univocité de l’étant, PUF, Paris 1988, 49).
63 IOANNES DUNS SCOTUS, Ord. Prol. n. 28: «(I filosofi) accipiunt naturam nostram vel potentiam intel-lectivam esse nobis naturaliter cognoscibilem; quod falsum est, sub illa ratione propria et speciali subqua ad talem finem ordinatur, et sub qua capax est gratiae consumatae, et sub qua habet Deum pro per-fectissimo obiecto. Non enim cognoscitur anima nostra a nobis nec natura nostra pro statu isto nisi subaliqua ratione generali, abstrahibili a sensibilibus [...] Et secundum talem generalem rationem non con-venit sibi ordinari ad illum finem, nec posse capere gratiam, nec habere Deum pro obiecto perfectissi-mo». Che la funzione di modo d’essere e di pensare, propria della filosofia antica, sia passata nel Me-dioevo alla teologia, cifra di un nuovo modo d’essere e di pensare, dettato dalla parola divina, è al centrodegli studi di P. HADOT, del quale sono disponibili in versione italiana: Esercizi spirituali e filosofia anti-ca, Torino, Einaudi 1988; La cittadella interiore. Introduzione ai “Pensieri” di Marco Aurelio, Vita e Pen-siero, Milano 1996. Inoltre cf. J. DOMANSKI, La philosophie, théorie ou manière de vivre?, Cerf, Paris 1996.
64 O. BOULNOIS, Analogie et univocité selon Duns Scot. La double destruction, «Les Etudes philosophi-ques», 62 (1989), 347-369.
65 Cf. quanto ho scritto in Averroè nel dibattito medievale, FrancoAngeli, Milano 1999.66 IOANNES DUNS SCOTUS, Ord. I, d. 3, p. 1, q. 3, n. 17: «Nulla scientia de suo obiecto primo quaerit “si
est” vel “quid est”, ergo vel omnino non est quaeribile, vel tantum in scientia priore; prima nulla est prior;ergo de eius primo subiecto nullo modo est quaeribile “si est” vel “quid est”. Ergo conceptus simplicitersimplex, ergo ens».
266 Orlando Todisco
essentiae e all’esse existentiae, con cui il maestro belga cercava di render contodell’atto creativo divino, eterno – esse essentiae – e insieme temporale e libero –esse existentiae – Scoto oppone l’ens in quantum ens, sufficiente per render con-to sia della gratuità che della radicale novità del mondo a opera del gesto crea-tivo divino. Essendo ciò cui non ripugna l’essere, l’ente in quanto ente diventacifra di ciò che può venire all’essere perché non-contraddittorio, ed essendo so-lo non-contraddittorio, senza alcun diritto a essere, se viene all’essere, il suo es-sere è dono gratuito di colui che poteva non volerlo o volerlo altrimenti. Per mi-surare l’interesse di Scoto per questo passaggio, si evochi quanto dice in meritoal problema se qualcosa debba ritenersi intelligibile in collegamento all’intel-letto divino o invece debba dirsi tale etsi Deus non daretur, con l’intento di in-dicare cosa sia realmente indipendente dalla fonte creatrice. In breve, l’esseredelle idee è da sé e per sé o invece è espressione dell’intelletto pensante? Eb-bene, l’intelligenza divina non dipende dall’intelligibile, quasi che si dia qual-cosa che sia anteriore o indipendente rispetto all’intelligenza divina67. Caduta lasubordinazione all’essere del conoscibile – pilastro del platonismo-agostiniano– non resta che la coeternità di Dio e delle idee. Ed è appunto la tesi di Scoto,per il quale l’intelligibilità delle cose va ricondotta alla non-contraddizione opossibilità delle cose, e dunque all’ens in quantum ens68.
L’interpretazione scotista della metafisica ha una profonda motivazione teolo-gica, cui l’ontologia dell’ente in quanto ente, pur autonoma, si rivela in ultimaanalisi funzionale; mentre l’interpretazione heideggeriana ha una motivazionepropriamente filosofico-antropologica, nel senso che parte dalla pre-compren-sione dell’essere che l’esistenza umana ha di se stessa. Heidegger è intransigen-te. Il pensiero è in fondo un pensiero “ateo” (gottlos), al di qua delle decisioni siaa favore che contro l’esistenza di Dio. Egli ritiene aporetico l’accostarsi al tempopartendo dall’eterno e dunque l’occuparsi della creatura muovendo dal creatore.Il tempo lo si comprende partendo dal tempo e restando in esso69, altrimenti si ca-
67 IOANNES DUNS SCOTUS, Ord. I, d. 35, q. u., n. 31: «Potest concedi quod sunt relationes aeternae inDeo ad cognita, sed non priores naturaliter ipsis cognitis in ratione obiectorum».
68 IOANNES DUNS SCOTUS, Ord. I, d. 35, q. u. n. 32: «Deus in primo instanti intelligit essentiam suamsub ratione mere absoluta; in secundo instanti producit lapidem in esse intelligibili et intelligit lapidem,ita quod ibi est relatio in lapide intellecto ad intellectionem divinam, sed nulla adhuc in intellectione di-vina ad lapidem». Scoto si interroga sullo statuto dell’intelligibile, di cui difende l’autonomia purché iden-tificata con quella non-contraddizione o opposizione al nulla, a cui va ricondotto l’ens in quantum ens. Inmaniera rapida: «Unde lapis dicitur “ad se” primo, sed ex perfectione sua includit respectum» (IOANNES
DUNS SCOTUS, Lectura II, d. 1, qq. 4-5, n. 258). Come Scoto si sottragga alla tentazione cartesiana di faredi Dio il creatore delle verità eterne, cui è riconducibile un filone rilevante della modernità, cf. A. PETIT,J. Duns Scot et Gudworth. La quaestio augustinienne De Ideis, «Revue de Sciences Philosophiques etThéologiques», 83 (1999), 79ss.
69 M. HEIDEGGER, Der Begriff der Zeit (1924), Niemeyer, Tübingen 1985; trad. di F. Volpi, Il concettodi tempo, Adelphi, Milano 1989, 24: «Il filosofo non ha fede. Se il filosofo domanda del tempo, egli è ri-
Il carattere oggettivo dell’ente scotista nella lettura di Martin Heidegger 267
de vittima della pseudo-eternità che ostacola la comprensione dell’essere dellavita, mortificandone l’essenziale motilità. Se Scoto con l’ontologia dell’ente inquanto ente cerca di non oscurare la gratuità di tutto ciò che è, né di far velo allaparola di Dio come parola-guida del pensare e dell’essere, con un taglio criticoverso la filosofia pagana dovuto alla coscienza dello status iste; Heidegger, rile-vando che «ogni concetto teologico racchiude necessariamente in sé la com-prensione dell’essere che l’esserci umano, come tale, ha di per sé in quanto in ge-nerale esiste»70, suggerisce di accostarsi alla parola divina attraverso la sua on-tologia-antropologia o Dasein. È la griglia di lettura che Rudolf Bultmann, con cuiHeidegger si confrontava a Marburgo (1923-1928), assunse entusiasticamente71,attirandosi però l’accusa da parte di Th. Barth di ricadere in una lettura antropo-logica del cristianesimo72. Quanto sia problematica la precomprensione di Dio edella sua parola attraverso l’analisi dell’esistenza, risulta dal fatto che questa vie-ne presentata nella sua ‘naturale bontà’, con quel taglio mitico-pagano73, che malsi concilia con la prospettiva storico-salvifica entro cui l’evento cristiano si col-loca e ha senso. D’altra parte, la storicità del Dasein non pare che scongiuri quel-l’antropocentrismo che Heidegger ha pur così lucidamente diagnosticato, comel’esito di quel cammino, intrapreso nell’età moderna, quando a supporto della sto-ria l’uomo venne messo al posto di Dio.
A sostegno dello scontro dei due atteggiamenti, si potrebbe richiamare perun verso il Prologo all’Ordinatio, in cui, ad apertura, Scoto si chiede «Utrum ho-mini pro statu isto sit necessarium aliquam doctrinam supernaturaliter inspira-
soluto a comprendere il tempo partendo dal tempo, ovvero dall’a¬eí, il quale ha l’aspetto dell’eternità masi rivela come un mero derivato dell’essere-temporale».
70 HEIDEGGER, Il concetto di tempo, 20. Alludendo al concetto filosofico di colpa come «determinazio-ne ontologica originaria dell’esistenza dell’esserci», incluso nel concetto teologico di peccato, Heideggernota che «se si assume in questo modo il concetto ontologico di colpa come filo conduttore, allora è pro-pria la filosofia che decide in modo primario del concetto teologico» (HEIDEGGER, Il concetto di tempo, 20).Per una critica penetrante, in linea con il taglio teoretico fin qui seguito, cf. H. BIRAULT, Philosophie etThéologie. Heidegger et Pascal, in “Cahier de L’Herne” (Heidegger), éd. de L’Herne, Paris 1983, 515-541.
71 R. BULTMANN, Nuovo Testamento e mitologia. Il manifesto della demitizzazione, Queriniana, Brescia1970. Nell’importante saggio Il problema della “teologia naturale” (1931), in Credere e comprendere (Que-riniana, Brescia 1977) Bultmann spiega perché ai praeambula fidei della dottrina tomistica abbia prefe-rito l’analitica esistenziale heideggeriana.
72 Per l’approfondimento del problema cf. A. MAGRIS, Rudolf Bultmann e la dialettica della demitiz-zazione, «Teoria», 19 (1999), 99-132. W. Pannenberg ritiene che K. Lehmann ha sicuramente ragione nelritenere che Bultmann, attenuando le intenzioni di Heidegger circa la riproposizione del problema del-l’essere, le quali vanno al di là dell’analitica esistenziale, abbandoni «sin dall’inizio la reale problemati-ca heideggeriana». Si comprende da ciò come Bultmann non abbia più preso parte allo sviluppo succes-sivo del pensiero di Heidegger (R. BULTMANN, Teologia e filosofia, Queriniana, Brescia 1999, 293).
73 A supporto si ricordi che a partire dagli anni Trenta, Heidegger è decisamente interessato al mon-do greco, il che spiega il suo rapporto di amicizia con W. F. Otto, forse più congeniale di quello con Bult-mann. Per il taglio mitico-greco che Heidegger dà al suo discorso cf. A. MAGRIS, I concetti fondamentalidei Beiträge di Heidegger, «Annuario filosofico», 8 (1992), 248-258.
268 Orlando Todisco
ri», con l’evidente primato accordato al dato rivelato, come a quello teologico ri-spetto a quello naturale e filosofico; e per l’altro, per quanto concerne Heideg-ger, la conferenza su Fenomenologia e teologia, tenuta per la prima volta a Tu-binga nel ’27, ripetuta a Marburgo nel ’28, e poi pubblicata riproducendo il te-sto della seconda parte della conferenza marburghese intitolata La positività del-la teologia e il suo rapporto con la fenomenologia, cui Heidegger aggiunse il con-tenuto di una lettera relativa al dibattito su Il problema di un pensiero e di un lin-guaggio non oggettivanti nella teologia odierna. Tra i brani emblematici, si leg-ga il n. 5 del Prologo, nel quale Scoto così compendia la «controversia inter phi-losophos et theologos»:
«Et tenent philosophi perfectionem naturae, et negant perfectionem supernaturalem;theologi vero cognoscunt defectum naturae et necessitatem gratiae et perfectionem su-pernaturalem»74,
titolari i teologi di un sapere che va ben oltre quello dei puri filosofi. E a propo-sito dell’opera di Heidegger, si legga il brano, riassuntivo di un ampio discorso,più sopra richiamato, nel quale è scritto:
«La filosofia è il possibile correttivo ontologico che indica formalmente il contenutoontico, cioè precristiano, dei concetti teologici fondamentali. La filosofia può essereciò che è, anche senza svolgere effettivamente questa funzione di correttivo»75.
Se nella controversia ridimensiona le pretese e rettifica la prospettiva dei filo-sofi del tempo, Scoto non esiterebbe a criticare quanto Heidegger dice intornoalla sua ontologia dell’ente in quanto ente, non perché falso, ma perché non inlinea con la sua strategia teoretica, dal momento che si rifiuta di prendere in esa-me l’auspicato raccordo tra l’indole univoca di tale ontologia e la teologia. L’in-sistenza di Scoto sul carattere neutro dell’ente in quanto ente e dunque sul suopeso ontologicamente minimale è dovuta al bisogno di garantire uno spazio ac-cogliente alla rivelazione del Dio vivente, e l’apertura universale all’intelletto,perché quella parola non giunga indecifrata e inintelligibile.
5. È ontoteologica la metafisica di Scoto?
La risposta negativa è sostenuta dall’assunto che Scoto pensa l’ente in quanto en-te come la “cosa più universale”, ma non come la “cosa suprema”, né come la pre-
74 IOANNES DUNS SCOTUS, Ord. Prol., n. 5.75 HEIDEGGER, Fenomenologia e teologia, 22.
Il carattere oggettivo dell’ente scotista nella lettura di Martin Heidegger 269
messa che in positivo abiliti a pensare “la cosa suprema”, quasi che il modo d’es-sere infinito con il suo potere singolarizzante si trovi all’interno della stessa di-mensione. L’ontologia di Scoto non è possibile sottoporla ad alcuna azione de-co-struttiva perché frutto a sua volta di un radicale movimento de-costruttivo, il cuiobiettivo è di fare emergere la disparità tra ciò che possiamo ricevere e ciò chepossiamo conquistare76, e di ribadire che un’autentica elevazione oltre la naturapro statu isto è opera gratuita di un ente, di là dal nostro orizzonte attuale, ma nonfuori della logica dell’ens in quantum ens77. L’ens in quantum ens custodisce l’a-pertura dell’intelletto sul reale, senza limite alcuno; indica il tracciato lungo ilquale si svolge l’attività conoscitiva pro statu isto; e infine, impedisce che la pa-rola divina appaia superflua e ci trovi sordi o estranei al suo appello.
Oltre che oggetto proprio dell’intelletto, l’ente in quanto ente non è forse an-che il soggetto della metafisica, coprendo per intero il territorio del reale, al pun-to che più nulla pare si sottragga alla nostra comprensione? Non deve dirsi, ta-le ontologia, fondante e possibilitante la teologia come una parte speciale del suosistema assoluto? non garantisce forse l’universale pensabilità di tutto ciò che è,sicché finito e infinito debbano dirsi inferiora rispetto al concetto unitario e ge-nerale di ente? Ma è poi vero che siffatta ontologia dell’ente in quanto ente dicarattere univoco, anteriore alle sue determinazioni, sostanza e accidente, fini-to e infinito, possa dirsi fondante e possibilitante la stessa teologia?
Innanzitutto, l’ens in quantum ens di Scoto è altra cosa rispetto all’ens in quan-tum ens di Tommaso. Se l’Aquinate scrive che l’«ens commune est proprius ef-fectus causae altissimae, scilicet Deus», Scoto annota che «sed istud non capio,sicut enim unumquodque habet essentiam ita et esse, quia omnis essentia est perse actus»78; e se Tommaso, ribadendo tale dipendenza causale, rileva che l’attri-butio ad Deum appartiene essenzialmente all’essenza di ogni ente, alla sua enti-tas79, Scoto nota che l’attributio ad Deum non è costitutiva dell’ente in quanto en-
76 IOANNES DUNS SCOTUS, Ord. Prol., n. 75: «Et si obiicitur quod istud vilificat naturam quod ipsa nonpossit consequi perfectionem suam ex naturalibus... Nunc autem illam concedo posse haberi naturaliter,et ultra, dico aliam eminentiorem posse recipi naturaliter. Igitur in hoc magis dignificatur natura, quamsi suprema sibi possibilis poneretur illa naturalis».
77 IOANNES DUNS SCOTUS, Reportata Parisiensia. Prologus (abbr.: Rep. Par.), q. 3, a. 3, n. 7, ed. Wad-ding, Lyon 1639: «Dico quod potentia passiva non est frustra in natura, quia etsi per agens naturale nonpossit principaliter reduci ad actum, tamen potest per tale agens dispositio ad ipsum induci, et potest peraliquod agens in natura – id est in tota coordinatione essendi vel entium – puta per agens primum vel su-pernaturale complete reduci ad actum».
78 IOANNES DUNS SCOTUS, Rep. Par. IV, d. 12, q. 1, n. 4. E nel De Primo Principio: «Hoc reputo nihilvalere, quia secundum ipsos, Angelus immaterialis non est infinitus. Numquid esse posterius essentia,secundum ipsos, essentiam finitabit? Unde quaelibet entitas habet intrinsecum gradum perfectionis, nonper aliud ens».
79 THOMAS DE AQUINO, In Sent. Prol., q. 1, art. 2, ad secundum: «creatura enim non habet esse nisi se-cundum quod a primo ente descendit, unde nec nominatur ens nisi in quantum primum ens imitatur». A.
270 Orlando Todisco
te80. Ciò che è intelligibile è tale di per sé, etsi Deus non daretur. La relazione nonè forse successiva ai termini della relazione?81 Scoto propone qualcosa che è co-mune e anteriore sia a Dio che alle intelligenze, e dunque al finito e all’infinito82,e cioè l’ente univoco, inteso però come «tantum determinabilis»83, non nel sensoche sia in grado di sopportare l’esistere e le determinazioni conseguenti, ma nelsenso che senza quella determinabilità sia l’esistere che le determinazioni nonpotrebbero aver luogo. L’ente non genera ma subisce la “contrazione”, nel sensoche questa ha luogo «per aliquod additum»84. La ratio entis dell’ente prescindedai modi intrinseci (finito e infinito), rivelandosi finitus negative, indifferente nelfondo, e cioè né finito né infinito85. Infatti, la conoscenza dell’ente simpliciter sim-plex è altra cosa rispetto ai profili specifici degli enti, le cui passiones o proprie-tates godono della distinzione “formale” rispetto all’ente86. Più che includere in
Funkenstein a commento di questa tesi nota: «L’universo di Tommaso è una gerarchia di forme sostanzialiche posseggono gradi diversi di perfezione e sono fra loro interdipendenti: il mondo è “uno” perché le co-se sono strutturate in un ordine nel quale si sostengono reciprocanmente (ordo ad invicem), sono “ordi-nate l’una verso l’altra” (ad alia ordinantur)» (A. FUNKENSTEIN, Teologia e immaginazione scientifica dalMedioevo al Seicento, trad. it. di A. Serafino, Einaudi, Torino 1996, 162).
80 IOANNES DUNS SCOTUS, Lectura II, d. 1, q. 5, n. 258: «Unde lapis dicitur “ad se” primo, sed ex per-fectione sua includit respectum». Lo stesso Funkenstein, commentando questa tesi, che Ockham porrà alcentro della sua prospettiva, annota: «Da un lato, assistiamo al passaggio da una concezione dell’ordinecome qualcosa che inerisce alle cose in modo quasi organico, a una concezione che mette l’accento sugliesseri individuali, per cui il loro ordine è paragonabile a quello di un patto» (FUNKENSTEIN, Teologia e im-maginazione scientifica..., 180).
81 Il che non scalfisce il volontarismo di Scoto, a condizione che l’oggettività dell’ente venga ricon-dotta alla non-contraddizione o potenza logica. Cf. IOANNES DUNS SCOTUS, Lectura I, d. 39, q. 5, n. 49: «Sedadhuc illam libertatem voluntatis consequitur alia potentia, quae est logica (cui etiam correspondet po-tentia realis). Potentia logica non est aliqua nisi quando extrema sic sunt possibilia quod non sibi invi-cem repugnant sed uniri possunt». Poco prima Scoto ribadisce il carattere neutrale del dato oggettivo, nonancora né vero né falso: «Undequando intellectus divinus apprehendit “hoc est faciendum” ante volun-tatis actum, apprehendit ut neutram, sicut cum apprehendo “astra esse paria”; sed quando per actum vo-luntatis producitur in esse, tunc est apprehensum ab intellectu divino ut obiectum verum secundum al-teram partem contradictionis. Oportet igitur assignare causam contingentiae in rebus ex parte voluntatisdivinae» (IOANNES DUNS SCOTUS, Lectura I, d. 39, q. 5, n. 44).
82 IOANNES DUNS SCOTUS, Ord. Prol., n. 193: «Praeter scientias speciales oportet aliquam esse com-munem, in qua probentur omnia quae sunt communia illis specialibus; igitur praeter scientias oportet ali-quam esse communem de ente, in qua tradatur cognitio passionum de ente, quae cognitio supponitur inscientiis specialibus; si igitur aliqua est de Deo, praeter illam est aliqua de ente naturaliter scita in quan-tum ens».
83 IOANNES DUNS SCOTUS, Ord. I, d. 3, p. 1, q. 3, n. 133.84 IOANNES DUNS SCOTUS, Collationes, ed. C. R. S. Harris, in appendice al vol. II del Duns Scotus, Cla-
rendon Press, Oxford 1927, 374: «Conceptus communis univocus si contrahatur, oportet quod contraha-tur per aliquod additum».
85 IOANNES DUNS SCOTUS, Ord. I, d. 8, p. 1, q. 3, n. 41: «Concedo quod conceptus ille communis Deoet creaturae est finitus, hoc est non de se infinitus [...]; et ideo est finitus negative, id est non ponens in-finitatem».
86 IOANNES DUNS SCOTUS, Ord. I, d. 8, q. 3, n. 139: «Isto modo ens continet multas passiones, quae nonsunt aliae ab ipso ente [...] distinguuntur tamen ab invicem formaliter et quidditative, et etiam ab ente,formalitate dico reali et quidditativa».
Il carattere oggettivo dell’ente scotista nella lettura di Martin Heidegger 271
sé alcunché, l’ente è “incluso” e dunque è presupposto87. ll che risulta ribaditoallorché Scoto inserisce l’ente tra i “comunissima” o maxime scibilia88.
Quale dunque, il soggetto della metafisica, l’ente in quanto ente nel senso diAvicenna, o invece, Dio e le sostanze separate, come proponeva Averroè, o for-se né l’uno né l’altro?89 Che il soggetto metafisico non sia l’ente in senso avi-cenniano, è dovuto al fatto che il filosofo persiano considera l’ente in senso re-duplicativo, e cioè quale causa o ragione dell’attribuzione di un predicato al sog-getto90, mentre Scoto pensa all’ente in senso specificativo, e cioè fermo alla ra-tio entis91, la cui conoscenza non rende capaci di abbracciare la realtà nel suoinsieme, ma solo la trama minimale, senza la quale nulla è pensabile e con laquale nulla di concreto è pensato. Dunque, quando parla di scientia trascendens,anteriore a ogni altra92, Scoto non si discosta dalla logica dell’ente in quanto en-te, ribadendo che l’ontologia precede la teologia, come l’ente in quanto ente pre-cede un qualsiasi ente specifico.
Ma l’ontologia di Scoto non comporta il pieno dispiegamento della ratio en-tis attraverso le passiones convertibiles et disiunctivae? non costituisce lo scena-rio su cui si inscrivono come tanti capitoli le singole scienze, saldando l’unitàdella metaphysica generalis e della metaphysica specialis, secondo la logica del-l’ontoteologia? E la ratio entis, con cui Scoto legittima l’ascesa a Dio, pensato co-me supremamente perfetto93, non allude forse a una ragione in grado di rag-giungere siffatta altezza, confermando che il Dio di Scoto è un ente tra gli entisia pure il sommo? Ebbene, in merito occorre dire che dispiegando la ratio en-
87 IOANNES DUNS SCOTUS, Ord. I, d. 3, p. 1, q. 3, n. 137, dove a proposito dell’inerenza dei trascenden-tali all’ente Scoto parla di inclusione essenziale e di inclusione virtuale.
88 IOANNES DUNS SCOTUS, Quaest. super Metaph., Prol., ed. Wadding, Lyon 1639, n. 5: «Maxime scibiliaprimo modo sunt comunissima, ut est ens in quantum ens, et quaecumque sequuntur ens in quantum ens».
89 IOANNES DUNS SCOTUS, Quaest. super Metaph..., q. 1, n. 1: «Utrum subiectum Metaphysicae sit ensinquantum ens, sicut ens posuit Avicenna? vel Deus et intelligentiae, sicut posuit Commentator Averroes?Quod neutrum probo».
90 IOANNES DUNS SCOTUS, Rep. Par. I, d. 21, q. 1, n. 8: «uno modo denotat habitudinem subiecti adpraedicatum ut quod in subiecto sit causa inhaerentiae praedicati».
91 IOANNES DUNS SCOTUS, Rep. Par. I, d. 21, q. 1, n. 8: «Est autem scientia quae speculatur ens in-quantyum ens. Non enim intelligitur reduplicative, tunc enim sequitur quod specularetur quodcumqueens particulare, sed tenetur ibi specificative ratio entis, secundum quam de illo est scientia».
92 IOANNES DUNS SCOTUS, Quaest. super Metaph., q. 1, n. 47: «Sed demonstratio concludens primum deente, cum sit particularis, non potest esse per naturam entis; igitur demonstratio passionis transcenden-tis de ente, prior est ista, sicut universalis particulari, sicut medium medio, sicut omnis demonstratio denumero in communi erit ante illam qua probatur numerus aliquis esset primus; igitur metaphysica tran-scendens est tota prior scientia divina, et ita essent quattuor scientiae speculativae, una transcendens etaliae tres speciales».
93 IOANNES DUNS SCOTUS, Ord. I, d. 3, qq. 1-2, n. 39: «Omnis inquisitio de Deo supponit intellectumhabere conceptum eundem univocum, quem accipit ex creaturis». E per quanto concerne la plenaria com-piutezza dell’ente-infinito Scoto scrive: «Possumus ens “infinitum in entitate” sic describere quod ipsumest cui nihil entitatis deest» (IOANNES DUNS SCOTUS, Quaestiones Quodlibetales V, art. 3, n. 27).
272 Orlando Todisco
tis nella direzione del finito e dell’infinito, Scoto non fa altro che applicare la re-gula Anselmi, secondo cui bisogna concedere il massimo purché non entri incontraddizione con il soggetto di inerenza; o, in negativo, non bisogna porre im-perfezione alcuna a meno che non si sia costretti dall’indole del soggetto in que-stione. Ora, se «nulla imperfectio ponenda est in aliqua natura nisi necessitasappareat in natura tali»94, l’ente non deve espandersi nella direzione dell’infi-nità, dal momento che “ente” e “infinità” sono compossibili? La ragione umana,più che compiere il percorso, ha il compito di eliminare quanto può bloccare ta-le espansione frenandone la logica. Qui è in azione la logica della non-contrad-dizione e, sullo sfondo, la mistica. Il che risulta ribadito a proposito dell’ascesaa Dio, fondata non sull’illuminazione agostiniana o sulla razionalità tomista, masolo sulla logica della non-contraddizione della ratio entis e della ratio causae,da cui, alla luce della regula Anselmi, risulta l’impossibilità di negare il darsidella causa prima. Infatti, la causa prima è posta, non perché il regresso all’in-finito è impossibile, anzi tale regresso è impossibile perché è possibile la causaprima. L’approdo non è conseguente alla definizione positiva dell’idea di Dio –criticata da Tommaso – ma al concetto negativo – la non-inconciliabilità tra en-te e causa – senza dunque presupporre l’esistenza, nel qual caso si cade nel cir-colo vizioso, come Kant poi ampiamente dimostrerà. Scoto prima mostra che“ente e causa” non sono incompossibili, e poi che la nozione di causa non im-plica imperfezione alcuna, sicché una causa prima è possibile e, se possibile,esiste, perché «quod non est a se non potest esse a se»95. La ragione discorsivaresta al di qua, come risulta anche dall’indole, apparentemente positiva ma so-stanzialmente negativa, del linguaggio teologico. Solo in quest’ottica e in questosenso la metafisica risulta “teologica” «finaliter et principaliter»96. Dio dunquenon è propriamente soggetto della metafisica, come ipotizzava Averroè97 – nelqual caso, a causa dei vincoli di necessità tra il soggetto e i suoi predicati, taleDio non potrebbe dirsi libero – ma è soggetto solo in senso “finale”, in quantoapprodo del compiuto dispiegamento logico della ratio entis.
Ora, questo capitolo teologico dell’ontologia di Scoto relativo all’ente infinitoimplica forse una qualche sottomissione della teologia rivelata all’ontologia?Certo, Dio è «aliquo modo sub subiecto metaphysicae», senza però che una qual-
94 IOANNES DUNS SCOTUS, Ord. I, d. 3, n. 368.95 IOANNES DUNS SCOTUS, Ord. I, d. 2, n. 53: «Effectibilitas simpliciter prima est possibilis. Hoc suffi-
cit, quia inferius ex hoc concluditur quia tale efficiens primum, si est possibile, est in re».96 IOANNES DUNS SCOTUS, Ord. I, d. 3, n. 17: «metaphysica est theologia finaliter et principaliter, quia
sicut est principalius de substantia quam de accidente [...] ita principalius de Deo, quia semper prius, or-dine perfectionis, includitur in ratione subiecti primi particulariter pars passionis disiunctae quae est sim-pliciter perfectior».
97 IOANNES DUNS SCOTUS, Quaest. super Metaph. q. 1, n. 34: «Tenendo quod Deus sit hic subiectum,aliter est ponendum quam posuit Averroes».
Il carattere oggettivo dell’ente scotista nella lettura di Martin Heidegger 273
che proposizione autenticamente teologica sia possibile dimostrarla attraverso lalogica dell’ente e i suoi principi98. Dunque, non si dà una “scienza di Dio”, nonessendo Dio soggetto della metafisica, ma del tutto oltre e al di là (obiectum vo-luntarium). In quanto fondamento senza fondamento, il Dio della salvezza non èdisponibile nella sua essenza al pensiero che pensa a partire dall’alterità; o an-che, in quanto somma libertà, Dio è oltre la metafisica, perché oltre la necessi-tà99. Il Dio che salva si fa conoscere come e quando vuole. La rivelazione non èche il compendio di questo suo disegno, gratuito e contingente. L’iniziativa uma-na, qualunque sia la piega e l’intento, se non introduce o non dispone all’inizia-tiva divina, senza anticiparla e insieme senza ostacolarla, porta lontano, forsenella regione degli idoli, lambendo forse, ma senza raggiungere il Dio di Abramo,Isacco, Giacobbe. Dio lo conosciamo se vuole, come e quando vuole. Il problemainteressa meno l’intelletto umano e il suo potere, e più la libertà abissale di Dio,su cui nulla può l’ontologia sia dell’ente univoco che dell’ente analogico100.
98 IOANNES DUNS SCOTUS, Ord. Prol., n. 214: «Haec scientia (theologia) nulli subalternatur, quia licetsubiectum eius esset aliquomodo sub subiecto metaphysicae, nulla temen principia accipit a metaphysi-ca, quia nulla passio theologica demonstrabilis est in ea per principia entis vel per rationem sumptam exratione entis».
99 IOANNES DUNS SCOTUS, Quaest. super Metaph., q. 1, n. 11: «Metaphysica, quae est proprie sapientiasecundum Philosophum hic in Proemio est scientia propter quid; de Deo autem non est scientia propterquid, ut de primo subiecto, et nulla scientia considerat Deum ut causam, cum nihil causet necessario se-cundum veritatem, quidquid sit de Aristotele».
100 IOANNES DUNS SCOTUS, Ord. I, d. 3, n. 57: «Est ergo ratio huius conclusionis, videlicet quod Deusut haec essentia in se, non cognoscitur naturaliter a nobis, quia sub ratione talis cognoscibilis est obiec-tum voluntarium, non naturale, nisi respectu sui intellectus tantum. Et ideo a nullo intellectu creato po-test sub ratione huius essentiae ut haec est naturaliter cognosci».
































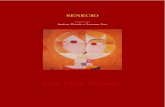







![Todisco tabelline[1]](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5593057b1a28ab5d768b4700/todisco-tabelline1.jpg)