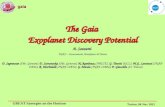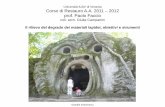The Urban Potential of External Territories...Proprio per questo, non si tratta di creare...
Transcript of The Urban Potential of External Territories...Proprio per questo, non si tratta di creare...

Giovanni Maciocco è professore ordinario di Tecnica e Pia-nificazione Urbanistica. È direttore del Dipartimento di Archi-tettura e Pianificazione e preside della Facoltà di Architettura di Alghero, Università di Sassari. Ha pubblicato diversi volumi. Tra i tanti: La città in ombra (FrancoAngeli, 1996); Wastelands (Dedalo, 2000); Fundamental Trends in City Development (Sprin-ger, 2008); Urban Landscape Perspectives (ed.) (Springer, 2008); The Territorial Future of the City (ed.) (Springer, 2008); People and Space. New Forms of Interaction in the City Project, con Ta-gliagambe S. (eds) (Springer, 2009); Enhancing the City. New Per-spectives for Tourism and Leisure, con Serreli S. (eds) (Springer, 2009); Il territorio, la memoria, il progetto (FrancoAngeli, 2010).
Gianfranco Sanna è ricercatore in Disegno e Rappresenta-zione presso la Facoltà di Architettura di Alghero, Università di Sassari. È docente di Disegno e Rappresentazione nei corsi di laurea in Architettura e Pianificazione Territoriale Urbanisti-ca e Ambientale. Tra le sue pubblicazioni recenti: “Dimensione ambientale e future forme dell’abitare”, in Purini F. et al. (a cura di), La città nuova italia - y - 26 invito a Vema. Il Padiglione Italiano alla 10. Mostra Internazionale di Architettura (Editrice Composi-tori, 2006); “Paesaggi contemporanei e progetto della città”, in Maciocco G. (a cura di), Studi sul progetto del paesaggio (Fran-coAngeli, 2010); “Territori-struttura e scenari ambientali della città”, in Maciocco G. (a cura di), Laboratori di progetto sul pae-saggio (FrancoAngeli, 2010).
Silvia Serreli è ricercatore in Tecnica e Pianificazione Urbani-stica presso la Facoltà di Architettura di Alghero, Università di Sassari. È docente di Pianificazione Territoriale presso la stessa Facoltà. Tra le sue pubblicazioni recenti: Le dimensioni plurali della città ambientale. Prospettive di integrazione ambientale nel progetto del territorio (FrancoAngeli, 2004); “Urban Landsca-pe and an ecology of creativity”, in Maciocco G. (ed.), Urban Landscape Perspectives (Springer, 2008); “Derelict places as alternative territories of the city”, in Maciocco G. (ed.), The Territorial Future of the City (Springer, 2008); Enhancing the City. New Perspectives for Tourism and Leisure, con G. Maciocco (eds) (Springer, 2009); Paesaggi costieri e progetti di territorio, con G. Maciocco (a cura di) (FrancoAngeli, 2010).
Il potenziale urbano del territorio sembra in primo luogo richiamare la riscoperta di un ancoraggio alla terra, nel senso che dal territorio la città riceve un richiamo alla riflessione sul senso della casa dell’uomo, come ricerca degli elementi pri-mari della sua costruzione, una ricerca dell’essenziale urbano. In un orizzonte che sembra spingerci verso una vita urbana orientata in senso ambientale, sembrano forse aprirsi per i va-sti territori densi di natura e di storia prospettive promettenti per la costruzione di mondi urbani possibili.
Il volume esplora le ragioni attuali delle relazioni tra i ter-ritori e l’insediamento urbano, delineando una prospettiva di città ambientale che recupera la profondità storica e il senso del territorio e li rilancia in termini attuali. Gli autori mettono in luce i modi inediti in cui il territorio è posto all’attenzione di una vita urbana che proprio attraverso queste relazioni inedi-te si rinnova e trova la luce di una prospettiva.
I progetti illustrati propongono un ricentramento selettivo della città sui suoi cardini ambientali, in un certo senso ester-ni alle dinamiche consuetudinarie della città mettendo in luce territori-struttura che rivelano nella loro densità di natura e di storia la forza generatrice di un ordine diverso dello spazio insediativo. In questi territori il progetto anche nei suoi gesti più piccoli fa emergere lo spazio pubblico contemporaneo, scoprendo un mondo comune di significati urbani nel territo-rio della città.
The urban potential of the territory seems first and fore-most to evoke the rediscovery of an anchorage to the land, in the sense that the city receives an appeal from the territory to reflect on the sense of man’s home, as a quest for the primary elements of its construction, a search for urban essence. On a horizon that appears to be urging us towards environmental-ly-oriented urban life, promising perspectives seem perhaps to be opening up for the vast territories rich in nature and history for the construction of possible urban worlds.
This book explores the current reasons for the relations between territories and urban settlement, outlining a per-spective of environmental city that will retrieve the historic depth and sense of the territory to relaunch them in current terms. The authors highlight the original ways the territory is brought to the attention of an urban life that, precisely throu-gh these new relations, is renewed and finds the light of a perspective.
The projects illustrated propose selective re-centring of the city on its environmental cornerstones, to some extent ex-ternal to the usual dynamics of the city, highlighting structure-territories that reveal in their natural and historic wealth the generating force of a different kind of settlement space. In the-se territories the project, even with the smallest action, ma-kes public contemporary space emerge, disclosing a common world of urban meanings in the territory of the city.
€ 39,00 (U)
Giovanni Maciocco is full professor of Town and Regional Planning, director of the Department of Architecture and Planning and dean of the Faculty of Architecture, University of Sassari. His works include: La città in ombra (FrancoAngeli, 1996); Wastelands (Dedalo, 2000); Fundamental Trends in City Development (Springer, 2008); Urban Landscape Perspectives (ed.) (Springer, 2008); The Territorial Future of the City (ed.) (Springer, 2008); People and Space. New Forms of Interaction in the City Project, with S. Tagliagambe (eds) (Springer, 2009); En-hancing the City. New Perspectives for Tourism and Leisure, with S. Serreli (eds) (Springer, 2009); Il territorio, la memoria, il progetto (FrancoAngeli, 2010).
Gianfranco Sanna is a researcher in Architectural Design at the Faculty of Architecture, University of Sassari. At present he is teaching Architectural Design and Planning. His publi-shed works include: “Dimensione ambientale e future forme dell’abitare”, in Purini F. et al. (eds), La città nuova italia - y - 26 invito a Vema. Il Padiglione Italiano alla 10. Mostra Internazionale di Architettura (Editrice Compositori, 2006); “Paesaggi con-temporanei e progetto della città”, in Maciocco G. (ed.), Studi sul progetto del paesaggio (FrancoAngeli, 2010); “Territori-struttura e scenari ambientali della città”, in Maciocco G. (ed.), Laboratori di progetto sul paesaggio (FrancoAngeli, 2010).
Silvia Serreli is a researcher in Landscape and Urban Plan-ning at the Faculty of Architecture, University of Sassari. She is a lecture in Territorial Planning. Her recent publications in-clude: Le dimensioni plurali della città ambientale. Prospettive di integrazione ambientale nel progetto del territorio (FrancoAngeli, 2004); “Urban Landscape and an ecology of creativity”, in Ma-ciocco G. (ed.), Urban Landscape Perspectives (Springer, 2008); “Derelict places as alternative territories of the city”, in Ma-ciocco G. (ed.), The Territorial Future of the City (Springer, 2008); Enhancing the City. New Perspectives for Tourism and Leisure, with G. Maciocco (eds) (Springer, 2009); Paesaggi costieri e progetti di territorio, with G. Maciocco (eds) (FrancoAngeli, 2010).
The Urban Potentialof External Territoriesedited by Giovanni Maciocco, Gianfranco Sanna and Silvia Serreli
Metodi del Territorio
FrancoAngeli /Facoltà di Architettura di Alghero
1126.31 G
. Maciocco, G
.Sanna, S. Serreli (eds) The U
rban Potential of External Territories
La passione per le conoscenze

Metodi del TerritorioSeries founded by Fernando Clemente and directed by Giovanni Maciocco
Series EditorGiovanni Maciocco
Editorial Board Michael BattyDino BorriArnaldo CecchiniXavier CostaFrancesco IndovinaCarlo OlmoPier Carlo PalermoNuno PortasBernardo SecchiThomas SievertsRay Wyatt
Editorial CommiteePaola Pittaluga Gianfranco SannaSilvia SerreliFrancesco Spanedda
Graphic designersSamanta BartocciEnrico CicalòLisa MeloniMichele Valentino
Managing AssistantsMonica JohanssonLisa Meloni
Editorial StaffGiovanni Maria BiddauLaura Lutzoni
TranslationChristine Tilley

Aims and Scope
Methods for the Territory is an expression that indicates almost the belonging of methods to the territory, methods for the city project, that take the territory on as a centre of reasoning, methods that explore the territory as a field of potentialities for the renewal of urban life. The environmental dimension reminds us also that the city is of the territory due to the environmental interdepend-ence that characterises its relations and are at the basis of the environmental quality of urban life. The territory is no longer the set of conditions external to the city, for the context has become an internal horizon of the city. We may therefore say that the city coincides with the territory; it is its contextual universe.Precisely for this reason, it is not a matter of creating separation between urban morphologies, but of trying to see the city in all the different spatial forms in which the contemporary urban condition is expressed, exploring the conditions of territoriality that will necessarily be incorporated in the city. Understood in this sense, the territory indicates inclination towards the project for settlement. Territory meant as a place of recognition of the spatial differences of the urban, the place of retrieval of the ethos, of all that which was not at the centre, not in the polis; the deep matrix of the primary elements of inhabiting.In this perspective, the project for space may be imagined as a complex process towards under-standing contemporary public space, a process that by adopting a cognitive conception of the project favours a shared background in which all the inhabitants of a territory have a voice to construct a true city. In this sense the project for the territory is the project for the city.
Metodi del Territorio è un’espressione che segnala quasi un’appartenenza dei metodi al territorio, metodi per il progetto della città, che assumono il territorio come centro del ragionamento, metodi che esplorano il territorio come campo di potenzialità per il rinnovo della vita urbana. La dimensione ambientale ci ricorda anche che la città è del territorio per l’interdipendenza ambientale che ne carat-terizza le relazioni e che sono alla base della qualità ambientale della vita urbana. Il territorio non è più l’insieme delle condizioni esterne della città perché il contesto è diventato un orizzonte interiore della città. Possiamo dire perciò che la città coincide con il territorio, suo universo contestuale. Proprio per questo, non si tratta di creare separatezze tra le morfologie urbane, ma di cercare di ve-dere la città in tutte le differenti forme spaziali in cui si esprime la condizione urbana contemporanea, esplorando le condizioni di territorialità che necessariamente si incorporeranno nella città. Inteso in questo senso, il territorio segnala una disponibilità al progetto, dell’insediamento. Territorio in-teso come luogo di riconoscimento delle differenze spaziali dell’urbano, luogo del recupero dell’ethos, di tutto ciò che non è stato al centro, che non era nella polis; matrice profonda degli elementi primari dell’abitare. In questa prospettiva, il progetto dello spazio può essere immaginato come un processo complesso verso la comprensione dello spazio pubblico contemporaneo, un processo che assumendo una con-cezione conoscitiva del progetto favorisca uno sfondo condiviso in cui tutti gli abitanti di un territorio abbiano voce per la costruzione di una città giusta. In questo senso, il progetto del territorio è il progetto della città.
All the texts published in the series have been subjected to blind peer reviewTutti i testi pubblicati nella collana sono sottoposti a un processo di blind peer review

The Urban Potential of External Territoriesedited by Giovanni Maciocco, Gianfranco Sanna, Silvia Serreli
FrancoAngeli /Facoltà di Architettura di Alghero

On cover / In copertina: Montiferru structure-territory / Il territorio-struttura del Montiferru
Copyright © 2011 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy
Ristampa Anno
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.
Sono vietate e sanzionate (se non espressamente autorizzate) la riproduzione in ogni modo e forma (comprese le fotocopie, la scansione, la memoriz-
zazione elettronica) e la comunicazione (ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la distribuzione, l’adattamento, la traduzione e la rielabora-
zione, anche a mezzo di canali digitali interattivi e con qualsiasi modalità attualmente nota od in futuro sviluppata).
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso
previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o com-
merciale o comunque per uso diverso da quello personale, possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO
(www.aidro.org, e-mail [email protected]).
Stampa: Tipografia Gamma, via G. Pastore 9, Città di Castello (PG)

5
1011
8081
142143
196197
228229
268269
308309
Contents / Indice
External territories and city project / Territori esterni e progetto della città
The urban potential of external territories / Potenziale urbano dei territori esterni
Scenarios for a territorial future of the city Scenari per un futuro territoriale della città Giovanni Maciocco
External territories and environmental city project Territori esterni e progetto ambientale della cittàSilvia Serreli
Territory, representation, project Territorio, rappresentazione, progettoGianfranco Sanna
Formative contents of external territories / Contenuti formativi dei territori esterni
Places, matrices, traces / Luoghi, matrici, tracce
History for placesLa storia per i luoghi Giovanni Azzena
Lingering over “play”: the status of art in relations between men and placesIndugiare nel “gioco”: lo stato dell’arte nella relazione tra uomini e luoghi Elena Moreddu
Other urban landscapes / Altri paesaggi urbani
From a conservative to a project-oriented approach to the contemporary landscapeDa un approccio conservativo a uno progettuale al paesaggio contemporaneo Paola Pittaluga
Beyond Bigness. Some reflections on architecture in low-density conditions Oltre la Bigness. Alcune riflessioni sull’architettura della bassa densitàFrancesco Spanedda

Spaces of the public sphere / Spazi della sfera pubblica
Designing spaces, constructing imagesProgettare spazi, costruire immaginiEnrico Cicalo`
Spaces of silence in the construction of a new urban scoreSpazi del silenzio nella costruzione di una nuova partitura urbana Lidia Decandia
New urban behaviour / Comportamenti urbani inediti
Revealing the city on the territoryRivelare la città nel territorioGiovanni Maria Filindeu
Temporary uses as a perspective of the urban projectUsi temporanei come prospettiva del progetto urbanoLaura Lutzoni
Informal micro-economies and new urban catalysts Micro-economie informali e nuovi catalizzatori urbaniDaniela Marongiu
Structures identifying the city / Strutture di riconoscimento della città
Cities on water Città dell’acqua Elisa Mura
External territories and mobility infrastructure Territori esterni e infrastrutture della mobilità Tanja Congiu
Indexes / Indici
Name Index / Indice dei nomiSubject Index Indice degli argomenti
Credits / Crediti
Contributors / Autori
360361
388 389
420421
464465
494495
524525
558559
594597600
603
604

194
History for placesGiovanni Azzena
Abstract
To reveal the territorial dimension of cities we attempt to motivate the need for some renewed “principles of individuation” of “historic” land-scapes which, though still far from constituting a systematic approach, will nevertheless begin to show how the “chronodiversity” features of a territory can be analytically investigated. Not so much, then, or not only, the scientific reconstruction of one or more historic phases of a context (principal task of urban and landscape archaeology), as rather an analytical investigation into what is given, to everybody, to perceive and enjoy now: the exclusive “historic” features of a territory. It thus becomes necessary to try to break down some of the disciplinary barriers that predetermine the role of history in place design, almost always only documental and above all often rhetorically instrumental. An approach that seems simul-taneously both cause and effect of a secular legislation for preservation that has considered the historic condition of places as determined just by the physical presence of “objects” no longer in use. The virtual or material enclosures cut out, over time, around these “objects” establishing history are thus considered the ultimate consequences of this cultural attitude – which from the “cult of the monument” has reached the “rhetoric of the ruin”– protective enclosures as untouchable, in theory, as they are fragile through the practice of indifference “surrounding” them; enclosures made impermeable to life and, therefore, to all effects that might be considered “external”, also (or especially) when they are situated in the centre of our cities. By clarifying the ambiguous statute of the historicity of places, not only might a concept of preservation ensue that is less abstract and therefore more subscribed to, but also – and this is the deep meaning of this paper – a projectual-oriented view no longer dominated by the impediment their cumbersome presence constitutes, but a guarantee of the potential deriving from the fascination of their being, still, present.
Key words: ancient topography, archaeology, preservation, chronodiversity

195
La storia per i luoghiGiovanni Azzena
Abstract
Per rivelare la dimensione territoriale delle città si prova a motivare la ne-cessità di alcuni rinnovati “principi di individuazione” dei paesaggi “storici”, ancora lontani dal costituire un approccio sistematico ma che tuttavia ini-ziano a mostrare in che modo possano essere indagati analiticamente i ca-ratteri di “cronodiversità” di un territorio. Dunque non tanto, o non solo, la ricostruzione scientifica di una o più fasi storiche di un contesto (compi-to precipuo dell’archeologia urbana e del paesaggio) ma indagine analitica di ciò che è dato, a tutti, di percepire e di godere adesso: le peculiarità “storiche” di un territorio. Si rende perciò necessario provare ad abbatte-re alcune barriere disciplinari che predeterminano il ruolo della storia nel progetto dei luoghi, quasi sempre solo documentale e soprattutto spesso retoricamente strumentale. Un approccio che sembra allo stesso tempo causa ed effetto di una secolare legislazione di tutela che ha ritenuto la condizione storica dei luoghi determinata soltanto dalla presenza fisica di “oggetti” non più in uso. Si considerano perciò, quali conseguenze ultime di questo atteggiamento culturale – che dal “culto del monumento” è pervenuto alla “retorica del rudere” – i recinti virtuali o materiali ritagliati, nel tempo, intorno a questi “oggetti” asserenti la storia: recinti protettivi tanto intoccabili in teoria, quanto fragili nella pratica dell’indifferenza al loro “intorno”; recinti resi impermeabili alla vita e, perciò, a tutti gli effetti pensabili come “esterni”, anche (o soprattutto) quando collocati nel cen-tro delle nostre città. Dal chiarimento dell’ambiguo statuto della storicità dei luoghi potrebbe derivare non solo un concetto di tutela meno astratto e, dunque, più condiviso, ma anche – ed è questo il senso profondo di questo contributo – una visione progettuale non più succube dell’impedi-mento rappresentato dalla loro, ingombrante, presenza, ma garante delle potenzialità derivanti dalla suggestione del loro essere, ancora, presenti.
Parole chiave: topografia antica, archeologia, tutela, cronodiversità

196
A context for contexts
The reconstruction of the formae and functioning of early territorial profiles entails thorough analytical knowledge of the traces history leaves on the land, based, as with archaeological excavations, on the need to progressively “eliminate” layers of stratified material to reach the image of the stage sought. The problem will be posed below whether, in the attempt, not new but perhaps renewable, to have history work for places, too – that is, targeted at the develop-ment of places – a type of reading might not be more suitable that adopts the synchronic plan of the last knowable form, the “present and alive”. A glance, from a historic point of view “unusual”, that considers above all “every” component of the anthropisation framework (including the “absence” of anthropisation) as elements contributing together to forming the social representation of terri-tories (the cultural-historic formation of the landscape).Reference will consequently be made not to cities, territories, environments and spaces more or less “historic”, but simply to the landscape and, in particular, the idea of landscape as “representation”, or reflection of the whole set of cultural notions of perception of

197
Nuraghe at Juanne Abbas, near the Strada dei Due Mari in north-west Sardinia Nuraghe a Juanne Abbas sulla Strada dei Due Mari nella Sardegna nord occidentale
Un contesto per i contesti
La ricostruzione del funzionamento e delle formae degli antichi as-setti territoriali implica una conoscenza profondamente analitica delle tracce che la storia lascia sul terreno, basata, come nello scavo archeologico, sulla necessità di “eliminare” in progressione strati di sovrapposizioni materiali per pervenire all’immagine dello stadio ricercato. Di seguito ci si porrà il problema se nel tentativo, non nuovo ma forse rinnovabile, di far lavorare la storia anche per i luo-ghi – in funzione, cioè, dello sviluppo dei luoghi – non sia più adatto un tipo di lettura che, quale base di riferimento per l’analisi, assuma il disegno sincronico dell’ultima forma conoscibile, la “presente e viva”. Uno sguardo, storicamente “insolito”, che consideri “tutte” le componenti del quadro dell’antropizzazione (compresa l’“assenza” di antropizzazione) quali elementi pariteticamente concorrenti alla formazione della rappresentazione sociale dei territori (la forma-zione storico-culturale del paesaggio).Pertanto si farà riferimento non a città, territori, ambienti, spazi più o meno “storici”, ma semplicemente al paesaggio e, in particolare, all’accezione di paesaggio come specchio dell’insieme delle nozioni

198
“lived” spaces, certainly not unique (Farinelli 1981; Gambi 1981; Castelnovi 1998; Caravaggi 2002; Milani, Morpurgo 2003; Milani 2005; Turri 2006, pp. 15-18) but scientifically consolidated1. Because the landscapes continues – as it has always done – to evade clear, shared definition. Indeed: the more refined the inter-pretative instruments of the disciplines delegated to deal with its multiple asp_ects become, the more the already weak semantic convergences seem to grow hazy and drift away.Once granted, but only because it is now a fact, that the landscape may be faced in a “disciplinary” form, we need to acknowledge that the present moment is one of the most frenetic in the history of all the disciplines involved. Prompted – some for the first time – by a new sensitivity oriented by the themes of the various “sustain-abilities” and intent on “identitary”2 nevertheless pervaded by an improbable as much as inevitable compromise between quality of life, based longingly on the excellence of places, and quantity of life, which flows over the same places in an unseemly manner. The inflexible complexity of the proteiforms comprising the territory (landscape?) has been boxed up into structures, systems, taxonomies (frames, units, classes, etc.) through which each discip-line has consolidated its own distinct concept of landscape, basing itself though on a word that has remained the same for all (Copeta 1990, p. 17). With the risk, not just semantic, of neglecting two basic components of the analysis, the least easily modelisable; on the one hand, time and on the other, the networks of relations, be they visual, symbolic, religious, socio-political, affective (Farinelli 2003a, pp. 200-201; De Candia 2004, pp. 16-24). If not analysable, perhaps at least comprehensible, in a view that will enclose the emotional aspects and techno-scientific ones, those only percep-tive and those classificatory, in an attempt to restore on the one hand, historic, cultural and affective consistency to the taxonomic frames and, on the other, make less weak the “emotional” aspects of the landscape. An integrated reading and not a sum of readings, nor, even less, a single interpretative choices: like in “Humboldt’s model”, in the shrewd re-proposal Farinelli (2003b, p. 66) gives, where the aesthetic-sentimental influence of nature (Eindruck, namely the landscape in the true sense) is espoused with analysis, world measure (Einsicht) arranged concentrating on only one of its aspects, to finally arrive at Zusammenhang, that is, the return to the complexity of the groups and systems of relations on which the
1 Diff icult to investigate, however, above all because it cannot be related to any concrete entity: neither perceived reality, nor that which the human eye embraces of it, and not even the eye that gazes. A lens, rather (but not only) – cultural transfiguration – by which the eye perceives the existing (Farinelli 2003b, p. 66: “to look at the world through those glasses we still today call landscape”; Raffestin 2005, p. 48: “landscape is an intersection between the physiology of the eye, subjectivity and cultural mediators”; cfr. Turri 1983, pp. 83-87). An obvious diff iculty (Cosgrove 1990, pp. 32-34; Raffestin 2005, p. 36; Turri 2006, pp. 11-15), a linguistic trace of which is detected by some in the term and concept of landscape converging with those of territory or environ-ment, or indeed the complete overlapping of territorial morphology and landscape, as implied by the famous “earth-landscape paradigm”. A diff iculty that increases in the event we attempt an ineffable “individuation” of the landscape, to use an expression to which almost legislative eff icacy is now ascribed: “each party undertakes to [...] single out its landscapes, on the whole of its territory”. (Guido, Sandroni 2000, art. 6 comma C, § 1; cfr. Farinelli 1991, pp. 10-12; Cavezzali, Palombi 2000; Palazzo 2002; Aedon 2005, Carpani 2005; Di Bene, Scazzosi 2006; Turri 2006, pp. 11-13).
2 In forms more or less, but also not at all, rhetor-ical (De Candia 1994, 2000, 2004; Fazio 1996; Bonesio 1997, 2002; Venturi Ferriolo 2002).

199
culturali di percezione dello spazio vissuto, certamente non uni-ca (Farinelli 1981; Gambi 1981; Castelnovi 1998; Caravaggi 2002; Milani, Morpurgo 2003; Milani 2005; Turri 2006, pp. 15-18) ma scientificamente consolidata1.Perché il paesaggio continua – come ha sempre fatto – a sfuggire a una definizione certa e condivisa. Anzi: più gli strumenti interpreta-tivi delle discipline delegate ad affrontarne gli innumerevoli aspetti si affinano, più le già labili convergenze semantiche sembrano con-fondersi e allontanarsi.Una volta concesso, ma solo perché ormai dato, che il paesaggio possa essere affrontato in forma “disciplinare”, occorre riconoscere che quello presente è uno dei momenti più affannosi della storia di tutte le discipline coinvolte. Sollecitate – alcune per la prima volta – da un’inedita sensibilizzazione orientata dai temi delle varie “soste-nibilità” e tesa verso recuperi “identitari”2; comunque pervasa da un improbabile quanto ineluttabile compromesso tra qualità della vita, che si vagheggia basata sull’eccellenza dei luoghi, e quantità della vita che sui medesimi luoghi scompostamente si riversa. L’irriducibile complessità delle proteiformi componenti del territo-rio (paesaggio?) è stata inscatolata in strutture, sistemi, tassono-mie (quadri, unità, classi, ecc.) attraverso le quali ciascuna disciplina consolida il proprio distinto concetto di paesaggio, basandosi però su un vocabolo che è rimasto uguale per tutti (Copeta 1990, p. 17). Con il rischio, questo non solo semantico, di trascurare due componenti basilari dell’analisi, le meno agevolmente modellizzabili: da una parte il tempo e dall’altra le reti delle relazioni, siano esse visive, simboliche, religiose, socio-politiche, affettive (Farinelli 2003a, pp. 200-201; De Candia 2004, pp. 16-24). Se non analizzabili for-se almeno comprensibili in una visione che ne racchiuda gli aspetti emozionali e quelli tecnico-scientifici, quelli solo percettivi e quelli classificatori, nel tentativo di restituire da un lato spessore stori-co, culturale, affettivo ai quadri tassonomici e, dall’altro, di rendere meno labili gli aspetti “emotivi” del paesaggio. Una lettura integrata e non un’addizione di letture né, tanto meno, un’unica scelta inter-pretativa: come nel modello di Humboldt, nell’acuta riproposizione di Farinelli (2003b p. 66), dove alla suggestione estetico-sentimen-tale davanti alla natura (Eindruck, ossia il paesaggio propriamente detto) si congiunge l’analisi, la misura del mondo (Einsicht) disposta concentrandosi su uno solo dei suoi aspetti, per pervenire infine al Zusammenhang, cioè al ritorno alla complessità degli insiemi e dei
2 In forme più o meno, ma anche per niente, reto-riche (De Candia 1994, 2000, 2004; Fazio 1996; Bonesio 1997, 2002; Venturi Ferriolo 2002).
1 Difficile da indagare, però, soprattutto perché nonriferibile ad alcuna entità concreta: non la realtà per-cepita, neppure ciò che l’occhio umano di questa abbraccia e nemmeno l’occhio che guarda. Piuttosto (ma non solo) lente – trasfigurazione culturale – at-traverso la quale l’occhio percepisce l’esistente (Fa-rinelli 2003b, p. 66: “guardare il mondo attraversoquegli occhiali che ancora oggi chiamiamo paesag-gio”; Raffestin 2005, p. 48: “paesaggio è un’interse-zione tra la fisiologia dell’occhio, la soggettività e i mediatori culturali”; cfr. Turri 1983, pp. 83-87). Dif-ficoltà palese, della quale alcuni (Cosgrove 1990, pp. 32-34; Raffestin 2005, p. 36; Turri 2006, pp. 11-15) individuano traccia linguistica nella coinciden-za di termine e concetto di paesaggio a quelli di territorio o di ambiente, quando non alla perfetta sovrapposizione tra morfologia territoriale e pae-saggio, così come sottintesa nel famoso “paradigma suolo-paesaggio”. Difficoltà accresciuta nel caso si tenti, del paesaggio, un’ineffabile “individuazione”, per usare un’espressione alla quale è ora ascritta efficacia quasi legislativa “ogni Parte si impegna a [...] individuare i propri paesaggi, sull’insieme del proprio territorio” (Guido, Sandroni 2000, art. 6 comma C, § 1; cfr. Farinelli 1991, pp. 10-12; Cavezzali, Palombi 2000; Palazzo 2002; Aedon 2005; Carpani 2005; Di Bene, Scazzosi 2006,;Turri 2006, pp. 11-13).

200
functioning of the world is based, finally clear thanks to the passage through the preceding phases3. This is without doubt a painful gaining of awareness which is gradually engaging all the disciplinary spheres (Panizza, Piacente 2003; Farina 2006) and tending to positively highlight their real limits; very obvious limits, I believe, indeed in the practices of knowledge and safeguarding of the past, thus in the analysis of the so-called “historic” landscapes (Carpentieri 2004; Cicala, Guermandi 2005; Di Bene Scazzosi 2006; Guermandi 2006; Poli 2006). It is possible that this depend on disciplinary delay; but it may also have happened that, at the moment when the forms of methodological unrest began to pervade the already aged methodological statute of the historico-archaeological disciplines dealing with the territory, every-thing was challenged by the dictates of a new Cultural Patrimony and Landscape Code; or, vice versa, that renewed positions and attitudes derived from the critical impetus against the indications of the said Code (Carpentieri 2004; Cicala, Guermandi 2005; Di Bene Scazzosi 2006; Guermandi 2006; Poli 2006).
The ambiguous statute of the “historic” landscape
History for places, then, rather than, or not only, history of places. But above all not of “historic” places – or landscapes. Since the expression “historic landscape” is already superfluous: in effect, in the Romance languages the word landscape contains in itself, etymologically speaking, the sign of man and thus of history (Scazzosi 1999, 2002, Ulisse 2004). In actual fact all landscapes not only contain (or reflect) history, but are history4. And above all, conversely, an a-historic landscape does not exist. The terminological misunderstanding, of which mention has already been made, concerns the term landscape in that “it identifies both reality and the representation of it” (Berque 1995, p. 11), but I think above all it can be more easily understood if focalised on the object of the act of cultural representation that we call “landscape”. Run-down spaces, it has now been made clear (Clément 2005; Careri 2006; La Cecla 2005), can also be exciting – as well as vital. But they will be so in a more subtle, penetrating way if touched by disuse5 . The interruption of the processes of use or of life in fact entails a sort of perceptive promotion from one state to the other, attributing seductiveness to places considered unpleasant
3 Cfr. also Raffestin (2005, p. 18); as, moreover, is also threefold the perceptive/descriptive function of space connected with the development of a zenithal view of the world: from the Weiteraum (emoziona space) to the Orstraum (localisation, or cartographic space) through the Richtungsraum (directional or odological space), as identif ied by H. Schmitz, quoted in Janni (1984, p. 93).
4 Moreover, it is the territorial transformations that make history Guzzo (2002, p. 34); cfr. also Gambi (1986).
5 Think of the “Zone” in Andrej Tarkovskij’s film Stalker and also of the features of the three char-acters in it, in some way personifications of the three Humboldtian stages of knowledge.

201
sistemi delle relazioni su cui si basa il funzionamento del mondo, finalmente chiari grazie al passaggio attraverso le fasi precedenti3.Si tratta senza dubbio di una sofferta presa di coscienza che sta via via impegnando tutti gli ambiti disciplinari (Panizza, Piacente 2003; Farina 2006) e che positivamente tende a evidenziarne limiti reali; limiti molto evidenti, credo, proprio nelle pratiche di cono-scenza e di salvaguardia del passato, quindi nell’analisi dei cosiddetti paesaggi “storici” (Carpentieri 2004; Cicala, Guermandi 2005; Di Bene Scazzosi 2006; Guermandi 2006; Poli 2006). È possibile che ciò dipenda da un attardamento disciplinare; ma può anche essere accaduto che, nel momento in cui le forme dell’inquietudine meto-dologica cominciavano a pervadere l’ormai invecchiato statuto me-todologico delle discipline storico-archeologiche a indirizzo territo-riale, tutto sia stato rimesso in discussione dai dettami di un nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; o viceversa che indirizzi e atteggiamenti rinnovati siano discesi dalla carica critica verso le in-dicazioni dello stesso Codice (Carpentieri 2004; Cicala, Guermandi 2005; Di Bene, Scazzosi 2006; Guermandi 2006; Poli 2006).
L’ambiguo statuto del paesaggio “storico”
La storia per i luoghi, dunque, piuttosto o non solo che la storia dei luoghi. Ma soprattutto non di luoghi – o paesaggi – “storici”. Perché già l’espressione “paesaggio storico” è ridondante: nelle lingue ro-manze, infatti, il vocabolo paesaggio contiene in sé, etimologica-mente parlando, il segno dell’uomo e dunque della storia (Scazzosi 1999, 2002; Ulisse 2004). Nei fatti tutti i paesaggi non solo conten-gono (o rispecchiano) la storia, ma sono storia4. E soprattutto, per converso, non esiste un paesaggio a-storico. L’equivoco terminolo-gico, cui si è già fatto cenno, riguarda il termine paesaggio in quan-to “identifica sia la realtà che la sua rappresentazione” (Berque 1995, p. 11) ma soprattutto credo si possa meglio comprendere se focalizzato sull’oggetto dell’atto di rappresentazione culturale che chiamiamo “paesaggio”. Anche gli spazi del degrado, è ormai accla-rato (Clément 2005; Careri 2006; La Cecla 2005), possono essere emozionanti – oltre che vitali. Ma lo saranno in modo più sottile e penetrante se lambiti dalla dismissione 5. L’interruzione dei processi d’uso o di vita comporta in effetti una sorta di promozione percet-tiva da uno stato all’altro, attribuendo seduttività a luoghi reputati
3 Cfr. anche Raffestin (2005, p. 18); come è d’altra parte triplice anche la funzione percettivo/descrit-tiva dello spazio legata all’evoluzione di una visio-ne “zenitale” del mondo: dal Weiteraum (spazio emozionale) all’Orstraum (spazio della localizza-zione, o cartografico) attraverso il Richtungsraum (spazio direzionale, o odologico), come identificati da H. Schmitz, cit. in Janni (1984, p. 93).
4 Per altro sono le trasformazioni territoriali a fare storia. Guzzo (2002, p. 34); cfr. anche Gambi (1986).
5 Si pensi alla “Zona” del film Stalker di Andrej Tarkovskij e anche alle caratteristiche dei tre personaggi che vi entrano, in qualche modo personificazioni dei tre stadi humboldtiani della conoscenza.

202
up until some time before (Milani 2005, pp. 97-98). Let us remember that ruins, the primary traces of history, having been contemplated throughout the whole of the Middle Ages with an almost religious fear, which is reflected in the numerous toponomastic references to the diabolical, have become the protagonists of the artistic-cultural season of the “landscape with ruins” as well as engines of the idea itself of landscape, at least the Western one6. In a word, even if we wanted to find a theoretical differentiation only, it is clear how history pervades the landscape come what may.And yet the ambiguous statute of an a-historic landscape has produced, in our country certainly since the end of the Second World War, a sort of perverse ranking between intangible landscapes/territories,being rich in environmental, symbolic, cultural meanings7 and others, children of a lesser God, expendable “for progress” (Ricci 2006). A confrontation becoming less frontal over time, it is true, but not for that less incisive, especially if transferred to the land by centre vs periphery practices, in vitro conservation, the enclosure, the Oasis, the Area and the Archaeological Park (Guzzo 1996, p. 372), always carved out around “worthy” areas, nice districts. While the attention (historic in particular) should include all territories, if intended correctly not just as contexts of the cultural-historic patrimony but, since they constitute the indissoluble connective tissue of it, also as an integral part8. But this is still not enough: attention should also be paid where it would not indeed seem necessary: for example, to those run-down, marginal, edge contexts we spoke of before. Wastelands, an almost inexhaustible store of biodiversities focalising increasingly articulate visions of disparate disciplinary approaches (Clément 2005; Careri 2006; La Cecla 2005, pp. 141-147. Cfr. Gambi 1986; Lenzi 1999; Maciocco 2000; Maciocco, Pittaluga 2001; Colantonio Venturelli, Galli 2005), but which are often automatically excluded from the interest of history and also from the umbrella of protection. Due, I fear, indeed to the ambiguity which unnaturally distinguishes “historic” and “a-historic” places, tending moreover to make of the first a new type of derelict landes, compounds hostile to life, indecipherable non-places of the memory9 (Longobardi 2002; Venturi Ferriolo 2002, p. 112; Ricci 2006). So that the greatest binding attention is more often than not concen-trated on the areas less exposed to risk. Enclosed spaces and parks, in the first place, but then all the places “blessed” by the physical presence of the past, tangible and where possible not too dilap-
6 Cfr. now Battisti (2004); Milani (2005); Büttner (2006). Summary in Azzena (2001). On the birth of the concept of landscape, see recently Botti (2006).
7 Think of the case of the Yosemite Valley or, nearer to us in time and space, that of the Appia Antica.
8 For a renewed look at an old problem, see those of: Leon (1991); Palazzo (2003, p. 108); Colavitti, De Montis (2004).
9 I would like to recall incidentally that one type of “extensive” attention to the pervasiveness of the past into the present and the inseparability of its effects from everyday life, is a result neither of extraordinary legislative revolutions nor of a recent conceptual “thickening”. It can be traced back to the 1700s (Azzena 2001, p. 150; Colavitti, De Montis 2004, p. 9) but in a form still mediated; certainly to the beginning of the 1900s, with a direct, aware formulation (“each man-made work, for the simple fact of being a “monument”, that is, to have already existed for a certain time, enjoys the right to protection” Riegl 1995, p. 40) which Françoise Choay (1994, p. 9) has brought up to date with: “historic patrimony: the expres-sion denotes remains destined for the pleasure of an enlarged community of planetary dimensions and made up by the continuous accumulation of a large number of objects linked by a common belonging to the past: works and works of art from the fine arts and applied arts, works and products of all kinds of knowledge and all the capacities of human production”.

203
sgradevoli fino a qualche tempo prima (Milani 2005, pp. 97-98). Ricordiamo che le tracce primarie della storia, i ruderi, essendo state guardate, durante tutto il Medioevo, con un timore quasi re-ligioso che si riflette nei numerosi richiami toponomastici al demo-niaco, divengono protagoniste della stagione artistico-culturale del “paesaggio con rovine” nonché motori dell’idea stessa di paesaggio, almeno di quella occidentale6. Insomma, anche a voler cercare una differenziazione solo teorica, è evidente come la storia pervada sempre e comunque il paesaggio. Eppure l’ambiguo statuto di un paesaggio a-storico ha prodotto, nel nostro Paese sicuramente a far data dal secondo dopoguerra, una sorta di perversa graduatoria tra territori/paesaggi intangibili perché densi di significati ambientali, simbolici, culturali7 e altri, figli di un dio minore, sacrificabili “al progresso” (Ricci 2006). Contrapposizione nel tempo sempre meno frontale, questo è vero, ma non per que-sto meno incisiva, specie se tradotta sul terreno dalle pratiche del centro vs. periferia, della conservazione in vitro, del recinto, dell’Oasi, dell’Area e del Parco archeologico (Guzzo 1996, p. 372), sempre ritagliati intorno ad aree “meritevoli”, alle belle contrade. Mentre l’attenzione (e quella storica in particolare) dovrebbe includere tutti i territori, se correttamente intesi non solo come contesti del pa-trimonio storico-culturale ma, costituendone l’indissolubile tessuto connettivo, anche come parte integrante8. Ma non basta ancora: l’attenzione si dovrebbe volgere anche laddove non sembrerebbe proprio necessario: ad esempio in quei contesti degradati, marginali, di bordo di cui si diceva prima. Le wastelands, dispense quasi inesau-ribili di bio-diversità che focalizzano visioni sempre più articolate di disparati approcci disciplinari (Clément 2005; Careri 2006; La Cecla 2005, pp. 141-147. Cfr. Gambi 1986; Lenzi 1999; Maciocco 2000; Maciocco, Pittaluga 2001; Colantonio Venturelli, Galli 2005) e che vengono invece spesso automaticamente escluse dall’interesse del-la storia e anche dall’ombrello della tutela. A causa, temo, proprio dell’ambiguità che innaturalmente distingue luoghi “storici” e “a-sto-rici”, tendendo fra l’altro a fare dei primi un nuovo tipo di derelict landes, recinti indisponibili alla vita, indecifrabili nonluoghi della me-moria9 (Longobardi 2002; Venturi Ferriolo 2002, p. 112; Ricci 2006). Così che la massima attenzione vincolistica è il più delle volte con-centrata sulle aree meno esposte al rischio. Recinti e parchi, in primo luogo, ma poi tutti i luoghi “benedetti” dalla presenza fisica della storia, tangibile e ove possibile non troppo malridotta: aree archeo-
6 Cfr. ora Battisti (2004); Milani (2005); Büttner (2006). Sintesi in Azzena (2001). Sulla nascita del concetto di paesaggio si veda di recente Botti (2006).
7 Si pensi al caso Yosemite Valley o, più vicino a noi nel tempo e nello spazio, a quello dell’Appia antica.
8 Sguardi rinnovati su un vecchio problema, posso-no essere quelli di: Leon (1991); Palazzo (2003, p. 108); Colavitti, De Montis (2004).
9 Per inciso vorrei ricordare che un tipo di atten-zione “estensiva” verso la pervasività del passato nel presente e l’inscindibilità dei suoi effetti dal vissuto quotidiano, non risulta né da straordina-rie rivoluzioni legislative né da un ispessimento concettuale recente. Può essere fatto risalire al Settecento (Azzena 2001, p. 150; Colavitti, De Montis 2004, p. 9) ma in forma ancora media-ta; sicuramente ai primi del Novecento, con una formulazione diretta e consapevole (“ogni opera della mano dell’uomo, per il solo fatto di essere ‘monumento’ cioè di essere già esistita per un certo tempo, gode il diritto di protezione” Riegl 1995, p. 40) che Françoise Choay (1994, p. 9) ha attualizzato “Patrimonio storico: l’espressio-ne designa un fondo destinato al godimento di una comunità allargata di dimensioni planetarie e costituito attraverso l’accumulazione continua di una molteplicità d’oggetti riuniti dalla comune appartenenza al passato: opere e capolavori delle belle arti e delle arti applicate, lavori e prodotti di tutti i saperi e di tutte le capacità di fare umane”.

204
idated: areas already perfectly well-known archaeologically and thus on a sort of ranking list, widespread, consolidated, pernicious. A list of “objects”, which has the historicity of a landscape derive from the result of the sum of the “old” objects (no longer in use) it contains, or from an enigmatic quality of these. It could correctly be observed that the first phase of an archaeological survey “in the field” cannot but feature objects. That is: in a given context first of all entities should be singled out that only have in common the fact of being antecedent to the current state. We could summarise this decree by saying that through pinpointing/positioning the single traces of history on the land10 it is possible to compose that precious cognitive instrument which for clarity’s sake we define, in spite of permanent indefiniteness of current products, Archaeological Charter. Its use in its raw state as a “registry of archaeological entities”, in the absence, that is, of an interpretative synthesis, proves essential in the practice of careful protection (of objects, indeed), but totally inadequate both for pinpointing historic landscapes, and for safeguarding landscapes, and, as is obvious, for the effects of these practices on urban and territorial planning (Azzena 2004). It begins to produce outcomes in this sense, though partial and schematic, when used as a base – moreover, it is always best to emphasise it, irreplaceable – in the reconstruction of ancient modalities of use and consequent proto-morphologies of the anthropised profiles of territories. This is an initial surpassing of the empirical, taxonomical stage of archaeolog-ical knowledge, by which one enters (or tries to enter) the space of relations, of processes of formation, development and discarding of urban and territorial “systems”: “to identify the landscape means [...] to identify the relations reproduced in a more or less extended space within which the landscape expresses and summarises the said relations” (Turri 1983, p. 90). Following this indication, already in this phase of the research we would therefore have reached “identifica-tion” of the landscape.Of which landscape though? Of course that pertaining to the period chosen at the beginning of the research, namely, in the case of inves-tigations with a wide chronological spectrum, of certain “landscapes” (archaic, Roman, medieval and so on) in a sequence. This is one of the crucial knots of the entire argument, for two reasons. The first is only formal but should, however, be clarified: it is a question of terminological misunderstanding linked with the fortune of the defi-nition “landscape archaeology” to indicate first the practices only,
10 Objects characterised, however, by being ante-cedent, according to this way of seeing: a recent attempt to put them into categories is in Fazzio (2005, pp. 98-102).
Door in the walls of Messene, Peloponnese, GreeceLa porta delle mura di Messene, Peloponneso, Grecia

205

206

207
Bosa sea-front at the mouth of the River TemoMarina di Bosa, alla foce del f iume Temo
logicamente già del tutto note e per questo inserite in una sorta di graduatoria, diffusa, consolidata, perniciosa, quella oggettuale, che fa discendere la storicità di un paesaggio dal risultato della somma degli oggetti “vecchi” (non più in uso) che esso contiene, ovvero da una si-billina qualità degli stessi. Si potrebbe correttamente osservare che la prima fase di un’indagine archeologica “sul campo” non può che ave-re carattere oggettuale. Cioè: in un contesto dato occorre in primo luogo individuare entità accomunate soltanto dall’essere antecedenti allo stato di fatto. Potremmo riassumerne il dettato col dire che attraverso individuazione/posizionamento delle singole tracce della storia sul terreno10 è possibile comporre quel prezioso strumento conoscitivo che per chiarezza definiamo, malgrado una permanen-te indeterminatezza dei prodotti correnti, Carta Archeologica. La sua utilizzazione allo stato grezzo di “catasto delle presenze arche-ologiche”, in assenza cioè di sintesi interpretativa, risulta essenziale nella prassi della tutela puntuale (oggettuale, appunto), ma del tutto insufficiente sia per l’individuazione dei paesaggi storici, sia per la sal-vaguardia paesaggistica, sia, come è ovvio, per gli effetti di queste pratiche sulla pianificazione urbanistica e territoriale (Azzena 2004). Inizia a produrre esiti in tal senso, pur parziali e schematici, quando usata come base – peraltro, è sempre bene ribadirlo, insostituibile – nella ricostruzione di antiche modalità d’uso e conseguenti proto-morfologie degli assetti antropizzati dei territori. È questo un primo superamento dello stadio empirico e tassonomico della conoscenza archeologica, attraverso il quale si entra (si prova a entrare) nello spazio delle relazioni, dei processi di formazione, di sviluppo e di-smissione dei “sistemi” urbani e territoriali “identificare il paesaggio significa [...] identificare relazioni che si riproducono in uno spazio più o meno esteso entro il quale il paesaggio esprime e sintetizza le relazioni stesse” (Turri 1983, p. 90). Secondo questa indicazione, già in questa fase della ricerca saremmo dunque pervenuti alla identifi-cazione del paesaggio. Ma di quale paesaggio? Naturalmente di quello relativo al periodo prescelto all’inizio della ricerca, ovvero, nel caso di indagini ad ampio spettro cronologico, di alcuni “paesaggi” (arcaico, romano, medieva-le e via dicendo) in sequenza. È questo uno dei nodi cruciali di tutto il ragionamento, per due motivi. Il primo è solo formale, ma deve essere comunque chiarito: si tratta di un equivoco terminologico le-gato alla fortuna della definizione landscape archaeology (archeologia del paesaggio) a indicare prima solo le pratiche ma, in seguito, anche
10Oggetti comunque caratterizzati dall’essere ante-cedenti, secondo questo modo di vedere: un re-cente tentativo di disporli in categorie è in Fazzio (2005, pp. 98-102).

208
but subsequently, also the theoretic processing based on archaeo-logical research conducted directly on the land (without recourse to excavation). Well, to be precise, the results of this research do not deal with – nor arrive at the reconstruction of – “landscapes” in the strict sense, if anything of early territorial profiles: a sequence of “snapshots” of certain moments in their development, chosen on the basis of the highest index of material proof on the land11. The second reason is much more concrete: departing from the end of the first phase of the research, various historico-archaeological approaches face the difficult theme of the reconstruction of ancient “space”. Actually, apart from what the instruments of analysis or type of synthesis are, whether an inductive or deductive approach is used, whether to proceed by modelisation or by accumulating data, in short, whatever or however we want to call the method used, the result will always, come what may, be the knowledge of ancient territorial profiles, not of landscapes. And, however, even bearing in mind the indisputable scientific import-ance and consequent cultural value of this knowledge, it remains difficult to relate it usefully to the ethical, aesthetic, affective, legislative and managerial and, in a broad sense, also economic, values of the current landscape. In other words, apart from documenting the presence of the past on the land, it would be necessary to explain (as well as trace back to survey systematics) the positive sensation being immersed in a context he recognises in any way as “historic” provokes in contemporary man, regardless of scientific certification of this state. And if this adjec-tivisation is evasive and therefore disputable, it is on the other hand undeniable that the sensation is widely shared. Its systematic clarifica-tion, if nothing else, would bring us close to a determination of the ineffable historic component of the landscape: which does not result from the sum, as stated, or quality of the “old” objects contained in it; nor – only – from the existence and possible continuity of traces of ancient territorial systems; nor yet from the official recognition of their role of contexts, inseparable from – and in – the whole of cultural patrimony. In short, it is not something tangible but neither is it an aesthetising longing (landscape = beautiful view, to say it in a banal way), to which the ancient rhetoric of locus amoenus rigorously attributed six parameters of agreeableness: ales, amnis, aura, lucus, flos et umbra – according to the poet Tiberius, in the fourth century AD (Curtius 1992, p. 220) – in actual fact not very dissimilar from those still efficaciously in force today.
11 In clarifying the specific object of this type of research perhaps the Braudelian expression “Archaeology of space” is less ambiguous, though it has had little luck, and ours is in particular: Ancient Topography. But it is not only a matter, as is obvious, of expressiveness of the name of a discipline, granted that we have already admitted that the true problem is in the ambiguity of the term landscape which “identifies both reality and the representation of it” (Berque 1995, p. 11). It cannot therefore be denied that this distinction is both very subtle and, we might say, specious. However it exists. For an archaeology of the landscape should deal first of all with the sequence of cultural representations of space ‘lived’, in the sense that also the gaze of human systems over places “should always be considered in its diachronic dimension” (Raffestin 2005, p. 46).

209
le elaborazioni teoriche basate su ricerche archeologiche condotte direttamente sul terreno (senza il ricorso allo scavo). Ebbene, a vo-ler essere precisi i risultati di tali ricerche non si occupano – né per-vengono alla ricostruzione – di “paesaggi” in senso stretto, semmai di antichi assetti territoriali: una sequenza di “istantanee” di alcuni momenti del loro sviluppo, scelti in funzione dell’indice più alto di attestazioni materiali sul terreno11. Il secondo motivo è molto più concreto: a partire dalla conclusione della prima fase della ricerca, vari approcci storico-archeologici affrontano il difficile tema della ricostruzione dello “spazio” antico. In realtà, a prescindere da quali siano gli strumenti dell’analisi o la tipologia della sintesi, che si utilizzi un approccio induttivo o uno deduttivo, che si proceda per model-lizzazioni oppure per accumulo di dati, insomma, qualunque sia e comunque si voglia chiamare il metodo utilizzato, la risultante sarà sempre e comunque la conoscenza di antichi assetti territoriali, non di paesaggi. E, comunque, anche considerata la indiscutibile rilevanza scientifica e il conseguente valore culturale di questa conoscenza, resta difficile rapportarla utilmente alle valenze etiche, estetiche, af-fettive, legislative, gestionali e, in senso lato, anche economiche, del paesaggio attuale. In altri termini, oltre a documentare la presenza della storia sul terreno, sarebbe necessario spiegare (nonché ricon-durre a una sistematica di indagine) la sensazione positiva che pro-voca nell’uomo contemporaneo l’essere immerso in un contesto che in qualsiasi modo riconosce come “storico”, a prescindere dalla certificazione scientifica di questo stato. E se questa aggettivazione è sfuggente e quindi discutibile, è invece innegabile che la sensazione sia largamente condivisa. La sua esplicitazione sistematica, se non altro, ci avvicinerebbe a una determinazione dell’ineffabile compo-nente storica del paesaggio: che non risulta dalla somma, si è detto, o dalla qualità degli oggetti “vecchi” in esso contenuti; nemmeno – soltanto – dall’esistenza e dall’eventuale permanenza di tracce di antichi sistemi territoriali; neppure dal riconoscimento ufficiale del loro ruolo di contesti, inscindibili dal – e nel – complesso del patri-monio culturale. Non è, insomma, qualcosa di tangibile ma non è neppure vagheggiamento estetizzante (paesaggio = bel panorama, per spiegare banalizzando), cui l’antica retorica del locus amoenus rigorosamente attribuiva sei parametri di piacevolezza: ales, amnis, aura, lucus, f los et umbra – così il poeta Tiberiano, nel IV sec. d.C. (Curtius 1992, p. 220) – a ben guardare in poco dissimili da quelli a tutt’oggi efficacemente in vigore.
11 Nel chiarire l’oggetto specifico di questo tipo di ricerca è forse meno ambigua l’espressione brau-deliana “Archeologia dello spazio”, che ha però avuto scarsa fortuna, e soprattutto lo è quella nostrana: Topografia Antica. Ma non si tratta solo, come è ovvio, di espressività del nome di una di-sciplina, dato che abbiamo già ammesso che il vero problema sta nell’ambiguità del termine paesaggio che “identifica sia la realtà che la sua rappresenta-zione” (Berque 1995, p. 11). Non si può dunque negare che questo distinguo sia sottilissimo e, se vogliamo, pretestuoso. Tuttavia esiste. Perché una archeologia del paesaggio dovrebbe occuparsi in-nanzi tutto della sequenza delle rappresentazioni culturali dello spazio vissuto, nel senso che anche lo sguardo delle compagini umane sui luoghi “deve sempre essere considerato nella sua dimensione diacronica” (Raffestin 2005, p. 46).

210
Chronodiversity?
We therefore need to try at least to recognise, in the territory surrounding us and in its transfiguration into landscape, a certain rate of “chronodiversity” and perhaps also to classify it, for the purposes of future design of that territory12..All the reasoning perhaps finds a clarifying synthesis in the pinpointing of a line of investigation that, according to a cognitive pattern of an “archaeological” type, frames both the group of anthropic entities on the land (regardless of the period when they were established, their use and their being discarded), and the group of “absences” as persistent historic entities at the same hierarchical level, or, according to a comparable definition13 , as “resistant structures”14 , like a cathedral, an amphitheatre, a nuraghe or an Eneolithic altar. A protagonist, together with all the natural components, of the current form of the territory and thus also of its social representa-tion, or “landscape”. To concentrate on one or the other of these entities, for their “exceptional historic and artistic interest” or for “their important environmental value” and have the degree of conservational meticulousness depend on their presence or, worse still, quality and quantity, means – as well as all the rest – to chain up the maintenance of landscape values completely and utterly to chance. The examination of the territory based on historic sections that can be likened to a stratigraphic sequence15, useful to tidy up in an analytically manageable way the huge complexity of settle-ment palimpsests, risks taking us off the track if applied in a non-mediated way to the singling out, management and protection of the landscape (Azzena 2004, p. 190). All the anthropisation elements need to be considered each time disrupting elements of the status quo and the temporal progression of that “reciprocal relationship between a living organism and the environment it is part of” that has been defined affordance (Gibson quoted in Tagliagambe 2005, pp. 76-77 and 203). But it is just as clear how they constitute elements contributing together to the formation of the social “representation” of those territories (the historico-cultural formation of the landscape) in a diachronic but above all synchronic sense: in particular, in the latter, with formal and visual outcomes that are also highly differentiated, but never completely dissolved nor, in spite of widespread prejudice, particu-larly distinguished from or in the group. Some of these elements
12 I provokingly use a neologism, roughly traced over the word “biodiversity” with a little envy for its communicative fortune. It only serves as a provocation, indeed, to try to understand what it is necessary to concentrate on to achieve respect that is felt and not imposed, as well as understand the phenomena, rather than enclose them (the original meaning of the two words is similar, but fortunately the lexical result is not). Ultimately, it serves to indicate an abstract, yet widely used, coefficient; an emotion, and constant compul-sion, diff icult to trace back to concreteness, yet tangible.
13 This is Turri’s definition (2006, p. 34).14 Note the oxymoron value in applying it to absences.15 For example, territorialising and deterritorialising
phases. Cfr. Poli (2001, pp. 39-41).

211
Cronodiversità?
Occorre, allora, almeno provare a riconoscere, nel territorio che ci circonda e nella sua trasfigurazione in paesaggio, un certo tasso di “cronodiversità” e magari anche a graduarlo, funzionalmente al progetto del futuro di quel territorio12. Tutto il ragionamento trova forse una sintesi chiarificatrice nell’in-dividuazione di una linea di indagine che, secondo uno schema co-noscitivo di tipo “archeologico”, inquadri sia l’insieme delle presen-ze antropiche sul terreno (indipendentemente dalla loro epoca di impianto, d’uso e di dismissione), sia l’insieme delle sue “assenze” come persistenze storiche del medesimo livello gerarchico, ovve-ro, secondo una definizione equivalente13, quali “strutture resisten-ti”14, alla stregua di una cattedrale, di un anfiteatro, di un nuraghe o di un altare eneolitico. Protagonista, insieme a tutte le componenti naturali, della forma attuale del territorio e dunque anche della sua “rappresentazione sociale”, o “paesaggio”. Il concentrarsi su una o sull’altra di queste entità, per il loro “eccezionale interesse storico e artistico” oppure per “il rilevante valore ambientale” e far dipendere il grado di scrupolosità conservativa dalla loro presenza o, peggio, qualità e quantità, significa – oltre a tutto il resto – in-catenare il mantenimento dei valori paesaggistici alla più assoluta casualità. L’esame del territorio secondo sezioni storiche assimila-bili a una sequenza stratigrafica15, utile per ordinare in modo ana-liticamente gestibile la smisurata complessità dei palinsesti insedia-mentali, rischia di portare fuori strada se applicato in modo non mediato all’individuazione, alla gestione e alla tutela del paesaggio (Azzena 2004, p. 190).Tutti gli elementi dell’antropizzazione devono essere considerati quali elementi di volta in volta perturbanti lo status quo e la pro-gressione temporale di quel “rapporto reciproco tra un organismo vivente e l’ambiente in cui è inserito” che è stato definito affordance (Gibson, cit. in Tagliagambe 2005, pp. 76-77 e 203). Ma è altrettan-to chiaro come essi costituiscano elementi pariteticamente con-correnti alla formazione della “rappresentazione” sociale di quei territori (la formazione storico-culturale del paesaggio), in senso diacronico ma soprattutto sincronico: in particolare, in quest’ul-timo, con esiti formali e visivi anche molto differenziati, ma mai totalmente dissolti né, malgrado un diffuso pregiudizio, particolar-mente distinti dall’insieme e nell’insieme. Alcuni di questi elementi
12 Uso provocatoriamente un neologismo, rozza-mente ricalcato sulla parola “biodiversità” con un po’ di invidia per la sua fortuna comunicati-va. Esso serve soltanto, provocatoriamente ap-punto, a tentare di capire su cosa sia necessario concentrarsi per pervenire a un rispetto sentito e non imposto, nonché alla comprensione dei fe-nomeni, più che alla loro recinzione (il signif icato originale delle due parole è simile, ma fortunata-mente l’esito lessicale no). Serve, in ultima analisi, a indicare un coefficiente astratto eppure diffu-samente utilizzato; un’emozione, e una costante pulsione, diff icilmente riconducibili alla concre-tezza, eppure tangibili.
13 Questa definizione è di Turri (2006, p. 34).14 Si noti, nell’applicazione alle “assenze”, il valore di
ossimoro.15 Ad esempio di fasi territorializzanti e deterrito-
rializzanti. Cfr. Poli (2001, pp. 39-41).

212
may be said, if anything, to be “lucky”, when the possible connota-tion of “valuable” territorial structure has been transmitted through time without the changes, including graphic ones, in the conditions of use having tarnished the parameters of approval16 .But for the lucky places, as for the marginal ones, the same trap underlying the conception of “historic” landscape holds true in that they are studded with historic objects. An active trap even when the research concentrates on one or more “states of innocence” of places: moments of particular harmony deriving from a primitive imprinting meaning an “initial gesture that in man of the remote past obeyed simple, basic, elementary options, therefore dictated, we could say, by nature” (Turri 2002, p. 14). The demands of the tourism market drive some of these neo-mythical (Fonti 1991) sites towards a role increasing in priority which then means, especially from the point of view of local powers, the almost exclusive chan-nelling of care, protection and enhancement of these landscapes par excellence. Some of these are actually endowed with a strange transcendence, created, however, by advertising skills with false, glazed emotional excesses17 .“High” culture is not exempt from these risks either. The Mediterranean context abounds in instances of this problematic issue and Sardinia is a particular example18 . On the other hand does not the most exclusive idiosyncrasy of the classical “Sardinian landscape” lie in that dreadfully archaic sense of oppression of nature over man and, even more, in the sign of his absence? Well what is wrong with recognising and wanting to conserve the seductive charm of such an archaic landscape, or even of total, gratifying “immaculacy”? Nothing. The danger is all in the under-lying question, completely misleading in protection practice: where should I place the threshold between uncontaminated and jeop-ardised? And where the one between historic and less historic, or a-historic? In other words, where can I draw the boundary between what is “sacred” and what is simply expendable? The answer is fortunately obvious: I do not have to place it, I do not have to draw it. The fortune of the landscape lies precisely in the fact that all those overlappings do not cancel each other out and still prove, almost all of them and almost always, perceivable in the whole. All the past is in the landscape: this, when understood, is the greatest value and, simultaneously, the most fragile and irreproducible. To work for the landscape therefore means, simply, to develop, spread
16 Aesthetic approval, of course (though sometimes also economic), certainly often sacrif iced for more material goods, without too many regrets by individuals or communities, but solidly absorbed, without bowing to renewed cultural stimuli, tendencies, emotions. Each time accom-panied by “focusing”, by chance (it should be said) positive, of the famous deforming lens of the landscape.
17 Easily singled out by iconemes now totally artif icial as they are distilled by belittling a very complex cultural reality and, possibly, also a territorial context otherwise endangered: white columns, blue doors and bozoukis or nuraghi, sheep and launeddas, obscure the geography of choremes (for semantic use based on choreme geography, and, on the landscape of iconemes, see the recent Turri 2006, pp. 169-175) and, rather than bear witness to the history and culture of a land and its inhabitants, are delegated to provide guaran-tees of globalised recognisability, able to appease without shocks our “nostalgia for the landscape” (Raffestin 2005; Turri 2006, pp. 155-160).
18 “It is indeed to the ancient peoples, to their early co-cooning themselves in the body of nature, that we owe that plan of the territory [...] which shows a web of relations between man and environment much deeper and more ancient than that imposed by the Roman villa, the domus of the ‘kingdom’ era and even the medieval village” (Ortu 1992, p. 663).

213
possono dirsi semmai “fortunati”, quando l’eventuale connotazione di struttura territoriale “di pregio” si sia trasmessa nel tempo senza che le modifiche, anche icastiche, delle condizioni d’uso ne intaccas-sero i parametri di gradimento16.Ma per i luoghi fortunati, come per quelli marginali, vale la stessa trappola sottesa nella concezione di paesaggio “storico” in quanto costellato di oggetti storici. Una trappola attiva anche quando ci si concentri nella ricerca di uno o più “stati di innocenza” dei luoghi: momenti di particolare armonia derivanti da un originario imprin-ting inteso come “gesto iniziale che nell’uomo del passato remoto obbediva a opzioni semplici, essenziali, elementari, e per ciò stesso dettate, si può dire, dalla natura” (Turri 2002, p. 14). Le esigenze del mercato turistico spingono alcuni di questi siti neo-mitici (Fonti 1991) verso un ruolo sempre più prioritario, che poi significa, spe-cie nell’ottica dei poteri locali, il convogliamento in forma pressoché esclusiva di cure, salvaguardia, valorizzazione su questi paesaggi per antonomasia, taluni effettivamente dotati di una peculiare trascen-denza, resa però dall’artificio pubblicitario con eccessi emozionali patinati e falsi17.Anche la cultura “alta” non è esente da questi rischi. Il contesto mediterraneo è ricco di evenienze di questa problematicità e quel-lo sardo lo è, ad esempio, in particolare18. D’altra parte la pecu-liarità più esclusiva del classico “paesaggio sardo” non sta forse in quel senso spaventosamente arcaico di sopraffazione della natura sull’uomo e, più ancora, nel segno della sua assenza? E allora che male c’è a riconoscere e voler conservare il seduttivo richiamo di un paesaggio così arcaico, o addirittura di una totale, gratificante “incontaminazione”? Nessuno. Il pericolo è tutto nella domanda che ciò sottintende, totalmente fuorviante nella prassi della tutela: dove devo erigere la soglia tra incontaminato e compromesso? E dove quella tra storico e meno storico, o a-storico? In altre parole, dove posso tracciare il confine tra ciò che è “sacro” e ciò che è semplicemente sacrificabile? La risposta fortunatamente è ovvia: non la devo erigere, non lo devo tracciare. La fortuna del paesaggio sta proprio nel fatto che tutte quelle sovrapposizioni non si elidono tra loro e risultano ancora, quasi sempre e quasi tutte, percepibili nell’insieme. Tutta la storia è nel paesaggio: è questo, quando ca-pito, il valore più grande e, a un tempo, il più fragile e irriproduci-bile. Lavorare per il paesaggio significa allora, semplicemente, far crescere, diffondere e insieme rendere più profonde le possibilità
16 Gradimento estetico, naturalmente (ma talvolta anche economico), certo sovente sacrif icato per beni più materiali e senza troppi rimpianti dai sin-goli o dalle comunità, ma inglobato solidamente e senza flessioni in rinnovate tendenze, emozioni, stimoli culturali. Di volta in volta accompagnato da una “messa a fuoco” fortunosamente (è il caso di dirlo) positiva della famosa lente deformante del paesaggio.
17 Facilmente individuabili attraverso iconemi ormai totalmente artefatti perché distillati banalizzando una realtà culturale molto complessa e, magari, anche un contesto territoriale altrimenti compro-messo: colonne bianche, porte azzurre e bozouki o nuraghi, pecore e launeddas, annebbiano la ge-ografia dei coremi (per un uso semantico riferito alla geografia dei coremi e, al paesaggio, degli ico-nemi si veda Turri 2006, pp. 169-175) e, più che testimoniare la storia e la cultura di una terra e dei suoi abitanti, sono delegati a fornire garanzie di riconoscibilità globalizzata, capaci di appagare senza scosse la nostra “nostalgia di paesaggio” (Raffestin 2005; Turri 2006, pp. 155-160).
18 “È proprio agli antichi populi, al loro primo im-bozzolarsi nel corpo della natura, che si deve quel disegno del territorio [...] che manifesta una trama di rapporti tra uomo e ambiente assai più antica e profonda di quella imposta dalla villa romana, dalla domus giudicale e dallo stesso villaggio me-dievale” (Ortu 1992, p. 663).

214
and at the same time deepen the cultural possibilities of percep-tion of the components of the whole and the consequent intrinsic value of that whole. To condense the reasons for protection in criteria of exceptionality based on “tradition, fame and particular features” may legally be unobjectionable, but is certainly consider-ably restrictive.I believe that one of the most important consequences of the approach adopted up to now is that the landscape (the landscape, not the territory, or the environment), apart from being utterly “historic” still needs protection in the absolute absence of witnesses or traces – material, monumental, archaeological or artistic; it possesses “exceptional” environmental qualities. And the last conse-quence coincides with the clarification in practical terms of some principles or broad criteria, which could steer renewed models of historico-territorial investigation. For some the simple specification of parameters is valid which, taken separately, are already widely used in territorial and urban archaeological analyses. This is the case of comparative evaluation of the physical, economic, cultural and historic “components” of territories, including visual effects: an evaluation that should be, but is not always, interdisciplinary19.It is indeed the evaluation of the quantity and quality of the inter-connections evident between the dispersed fragments of an period, as well as the possibility of revealing those that are hidden, that constitutes the first principle of individuation of history in the landscape (rather than of the “historic” landscape). Individuation obtained largely thanks to processing in a summarising manner of tenaciously analytical research conducted directly on the land (ancient topography, historic analysis of the territory, archaeology of the landscape, of space, etc.), but which should point out with greater conviction assessment criteria connected with perception.
Equidistance, scale, reciprocity, sharing
The arduous responsibility of “singling out” landscapes should also, however, be based on more abstract criteria, principles of individuation of “chronodiversity”, if we want to accept this definition, which, in their theoretical formulations, we have already partly examined. They could, therefore, be defined here briefly: equidistance, scale, reciprocity, sharing. Equidistance consists, as
19 In the sense that it is useful to compare the results of multidisciplinary surveys, but not enough, nor is it suff icient to add on the meth-odological approaches. We ought rather to attempt co-penetration, “join them together” not by accumulating them, indeed, but by the creation of a third approach, entirely new. The operative challenge is the most demanding and can be based only on the creation of a meth-odology directed by practical requests, on new landscape design, not only on static respect of the existing. Thus from a strictly technical point of view, the consequence proves also to be the surpassing of the bidimensional reading of historic phenomena, spontaneously deriving from cartographic production and often exclu-sively symbolic of the position of their material traces. If the Archaeological Maps (even if managed by GIS systems) are for some reason understood (misunderstood) as representa-tions of the “historic landscape” and above all if they are conceived exclusively as groups of objects (expressed in multi-coloured stars, dots, squares and triangles), they stand for themselves only: not for history, or even less the landscape (Azzena 1997).

215
culturali di percezione delle componenti dell’insieme e del conse-guente valore intrinseco di quell’insieme. Compendiarne i motivi di tutela in criteri di eccezionalità basati su “la tradizione, la fama e le particolari caratteristiche” potrà essere legalmente ineccepibile, ma certo è assai limitativo. Credo che una delle conseguenze più importanti del ragionamento fin qui condotto sia che il paesaggio (il paesaggio, non il territorio, o l’ambiente), oltre a essere “storico” tutto, sempre e per definizione, necessiti di tutela anche nella più totale assenza di testimonianze o tracce materiali, monumentali, archeologiche, artistiche, come an-che di “eccezionali” qualità ambientali. E l’ultima conseguenza coin-cide con l’esplicitazione in termini pratici di alcuni principi, o criteri di massima, che potrebbero orientare rinnovati modelli di indagine storico-territoriale. Per alcuni vale la semplice precisazione di para-metri che, presi separatamente, sono già ampiamente utilizzati nel-le analisi archeologiche territoriali e urbane. È il caso della valutazio-ne comparativa delle “componenti” fisiche, economiche, culturali e storiche dei territori, ivi comprese le incidenze visive: valutazione che dovrebbe essere, ma non sempre è, interdisciplinare19.È proprio la valutazione della quantità e della qualità delle inter-connessioni evidenti tra i frammenti dispersi di un’epoca, nonché la possibilità di rivelare quelle celate, a costituire il primo principio di individuazione della storia nel paesaggio (più che del paesaggio “storico”). Individuazione ottenuta in massima parte grazie all’ela-borazione in chiave sintetica di una ricerca tenacemente analitica condotta direttamente sul terreno (topografia antica, analisi storica del territorio, archeologia del paesaggio, dello spazio ecc.), ma che dovrebbe segnalare con più convinzione criteri di valutazione con-nessi alla percezione.
Equidistanza, scala, reciprocità, condivisione
La laboriosa responsabilità di “individuare” paesaggi si deve però fondare anche su criteri più astratti, principi di individuazione di “cronodiversità”, se vogliamo accettare questa definizione, che, nelle loro formulazioni teoriche, abbiamo già in parte esaminato. Potrebbero allora essere qui definiti in sintesi: equidistanza, scala, reciprocità, condivisione. L’equidistanza consiste, lo abbiamo accen-nato, nell’applicazione di una prospettiva storica in continuo movi-
19 Nel senso che è utile confrontare i risultati di in-dagini multidisciplinari, ma non basta, né è suff i-ciente addizionarne gli approcci metodologici. Si dovrebbe piuttosto tentare una compenetrazio-ne, “unirli insieme” non per accumulo, appunto, ma mediante la creazione di un approccio terzo, del tutto inedito. La sfida operativa è quella più impegnativa e si può basare solo sulla creazione di una metodologia orientata dalle richieste pra-tiche, sul progetto del nuovo paesaggio, non solo sul rispetto statico dell’esistente. Conseguente, poi, da un punto di vista strettamente tecnico, ri-sulta anche il superamento della lettura bidimen-sionale dei fenomeni storici, spontaneamente derivante dalla resa cartografica e spesso esclu-sivamente simbolica della posizione delle loro tracce materiali. Le Carte Archeologiche (anche se gestite da sistemi GIS) se per qualche motivo intese (fraintese) come rappresentazioni del “pa-esaggio storico” e soprattutto quando concepite esclusivamente come insiemi di oggetti (espressi in pallini, quadrati, triangoli e stelle multicolori) rappresentano solo se stesse: non la storia né tanto meno il paesaggio (Azzena 1997).

216
we have mentioned, in the application of a historic perspective in continuous movement, not concentrated on the most important (outstanding, famous, evident, etc.) phase of a context. Because the “reconstruction” of the features of a territory in a given phase of its past, or its development over time, is one thing, while the attempt to sensitively approach co-penetration (not stratification) of the numerous signs of past “landscapes” in the present one, tending, indeed, to single out “chronodiversity” is another. We have hinted at a series of “disruptive” historic events with respect to a primitive state of innocence of the territory, but none of these perhaps reaches the violence of the impact of a huge industrial plant built ex novo on a fragile coastal strip. Like the Argentiera mining complex (Mossa 1991, p. 112), with the sombre ghost of the enormous ‘sink-float’ plant a few metres from the sea, in no way different from a contemporary eco-monster, except for its transfiguration into a glamorous relic of the past through the historic lens of our gaze20. For those are probably right who think “the product of preceding systems of relations, for the people living there, were not landscapes.They were the territories of their existence, the places of everyday
20 And on the other hand, nowadays, does not pro-gressive abandoning perhaps begin to bestow a different aura, that of a Tarkovskyan Zone, to the industrial area of Porto Torres, too, the grey, in-human SIR which refined oil, processing lung can-cer? To its spiky skyline, Circensian backdrop of an overseas city, to the increasingly arcane cross-roads of rusty pipes, in a few centuries time new domus de janas, even if knowing nothing of janas?

217
mento, non concentrata sulla fase più rilevante (cospicua, famosa, evidente, ecc.) di un contesto. Perché una cosa è la “ricostruzione” delle caratteristiche di un territorio in una data fase della sua storia, ovvero della sua evoluzione nel tempo, altra il tentativo di approc-cio sensibile alla compenetrazione (non stratificazione) degli innu-merevoli segni dei “paesaggi” passati in quello presente, tendente, appunto, all’individuazione di “cronodiversità”. Abbiamo accennato a una serie di eventi storici “dirompenti” rispetto a un primitivo stato di innocenza del territorio, ma nessuno di questi forse rag-giunge la violenza dell’impatto di un immane stabilimento industria-le edificato ex novo su una fragilissima fascia litoranea. Come il complesso minerario dell’Argentiera (Mossa 1991, p. 112), con il tetro fantasma dell’enorme laveria a pochi metri dal mare, in nulla dissimile da un ecomostro contemporaneo, tranne per la trasfigu-razione in fascinosa reliquia del passato operata dalla lente storica del nostro sguardo20. Perché probabilmente ha ragione chi pensa che “il prodotto dei sistemi di relazioni precedenti, per la gente che li abitava, non erano paesaggi. Erano i territori dell’esistenza, i luoghi della vita quotidiana [...]. Questi territori di una volta sono
20 E d’altra parte, oggi, la progressiva dismissione non inizia forse a elargire un’aura diversa, da Zona tarkovskijana, anche all’area industriale di Porto Torres, la grigia, inumana SIR che raffinava petro-lio elaborando cancri ai polmoni? Al suo skyline spigoloso, fondale circense di città d’oltreoceano, ai crocicchi sempre più arcani di tubi arrugginiti, tra qualche secolo nuove domus di janas, anche se di janas ignoranti?
Porto Torres industrial zone in northern SardiniaLa zona industriale di Porto Torres nella Sardegna settentrionale

218
life [...]. These territories of time past became landscapes after the disappearance of preceding territorialities. This means that, in our society, a territory becomes a landscape when the relations that have created it begin to disappear” (Raffestin 2005, p. 58). Scale, always nullifying in landscape surveys, takes on decisive importance here: for perception (visual, corporeal, cultural, affective, ethical, aesthetic, etc.) also changes with variation in the scale of observation. The centralised protection policies, in their abstract severity, may prove excessive or totally insufficient depending on the scale of observation and perception of the phenomena protected. Or, also: elements disturbing discrete harmony on the scale of details may disappear in the overall view, but disruptive elements on the large scale will in all probability upset all discrete harmonies21. Reciprocity. The word “landscape”, as we have said, contains within it the sign of man. And, above all, even in the wildest, most remote territories man’s gaze brings history with it. Vice versa, in an obviously “historic” landscape (whatever that means) the signs of anthropisation are not distinguishable, in good and bad, from the physical, natural components of the framework supporting every-thing. By touching single ones there are effects on the others. And vice versa. With no possible exceptions. These thoughts open the way to the last principle, that of sharing. Accepted and, indeed, for some time a protagonist of the most advanced planning concep-tions and practices, it proves still to be little taken into account when the subject is protection. Like badly constructed reinforce-ment, increasingly restrictive legislation has covered with a thick mesh something that was already protected, leaving sensitive and particularly fragile parts uncovered. If this is true for the so-called individual patrimony, those “monuments/documents” often reduced to urban furniture in flower-beds on traffic islands, it is to a greater extent as far as landscape protection is concerned. In the first place, even just to safeguard ourselves from the “plague of language”, we would need to point out that safeguarding the landscape cannot concern “Landscape Patrimony”, simply because nothing exists, in nature or man-made, that might correspond to this definition. Second: safeguarding the landscape cannot be based on enclosures for if we are able to enclose the Archaeological Areas, with results however unresolved, even with all our goodwill we will never manage to enclose the landscape. Perhaps, then, wide-
21 The recent explosion of small-scale residency in the countryside round some of the ancient “royal cities” of Sardinia, which also represents a clear material, aesthetic disruption of the rural landscape, has – partly and in its own way – contributed to maintaining the olive-wood landscape, due to the simple, spontaneous awareness of those building their own villas wanting to enjoy the greenery, silence, the air (we recall: ales, amnis, aura, lucus, f los et umbra), as well as to live in a house and park the car. And if a few metres away a different model of urban propagation – for example a front of compact periphery – entails its complete cancellation, here, instead, for every ten olive trees succumbing to the small villa, another twenty are guaranteed free maintenance. The political consequence of the scale I have called “affective” has not escaped me: I just believe that a political value is much more ephemeral than a shared “affective” (or rather ethical) sense. Not so long ago those we nowadays call the homeless had their f ixed residence in the Colosseum and cows grazed on the Imperial Forums of Rome; and still in Rome, but only a few months ago, they set up scaffolding to restore the obelisk of the Foro Italico bearing – engraved in huge letters – Mussolini Dux.

219
diventati paesaggi dopo la scomparsa delle territorialità precedenti. Ciò significa che, nella nostra società, un territorio diventa paesag-gio quando le relazioni che lo hanno creato iniziano a scomparire” (Raffestin 2005, p. 58).La scala, sempre dirimente nelle indagini sul paesaggio, assume qui un’importanza decisiva: perché anche la percezione (visiva, corpo-rea, culturale, affettiva, etica, estetica, ecc.) cambia al variare della scala di osservazione. Le direttive centralizzate di tutela, nella loro severità astratta, possono risultare eccessive oppure totalmente in-sufficienti a seconda della scala di osservazione e percezione dei fe-nomeni tutelati. O, anche: elementi perturbanti un’armonia discreta alla scala di dettaglio possono scomparire nella visione d’insieme, ma elementi perturbanti sulla grande scala perturberanno con ogni probabilità tutte le armonie discrete21.Reciprocità. La parola “paesaggio”, lo abbiamo detto, contiene in sé il segno dell’uomo. E, soprattutto, anche nel più selvaggio dei territori estremi lo sguardo dell’uomo porta con sé la storia. Viceversa, in un paesaggio evidentemente “storico” (qualsiasi cosa ciò significhi) i segni dell’antropizzazione non sono distinguibili, nel bene e nel male, dalle componenti fisiche e naturali del telaio che sostiene il tutto. Toccando le une si incide sugli altri. E viceversa. Senza eccezioni possibili. Queste considerazioni aprono la strada all’ultimo principio, quello della condivisione. Accettato e, anzi, da tempo protagonista delle concezioni e delle pratiche più avanzate della pianificazione, risulta ancora poco considerato quando si trat-ta di tutela. Come armature mal costruite, legislazioni sempre più restrittive hanno coperto con maglie fittissime qualcosa che era già protetto, dimenticando scoperte parti sensibili e fragilissime. Se questo è vero per i cosiddetti beni individui, quei “monumenti/do-cumenti” spesso ridotti ad arredo urbano nelle aiuole spartitraffico, lo è in misura maggiore per quanto riguarda la tutela paesaggistica. In primo luogo, anche soltanto per salvaguardarsi dalla “peste del linguaggio”, bisognerebbe segnalare che la salvaguardia del paesag-gio non può riguardare “Beni Paesaggistici”, semplicemente perché non esiste niente, in natura o manufatto, che possa corrispondere a questa definizione. Secondo: la salvaguardia del paesaggio non si può fondare sui recinti perché se si riesce a recintare, con risultati peraltro irrisolti, le Aree Archeologiche, anche con tutta la buona volontà non si riuscirà mai a recintare il paesaggio. Forse, allora, do-vrebbe passare attraverso l’attenzione condivisa per il territorio nel
21 La recente esplosione della residenza minuta nell’agro di alcune delle antiche “città regie” della Sardegna, che pure rappresenta un’evidente per-turbazione materiale ed estetica del paesaggio rurale, ha – in parte e a suo modo – contribuito al mantenimento del paesaggio dell’olivo, per la semplice e volontaria coscienza da parte di chi costruiva il proprio villino di voler godere del ver-de, del silenzio, dell’aria (ricordiamo: ales, amnis, aura, lucus, f los et umbra), oltre che di abitare una casa e parcheggiare una macchina. E se a qualche metro di distanza un altro modello di propaga-zione urbana, ad esempio un fronte di periferia compatta, ne comporta il totale azzeramento, qui, invece, per dieci olivi che soccombono al villino, ad altri venti è garantita gratuitamente la manutenzione. Il risvolto politico della scala che ho chiamato “affettiva” non mi è sfuggito: credo solo che un valore politico sia molto più eff ime-ro di un condiviso senso “affettivo” (o piuttosto etico). Non troppo tempo fa dentro il Colosseo avevano residenza f issa quelli che oggi chiamia-mo i senza-tetto e sui Fori Imperiali di Roma pa-scolavano le vacche; e sempre a Roma, ma solo qualche mese fa, hanno montato le impalcature per restaurare l’obelisco del Foro Italico che reca inciso – a lettere cubitali – Mussolini Dux.

220
spread, “everted” attention, that is, projected (designed) towards the future, should pass through shared attention for the territory in its entirety. Antonio Cederna (1991, p. 288) wrote in 1950: “in art everything can be done in theory, whether “we should” or “we shouldn’t” does not come into it, but it is always and only a question of men, capable and genial or incapable and mediocre”. Later he rejected this view which now, on the other hand, fifty years later, translated into less apocalyptic terms, seems perfectly shareable: the only hope for protection of the high values of history, culture and good living contained in our territories and represented by our landscape, and for their feasible application, not being imposed from above, lies in the growth of awareness of those values, which are not actually those of the Land Registry. In other words it all dwells in the careful maintenance of the heads of men who inhabit those territories, travel across them, gaze at them.

221
The port of Porto Torres: buildings of the 70s, the Aragonese tower, SIR (petrochemical) factory chimneys and the wind turbine blades of Fiume Santo electricity plant make up an urban landscape memorable for its “past”Lo scalo di Porto Torres: palazzi anni ‘70, la torre aragonese, le ciminiere della SIR e le pale eoliche della centrale elettrica di Fiume Santo, compongono un paesaggio urbano problematicamente “storico”
suo complesso, attenzione diffusa ed “estroflessa”, cioè proiettata (progettata) verso il futuro. Antonio Cederna (1991, p. 288), nel 1950, scriveva “in arte tutto teoricamente si può fare, che il ‘si deve’ e il ‘non si deve’ non c’entrano nulla, ma è solo e sempre questione di uomini, capaci e geniali o incapaci e mediocri”. Più tardi rifiuterà questa visione che invece adesso, a distanza di cinquant’anni e tra-dotta in termini meno apocalittici, sembra perfettamente condivi-sibile: l’unica speranza per una tutela dei valori alti di storia, cultura e buon vivere contenuti nei nostri territori e rappresentati dal no-stro paesaggio, nonché di una sua applicazione praticabile perché non imposta dall’alto, sta nella crescita della consapevolezza di quei valori, che non sono propriamente quelli catastali. In altre parole risiede tutta nell’attenta manutenzione della testa degli uomini che quei territori li abitano, li percorrono, li guardano.

222
References / Bibliografia
Azzena G. (1997), “Questioni terminologiche – e di merito – sui GIS in archeologia”, in Gottarelli A. (a cura di), Sistemi Informativi e reti geografiche in archeologia: GIS-INTERNET VII Ciclo di Lezioni sulla ricerca applicata in campo archeologico, All’Insegna del Giglio, Firenze, pp. 33-43.
Azzena G. (2001), “L’indagine topografica e la cartografia ar-cheo-logica”, in Il Mondo dell’Archeologia, Treccani, Roma, pp. 149-152.
Azzena G. (2004), “Tancas serradas a muros. Tracce di inco-municabilità nel linguaggio archeologico”, Archeologia e Calcolatori, 15, pp. 185-197.
Battisti E. (2004), Iconologia ed ecologia del giardino e del paesag-gio, Leo S. Olschki, Firenze.
Benevolo L. (2006), L’architettura nell’Italia contemporanea. Ovvero il tramonto del paesaggio, Laterza, Roma-Bari.
Berque A. (1995), Les raisons du paysage, de la Chine antique aux environnements de synthèses, Hazan, Paris.
Bonesio L. (1997), Geofilosof ia del paesaggio, Mimesis, Milano.Bonesio L. (2002), Oltre il paesaggio, Arianna Editrice, Bologna. Botti F. B. (2006), “L’Epistola del Ventoso e le misure della rap-
presentazione petrarchesca della realtà”, Quaderns d’Italià, 11, pp. 291-311.
Büttner N. (2006), Il paesaggio. Nella storia dell’arte, Jaka Book, Milano.
Caravaggi L. (2002), Paesaggi di paesaggi, Meltemi, Roma. Careri F. (2006), Walkscapes, Einaudi, Torino. Carpani E. (2005), “La convenzione europea del paesaggio
nell’esperienza italiana di tutela paesistica”, in Colantonio Venturelli R. Tobias K. (a cura di) (2005), La cultura del pae-saggio, Leo S. Olscki, Firenze, pp. 21-38.
Castelnovi P. (1998), “Il senso del paesaggio. Relazione introdut-tiva”, in Il senso del paesaggio. Atti Seminario internazionale, Politecnico di Torino, Torino, pp. 1-22.
Cavezzali D., Palombi M. R. (2000), Conferenza nazionale per il Paesaggio, Atti I-II, Gangemi, Roma.
Cederna A. (1991), Brandelli d’Italia: come distruggere il bel pae-se, Newton Compton, Roma.
Choay F. (1994), L’allegoria del patrimonio, Officina, Roma. Clément G. (2005), Manifesto del Terzo paesaggio, Quodlibet,
Macerata.
Colantonio Venturelli R., Galli A. (2005), “La Convenzione Europea del Paesaggio e la gestione nelle aree metropolitane degli spazi rurali di riequilibrio”, in Colantonio Venturelli R., Tobias K. (a cura di) (2005), La cultura del paesaggio, Leo S. Olscki, Firenze, pp. 255-275.
Colavitti A. M., De Montis A. (2004), “Dai monumenti al conte-sto: politiche plurali verso la tutela delle forme dell’ambiente e del paesaggio”, Urbanistica Informazioni, 195, pp. 9-10.
Copeta C., “Prefazione” in Cosgrove D. (1990), Realtà sociali e pae-saggio simbolico, Unicopli, Milano, pp. 9-22.
Cosgrove D. (1990), Realtà sociali e paesaggio simbolico, Unicopli, Milano.
Curtius E. R. (1992), Letteratura europea e Medio Evo latino, La Nuova Italia, Firenze.
Decandia L. (1994), “Recinti sacri e feste lunghe in Sardegna. La centralità dei luoghi sacri nella costruzione della realtà territo-riale sarda”, in Costa G. (a cura di), Un campus Teatrale a Sant’Anna Arresi in Sardegna, Contemporanea, Firenze, pp. 23-37.
Decandia L. (2000), Dell’Identità. Saggio sul luoghi: per una critica della razionalità urbanistica, Rubettino, Soveria Mannelli.
Decandia L. (2004), Anime di luoghi, FrancoAngeli, Milano. Di Bene A., Scazzosi L. (a cura di) (2006), La relazione paesaggi-
stica. Finalità e contenuti, Gangemi, Roma. Farina A. (2006), Il paesaggio cognitivo. Una nuova entità ecologica,
FrancoAngeli, Milano. Farinelli F. (1981), “Storia del concetto geografico di paesaggio”, in
Paesaggio. Immagine e realtà, Electa, Milano, pp. 151-158. Farinelli F. (1991), “L’arguzia del paesaggio”, Casabella, 575-76,
pp. 10-12. Farinelli F. (2003a), Geografia. Un’introduzione ai modelli del mondo,
Einaudi, Torino. Farinelli F. (2003b), “La natura del paesaggio”, in Milani R., Morpurgo
A. (2003), Parametro, 245 (n. monografico: “Mutazioni di paesaggio”).
Fazio M. (a cura di) (1996), “Dossier. Paesaggio, identità perduta. La trasformazione del paesaggio italiano”, Italia Nostra, 327, pp. 2-18.
Fazzio F. (2005), Gli spazi dell’archeologia. Temi per il progetto urba-nistico, Officina, Roma, pp. 98-102.
Fonti A. (1991), “Il sito del rito e del mito: la scena mutante”, Art Ven, 1, pp. 99 -103.

223
Gambi L. (1981), “Riflessioni sui concetti di paesaggio nella cultu-ra italiana degli ultimi trent’anni”, in Martinelli R. e Nuti L. (a cura di), Fonti per lo studio del paesaggio agrario, CISCU, Lucca, pp. 3-9.
Gambi L. (1986), “I valori storici dei quadri ambientali”, in Storia d’Italia vol. 1, I caratteri originali, Einaudi, Torino, pp. 5-60.
Guermandi M. P. (a cura di) (2006), “Dossier. Oltre il Codice”, IBC, 14(2), pp. 57-80.
Guido M. R., Sandroni D. trad. it., Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 20 ottobre 2000), art. 6, comma C, §1.
Guzzo P. G. (1996), “Considerazioni sui parchi archeologici”, Ostraka, 5(2), pp. 369-375.
Guzzo P. G. (2002), Natura e storia nel territorio e nel paesaggio, “L’Erma” di Bretschneider, Roma.
La Cecla F. (2000), Perdersi. L’uomo senza ambiente, Laterza, Roma-Bari.
Lenzi F. (a cura di) (1999), Archeologia e ambiente. Atti, Abaco, Bologna-Forlì.
Leon P. (1991), “La politica del paesaggio”, Casabella, 575-76, pp. 94-96.
Longobardi G. (2002), “Aree archeologiche: non luoghi della città contemporanea”, in Segarra Lagunes M. M. (a cura di), Archeologia urbana e progetto di architettura. Atti, Gangemi, Roma, pp. 41-52.
Maciocco G. (a cura di) (2000), “Wastelands”, Plurimondi, 3. Maciocco G., Pittaluga P. (a cura di) (2001), La città latente. Il proget-
to ambientale in aree di bordo, FrancoAngeli, Milano. Milani R., Morpurgo A. (a cura di) (2003), Parametro, 245 (n.
monografico: “Mutazioni di paesaggio”).Milani R. (2005), “Cultura del paesaggio ed estetica del paesaggio
in Italia”, in Colantonio Venturelli R ., Tobias K. (a cura di) (2005), La cultura del paesaggio, Leo S. Olscki, Firenze, pp. 93-107.
Mossa V. (1991), Luna & sole. Curiosità edilizie di Sassari, Delfino, Sassari.Ortu G. G. (1992), “Il corpo umano e il corpo naturale. Costru-
zione dello spazio agrario e pretese sulla terra nella Sardegna medievale e moderna”, Quaderni Storici, 81(3), pp. 653-685.
Palazzo A. (2002), “Identif icare i paesaggi. Risorse storico cul-turali”, in Clementi A. (2002), Interpretazioni di paesaggio. Convenzione Europea e innovazioni di metodo, Meltemi, Roma, pp. 138-160.
Palazzo A. L. (2003), “Paesaggi e modificazione. Riflessioni sulla fertile ambiguità della storia”, Urbanistica, 120, pp. 102-110.
Panizza M., Piacente S. (2003), Geomorfologia culturale, Pitagora, Bologna.
Poli D. (2001), Attraversare le immagini del territorio, All’Insegna del Giglio, Firenze.
Poli G. (2006), “Il territorio? Nasconde un tesoro”, Europei, 5(24), pp. 8-9.
Poli G. (2006), “Quali prospettive per la pianif icazione paesaggi-stica?”, IBC, 14(2), pp. 76-80.
Raffestin C. (2005), Dalla nostalgia del territorio al desiderio di pa-esaggio. Elementi per una teoria del paesaggio, Alinea, Firenze.
Ricci A. (2006), Attorno alla nuda pietra, Donzelli, Roma. Riegl A. (1995), “Progetto di un’organizzazione legislativa della con-
servazione in Austria”, in Scarrocchia S. (a cura di), Alois Riegl, teoria e prassi della conservazione dei monumenti, Clueb, Bologna, pp. 209-210.
Scazzosi L. (1999), Politiche e culture del paesaggio. Esperienze in-ternazionali a confronto, Gangemi, Roma.
Scazzosi L. (2002), Leggere il paesaggio. Confronti internazionali, Gangemi, Roma.
Schmitz H., cit. in Janni P. (1984), La mappa e il periplo. Cartografia antica e spazio odologico, Giorgio Bretschneider, Roma, p. 93.
Turri E. (1983), Antropologia del paesaggio, Comunità, Milano. Turri E. (2002), La conoscenza del territorio. Metodologia per un’analisi
storico-geografica, Marsilio, Venezia. Turri E. (2006), Il paesaggio come teatro. Dal territorio vissuto al
territorio rappresentato, Marsilio, Venezia (5° ed.). Venturi Ferriolo M. (2002), Etiche del paesaggio. Il progetto del
mondo umano, Editori Riuniti, Roma.

224
Webliography / Sitografia
Aedon (2005) - Rivista di arti e diritto on line. Numero monogra-fico sui Beni Paesaggistici, 3
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2005/3/index305.htm Carpentieri P. (2004), “La nozione giuridica di paesaggio”, Rivista
trimestrale di Diritto Pubblico, 2, pp. 263-424. http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/stu-
di_contributi/carpentieri4.htm Cicala V., Guermandi M. P. (a cura di) (2005), Regioni e ragioni nel
nuovo Codice dei Beni culturali e del paesaggio. Atti del Convegno, Regione Emilia Romagna, Bologna.
http://ibcregione.emilia-romagna.it/h3/h3.exe/aRIVISTAIBC/sC:!TEMP!HwTemp!3seCB52.tmp/d1;data.x=>[01/07])
Collapsed columns of the Temple of Zeus, OlimpiaLe colonne crollate del tempio di Zeus a Olimpia

225

Giovanni Maciocco è professore ordinario di Tecnica e Pia-nificazione Urbanistica. È direttore del Dipartimento di Archi-tettura e Pianificazione e preside della Facoltà di Architettura di Alghero, Università di Sassari. Ha pubblicato diversi volumi. Tra i tanti: La città in ombra (FrancoAngeli, 1996); Wastelands (Dedalo, 2000); Fundamental Trends in City Development (Sprin-ger, 2008); Urban Landscape Perspectives (ed.) (Springer, 2008); The Territorial Future of the City (ed.) (Springer, 2008); People and Space. New Forms of Interaction in the City Project, con Ta-gliagambe S. (eds) (Springer, 2009); Enhancing the City. New Per-spectives for Tourism and Leisure, con Serreli S. (eds) (Springer, 2009); Il territorio, la memoria, il progetto (FrancoAngeli, 2010).
Gianfranco Sanna è ricercatore in Disegno e Rappresenta-zione presso la Facoltà di Architettura di Alghero, Università di Sassari. È docente di Disegno e Rappresentazione nei corsi di laurea in Architettura e Pianificazione Territoriale Urbanisti-ca e Ambientale. Tra le sue pubblicazioni recenti: “Dimensione ambientale e future forme dell’abitare”, in Purini F. et al. (a cura di), La città nuova italia - y - 26 invito a Vema. Il Padiglione Italiano alla 10. Mostra Internazionale di Architettura (Editrice Composi-tori, 2006); “Paesaggi contemporanei e progetto della città”, in Maciocco G. (a cura di), Studi sul progetto del paesaggio (Fran-coAngeli, 2010); “Territori-struttura e scenari ambientali della città”, in Maciocco G. (a cura di), Laboratori di progetto sul pae-saggio (FrancoAngeli, 2010).
Silvia Serreli è ricercatore in Tecnica e Pianificazione Urbani-stica presso la Facoltà di Architettura di Alghero, Università di Sassari. È docente di Pianificazione Territoriale presso la stessa Facoltà. Tra le sue pubblicazioni recenti: Le dimensioni plurali della città ambientale. Prospettive di integrazione ambientale nel progetto del territorio (FrancoAngeli, 2004); “Urban Landsca-pe and an ecology of creativity”, in Maciocco G. (ed.), Urban Landscape Perspectives (Springer, 2008); “Derelict places as alternative territories of the city”, in Maciocco G. (ed.), The Territorial Future of the City (Springer, 2008); Enhancing the City. New Perspectives for Tourism and Leisure, con G. Maciocco (eds) (Springer, 2009); Paesaggi costieri e progetti di territorio, con G. Maciocco (a cura di) (FrancoAngeli, 2010).
Il potenziale urbano del territorio sembra in primo luogo richiamare la riscoperta di un ancoraggio alla terra, nel senso che dal territorio la città riceve un richiamo alla riflessione sul senso della casa dell’uomo, come ricerca degli elementi pri-mari della sua costruzione, una ricerca dell’essenziale urbano. In un orizzonte che sembra spingerci verso una vita urbana orientata in senso ambientale, sembrano forse aprirsi per i va-sti territori densi di natura e di storia prospettive promettenti per la costruzione di mondi urbani possibili.
Il volume esplora le ragioni attuali delle relazioni tra i ter-ritori e l’insediamento urbano, delineando una prospettiva di città ambientale che recupera la profondità storica e il senso del territorio e li rilancia in termini attuali. Gli autori mettono in luce i modi inediti in cui il territorio è posto all’attenzione di una vita urbana che proprio attraverso queste relazioni inedi-te si rinnova e trova la luce di una prospettiva.
I progetti illustrati propongono un ricentramento selettivo della città sui suoi cardini ambientali, in un certo senso ester-ni alle dinamiche consuetudinarie della città mettendo in luce territori-struttura che rivelano nella loro densità di natura e di storia la forza generatrice di un ordine diverso dello spazio insediativo. In questi territori il progetto anche nei suoi gesti più piccoli fa emergere lo spazio pubblico contemporaneo, scoprendo un mondo comune di significati urbani nel territo-rio della città.
The urban potential of the territory seems first and fore-most to evoke the rediscovery of an anchorage to the land, in the sense that the city receives an appeal from the territory to reflect on the sense of man’s home, as a quest for the primary elements of its construction, a search for urban essence. On a horizon that appears to be urging us towards environmental-ly-oriented urban life, promising perspectives seem perhaps to be opening up for the vast territories rich in nature and history for the construction of possible urban worlds.
This book explores the current reasons for the relations between territories and urban settlement, outlining a per-spective of environmental city that will retrieve the historic depth and sense of the territory to relaunch them in current terms. The authors highlight the original ways the territory is brought to the attention of an urban life that, precisely throu-gh these new relations, is renewed and finds the light of a perspective.
The projects illustrated propose selective re-centring of the city on its environmental cornerstones, to some extent ex-ternal to the usual dynamics of the city, highlighting structure-territories that reveal in their natural and historic wealth the generating force of a different kind of settlement space. In the-se territories the project, even with the smallest action, ma-kes public contemporary space emerge, disclosing a common world of urban meanings in the territory of the city.
€ 39,00 (U)
Giovanni Maciocco is full professor of Town and Regional Planning, director of the Department of Architecture and Planning and dean of the Faculty of Architecture, University of Sassari. His works include: La città in ombra (FrancoAngeli, 1996); Wastelands (Dedalo, 2000); Fundamental Trends in City Development (Springer, 2008); Urban Landscape Perspectives (ed.) (Springer, 2008); The Territorial Future of the City (ed.) (Springer, 2008); People and Space. New Forms of Interaction in the City Project, with S. Tagliagambe (eds) (Springer, 2009); En-hancing the City. New Perspectives for Tourism and Leisure, with S. Serreli (eds) (Springer, 2009); Il territorio, la memoria, il progetto (FrancoAngeli, 2010).
Gianfranco Sanna is a researcher in Architectural Design at the Faculty of Architecture, University of Sassari. At present he is teaching Architectural Design and Planning. His publi-shed works include: “Dimensione ambientale e future forme dell’abitare”, in Purini F. et al. (eds), La città nuova italia - y - 26 invito a Vema. Il Padiglione Italiano alla 10. Mostra Internazionale di Architettura (Editrice Compositori, 2006); “Paesaggi con-temporanei e progetto della città”, in Maciocco G. (ed.), Studi sul progetto del paesaggio (FrancoAngeli, 2010); “Territori-struttura e scenari ambientali della città”, in Maciocco G. (ed.), Laboratori di progetto sul paesaggio (FrancoAngeli, 2010).
Silvia Serreli is a researcher in Landscape and Urban Plan-ning at the Faculty of Architecture, University of Sassari. She is a lecture in Territorial Planning. Her recent publications in-clude: Le dimensioni plurali della città ambientale. Prospettive di integrazione ambientale nel progetto del territorio (FrancoAngeli, 2004); “Urban Landscape and an ecology of creativity”, in Ma-ciocco G. (ed.), Urban Landscape Perspectives (Springer, 2008); “Derelict places as alternative territories of the city”, in Ma-ciocco G. (ed.), The Territorial Future of the City (Springer, 2008); Enhancing the City. New Perspectives for Tourism and Leisure, with G. Maciocco (eds) (Springer, 2009); Paesaggi costieri e progetti di territorio, with G. Maciocco (eds) (FrancoAngeli, 2010).
The Urban Potentialof External Territoriesedited by Giovanni Maciocco, Gianfranco Sanna and Silvia Serreli
Metodi del Territorio
FrancoAngeli /Facoltà di Architettura di Alghero
1126.31 G
. Maciocco, G
.Sanna, S. Serreli (eds) The U
rban Potential of External Territories
La passione per le conoscenze