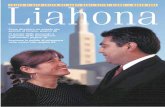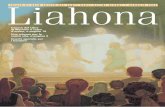Tesi 2004.pdf
-
Upload
gian-vittorio-cermelli -
Category
Documents
-
view
35 -
download
4
Transcript of Tesi 2004.pdf

RICCARDO TESI (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA)
La lingua dei classici della letteratura e l�italiano di oggi
Italiano lingua �ad una sola arcata�? (�continuisti�) La grammatica, l�ortografia, e per conseguenza la pronunzia, e tutte le parole e frasi della lingua italiana sono oggi, con rare e irrilevanti eccezioni, precisamente quelle medesime che si trovano non solo nelle prose di Dante, ma di scrittori che vissero innanzi a lui. E vi sono lunghi tratti di poemi, e pagine numerose di storie del secolo XIII nelle quali non s�incontra un unico vocabolo che gli scrittori viventi a� dì nostri non possano usare senza la minima taccia di affettazione. Gl�Inglesi e i Francesi che scrivevano a que� tempi, ed anco posteriormente, non sono intesi (U. Foscolo, Epoche della lingua italiana, 1823). L�italiano vero e proprio, non è la resultanza del latino volgare che si combini o collutti con altre favelle, ma è la limpida continuazione del solo latino volgare� La maggior purezza della tempera del linguaggio si combina poi con una persistenza che rasenta l�invariabilità. Non c�è così un antico italiano da contrapporre al moderno, come al moderno francese si contrappone un antico� è� evidente per tutti, che la lingua di Dante è l�italiano che ancor vive e si scrive (G. I. Ascoli, Archivio glottologico italiano, VIII, 1882-85).

Italiano �antico� vs italiano �moderno� (�discontinuisti�) Ora noi ambiremmo a che questo esercizio d�interpretazione [di un sonetto di Dante] cadesse specialmente sotto occhi liceali; sì che, entrando nella memoria, questa poesia vi s�imprimesse con un significato diverso da quello che di solito ritiene. Passa per il tipo di componimento linguisticamente limpido, che non richiede spiegazioni, che potrebbe �essere stato scritto ieri�; e si può dire invece che non ci sia parola, almeno delle essenziali, che abbia mantenuto nella lingua moderna il valore dell�originale (G. Contini, Esercizio d�interpretazione sopra un sonetto di Dante [1947], in Id., Varianti e altra linguistica, Torino, Einaudi, 1979). Un mito che io credo verrà� dissipato è quello di ciò che può essere chiamata l�unità storica dell�italiano. Si dice spesso che l�italiano è notevole per la accessibilità dei suoi monumenti letterari più antichi, che possono essere letti dai moderni parlanti dell�italiano con un minimo di preparazione specialistica, e si fanno paragoni con l�impenetrabilità dell�inglese di Chaucer o del francese di Froissart per un parlante/lettore moderno non istruito. Ma questa argomentazione si fonda sull�idea di un parlante moderno che è decisamente portato alla storia letteraria, che ha una buona conoscenza della Bibbia e un�istruzione nelle lingue classiche. Togliete questi presupposti culturali e confrontate la lingua di Dante con il linguaggio quotidiano dell�Italia moderna; la sovrapposizione è molto meno ovvia. Possiamo sin d�ora sottolineare ovvie differenze di vocabolario e di grammatica: le regole che presiedono alla collocazione dei pronomi atoni (clitici) sono molto diverse nell�italiano di Dante e nei linguaggi moderni, così come lo sono quelle che fanno riferimento al gerundio o all�uso delle preposizioni (N. Vincent, Il progetto �ItalAnt�, in «Lingua e stile», XXXV, 2000).

Premesse illuministiche Premessa questa predilezione e questo geniale contagio [per la lingua francese], non è che una conseguenza l�abbandono, il disprezzo e la dimenticanza de� classici libri italiani e dello studio della litterale nostra favella. I librai dell�Italia, i quali scorgeranno divenir zepperelli [�pezzi di legno per rincalzare mobili�] inutili delle loro botteghe i libri egregi, e spezialmente i capidopera di lingua della nostra nazione, spinti dal bisogno della venalità, asseconderanno il pubblico umore e il �Genio attuale scoppiato con forza a trionfare sul despotismo della scuola�; faranno arrivare in Italia le balle di libri francesi, le porranno a mostra come gioielli al bulicame [�moltitudine�] de� dotti e degli indotti appassionati, che si affollerà a comperarli� (Carlo Gozzi, Il gusto francese e la gallomania in Italia, 1790 ca., in Discussioni linguistiche del Settecento, a cura di M. Puppo, Torino, Utet, 1979, p. 513-14). La lingua letteraria sta diventando una �lingua specialistica�? La stabilità della lingua italiana nel corso dei secoli e la sua stretta interrelazione con quella letteraria hanno consentito alle minoranze colte del nostro paese di godere di un privilegio ignoto agli altri europei, quello di poter leggere, pur con qualche sussidio, i grandi testi a partire quasi dalle origini, diciamo da Dante, senza soffrire di una sostanziale discontinuità linguistica. Dante e Petrarca sono stati �nostri�, attuali, fino a poco tempo fa; i Promessi sposi sono stati un laboratorio per l�insegnamento linguistico ancora ai tempi in cui io frequentavo il liceo. Questo privilegio, che una cultura di impianto retorico-umanistico ha teso a presentare come un vanto, dimenticando quale arretratezza sociale e culturale essa sottendesse, oggi si sta rovesciando in una grave penalizzazione. L�effetto congiunto di una lingua di comunicazione che non si nutre di quella tradizione linguistica e del vero salto antropologico che la società postindustriale ha provocato nelle nuove generazioni ha avuto come effetto quello di �antichizzare� nel volgere di pochi decenni l�intera tradizione letteraria nazionale. Sarebbe eccessivo dire che quella lingua ha ormai i connotati di lingua straniera, ma non si va lontano dal vero sostenendo che la rescissione del rapporto con la lingua d�uso l�ha relegata fra quelle �specialistiche�. Che fare? Rinunciare all�intera nostra memoria letteraria? Credo che nessuno assentirebbe a cuor leggero. È forse prevedibile che in un futuro non troppo lontano i processi in corso ridurranno per davvero la lingua letteraria italiana, dalle origini fin dentro a questo secolo, a lingua �morta�, da studiare come una sorta di secondo latino (M. Santagata, Tradurre Machiavelli?, in «Rivista dei libri», 1998, n. 5, maggio, pp. 11-12).

Alcune testimonianze sulla difficoltà (linguistica) di comprendere i classici
L�ottimo Paciaudi mi raccomandava frattanto di non trascurare nelle mie laboriose letture la prosa, ch�egli dottamente denominava la nutrice del verso. Mi sovviene a questo proposito, che un tal giorno egli mi portò il Galateo del Casa, raccomandandomi di ben meditarlo quanto ai modi, che certo ben pretti toscani erano, ed il contrario di ogni franceseria. Io, che da ragazzo lo aveva (come abbiam fatto tutti) maledetto, poco inteso, e niente gustatolo, mi tenni quasiché offeso di questo puerile o pedantesco consiglio. Onde, pieno di mal talento contro quel Galateo, lo apersi. Ed alla vista di quel primo Conciossiacosache, a cui poi si accoda quel lungo periodo cotanto pomposo e sì poco sugoso, mi prese un tal impeto di collera, che scagliato per la finestra il libro, gridai quasi maniaco: «Ella è pur dura e stucchevole necessità, che per iscrivere tragedie in età di venzett�anni mi convenga ingoiare di nuovo codeste baie fanciullesche, e prosciugarmi il cervello con sì fatte pedanterie»1.
È innegabile che da buona pezza a questa parte, un po� di scioltezza, se non di leggiadria, s�è venuta acquistando. Il giornalismo, a tal riguardo, ha fatto un gran bene, e assai più che comunemente si creda. Il contegno austero, da edifizii ambulanti, delle matrone periodesse è spezzato; il nesso sintattico, se lascia ancor molto a desiderare per la correttezza, è veramente più snello e più facile. Si pensi alla prosa dei nostri classici. Io, per me, lo dico senza ipocrisia di frasi, io leggendo quella prosa ho sempre finito col cascarci sopra con tutto il peso del più pesante sonno. Ricordo che, ragazzo, il signor professore m�ingiungeva sempre di leggere i dialoghi del Tasso; io, se bene con grave animo, mi davo sempre a obbedirgli; ma, l�ombra del Grande me lo perdoni, ci cascavo anche sopra, come per forza di legamento oscuro2.
Alcuni anni or sono, Goffredo Parise mi confidò che abbastanza di frequente l�italiano di Machiavelli gli risultava difficile, complicato e oscuro. Mi disse di essere riuscito a capire e a gustare Il Principe di Machiavelli solamente dopo averlo letto in traduzione francese. Soggiunse che gli stranieri conoscevano Machiavelli meglio degli italiani, poiché avevano la fortuna di leggerlo tradotto. Suggerì di tradurre Il Principe in italiano moderno, e sostenne che la cultura politica degli italiani ne avrebbe tratto gran giovamento. Gli diedi ragione e gli confessai come anche per me la lettura del Principe risultasse molto spesso ardua. Gli proposi di tentar lui la traduzione moderna, ma rifiutò incitandomi a tentar io l�impresa3. 1 V. Alfieri, Vita, a cura di G. Dossena, Torino, Einaudi, 1981, pp. 157-58. 2 L. Pirandello, Prosa moderna (1890), in Id., Saggi, poesie, scritti varii, Milano, Mondadori, 1960, p. 853. 3 P. Melograni, Premessa e dedica, in N. Machiavelli, Il Principe, testo originale con la versione in italiano di oggi, Milano, Rizzoli, 1991.

�Falsi amici�
Il quale [Federigo degli Alberighi], sì come il più de� gentili uomini avviene, d�una gentil donna chiamata monna Giovanna s�innamorò, ne� suoi tempi tenuta delle più belle donne e delle più leggiadre che in Firenze fossero; e acciò che egli l�amor di lei acquistar potesse, giostrava, armeggiava, faceva feste e donava, e il suo senza alcun ritegno spendeva; ma ella, non meno onesta che bella, niente di queste cose per lei fatte né di colui si curava che le faceva (Decameron, V, 9). Questi [Federigo degli Alberighi], come accade il più delle volte agli uomini di animo nobile, si era innamorato di una donna gentile chiamata monna Giovanna, una delle più belle e leggiadre della Firenze del tempo e, per conquistare il suo amore, organizzava feste, spettacoli d�arme, donava generosamente, consumando senza misura il suo denaro. La donna però, onesta oltre che bella, non si curava affatto di queste cose né di lui. (Claudio Bura - M. Antonietta Morettini, Dieci novelle dal �Decameron� di G. B. «tradotte» e commentate con testo originale a fronte, Perugia, Guerra, 1997, p. 97). Anche Federico, come di solito accade ai blasonati, si innamorò di una blasonata, la nobile Giovanna, che a quei tempi era considerata una delle dame più belle e avvenenti di Firenze. Per potersi conquistare una nicchia nel suo cuore, partecipava ai tornei, faceva un duello dopo l�altro, dava ricevimenti e le inviava regali su regali senza badare a spese, ma la signora, non meno fedele che bella, era del tutto indifferente sia a queste giostre seduttive che al loro artefice. (Giovanni Boccaccio - Aldo Busi, Decamerone da un italiano all�altro, Milano, Rizzoli, 1990, p. 446).

Tradurre �Il Principe� di Machiavelli
(1a) Ma di poi valsono ancora a lei poco le fortezze, quando Cesare Borgia l�assaltò e che il populo, suo inimico, si coniunse col forestiere (XX, 145);
(1b) Ma in seguito, quando Cesare Borgia la attaccò e il popolo che le era ostile si unì allo straniero, le fortezze le servirono a poco (Melograni, p. 199).
(2a) Non può pertanto uno signore prudente, né debbe, osservare la fede quando tale osservanzia gli torni contro e che sono spente le cagioni che la feciono promettere (XVIII, 116-7);
(2b) Un signore prudente, pertanto, non può né deve rispettare la parola data se tale rispetto lo danneggia e se sono venute meno le ragioni che lo indussero a promettere (Melograni, 167).
(3a) E quel principe che va con li eserciti, che si pasce di prede, di sacchi e di
taglie, maneggia quello di altri, gli è necessaria questa liberalità: altrimenti non sarebbe seguito da� soldati (XVI, 107);
(3b) Se un principe che guida un esercito si sostiene predando, saccheggiando, taglieggiando, impadronendosi dei beni del nemico sconfitto, deve necessariamente essere prodigo, altrimenti non sarebbe seguito dai suoi soldati (Melograni, p. 157).

Tradurre il �Cortegiano� di Baldassar Castiglione Alle pendici dell�Appenino, quasi al mezzo della Italia verso il mare Adriatico, è posta (come ognun sa) la piccola città d�Urbino; la quale, ben che tra monti sia, e non così ameni come forse alcun altri che veggiamo in molti lochi, pur di tanto havuto ha il cielo favorevole, che intorno il paese è fertilissimo e pien di frutti; di modo che, oltre alla salubrità dell�aere, si trova abundantissima d�ogni cosa che fa mestieri per lo vivere humano. Ma tra le maggior felicità che se le possono attribuire, questa credo sia la principale: che da gran tempo in qua sempre è stata dominata da ottimi signori, avenga che nelle calamità universali delle guerre della Italia essa anchor per un tempo ne sia restata priva [editio princeps, 1528]. Alle pendici dell�Appennino, quasi al mezzo dell�Italia verso il mare Adriatico, è posta (come ognuno sa) la piccola città di Urbino. La quale, benché tra monti sia, e non così ameni come forse alcuni altri che vediamo in molti luoghi, pure di tanto avuto ha il cielo favorevole, che intorno il paese è fertilissimo e pieno di frutti, di modo che, oltre alla salubrità dell�aria, si trova abbondantissima di ogni cosa che fa mestieri per il vivere umano. Ma tra le maggiori felicità che si le [sic!] possono attribuire, questa credo sia la principale: che da gran tempo in qua sempre è stata dominata da ottimi signori, avvenga che nelle calamità universali delle guerre dell�Italia essa ancora per un tempo ne sia restata priva [edizione A. Quondam].

Tradurre l�incipit del �Galateo� di Giovanni Della Casa Conciossiacosaché tu incominci pur ora quel viaggio del quale io ho la maggior parte, sì come tu vedi, fornito, cioè questa vita mortale, amandoti io assai, come io fo; ho proposto meco medesimo di venirti mostrando quando un luogo e quando altro, dove io, come colui che gli ho sperimentati, temo che tu, camminando per essa, possi agevolmente o cadere o come che sia errare; acciocché tu, ammaestrato da me, possi tenere la diritta via con salute dell�anima tua e con laude e onore della tua orrevole e nobile famiglia [editio princeps, 1558]. Sei appena all�inizio di quel viaggio della vita che io ho quasi del tutto compiuto; e per l�amore che ti porto ho deciso di farti riflettere su svariate situazioni dove temo − io che ne ho già fatto esperienza − che tu possa, nel tuo cammino, facilmente cadere in errore o sbagliare in qualche modo: affinché, con l�aiuto dei miei insegnamenti, ti mantenga sulla dritta via della buona educazione, giovando all�anima e arricchendo di meritate lodi la tua nobile e onorata famiglia [traduz. Myriam Cristallo]. Visto che stai appena per intraprendere quel viaggio che io ho per la maggior parte concluso, cioè questa esistenza terrena, mi sono proposto, per l�affetto profondo che nutro nei tuoi confronti, di venirti a mostrare quei frequenti incidenti di percorso, che ho sperimentato su di me, nei quali temo che tu possa cadere, o comunque imbatterti. E questo perché tu, ammaestrato dal mio esempio, possa seguire la retta via che ti metterà in salvo e che produrrà lodi e onori alla tua onorata e nobile famiglia .

Leopardi �traduttore� del Petrarca
Nessuno oggi in Italia, fuori dei letterati (io voleva dir fuori di pochissimi letterati), conosce nè può intendere facilmente la lingua italiana antica. Nondimeno anche le donne italiane, e oltre di ciò un gran numero di stranieri, vogliono leggere il Petrarca, poeta molto difficile anche alle persone dotte ed esercitate nella lettura e nella lingua dei nostri scrittori classici� Di più, quantunque non tutti i comentatori del Petrarca conoscano la lingua italiana antica, nondimeno tutti presuppongono che i lettori la sappiano molto bene: di modo che anche per questa parte sono inutili agli stranieri, alle donne, e agl�italiani di oggidì, generalmente parlando. L�intento di questa Interpretazione si è di fare che chiunque intende mediocremente la nostra lingua moderna, possa intendere il Petrarca, non mica leggendo spensieratamente, perchè in questo secolo non si può far l�impossibile, ma ponendoci solamente quell�attenzione che si mette nel leggere l�articolo delle mode nei giornali. La chiamo Interpretazione, perch�ella non è un comento come gli altri, ma quasi una traduzione del parlare antico e oscuro in un parlar moderno e chiaro, benchè non barbaro� (G. Leopardi, L�autore dell�interpretazione a chi legge, in Le rime di Francesco Petrarca con l�interpretazione di G. Leopardi, Milano, Stella, 1826). «una doppia lingua» Ho già detto altrove che non prima del passato secolo e del presente si è formato pienam. e perfezionato il linguaggio (e quindi anche lo stile) poetico italiano� ha perduto ogni aria di familiare; e si è con ben certi limiti� distinto dal prosaico. O vogliamo dir che il linguaggio prosaico si è diviso esso medesimo dal poetico. Il che propriamente non sarebbe vero; ma e� s�è diviso dall�antico: e così sempre accade che il linguaggio prosaico, insieme coll�ordinario uso della lingua parlata, al quale ei non può fare a meno di somigliarsi, si vada di mano in mano cambiando e allontanando dall�antichità� Dalla quale antichità la prosa, obbligata ad accostarsi all�uso corrente, sempre più s�allontana. Ond�è che il linguaggio prosaico si scosti per vero dire esso stesso dal poetico (piuttosto che questo da quello) ma non in quanto poetico, solo in quanto seguace dell�antico, e fermo (quanto più si può) all�antico, da cui il prosaico s�allontana. Del resto il linguaggio e lo stile delle poesie di Parini, Alfieri, Monti, Foscolo è molto più propriam. e più perfett. poetico e distinto dal prosaico, che non è quello di verun altro de� nostri poeti, inclusi nominatamente i più classici e sommi antichi. Di modo che per quelli e per gli altri che li somigliano, e per l�uso de� poeti di questo e dell�ultimo secolo, l�Italia ha oggidì una lingua poetica a parte, e distinta affatto dalla prosaica, una doppia lingua, l�una prosaica l�altra poetica� (G. Leopardi, Zibaldone [3417-18], 12 settembre 1823).

Traduzione sinonimica → parola antica > sinonimo moderno «plora. Piange» a �gradiente semantico� → «Vaghi pensier. Vagabondi. Leggeri. Vani» «parole accorte. Prudenti. Sagge. Giudiziose. Spiritose» «Qualor. Qualunque volta. Sempre che. Ogni volta che» «Paventoso. Pauroso. Spaventato», ecc. Traduzione �parafrastica� → sinonimo + glossa esplicativa «M�informe. M�informi. Cioè mi ammaestri e mi spingi» «Incischi, cioè lo frastagli, lo trinci, lo sforacchi superficialmente» «Poi che l�alma dal cor non si scapestra. Poiché l�anima non si scioglie, non si sprigiona dal cuore. Cioè, pochè con tutti questi mali, io non muoio», ecc. Traduzione �grammaticale� → �attualizzazione� fonomorfosintattica «là �ve sta per là dove, cioè dove» «vene, sta per viene» «aita. Aiuta», «ancide. Uccide» Tobler-Mussafia: «facciol. Lo fo» che �polivalente� o �indeclinato�: «Nella stagion che �l ciel. Nell�ora nella quale», ecc. Traduzione �topologica� → �attualizzazione� sintattica (ordine diretto) «d�or capelli. Capelli d�oro» «dell�alma tolle. Toglie dall�animo» «i più deserti campi vo misurando. Vo camminando per li campi più deserti» «quanti vorrei quel giorno attender anni. Quanti anni consentirei di aspettare quel giorno del mio contento», ecc.

Canzone All�Italia, 1818 (vv. 41-48) Dove sono i tuoi figli? Odo suon d�armi e di carri e di voci e di timballi: in estranie contrade pugnano i tuoi figliuoli. Attendi, Italia, attendi. Io veggio, o parmi, un fluttuar di fanti e di cavalli, e fumo e polve, e luccicar di spade come tra nebbia lampi. G. Leopardi, Canzoni. Versione in prosa, note e postfazione di Marco Santagata, Milano, Mondadori, 1998, p. 19. Dove sono i tuoi figli? Sento un rumore di armi, di carri, di voci e di tamburi: i tuoi figli combattono in paesi stranieri. Fa� attenzione, Italia, ascolta. Vedo, o così mi pare, un ondeggiare di soldati e di cavalli, e fumo e polvere e uno scintillio di spade come lampi nella nebbia. Le rime di F. Petrarca con l�interpretazione di G. Leopardi (1826) son. CCVIII, v. 7 : attendere �osservare attentamente, prestare attenzione� Vattene innanzi [rapido fiume]: il tuo corso non frena né stanchezza né sonno: e pria che rendi [�che tu restituisca�] suo dritto [�tributo d�acque�], fiso, u� si mostri, attendi l�erba più verde, e l�aria più serena. «fiso, u� si mostri, attendi. Guarda fissamente, attentamente, ove sia»

Cronologia 1612-1614 P. Beni traduce nell�Anticrusca e nel Cavalcanti brani del Decameron in lingua «moderna», «regolata e gentile». 1764 Protesta degli intellettuali del Caffè contro la lingua e il lessico del Vocabolario degli accademici della Crusca (Rinunzia avanti notaio degli autori del presente foglio periodico al Vocabolario della Crusca). 1826 G. Leopardi �traduce� in italiano moderno il Canzoniere del Petrarca. 1840-42 A. Manzoni pubblica una nuova edizione del suo romanzo adeguandolo alla lingua parlata a Firenze dalle persone colte. 1856 R. Bonghi, Perché la letteratura italiana non sia popolare in Italia. 1863 L�editore fiorentino Barbèra testimonia la crisi del mercato librario dei �classici� tre-cinquecenteschi. 1860-1880 Crisi delle �parole colte e letterarie� nella prosa narrativa. 1887-1891 P. Petrocchi, lessicologo e grammatico manzoniano, confina nella parte inferiore del suo Novo dizionario italiano il lessico arcaico e letterario. 1914 R. Serra: «Romanzi e novelle oramai in Italia hanno realizzato il tipo unico con una felicità da fare invidia ai produttori di vino toscano». 1936 B. Croce, La poesia. Introduzione alla critica e storia della poesia e della letteratura: è lecito tradurre «modernamente», anche «nell�ambito di una stessa lingua nazionale», autori come Vico o scrittori di materie scientifiche (matematici, fisici, filosofi e storici). 1950-1960 Scrittori toscani come C. Cassola decrescono il tasso della loro �toscanità� (cfr. I. Baldelli, Varianti di prosatori contemporanei [Palazzeschi, Cecchi, Bassani, Cassola, Testori], Firenze, Le Monnier, 1970). 1964 P. P. Pasolini, Nuove questioni linguistiche: esiste un �nuovo italiano�, una koiné che riflette «la nascente tecnocrazia del Nord», e «elabora un nuovo tipo di cultura e di lingua effettivamente nazionali» che ha rotto i legami con l�italiano letterario della tradizione (anche nella sua veste moderna, manzoniana). 1961-1965 Iniziano a pubblicarsi traduzioni in italiano moderno di classici del Trecento e del Cinquecento.

BIBLIOGRAFIA
Testi �classici� in prosa con traduzione in lingua moderna:
Il Novellino. Testo originale con la versione in italiano di oggi di Aldo Busi e
Carmen Covito, Milano, Rizzoli (�Bur Superclassici�), 1992; (�Superbur Classici�, 1999).
Marco Polo, Il Milione. Versione in italiano moderno e note a cura di Giorgio Trombetta-Panigadi, Milano, TEA, 2002.
Giovanni Boccaccio, Il Decamerone. Edizione integrale con testo a fronte in italiano moderno, Milano, Edizioni DCM, 1965-1966, 2 volumi.
Giovanni Boccaccio − Aldo Busi, Decamerone da un italiano all�altro, Milano, Rizzoli, 1990-1991, 2 volumi; edizione in un unico volume: Milano, Rizzoli (�Bur�), 1993.
Giovanni Boccaccio, Cinque novelle dal Decamerone, a cura di Maurizio Spagnesi, Roma, Bonacci (�Classici italiani per stranieri�, 2), 1995.
Claudio Bura − M. Antonietta Morettini, Dieci novelle dal Decameron di Giovanni Boccaccio, �tradotte� e commentate con testo originale a fronte, Perugia, Guerra, 1997.
Antonio Corsi, Il Principe di Machiavelli tradotto nella lingua di oggi, Roma, Edizioni De Sario, 1961.
Niccolò Machiavelli, Il principe. Testo originale con la versione in italiano di oggi di Piero Melograni, Milano, Rizzoli (�Bur Superclassici�), 1991; (�Superbur Classici�, 1998).
Niccolò Machiavelli, Il Principe. Sette capitoli scelti, a cura di Sabrina Maffei, Roma, Bonacci (�Classici italiani per stranieri�, 5), 1995.
Carmen Covito e Aldo Busi traducono Il Cortigiano di Baldassar Castiglione, Milano, Rizzoli, 1993.
Baldassarre Castiglione, Il Cortigiano, a cura di Amedeo Quondam, Milano, Mondadori (�Oscar Classici�), 2002, 2 volumi.
Giovanni Della Casa, Galateo. Testo originale con la versione in italiano di oggi di Myriam Cristallo, Milano, Rizzoli (�Bur Superclassici�), 1992; (�Superbur Classici�, 2000).