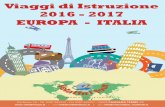Sovana
-
Upload
pierluigi-albini -
Category
Education
-
view
285 -
download
3
Transcript of Sovana
2
C’è una certa difficoltà a parlare in
modo lineare di Sovana. Conviene
seguire un percorso cronologico che
però non coincide con i passi che
porteranno il visitatore ad aggirarsi
per il borgo, oppure è meglio
seguire un criterio topografico, con
la fatica di dover compiere continui
balzi storici, anche molto ampi?
Seguiremo un criterio misto, forse
più faticoso ma che anticipa le
sequenze di ciò che vedremo
domani e che, nello stesso tempo,
cerca di seguire un filo logico.
3
Dall'apice di una breve
discesa, dopo aver
soffermato lo sguardo,
venendo da Pitigliano,
sulla sinistra, sulla roccia
chiamata la Mano di
Orlando [improbabile
assedio di Sovana da
parte di Carlo Magno], ci
appariranno i resti
smozzati del mastio di un
castello, ultimo avanzo,
assieme alle rossigne
mura di cotto, di quel che
fu la seconda e più
gloriosa capitale della
grande contea
aldobrandesca.
4
Sul pianoro c'è la
cittadina del Medio-
evo, allusiva a un
doppio destino, quello
dell'età feudale più
remota e quello del
trionfo dell'età comu-
nale. In basso, ci sono
la necropoli e le
tagliate etrusche,
anch'esse ripartite
attorno ad un doppio
messaggio: quello
dell'età più arcaica e
quello dell'ellenismo,
trionfante con la
Tomba Ildebranda.
Laggiù, ben radicata
nella Madre Terra e
segnata da una
religiosità remota, la
radice etrusca; qui, la
più recente
irriducibilità longobarda ed il sogno cristiano. In tutto quattro transizioni e due metamorfosi delle età
dell'uomo che aspettano la comunione delle vostre sensazioni quando visiteremo i luoghi. A queste
transizioni ne dobbiamo però aggiungere una quinta, ancora più remota, considerando anche l'insediamento
protostorico ritrovato dietro l’abside della Cattedrale.
Come una perla adagiata
nell'incavo dell'altopiano,
circondata da colli e
scolpita tra burroni e
forre, Sovana si staglia
improvvisa, con un
profilìo di edifici indistinti
i cui colori si confondono
con quelli della campagna
circostante. Sovana
sembrerebbe tutta qui. Ciò
che intravediamo
rappresenta l’ingresso di
un lungo viaggio nella
storia. Poco più avanti del
castello, dagli anni dopo il
Mille emergeranno, come
lo smalto cloisenné dei
gioielli barbarici, la
Loggia del Capitano, il
Palazzetto Comunale e la
più discosta Cattedrale.
5
Del periodo dello splendore rimane il piccolo gioiello attuale, abitato da circa duecento persone, immerso
come una Brigadoon mediterranea in un'atmosfera medievale (chi ricorda quel film del 1954 di Vincente
Minnelli con Van Johnson, Gene Kelly e Cyd Charisse?). Come dicono le guide, improvvisamente ci si
immerge nel Medioevo. Non a caso il San Francesco di Rossellini fu ambientato proprio qui.
Il Medioevo... ormai sono superate le
romantiche rappresentazioni che
facevano di quell'età il territorio di un
eroico e tenebroso fascino gotico; così
come sono false le interpretazioni
illuministiche che riducevano quell'epoca
a una indistinta oscurità... eppure, senza
ricadere in vecchi stereotipi, dobbiamo
ricordare che l' Alto Medioevo segnò per
davvero un discrimine, un luogo del
tempo in cui la storia sembrò chiudersi in
se stessa. La vita quotidiana e i grandi
rivolgimenti politici e militari apparvero
alle coscienze più vigili come il preludio
della fine del mondo.
L' Alto Medioevo costituisce una
specie di "buco nero" nella storia
dell'umanità occidentale. Parliamo della
peste ricorrente che spopolava le campagne e le città; parliamo dell'insicurezza quotidiana della vita;
parliamo delle invasioni e delle guerre continue; parliamo del declino delle città (in Italia, tuttavia, mai del
tutto completo); parliamo della definitiva eclisse dei valori dell'età classica; parliamo del clima irrigidito che
provocò una piovosità straordinaria; parliamo delle terribili carestie; parliamo del nuovo predominio della
foresta, delle selve e delle paludi. Prima dell'età longobarda il proprietario romano, l'ecclesiastico, l'in-
tellettuale, il mercante potevano pensare alla loro epoca in termini di decadenza, certo, e di disperato
degrado, ma anche di speranza per una possibile restaurazione, per un ritorno all'ordine antico. In fondo
l'Impero romano d'Oriente era ancora vitale. Gloriosa e ancora temibile, Bisanzio indicava un modello
concreto, un'idea alla quale riferirsi, ma anche un'effettiva possibilità di intervento e di ricupero dell’antica
grandezza militare.
Con l'avvento dei longobardi questa possibile
prospettiva, questa speranza, vennero
cancellate: quasi d'un tratto fu chiaro che il
futuro non avrebbe ripetuto il passato. Davanti
all'umanità impaurita c'era ormai l'ignoto, la
morte personale e, quasi sicuramente, anche
quella del mondo. Quel che ne pensassero i ceti
subalterni non lo sapremo mai, anche se
possiamo immaginare che la loro condizione
sociale e materiale non cambiasse granché,
salvo una più accentuata insicurezza personale.
Insomma, ciò che durante i lunghi decenni
delle invasioni barbariche e della distruttiva
guerra goto-bizantina poteva considerarsi una
possibile parentesi, tragica ma transitoria, ora
appariva un esito definitivo: affiorava nella co-
scienza collettiva l’irreversibilità e l’enormità di quanto era accaduto. Fu come se le menti più attente e
coscienti dell'epoca si risvegliassero improvvisamente in un mondo totalmente alieno. A un tratto, tutti i
valori che avevano comunque nutrito la lunga decadenza dell'Impero d'Occidente persero di attualità e di
attuabilità: di fronte alle popolazioni si aprì un futuro sconosciuto.
6
Il mondo sembrò fermarsi e
prepararsi a finire: "Stiamo per
assistere alla fine del mondo",
ripeteva continuamente l'angosciato
papa Gregorio Magno. Altro che la
favola ottocentesca dei terrori legati
all'attesa fine del mondo a ridosso
dell'anno Mille! Fu allora, nell'Alto
Medioevo, a partire da quel tragico,
spaventoso sesto secolo e fino
all'approdo dell'Impero carolingio,
che l'idea della fine universale
apparve come una possibilità
concreta nelle menti di popolazioni
sempre più rade, in balia della
violenza e dell'ignoranza. Il potere
dell'invisibile prese una fisionomia
demoniaca, riemersero le visioni
notturne e si assistette al ritorno di
pratiche magiche e esoteriche, persino al rifiorire di culti pagani.
Tornarono anche le antiche suggestioni e credenze degli Etruschi nelle lande maremmane? Non lo
sappiamo, ma solo nel 744 la Chiesa riuscì a far chiudere gli ultimi templi dei gentili e, da quella data, le
credenze e i culti pagani vennero confinati nelle campagne. Di fatto, nell'Occidente e nell'Oriente, prese
piede una ricca demonologia, che avrebbe trovato poi con Dante la sintesi della Divina Commedia. Lo
storico Fumagalli chiama questo periodo "il dominio della notte." Le pratiche magiche dilagavano dovunque,
persino nelle chiese e nei conventi!
Sono qui, in questa epoca, le radici più prossime di quel millenarismo cristiano che riemerge
prepotentemente nel corso della storia, ogni qualvolta si verifica un passaggio d'epoca, ogni qualvolta crolla
un assetto sociale e culturale che sembrava definitivo. E del resto, nel campo della cultura e della scienza, la
svolta del VI secolo rasentò la perdita totale delle conoscenze fino ad allora accumulate: la scienza
raggiunse, nell’Europa occidentale, il suo livello più basso.
I resti rosseggianti della
rocca aldobrandesca e la
stessa topografia dei luoghi,
stanno lì a testimoniare la
tenacia della vita e della
storia, segni inequivocabili
che non c'è mai distruzione
assoluta e che persino mentre
tutto il mondo sembra
crollare e perdere il senso
della propria direzione, la
ricostruzione è tuttavia già in
marcia e che, sempre, uomini
e donne, tenacemente e lungo
nuove vie che solo in un
secondo tempo (il tempo
degli storici) saranno chiare,
gettano i germi di un nuovo
inizio.
7
Insomma, non vi
traggano in inganno i
resti troppo segnati dal
tempo del castello.
Sovana fu città forte e
combattiva nelle aspre
contese che videro il
trionfo dei Comuni e
prepararono l’avvento
del Rinascimento
italiano. Federico II,
nonostante un lungo
assedio, nel 1240, non
riuscì a conquistarla e
dovette accontentarsi di
un giuramento formale
dell’Aldobrandeschi.
Ora dobbiamo compiere un
breve excursus storico per
avere un quadro meno
confuso di ciò che vedremo.
Sovana fiorì dapprima fra il
VII ed il VI secolo dell’evo
antico, nel periodo della
massima espansione etrusca,
rivale di Vulci, dalla quale
venne sconfitta. Un sovanese
è infatti raffigurato nella
celebre Tomba François. Ma
l’esistenza di Sovana è
molto più antica.
8
Sul pianoro
immediatamente
a sud-ovest della
Cattedrale, in
fondo al borgo
attuale, sotto un
uliveto e un
impianto di viti,
sono stati scavati
diversi strati
archeologici, le
cui indagini sono
terminate da
poco. Lì, dietro
l’abside, sono
stati ritrovati
anche i resti di
una precedente
chiesa dell’VIII
secolo. Gli scavi
hanno messo in
luce
un’impressionant
e continuità di
frequentazione del sito che si affaccia su una gola attraversata da un torrente. Si parte con il neolitico, dal
2.500 circa, ma una più intensa frequentazione dell’area si ebbe dall'età del rame e del bronzo.
E qui, sul pianoro di
Sovana, sono stati
ritrovati i fondi di
capanne dell’età del
bronzo finale (metà
XII – X secolo
dell’evo antico) sorrette da pali
perimetrali e centrali;
dei muri di argilla e di
incannicciata non è
rimasto nulla. La
frequentazione
continuò nel periodo
etrusco orientalizzante
e arcaico, con case a
pianta rettangolare su
grandi pali perimetrali.
Dopo un periodo di
abbandono del sito
(ma non
dell’insediamento
complessivo) la zona fu destinata ad attività produttive, con una fornace del IV-III secolo e diversi altri
impianti di servizio, frammisti ad abitazioni private. In epoca imperiale il sito fu utilizzato come cava di tufo
e poi come necropoli (di cui rimangono tracce e reperti), il cui uso continuò con la conquista longobarda, di
cui rimangono alcune sepolture. Dopo la conquista romana, Sovana era divenuta municipio. In seguito alla
9
caduta dell’impero romano passò sotto il dominio ecclesiastico e poi degli Aldobrandeschi, gente di stirpe
longobarda.
I Bizantini, attestati nel
caposaldo di Cosa e di Orbetello
(siamo nel 580 dell’era volgare,
all'incirca), contrastarono a
lungo i tentativi del duca
longobardo di Spoleto di impa-
dronirsi di Sovana e di chiudere
così il corridoio che permetteva
il collegamento tra Roma,
ancora bizantina, e l'Esarcato di
Ravenna. Finalmente Sovana fu
forse conquistata una prima
volta dai Longobardi nel 592,
ma fu poi probabilmente ripresa
dai bizantini.
Tuttavia, dopo la morte
di Gregorio Magno, nel 604,
Sovana entrò in possesso del
Duca di Spoleto Ariulfo.
Trecento anni dopo, la città
divenne la sede del Comitato aldobrandesco, in seguito all'abbandono di Roselle, divenuta poco sicura per le
continue incursioni saracene, ungare e normanne.
Sovana fu sede vescovile fin dall'epoca in cui il cristianesimo cominciò a diffondersi nell'alto Lazio.
È registrata la presenza di Maurizio, vescovo di Sovana, nel Concilio che si tenne Roma nel 679.
Ora, prima di entrare nel
borgo attuale e dopo
questa troppo lunga
introduzione storica,
diamo uno sguardo a come
si presentava nei primi
anni del Novecento la
piazza del Pretorio e una
veduta dal castello
aldobrandesco
10
E poi come si presenta
oggi la stessa piazza,
guardando verso il
castello, anche in una
visione notturna.
Girando lo sguardo, dal Palazzetto comunale si svolgono le due stradine che raggiungono la Cattedrale, lo
sperone preistorico e gli altri edifici.
11
Un po’ anticipato, subito dopo i resti irriconoscibili di San Mamiliano, c’è il Palazzo Bourbon Del Monte del
XVII secolo, una famiglia marchionale dell’alta valle tiberina, imparentata con gli Sforza e con gli Orsini, di
cui abbiamo visto un edificio anche a Sansepolcro. La facciata a rustico ha uno stile severo e fu ottenuta per
sopraelevazione di una Loggia pubblica già esistente. Forse testimonia degli sforzi dei granduchi toscani di
restituire la vita a Sovana, la cui decadenza e spopolamento dovuti alla malaria, ne avevano fatto un borgo
fantasma. Infatti, sotto i Medici e più tardi i Lorena, per ripopolare il luogo, vennero fatti venire a Sovana
greci, friulani, lombardi e lorenesi: ma la malaria riportò la miseria. Tutti gli immigrati vennero infatti
spazzati via dal male e dalle difficili condizioni ambientali.
Santa Maria, sulla
piazza, è del sec. XII-
XIII. L’ingresso è sul
fianco destro, perché
la facciata venne
ostruita dal Palazzo
Bourbon Del Monte. Il
campanile è posteriore
al XVII secolo.
12
L’interno è romanico con
qualche inserzione gotica.
La cosa più preziosa dal
punto di vista artistico è il
ciborio preromanico, che
termina con un baldacchino
a tronco di cono, il cui
candore contrasta con il
quasi buio delle tre navate.
Fu fatto tra l’VIII e il IX
secolo e forse apparteneva
originariamente alla chiesa
primitiva che fu distrutta per
costruire la Cattedrale.
Ci sono anche alcuni affreschi più tardi, dei primi del Cinquecento. Altri affreschi sono nella cappella di
fronte all’entrata, attribuiti ad allievi o imitatori del pittore senese Bernardino Fungai (seconda metà del
1400).
13
Qui uno scorcio del tetto e
delle volte.
Il Pretorio, romanico, costruito tra il XII e il XIII secolo, riadattato dai senesi. Prima del restauro tra le
finestre emergeva una trave, indicata come “la forca dei giustiziati”. All’interno, un affresco del XVI secolo
di suola senese (Madonna in trono con bambino). Al piano superiore i resti di altri due affreschi e lo stemma
della città: leone bianco rampante in campo rosso. Subito dopo c’è la Loggia del Capitano.
14
Il Palazzetto comunale con
un campanile a vela,
risalente all’incirca ai
secoli XII-XIII, quando il
Comune di Sovana
raggiunse il massimo di
libertà. Destinato a uffici
pubblici ha funzionato
anche da deposito degli
scavi del villaggio
preistorico.
Percorreremo poi l’unica strada interna di Sovana degna di questo nome.
15
Più avanti, procedendo dalla piazza centrale lungo l'unica via selciata che porta alla Cattedrale, ci imbattiamo
in una dimora singolare. Secondo la leggenda, questa è la casa natale di Ildebrando da Sovana, cioè di papa
Gregorio VII: quello della lotta per le investiture, quello che scomunicò l'imperatore Enrico IV e l'umiliò a
Canossa, forse alla presenza di uno degli Aldobrandeschi. Fu Gregorio il vero e tenace fondatore e
teorizzatore del primato della Chiesa e del papa sui principi e sugli stati. Nei ventisette assiomi a lui attribuiti
(il famoso Dictatus Papae) si legge tra l’altro che:
solo lui può usare le insegne imperiali
solo al Papa tutti i principi devono baciare i piedi
solo il suo nome venga pronunciato nelle chiese
solo a lui è permesso di deporre gli imperatori.
A suo ricordo è intitolata la più grande tomba etrusca dei dintorni.
È ancora discusso se
Gregorio VII sia stato uno
degli Aldobrandeschi. Lo
storico Gregorovius
scriveva di lui che: "Nel
genio dominatore di costui
viveva lo spirito austero e
magnanimo dei romani
antichi [...] La sua impor-
tanza sta in ciò, che con
una delle più violente
rivoluzioni note alla storia
mutò alle radici il rapporto
che era sussistito sino a
quel momento tra il mondo
e la Chiesa, tra la Chiesa e
il potere secolare. Fu il
Cesare della Roma papale.
La sua meta politica fu il
16
potere assoluto del pontefice." Per raggiungere gli obbiettivi di una piena autonomia della Chiesa
dall'Impero, dapprima, e di una stabile supremazia poi, Gregorio VII utilizzò tutte le armi spirituali e
materiali di cui disponeva. Altre ne mise a punto lui stesso, come quella del miles sancti Petri, embrione di
ciò che sarà poi nel basso Medioevo l'istituto della cavalleria.
Sta di fatto che proprio
Gregorio VII amplierà di
molto i domini aldobrandeschi.
Ma ciò non prova tanto
l'esistenza di legami familiari,
quanto il fatto che nel conflitto
con l'Imperatore i conti,
tradizionalmente ghibellini, si
schierarono dalla parte della
Chiesa. Ci guadagnarono,
perché nel 1269 l'Abbazia
romana delle Tre fontane dette
loro in enfiteusi il proprio
feudo maremmano (da
Marsiliana a Montauto, a Cap-
albio all'Argentario). La
contea aldobrandesca divenne
così una delle più grandi
d’Italia. Intanto, Ildebrando il
Rosso, fratello dell'Omberto
dantesco, attorno al 1259,
aveva trasferito la sede della contea da Sovana a Pitigliano, meglio difendibile. Da quell'epoca, la storia della
contea aldobrandesca divenne la storia dei conti di Pitigliano, ma Sovana rimase la culla della casata e fu a
Sovana che Margherita, figlia di Ildebrando, ultima contessa aldobrandesca, sposò Guido da Montfort.
La storia di Margherita (mi sia permessa un’autocitazione) è straordinaria e penso che sia bene raccontarne
qualcosa. Dopo si potranno guardare in modo diverso i resti della rocca e le pietre medievali di Sovana.
Quella di Margherita è stata una vita di tragedie, amori e tradimenti, nel solco delle migliori tradizioni del
genere: una vita di trame e di lotte per mantenere il possesso dei feudi ormai declinanti, sullo sfondo della
più splendida storia europea. Un romantico ci impazzirebbe sopra dall'entusiasmo.
17
In ogni caso, circolano persino dei fumetti ispirati alla sua storia.
Nel febbraio del 1270 Ildebrando Aldobrandeschi, soprannominato il Rosso, dette in sposa la giovane figlia
Margherita a Guido di Montfort, vicario generale in Toscana di Carlo d'Angiò, il conquistatore del regno
napoletano, il vincitore e carnefice di Corradino di Svevia. Questo Guido di Montfort era un gran
personaggio e un indomito combattente, discendente di una delle casate protagoniste del feudalesimo
europeo. A lui l'Angiò aveva concesso in feudo anche molte altre terre, costituendo così un controllo stra-
tegico unitario sulla Toscana. Ma la felicità e la tranquillità degli sposi durò appena un anno. Nel marzo del
1271 Guido di Montfort raggiunse Carlo d'Angiò a Viterbo per l'elezione del Papa e là pugnalò a morte, nella
chiesa di San Silvestro, Enrico di Cornovaglia, nipote di Enrico III di Inghilterra e pronipote di Giovanni
Senzaterra, re di Inghilterra e fratello di Riccardo Cuor di Leone. La vittima, che era un suo cugino, tornava
dalla Crociata di Tunisi. Non soddisfatto di averlo ucciso, Guido trascinò il cadavere del congiunto per i
capelli sul sagrato della chiesa e poi si dette alla fuga, nascondendosi nel suo feudo di Maremma. Nessuno
tentò di arrestarlo.
18
Perché un così efferato delitto, compiuto a freddo, nei confronti di un incolpevole? Per saperlo dovremo
entrare nella grande storia europea, in un crocevia della nascita della democrazia occidentale, delle istituzioni
parlamentari e delle prime guerre di religione. Qui basterà ricordare che il nonno di Guido, un grande
feudatario, è famoso per aver sconfitto e massacrato gli Albigesi al comando della crociata indetta dal papa, e
per aver dominando tutta la Francia meridionale; che il padre Simone si era trasferito in Inghilterra
assumendo l'investitura diretta del feudo di Leicester, ereditato dalla madre. In Inghilterra Simone sposò una
sorella del re Enrico III Plantageneto e riconquistò la Guascogna per la corona inglese. In seguito, dopo aver
rifiutato la reggenza di Francia, era divenuto il capo dei riformatori inglesi, il difensore di quella Magna
Charta che Giovanni Senzaterra aveva dovuto forzatamente concedere. Entrato in contrasto con la corona,
nella battaglia di Lewes del 1264 Simone di Montfort aveva sconfitto le truppe reali. L'anno dopo, aveva
convocato quello che è passato alla storia come il primo Parlamento inglese, facendovi intervenire non solo i
nobili e gli ecclesiastici, ma anche due rappresentanti del popolo per ogni circoscrizione del regno.
Il dominio di Simone di
Montfort sull'Inghilterra,
simile a quello tenuto in
seguito da Cromwell, durò
tuttavia poco: i tempi non
erano ancora maturi. Scon-
fitto nella battaglia di
Evesham dal principe
Edoardo, cugino di Guido di
Montfort e fratello di Enrico
di Cornovaglia non volle
arrendersi. Il suo cadavere
fu oltraggiato: i genitali
tagliati gli vennero messi in
bocca e la sua testa, staccata
dal busto, fu portata in
trionfo dai suoi nemici più
acerrimi.
19
Simone è diventato un
martire caro alla fantasia
popolare. C’è anche una
filastrocca recitata dai
bambini inglesi che ne
esalta la figura, oltre a
diversi inni e canzoni. Gli
è persino intitolata
l’Università politecnica di
Leicester.
Sei anni dopo la
morte del padre, dunque,
all'apice della propria
potenza militare e politica,
Simone di Montfort si
trovò di fronte il fratello di
colui che ad Evesham
aveva permesso oppure
ordinato lo strazio del
cadavere del padre. Fu
vendetta. Il delitto mise a
rumore le corti europee,
ma protetto dall’Angiò, Guido sfuggì anche ai tentativi della corte d’Inghilterra di catturarlo.
Presto perdonato dal papa, dopo essere stato scomunicato e espropriato di tutti i suoi beni, Guido non fu però
liberato dalla prigionia che qualche anno dopo. Ma Dante lo colloca all’Inferno (XII Canto), nel cerchio dei
20
violenti contro il prossimo, isolato per la gravità della sua azione. Comunque, Guido venne messo di nuovo a
capo di importanti spedizioni e, tra l’altro, combatté con successo i ghibellini di Guido di Montefeltro. Nel
1285 morivano Carlo d'Angiò e Martino V, ma non prima che il Montfort fosse reintegrato dal papa in tutti i
suoi diritti. L'anno successivo Guido di Montfort si imbarcava all'Argentario, a capo di milizie senesi, per
unirsi alla flotta francese che discendeva l'Italia con l'obbiettivo di contrastare l'offensiva aragonese in
Sicilia. Nel 1287, in una battaglia navale contro gli Aragonesi lanciati alla conquista di Napoli, Guido venne
fatto prigioniero e poco dopo moriva.
A questo punto inizia
la seconda parte della
storia di Margherita,
l'ultima degli
Aldobrandeschi: quella
parte che la colloca
nello spartiacque fra il
mondo medioevale e
l'incipiente ma non
meno drammatico
Rinascimento, quella
parte che la vedrebbe a
giusto titolo inserita fra
le eroine di Stendhal.
Raccontarla qui
sarebbe troppo lungo.
Basterà ricordare che
in seguito si sposò altre
tre volte, fu accusata di
bigamia per essere
stata l’amante di Nello
di Pietra, sospettato di
aver ucciso Pia de’ Tolomei per avere campo libero con la contessa.
Perseguitata da Bonifacio VIII che voleva impadronirsi dei suoi estesi feudi, e insidiata da Orviento
e Siena che volevano impadronirsi della contrada per conquistare uno sbocco al mare, sposò un Orsini.
Quando costui morì, Margherita (che aveva avuto due figlie legittime e un figlio illegittimo morto in tenera
età da Nello Pannocchieschi), fu costretta a sposare un nipote di Bonifacio VIII: un matrimonio presto
annullato dallo stesso papa che l’accusò di bigamia. Accerchiata da Siena e da Orvieto, si risposò con un
esponente del ramo di Santa Fiora degli Aldobrandeschi e con lui combattè altre furiose battaglie. Morto
costui e sconfitta, si rifugiò a Roma dagli Orsini e dal 1313, non si hanno più sue notizie. Come scrisse con
sufficiente retorica il Ciacci, nella storia della famiglia, "l'ala ormai stanca dell'aquila aldobrandesca si piegò
su di lei." La tradizione e gli autori che se ne sono occupati riferiscono che Margherita fosse molto bella. C'è
stato chi l'ha considerata come una svergognata seduttrice come nel caso dell’inattendibile Bruscalupi che
così la dipinge: “La contessa Margherita era stata in sua gioventù e continuava tuttavia a essere una donna
empia e rotta ad ogni scostumatezza...”, passando sotto silenzio le mascalzonate di Bonifacio VIII, primo
responsabile della sua rovina per espliciti interessi familiari. E c’è invece chi l'ha descritta come una creatura
soave, benché indomita, vittima delle circostanze e dei tempi di ferro.
Dopo alcuni anni i senesi conquistarono la città, nel frattempo passata agli Orsini, e saccheggiarono
anche gli edifici sacri. La campana del Duomo fu portata come trofeo a Siena e collocata sul campanile della
Cattedrale, dove si trova ancora oggi, ed è chiamata la Sovana. Più tardi, nel 1560 Sovana, dopo essere stata
a lungo feudo degli Orsini, fu annessa alla Toscana e fu sede di un Capitano di giustizia.
21
Ma, visto che abbiamo citato Dante, nella Divina Commedia trova ospitalità anche un altro Aldobrandeschi,
seppure nel Purgatorio, laddove i superbi debbono andare piegati sotto il peso di enormi massi. Si tratta di
Omberto, zio di Margherita, di cui per brevità non racconterò qui la storia.
Cosa rimase del fulgore aldobrandesco di Sovana? Un pittore inglese dell’Ottocento ce la restituisce così.
22
Riprendiamo il nostro cammino e arriviamo alla Cattedrale, intitolata a Pietro e Paolo. Costruita non prima
dell'XI-XII secolo su un precedente più piccolo edificio sacro (resti incastonati nei muri) è il simbolo in
pietra di un mutamento culturale profondo. Per i critici dell'arte, questa chiesa è uno dei maggiori esempi di
architettura romanica in trasformazione nella Toscana meridionale: segnerebbe anzi il passaggio dallo stile
romanico a quello gotico. Ancora una transizione. Il fascino della storia sta nel suo divenire, nel suo
processo, piuttosto che in un inesistente approdo. Alla facciata fu addossato l’edificio episcopale, di cui
rimangono degli ornamenti, per cui l’ingresso è laterale e la sua modestia contrasta fascinosamente con
l’interno severo e composto.
Per quanto, il portale possiede una
sua bellezza e un’espressività
immediatamente medievale. E anche
le finestre, pur nella rozzezza del tufo
sono notevoli.
23
Ma la bellezza della chiesa è nella sua struttura interna, che possiede una sua solennità essenziale e spoglia,
divisa in tre navate, con pilastri alternati bianchi e neri su cui si innestano le volte a crociera della navata.
L’abside è scandita da lesene con archetti ed è orientata a levante. La navata di destra, con archi tipicamente
gotici, contrasta con quelli a tutto sesto delle altre. Sembrerebbe che la Cattedrale sia opera di due diverse
maestranze: una originaria dall’alto Lazio e l’altra del senese. I capitelli sono di tradizione lombarda. Nella
navata destra c’è l’urna di San Mamiliano, evangelizzatore di Sovana.
Il fonte battesimale
è dei primi decenni
del Quattrocento.
Degli arredi mobili,
vale la pena di citare
un dipinto del
Manenti (1671,
Martirio di San
Pietro), della scuola
di Caravaggio; e una
tela attribuita alla
scuola di Andrea
Del Sarto (seconda
metà del XVI,
Madonna con
bambino ecc.). Nella
navata di destra è un
cippo romano con
una dedica alle
ninfe.
24
Vale la pena di vistare la cripta, se è accessibile.
Ma ora torniamo indietro, anche nel tempo, apprestandoci ad entrare nell’identità etrusca di Sovana.
25
I percorsi, come abbiamo visto dal cartello topografico, sono vari e noi ne sceglieremo solo due, pur dando
qualche occhiata alle immagini di alcuni monumenti. Con l’occasione parleremo di qualche aspetto della vita
etrusca, intanto guardando la cartina che mostra la massima espansione di questo popolo, che quasi riuscì a
unificare una parte notevole dell’Italia prima dell’espansione romana.
L’immagine di un
colombario ricavato in
una tomba etrusca
26
e quella della Tomba
del Sileno, corredati dei
demoni infernali
immaginati dagli
Etruschi, ci dà modo di
parlare un po’ della
loro religione e della
loro notoria bravura
nell’interpretare i
segnali celesti. Gli
etruschi erano
considerati tra i più
esperto aruspici (la
cosiddetta disciplina
etrusca, di cui parlano
gli autori romani).
Furono uno dei popoli
più superstiziosi mai
esistiti ma, appunto per
questo, erano
considerati tra le genti
più devote e attente al
volere dei celesti. Arnobio, scrittore cristiano dei primi secoli, accusava l'Etruria di essere generatrice e
madre di tutte le superstizioni. Ora, penso che Arnobio avesse del tutto ragione per quanto riguarda
l'Occidente; ma penso anche che non avesse tutte le carte in regola per dimostrarsi così scandalizzato. Il
mondo etrusco-romano era animato da presenze soprannaturali onnipresenti. Ognuno aveva il suo genio,
trasformato dal cristianesimo nel successivo angelo custode. Ogni attività umana era presieduta e controllata
da una divinità. Tra le divinità maggiori e gli uomini c'erano schiere di spiriti, ninfe o Lasa in forma di esseri
alati. Questi esseri erano rappresentati in veste celestiale, se svolgevano funzioni collegate alla parte benigna
del cielo oppure in forme mostruose, se si collegavano ad attività infernali. I bambini credono che se il vento
soffia è evidente che vuole soffiare. (J. Piaget) Tutte le cose sono animate. Il passo successivo è, per
l’appunto, che se il vento soffia è qualcuno che lo fa soffiare. Ma questo qualcuno cosa ci vuole dire?
Diciamo che parecchio di quest’ultimo meccanismo è rimasto, se ancora oggi è linguaggio e spesso credenza
comune dire “è un segno del cielo” di fronte ad un qualche accadimento.
Che cos'era, la cosiddetta
disciplina per la quale
andavano famosi? Adriano
Maggiani - un etruscologo -
la spiega così: “Non era
soltanto una tecnica per
formulare profezie e
previsioni, era un insieme di
nozioni di precetti, raccolti e
ordinati secondo precisi
criteri che potevano spiegare
tutta la realtà in quanto
sistema rigorosamente
strutturato di leggi e norme
dipendenti coerentemente da
un complesso di dogmi,
frutto di rivelazione divina”.
La rivelazione divina era
quella del fanciullo Tagete,
ma anche della ninfa o Lasa
Vegoia che, in veste
27
angelica, si era soffermata in particolare sui fenomeni dei fulmini, dettando i libri che permettevano la loro
interpretazione. Le saette venivano lanciate da diverse divinità, ma il padre di tutti gli dei, Tinia, ne poteva
scagliare di ben tre specie diverse. La più terribile di esse, il fulmine perentorio, poteva essere lanciato solo
con una decisione collettiva, cioè dopo che Tinia si era consultato con una costellazione di divinità
misteriose, chiamate Di involutes o Di consentes. Ma il punto essenziale è che proprio a partire dalla
concezione che gli Etruschi avevano sulle cause dei fenomeni celesti emerge la loro particolare mentalità. Le
cose per loro - avvertiva Plinio il Vecchio - non hanno un significato in quanto avvengono, ma avvengono
per mostrare un significato. In altre parole, la folgore non scaturisce dal cozzo delle nubi, ma le nubi si
scontrano per far scaturire il fulmine, in quanto la divinità ha deciso di inviare un messaggio. Beh, insomma,
non indaghiamo a fondo su ciò che crede la gente ancora oggi.
Presa la macchina, scenderemo
verso Poggio Felceto, per iniziare
una lunga passeggiata,
cominciando dalla famosa Tomba
Ildebranda. Tra le tombe a tempio
dell’area, in generale assai rare in
tutta l’Etruria, la Ildebranda è
davvero unica, oltre ad essere la
più grande.
Si tratta di un
edificio ellenistico
etrusco del III-II
secolo scolpito nel
tufo poroso, con
podio, colonnato,
fregi e camera
sottostante con il
soffitto a lacunari,
preceduto da un
dromos. L’edificio
era interamente
coperto di stucco
(escluse le scalinate
e le pareti del
dromos e della
camera funeraria) e
dipinto a vivaci
colori. Di questi
ultimi rimangono
alcuni relitti dietro
il colonnato
principale. Il tono
dominante era dato dagli zoccoli in rosso vivace, dal bianco-giallo dello stucco e da fregi policromi di
elementi vegetali gialli, rossi, verdi scuri e verdi chiari.
28
Nel tempio etrusco la parte più importante era il podio, a differenza di quello greco, in cui la parte
fondamentale era la cella interna abitata dal dio. Resti dei rilievi con figure e con ornamenti sono
intravedibili, nonostante l’avanzata corrosione dovuta alla friabilità della pietra.
Il dromos, leggermente rastremato in alto, conserva ancora i fori per la chiusura di accesso alla camera
sepolcrale. La quale ultima è singolarmente rozza (oltre che antecedente) in confronto alla magnificenza del
tempio soprastante. Bianchi Bandinelli sostiene che, nonostante l’ampiezza dell’ambiente, si trattava della
sepoltura singola di un personaggio insigne. L’intera area doveva avere comunque una destinazione
familiare, considerando che il dromos taglia quello di un’altra tomba, di epoca precedente. Nel complesso,
solo nel 1974 è stata rinvenuta una nuova tomba a camera che ha restituito intatto il corredo funebre, non
intaccato evidentemente dai tombaroli che sfondarono il retro dell’altro ambiente per cercare senza successo
tesori.
La diapositiva ci mostra una ricostruzione di
un tempio etrusco alla cui tipologia dovettero
ispirarsi i committenti della Tomba
Ildebranda. Come vedete la policromia
accesa contrasta non poco con l’immagine
tutta mattoni e statue bianche tramandataci
dal classicismo settecentesco, da
Winckelman, in particolare. In effetti la
capacità architettonica degli etruschi fu
notevole.
29
Qui ne vediamo alcuni esempi, assieme alla ragione per cui in generale nulla si è salvato delle case etrusche,
costruite con un’armatura di graticci di legno. Per inciso, l’arco a volta romano è di origine etrusca.
Il che ci porta a
compiere un rapido
excursus su alcune
delle eredità
etrusche passate ai
romani, che
debbono molto di
più di quanto
ammisero i loro
annalisti alla civiltà
dei tirreni. Tecnica
della granulazione
dell’oro, idraulica e
strade, mezzi di
trasporto, la groma
per misurazione dei
campi e parte del
vocabolario,
attraverso i romani,
furono ereditate
dalle età posteriori.
30
Deviando poi, se vorremo, in altri sentieri della stessa area, sarà possibile visitare anche la Tomba del Tifone,
cosiddetta per una testa con code di serpente molto corrosa, del II secolo. Si tratta di una tomba a timpano, la
cui camera sepolcrale, è completamente scomparsa.
Anche la Tomba Pola (o
Grotta Pola), su un’altra
biforcazione del sentiero,
presenta una
conformazione a tempio,
sia pure meno elaborata
dell’Ildebranda. Di
fronte c’è un complesso
di tombe a dado del III
secolo. In origine più
grandiosa delle tombe di
Norchia, ne è rimasta in
piedi una sola colonna
(ma ce n’erano altre
sette). La fronte era
anche qui coperta di
stucco dipinto a diversi
colori. La camera
sepolcrale, “servita da un
profondo dromos” è
lunga 18 metri e mezzo e
contornata da banchi
31
lungo le pareti, la cui struttura lascia pensare che gli inumati fossero messi in casse.
Torneremo un po’ indietro, attraversando la provinciale, avviandoci a scoprire uno dei famosi cavoni
etruschi. Lungo il suo percorso incontreremo fosse di sepoltura e tombe.
Alcune tombe sono
classicamente “a dado”, diffuse
soprattutto nella Tuscia
viterbese.
32
Lungo il percorso incontreremo anche questi costoni in cui si aprono le tombe. Hanno l’aria di aver avuto
una frequentazione anche preistorica.
Ma la tomba notevole
di questo ultimo
itinerario è quella
della Sirena del II-II
secolo, chiamata
anche Tomba di
Scilla. La facciata
riprende lo schema di
una casa etrusca ed è
sormontata da un
frontone con una
creatura alata con due
code pisciformi: due
figure alate e nude la
fiancheggiano. Le
sirene erano
considerate, tra le
altre incombenze, protettrici delle
tombe.
33
Dentro la cavità sta il letto conviviale ai cui lati erano due divinità dell’Oltretomba; probabilmente la dea
della morte Vanth e il demone Culsu. Sopra il letto i relitti di una scritta nuli (xta) vel velus, dove vel è un
nome proprio.
Ma cos’erano i cavoni etruschi? Scavata nel tufo, approfondita dalle acque, una rete di strade collegava le
città etrusche della zona. Una prima spiegazione suggerisce che i tratti di strada incassata servissero a
34
mantenersi in quota per superare più facilmente una morfologia ricca di pianori, di forre, di torrenti, di
burroni improvvisi. Molte di queste "tagliate", nel primo tratto, erano utilizzate per seppellire i morti, come
entrò più tardi nelle usanze romane. Entrati in un cavone, è facile suggestionarsi e immaginare la processione
funebre, con la salma adagiata sul carro, le cui ruote hanno lasciato con il tempo solchi talvolta ancora visibi-
li. Immaginiamo la scena dei familiari, accompagnati dal sacerdote e dalla musica, che nelle ricorrenze
religiose si recavano a sacrificare e a banchettare presso la tomba dei loro avi.
Una interpretazione più suggestiva (e anche molto azzardata) del significato delle tagliate, nega che si tratti
di strade nel senso banale del termine e sostiene che la rete dei cavoni sia da collegare ad azioni magiche,
legate alla sacralizzazione del territorio, cioè al tentativo di armonizzare il sotto ed il sopra del mondo.
L'intero sistema dei cavoni (multipli, paralleli, spesso fra loro confluenti o organizzati secondo una spirale,
specialmente nel pitiglianese) farebbe poi riferimento all'area del Fanum Voltumne, cioè allo spazio sacro
attorno al lago di Bolsena, centro religioso unificante e segreto dei popoli delle dodici città dell'Etruria.
Su un costone, in alto (non so se riusciremo a vederlo) c’è una croce uncinata etrusca (una svastica), simbolo
del sole o della vita, preceduta da una breve scritta.
Per aggiungere una
suggestione all'altra, si
può persino immaginare
che la fitta costruzione
dei posteriori romitori
cristiani, talvolta situati
proprio al culmine delle
tagliate (come proprio
nel caso del cavone che
visiteremo), costituisca
l'eco di quel
rovesciamento dei valori
operato dai cristiani nei
confronti del
paganesimo, per cui i
santi eremiti sarebbero
andati a fare le loro
prove di resistenza al
diavolo proprio laddove
il mondo sotterraneo
dell’antico paganesimo
affiorava alla superficie
e minacciava la salvezza del mondo. Del resto, non è un caso che tutte le potenze infernali dantesche, salvo
Lucifero, provengano dalla mitologia pagana.
35
E ora, completata la nostra ricognizione, facciamo la conoscenza con qualche volto etrusco, rappresentato da
manufatti d’epoca e da disegni tratti dalle pitture. Sembra che le donne fossero molto belle e anche piuttosto
autonome: ma questa è un’altra storia.
Non vi pare di trovare una certa aria di famiglia? Non molto distante da qui, a Murlo, nel senese, c’è la più
alta percentuale di eredità genetica etrusca, che è peraltro altissima in tutta la Toscana. Gli etruschi
scomparsi delle favolette giornalistiche e delle credenze tramandateci da informazioni approssimative non
esistono, perché i loro discendenti sono ancora tra noi.
36
Bibliografia essenziale
Albini P., Cara Maremma. Vagabondaggi nella terra della memoria, Valentano, Scipioni, 1995
Albini P., Margherita Aldobrandeschi. Ultima Signora della Maremma, Valentano, Scipioni, 2000
Autori Vari, Itinerari sovanesi, 1989
Bianchi Bandinelli R., Sovana. Topografia ed arte. Contributo alla conoscenza dell’architettura
etrusca, Firenze, Rinascimento del libro, 1929
Biondi A., Sovana. “Città di Geremia”. Guida storico-turistica, Pitigliano, A.T.L.A., 1989
Bruscalupi G., Storia della contea di Pitigliano, rist. anastatica ed. 1906, Roma, Multigrafica
editrice, 1975
Cavoli A., Leggende della Maremma e della Tuscia. L’immaginario collettivo in settanta
testimonianze religiose e profane, Valentano, Scipioni, s.d.
Collavini S.M., "Honorabilis domus et spetiosissimus comitatus". Gli Aldobrandeschi da "conti" a
"principi territoriali" (secoli IX-XIII), Firenze. ETS, 1998
Negroni Catacchio N. (a cura di), Preistoria e protostoria in Etruria. La cultura di Rinaldone:
Ricerche e scavi, Milano, Università, 1993
Pallottino M., Etruscologia, Milano, Hoepli, 1990, VII ed.
Repetti E., Dizionario Fisico Storico della Toscana, rist. anastatica Firenze, 1833 [nel Web
http://www.archeogr.unisi.it/repetti/]
Salviati F. et alt., Il Duomo di Sovana, GAR, 1982
Vatti R., Sovana, Pitigliano, Sorano: profili di città etrusche, Valentano, Scipioni, 1987
Tracce musicali Clark Curtis, Il lamento di Tristano (XIV sec. Italia)
Mina Mazzini, Dalla terra (Magnificat adattamento di Marco Frisina; Voi ch'amate lo criatore,
laudario di Cortona, XII sec.)
Peire Vidal (1175-1206), Bem pac d’inver. I trovatori nei castelli e nelle corti d’Europa, 1995
Synaulia, La musica dell'antica Roma, vol. I, track 20