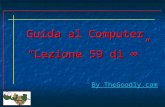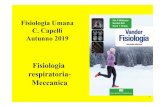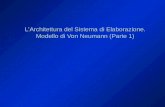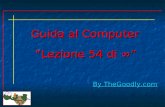SISTEMA ENDOCRNO (parte 1)
Transcript of SISTEMA ENDOCRNO (parte 1)
Data: 11 novembre Editori: Alessandra Rai, Giulia RicciAutori: Giada Giumbini, Carolina Goffredo, Arianna Guiducci, Roberta Ientile, Chiara Barone,Cristina Di Lecce
SISTEMA ENDOCRNO (parte 1)
Secrezione cellulare
Una cellula può secernere attraverso diversi meccanismi:
Un meccanismo endocrino → implica la secrezione da parte di una cellula di unmessaggero chimico nei capillari a sé adiacenti. Il messaggero chimico (chiamato ormone)è trasportato nel torrente sanguigno fino alla cellula bersaglio che presenta il recettorespecifico per l’ormone. (secondo un meccanismo di chiave-serratura). Le ghiandoleendocrine, dovendo secernere l’ormone nel circolo sanguigno, sono riccamentevascolarizzate. Si hanno tre tipi di capillari: i capillari continui, i capillari fenestrati e isinusoidi (tipici del fegato e appunto delle ghiandole endocrine).Gli ormoni circolano e vanno a finire nella cellula bersaglio che di solito si trova a distanza eche presenta dei recettori specifici.
Un meccanismo autocrino → la cellula va a secernere un ormone nell’ambienteextracellulare per poi andare a riprenderlo essendo dotata di recettori specifici (l'ormoneagisce sulla cellula stessa).
Un meccanismo paracrino → indica che l’ormone liberato agisce su una cellula che sitrova nelle immediate vicinanze.
Meccanismo neurocrino → di solito le cellule neuroendocrine presentano deiprolungamenti citoplasmatici provvisti di prolungamenti più piccoli (pedicelli) che vanno acollegarsi con il vaso sanguigno.
Molte cellule endocrine hanno anche proprietà paracrine, autocrine e a volte anche neurocrine. Sicrea in questo modo un meccanismo molto complesso (ci sono delle riviste scientifiche con il titolodi neuroimmunoendocrinologia, ancora più complessa è la psico-neuroimmunoendocrinologia).
Un meccanismo di secrezione scoperto da poco è il meccanismo intracrino, in cui la cellulasecerne un ormone in un compartimento cellulare per agire in un altro compartimento cellulare.L’importanza di questo meccanismo è stata scoperta poiché:
1. I tumori hanno bisogno di vascolarizzarsi al più presto e alcuni per farlo (come il tumore allaprostata o al seno) utilizzano questo tipo di secrezione.
2. Nella menopausa o negli individui castrati (in seguito ad asportazione dei testicoli), inseguito all’impossibilità per l’ovaio o per il testicolo di produrre estrogeni o androgeni, è ilsurrene che inizia secondo un meccanismo intracrino a secernere steroidi sessuali. Si hacome conseguenza l’ipertrofia del surrene.
Una ghiandola esocrina è composta da adenomeri e secerne il secreto in un sistema di dottiescretori che inizialmente sono piccoli poi progressivamente diventano sempre più grandi. La ghiandola endocrina invece si differenza principalmente per l’assenza di questo sistema didotti. In farmacologia, in base all’effetto specifico tra ormone e recettore si può parlare di: Sostanze agoniste: quelle sostanze che interagendo con il recettore creano degli effetti similiall’ormone naturale. (“una chiave molto simile alla serratura”). Sostanze Antagoniste: delle sostanze che interagendo con il recettore bloccano la sua azione.
Data: 11 novembre Editori: Alessandra Rai, Giulia RicciAutori: Giada Giumbini, Carolina Goffredo, Arianna Guiducci, Roberta Ientile, Chiara Barone,Cristina Di Lecce
Di conseguenza o l’effetto viene bloccato o si ha un effetto contrario a quello fisiologico. [I Pesticidi che si trovano sulla frutta si accumulano nel corpo creando degli effetti tossici che siportano ad alterazioni o a malformazioni congenite, aborti, problemi neurologici, problemi dineurodegenerazione]Il distruttore endocrino è una sostanza esogena (= che proviene fuori dal corpo) cheinterferisce con la produzione, il rilascio, il trasporto, il metabolismo, il legame al recettore, l’azioneo l’eliminazione degli ormoni naturali. Le sostanze tipiche che sortiscono questi effetti sono: ormoni sintetici, costituenti di piante,pesticidi, composti utilizzati nell’industria plastica che possono poi inquinare le acque. Gli effetti sulla salute sono molteplici e comprendono una ridotta fertilità, dei problemi riproduttivi edelle anomalie a livello del tratto riproduttivo ma anche problemi a livello comportamentale, a livellocerebrale o psichiatrico e addirittura portano allo sviluppo di diversi tipi di cancro. Agisconoprincipalmente nei periodi più fragili dello sviluppo umano e animale, quindi per esempio nelleprime 16 settimane quando si ha la formazione degli apparati, dello scheletro, del cuore e degliarti. Una donna incinta in seguito a contatto con queste sostanze ha un alto rischio di aborto o dimalformazioni al feto non compatibili con la vita.Possono sortire effetto sulla crescita muscolo-scheletrica fino ai 25 anni di età. Un esempio di distruttore endocrino è il mercurio. Il mercurio proveniente da una serie di processi industriali va poi a ritrovarsi nella nostra dieta inseguito alla contaminazione di molluschi, di bivalvi e di grandi pesci (come il pesce spada o iltonno).
Le ghiandole endocrine possono dividersi:
1. in organi discreti. Appartengono a questa categoria: ipotalamo, ipofisi e quindi l’asse ipotalamo-ipofisi. (questa parte è trattata
abbastanza bene sull’anastasi). Ghiandola pineale (chiamata dagli antichi epifisi) Tiroide (importante nella clinica) e paratiroidi Ghiandole surrenali Timo (oltre ad essere un organo linfoide ha infatti anche attività endocrine) Placenta (in alcuni paesi c’è la banca della placenta e la placenta viene usata in
diverse ricette poiché molto ricca di alcune sostanze).
2. In altre strutture. In questo caso non formano ghiandole, ma sono o gruppi di cellule ocellule isolate sparse che hanno attività endocrina. In questa categoria troviamo invece:
Le isole pancreatiche: contengono delle cellule che producono glucacone e insulinae mantengono il bilancio della glicemia. Un’alterazione della loro funzionalità causail diabete.Il pancreas è anficrino in quanto è sia esocrino che endrocino (in relatà solo l’1% delparenchima del pancreas è endocrino e nonostante la percentuale così bassaquesta parte è essenziale per la vita)
Rene: contiene delle cellule appartenenti all’apparato iuxtaglomerulare cheproducono sostanze endocrine
Testicolo: contiene Cellule di Leydig che vanno a produrre il testosterone L’ovaio: ha diverse cellule ad azione endocrina, autocrina e paracrina come le
cellule della granulosa, della teca e del corpo luteo. Hanno un’ azione estrogenica eprogestinica.
Data: 11 novembre Editori: Alessandra Rai, Giulia RicciAutori: Giada Giumbini, Carolina Goffredo, Arianna Guiducci, Roberta Ientile, Chiara Barone,Cristina Di Lecce
Il cuore : contiene cellule ad attività endocrina scoperte da qualche decennio. Sichiamano peptidi natriuretici scoperti inizialmente negli atri oggi se ne conosconoanche nei ventricoli.
DNES (diffuse neuroendocrine system o neuroendocrine diffuse system): unaserie di cellule isolate (anche una sola) ad azione endocrina che si trovano in diversiorgani generalmente non endocrini e in differenti apparati, tra cui il digerente, ilrespiratorio, l’urinario, il genitale e nell’utero. Formano i paragangli.
NB. Il sistema NDES è solitamente indicato sui libri come sistema APUD (o sistema delle celluleargentaffini o cromaffini) in seguito alla confusione della letteratura mondiale. Questaclassificazione poteva andare bene 50 anni fa ma ad oggi questa classificazione è ormai datatae si deve indicare come sistema DNES.
• Organo adiposo: il tessuto adiposo sta avendo un interesse della scienza mondiale. Ècollegato con l’ictus, con le cellule staminali, con l’obesità o con l’anoressia, con l’appetitosessuale, con lo scroto. Il suo studio sta permettendo di rispondere ad una serie di dubbifino ad oggi senza risposta. L’organo adiposo forma parte anche del sistemaneuroendocrino diffuso e produce le adiponectine. (Ad oggi è trattato principalmente datesti di lingua inglese)
• Muscolo, cute, annessi cutanei e osso: interagiscono nell’insieme soprattutto permantenere i livelli di glicemia ma agiscono anche nella crescita, nel metabolismo(sindrome metabolica quando vengono a mancare equilibrio tra l’organo adiposo con ilmuscolo e l’ osso)
Classificazione delle ghiandole endocrine in base alla derivazione embriologia: Ghiandole di origine ectodermica (adenoipofisi) Ghiandole di origine neuroectodermica (neuroipofisi, ghiandola pineale, midollare del
surrene e le cellule parafollicolari tiroidee) Ghiandole di origine mesodermica (corticale del surrene e gonadi) Ghiandole di origine endodermica (isole pancreatiche, tiroide e paratiroide).
In una stessa ghiandola possono trovarsi porzioni con una diversa origine embriologica e questo èimportante in clinica poiché i tumori mantengono l’imprinting di origine e nella stessa ghiandolapossono quindi presentarsi tumori che hanno una differente origine. Per esempio la midollare e lacorticale del surrene hanno origine da due lamine embrionali differenti e si sviluppano come dueorgani separati che si fondono solo alla nascita. Questo è importante per analizzare la patologiadel surrene.Nella tiroide le cellule parafollicolari avendo un’altra origine embriologia si differenziano per forma,dimensione, posizione all’interno dell’unità morfo-funzionale della tiroide.
Ci sono 3 grandi gruppi di ormoni: Ormoni peptidici → sono catene di amminoacidi e comprendono piccole proteine o
glicoproteine. Appartengono a questo gruppo LH, FSH, gonadotropine (che sonoglicoproteine), l’ossitocina e la prolattina (che sono invece piccole proteine).
Ormoni derivati dai lipidi → comprendono gli steroidi sessuali (androgeni ed estrogeni). In questa classe rientra anche un ulteriore sottoraggruppamento, ovvero gli ormoniderivati dell’acido arachidonico → (eicosanoidi e prostaglandine, leucotrieni,)
Data: 11 novembre Editori: Alessandra Rai, Giulia RicciAutori: Giada Giumbini, Carolina Goffredo, Arianna Guiducci, Roberta Ientile, Chiara Barone,Cristina Di Lecce
trombossani). La prostaglandina F2α durante il ciclo mestruali provoca delle contrazioniuterine responsabili del dolore mestruale.
Ormoni derivati dagli amminoacidi:1. Derivati dalla tirosina → tra cui gli ormoni tiroidei (la tiroxina per esempio) e le
ammine vaso-attive o catecolamine prodotte dal surrene (come l’adrenalina enoradrenalina).
2. Derivato del triptofano → è unicamente la melatonina. (su internet si trova suquesto argomento molta letteratura non scientifica).
Asse ipotalamo-ipofisario:
Si parla di asse ipotalamo-ipofisario in quanto agiscono insieme: l’ipotalamo invia dei fattori di rilascio all’ipofisi che in seguito secerne diversi ormoni .
L’ipofisi si divide in adenoipofisi (o ipofisi anteriore) e neuroipofisi (o ipofisi posteriore)
L’ipotalamo si trova in alto e contiene diversi nuclei (tra cui sovraottico, paraventricolare) econtiene dei neuroni parvicellulari (o pargocellulari) che sono ipofisiotropi ovvero che inviano deifattori di rilascio all’adenoipofisi.
Alla neuroipofisi arrivano invece gli assoni dei neuroni magnicellulari (neurosecrezione verso laneuroipofisi)
In figura sulla destra abbiamo una biopsia (un’asportazione dell’ipotalamo e dell’ipofisi).
Data: 11 novembre Editori: Alessandra Rai, Giulia RicciAutori: Giada Giumbini, Carolina Goffredo, Arianna Guiducci, Roberta Ientile, Chiara Barone,Cristina Di Lecce
L’ipotalamo è in bianco, con il terzo ventricolo al centro. Si può notare l’eminenza ipofisaria el’adenoipofisi è vista da davanti. Essendo una visione anteriore la neuroipofisi è poco visibile. Il colore rosso è dato dalla ricca vascolarizzazione ed ha un doppio sistema di capillari.L’asse ipotalamo-ipofisario ha un’importanza tale che, non solo deve assicurare la propriavascolarizzazione, ma anche gli ormoni che invia alle altre ghiandole. Il doppio sistema di capillariè un sistema portale. In alto e a destra si possono osservare nuclei ipotalamici.
Il nucleo paraventricolare e sopraottico sulla destra manda assoni con messaggeri di rilascioall’ipofisi. L’ipofisi andrà a secernere e regolerà la crescita attraverso il GH (ormone della crescita),ma onde evitare che questo si produca sempre e vada a determinare un’alterazione della crescita,interviene l’ipotalamo per bloccare questo meccanismo. L’ipotalamo regola l’attività dell’ipofisi attraverso la secrezione di un fattore di rilascio o un fattore diinibizione del Gh, con questo sistema di retroalimentazione positiva/negativa: Positiva: finché l’individuo è in crescita; Negativa: quando l’individuo è arrivato a 25 anni e quindi non deve più crescere, se invececontinua a essere attivo vuol dire che ci potrebbe essere un tumore all’ipofisi e quindi si sta secer-nendo troppo Gh, in quanto viene a mancare il blocco ipotalamico (devo vedere a che altezza c’è iltumore, possono essere benigni o maligni).(suggerimento libro di neuroanatomia : clinical neuroanatomy and neuroscience)
In basso a sinistra, in una sezione sagittale abbastanza mediana possiamo osservare l’osso sfe-noide.Nella zona mediana lo sfenoidepresenta un incavo, chiamato lasella turcica, dove va a poggiar-si la ghiandola ipofisaria, copertacon dei diaframmi in alto. Questaparticolare posizione permette diaccedere al tumore dell’ipofisi at-traverso le cavità nasali, proce-dura chiamata trans- sfenoidale,ciò non toglie comunque che cisiano altri accessi chirurgici.Vedere i nuclei ipotalamici nonè facile, sono necessari anticorpispecifici (ad esempio nei casi delnucleo paraventricolare, del nu-cleo infundibolare e del nucleosoprachiasmatico, sono stati uti-lizzati diversi anticorpi per evi-denziare le sostanze da essi pro-
dotti). Tramite questi, ad esempio, è stata evidenziata la produzione dell’ossitocina, dell’ormoneantidiuretico (ovvero vasopressina), rispettivamente da parte del nucleo sopraottico e paraventrico-lare.Microscopia confocale: per vedere vari tipi cellulari.
Data: 11 novembre Editori: Alessandra Rai, Giulia RicciAutori: Giada Giumbini, Carolina Goffredo, Arianna Guiducci, Roberta Ientile, Chiara Barone,Cristina Di Lecce
Diagramma del controllo delle ghiandole endocrine.
In alto è presente l’ipotalamo che secer-ne (in verde) l’ormone di rilascio egrazie a questo effetto, l’ipofisi anterioreo adenoipofisi andrà a secernere a suavolta un ormone proprio dell’adenoipofi-si, quest’ultimo andrà ad agire a distan-za sulla cellula bersaglio, che è unaghiandola periferica come ad esempiotesticolo, ovaio, ghiandola mammaria,ecc..La cellula bersaglio presenterà quindirecettori specifici per questo ormonedell’adenoipofisi e ad un certo puntopoi, può produrre un elemento che bloc-chi la produzione da parte dell’adenoi-pofisi, necessario per mantenere l’equi-
librio. Il blocco può essere a livello dell’adenoipofisi o a livello dell’ipotalamo, se è un blocco centra-le a livello dell’ipotalamo è un blocco molto forte ovviamente, se è un blocco a livello dell’adenoipo-fisi, andrà a regolarsi di conseguenza.
L’adenoipofisi quindi andrà a produrre: • l’ormone della crescita (GH); • la prolattina (PRL); • l’ormone tireostimolante (TSH);• l’ormone adrenocorticotropo (ACTH);• le gonadotropine che sono LH (ormone luteinizzante) ed FSH (ormone follicolo stimolante).
Ciascuno di questi ormoni dell’adenoipofisi andrà ad agire sulla sua ghiandola, per esem-pio:
l’ormone della crescita agirà sull’osso, sul muscolo, sul tessuto adiposo, praticamente sututto il corpo in quanto la crescita riguarda tutte le nostre strutture; LH ed FSH, al contrario, avranno un’azione più specifica, i cui recettori si trovano nell’ ovaioe nel testicolo; l’ormone tireostimolante è specifico poiché va ad agire sulla tiroide; la prolattina agirà invece nella donna a livello della ghiandola mammaria, ma ha anche re-cettori a livello dell’apparato riproduttivo maschile, agisce sull’istinto sessuale e nel caso di unamalattia può anche creare lo sviluppo della ghiandola mammaria nel maschio dopo l’andropausa.
Data: 11 novembre Editori: Alessandra Rai, Giulia RicciAutori: Giada Giumbini, Carolina Goffredo, Arianna Guiducci, Roberta Ientile, Chiara Barone,Cristina Di Lecce
In basso, nella figura, pos-siamo vedere le varie patolo-gie che si possono venire acreare a diversi livelli (ipota-lamici, ipofisari) che riguar-dano quindi alterazioni delsistema endocrino, ipotiroidi-smo, ipogonadismo , puber-tà precoce, prolattinoma,adenoma, sindrome di ca-sching, tumori dell’ipofisi,ipertiroidismo, il diabete, ti-roidite ecc…
L’asse ipotalamo-ipofisario possiede due tipi di cellule gliali specializzate,dato che si trovano in or-gani del sistema nervoso, per cui hanno un organizzazione che segue quella del sistema nervoso:oltre la cellula principale che è quella endocrina, c’è un sistema di cellule gliali di supporto.In questo caso le cellule gliali di supporto sono di due tipi: i pituiciti che riguardono la neuroipofisi; i taniciti (pochi testi ne parlano) che si trovano in prossimità del terzo ventricolo.
Nel diagramma al centro, sezione topografica dineuroni endocrini, parti cellulari ipotalamici e loroproiezione all’eminenza mediana e sul terzo ventri-colo. Le cellule gialle sono i taniciti che sono celluledell’ependima, cellule specializzate appartenentiagli organi circumventricolari, organi molto centraliche si trovano intorno ai ventricoli; quest’ultimi peròsono stati meglio studiati negli animali che nell’uo-mo.
I pituiciti si trovano nella neuroipofisi in quantoessa corrisponde ad assoni di neuroni che si trova-
no nell’ipotalamo, oltre agli assoni sono le uniche cellule qui presenti. Essi hanno una forma moltoparticolare, il corpo cellulare presenta un lungo prolungamento con dei pedicelli che abbracciano ilcapillare.
Data: 11 novembre Editori: Alessandra Rai, Giulia RicciAutori: Giada Giumbini, Carolina Goffredo, Arianna Guiducci, Roberta Ientile, Chiara Barone,Cristina Di Lecce
L’ipofisi ha una doppia origine, per cui una parte nasce dalla tasca ipofisaria (in rosso, in basso),e l’altra (in bianco) corrisponde all’abbozzo della neuroipofisi. Alla sedicesima settimana, l’abbozzodella neuroipofisi si avvicina a questa tasca ipofisaria e si viene a creare quindi la ghiandola ipofi-saria formata da due parti, una anteriore che corrisponde appunto all’adenoipofisi e una posteriore,
che corrisponde alla neuroipofisi, in mezzo, nella specie umana, rimane una fessura cistica che sichiama ipofisi intermedia (tuttavia nell’uomo non ha grandi funzioni dato che non abbiamo biso-gno ad esempio di cambiare il colore della pelle come la salamandra, il polipo o la lucertola)
L’ipofisi è una ghiandola endocrina di forma ovoidale, di colore grigio, le cui misure sono 0,5 cm dialtezza, 0,8 cm come diametro trasversale e pesa circa 500 mg. ( ricordare più o meno le dimen-sioni! ).
Sono ghiandole molto vascolarizzate per questo si parla di un sistema portale.
Nel diagramma si notano le due retiin blu di capillari, la prima rete capil-lare va dall’ipotalamo e scende ver-so l’infundibolo, la seconda rete ca-pillare, invece, sta proprio nell’ipofisi,adenoipofisi e neuroipofisi. I vasi chevanno a collegare le due reti capilla-ri, di conseguenza, prendono il nomedi vasi portali e agiscono come sefossero delle vene. In rosso vediamo le arterie. Abbiamol’arteria ipofisaria superiore e una ar-teria ipofisaria inferiore.
Nell’adenoipofisi la rete capillare vaad abbracciare tutti i cordoni di cellu-le endocrine del TSH, dell’
Data: 11 novembre Editori: Alessandra Rai, Giulia RicciAutori: Giada Giumbini, Carolina Goffredo, Arianna Guiducci, Roberta Ientile, Chiara Barone,Cristina Di Lecce
ACTH,ecc.. ; ogni cellula endocrina risulta quindi essere circondata da sinusoidi, capillari sinusoi-dali che poi scendono come vene ipofisarie.In alto sono segnati i nuclei ipofisari, paraventricolare e sopraottico, dove gli assoni in verde scen-dono alla neuroipofisi dove non ci sono altre cellule se non i corpi cellulari dei pituiciti (non sono
presenti corpi dei neuroni, essi si trovano solamente a livello dell’ipotalamo, mentre nella neuroipo-fisi ci sono le cellule endocrine vere e proprie).
Una sindrome particolare è la sindrome della sella vuota:alla radiografia ha un aspetto molto caratteristico dovuto all’erniaizone dello spazio subaracnoideo,dove l’ipofisi non ha la classica forma ma ha una forma a mezza luna, schiacciata completamenteda una parte della sella turgida. Nel diagramma in alto a sinistra si vede molto bene che la sellaanteriormente è vuota ma posteriormente ha questa mezza luna che corrisponde appunto allaghiandola schiacciata.Al centro in basso si vede che la ghiandola non è globosa ma appunto a mezza luna.Il riscontro è spesso incidentale alla risonanza magnetica o alla tac, la sintomatologia corrispondea cefalea, vertigini, obesità; può essere di tipo primaria se è un incompleto sviluppo del diaframmasellare o una sella vuota secondaria dovuta ad adenomi ipofisari, ad interventi chirurgici o a radio-terapia, atrofie. Questa sindrome non è comunissima ma è molto caratteristica all’imaging.
L’ipofisi produce appunto ormoni che agiscono su tutte le ghiandole come l’antidiuretico sul rene,l’ossitocina sulla prostata e sull’utero nel caso della neuroipofisi.
Tramite una tecnica particolare possiamo lasciare solo lo stampo di resina dei vasi.Dal solo percorso dei capillari possiamo notare la forma della ghiandola in quanto, come già detto,risulta essere riccamente vascolarizzata.
L’ipofisi si deve immaginare come una rete tridimensionale di cordoni di cellule endocrine perquanto riguarda l’adenoipofisi o pars distalis.Cordoni bidimensionali che si vedono nel preparato istologico, dobbiamo immaginarli come tridi-mensionali, dove tra tutti questi gruppi di cordoni scorrono i sinusoidi, quindi i capillari sanguigni.
Data: 11 novembre Editori: Alessandra Rai, Giulia RicciAutori: Giada Giumbini, Carolina Goffredo, Arianna Guiducci, Roberta Ientile, Chiara Barone,Cristina Di Lecce
Sulla destra (immagine in basso) vediamo il peduncoloipofisario, la pars intermedia che è un residuo della ta-sca di Ratkhe, la pars nervosa che prende meno colorantiperché sono assoni dei pituiciti e la pars distalis o adenoi-pofisi che prende molto colorante perché le cellule endocri-ne sono molto cromofile.
Data: 11 novembre Editori: Alessandra Rai, Giulia RicciAutori: Giada Giumbini, Carolina Goffredo, Arianna Guiducci, Roberta Ientile, Chiara Barone,Cristina Di Lecce
Cinquant’anni fa le cellule venivano classificate in base alla colorabilità. Ci sono cellule che si co-lorano e cellule che non si colorano, dette rispettivamente cellule cromofile e cellule cromofobe.E’ comunque una classificazione aspecifica, che sia viola o grigia non è comunque che si associaalla patologia.Le cellule cromofile si dividono in cellule acidofile e basofile:
le cellule acidofile: il 50% corrisponde a quelle che producono ormoni della crescita, e un20 % a quelle che producono la prolattina; si presentano rosa o rosse.
le basofile: 5% Tsh, 20 % Acth e 10 % gonadotropine, Lh ed Fsh. Si presentano blu o violascure.
Quest’anno (2015) sono state scopertifattori che riguardano le cellule stami-nali dell’ipofisi. Ci sono dei marcatoriche indicano che anche in vita adultaqueste cellule staminali, non si sa anco-ra però a cosa servano.Con la microscopia ottica se non ho altrimezzi, mi limito a differenziare le celluleappunto in base alla colorabilità:basofile (b), acidofile (a), cromofobe (c).Comunque non è una cosa specificacome nel caso dell’utilizzo di anticorpi.
Se si ha un microscopio elettronico esi-ste un ulteriore strumento per capire diche tipo di cellula si tratti, non è specifi-co come l'anticorpo e si basa sulla ca-
ratteristica delle cellule endocrine dell'adenoipofisi di presentare nel citoplasma dei granuli citopla-smatici (granuli di secrezione). Se si notano queste 4 cellule, al di là della differenza di nucleo, i“pallini” all'interno della cellula si possono osservare: più scuri o più chiari, più grandi o più piccoli,più o meno numerosi e in parti differenti della cellula.
Data: 11 novembre Editori: Alessandra Rai, Giulia RicciAutori: Giada Giumbini, Carolina Goffredo, Arianna Guiducci, Roberta Ientile, Chiara Barone,Cristina Di Lecce
Tali parametri mi servonoper discriminare i granulitra le cellule endocrinedell'adenoipofisi:
• forma del granulo• grandezza del
granulo• densità elettronica
(si parla di elettro-ni). La massimadensità è rappre-sentata dal nero ela minima dalbianco. Nella mi-
croscopia elettronica non si parla assolutamente di colore ma appunto di densità di elettro-ni.
• Distribuzione nel citoplasma: intorno al nucleo, sopra o sotto al nucleo, periferici o dapper-tutto.
Questi parametri rappresentano il comportamento variabile dei granuli citoplasmatici nelle variecellule endocrine dell'adenoipofisi.
[guardare immagine in alto]In alto a destra si osserva un'immagine della microscopia elettronica a scansione di una cellulache produce FSH, una cellula che produce TSH, un'altra che produce LH; apparentemente sonouguali ma non lo sono.In basso c'è la microscopia elettronica a trasmissione che ci aiuta di più rispetto a quella a scan-sione. Si osserva infatti: nella cellula in basso sono presenti tanti granuli piccoli, densi e dappertut-to, nella cellula a destra, segnata con la lettera G, sono presenti granuli più piccoli, in minor nume-ro e più periferici, nella cellula a sinistra, segnata con la lettera C, non sono presenti granuli
[Immagine in basso]Sono presenti cellule quiescenti che non hanno granuli perché hanno già finito di secernere o per-ché ne stanno formando altri, dovrebbero essere cellule cromofobe.Si osservano inoltre una cellula gonadotropa e somatotropa che presentano differenze nei granuli;la cellula somatotropa presenta un numero maggiore di granuli che appaiono anche più densi. In basso a sinistra si osservano invece degli anticorpi. Infatti, quando c'è un immagine di microsco-pia ottica dove si vede un colore sul marrone o arancione di solito si tratta di un immuno-istochimi-ca abbinata ad un colorante blu (colorazione specifica abbinata ad un ormone).
Data: 11 novembre Editori: Alessandra Rai, Giulia RicciAutori: Giada Giumbini, Carolina Goffredo, Arianna Guiducci, Roberta Ientile, Chiara Barone,Cristina Di Lecce
Una cellula endocrina che produce ormoni peptidici di solito presenta 3 caratteristiche nel citopla-sma:➢ ricco reticolo endoplasmatico rugoso➢ abbondanza di mitocondri ➢ abbondanza di granuli di secrezioneQuesta triade è importante per distinguere una cellula che produce ormoni peptidici da una cheproduce ormoni steroidei, che presenta una serie diversa di organelli citoplasmatici.
• Le cellule che producono GH presentano granuli di grandezza intermedia da 300-400 nm.
(un granulo è sempre in nanometri!)• La cellula che produce prolattina ha granuli molto grandi 600-900 nm.
Data: 11 novembre Editori: Alessandra Rai, Giulia RicciAutori: Giada Giumbini, Carolina Goffredo, Arianna Guiducci, Roberta Ientile, Chiara Barone,Cristina Di Lecce
TSH, ACTH, LH, FSH sono ormoni glicoproteici secreti da cellule grandi 20-25 micrometri.• TSH i granuli sono piccoli 150 nm, i granuli sono piccoli, densi e numerosi.• ACTH i granuli sono scarsi di 200 nm.
CELLULE FOLLICOLOSTELLATE
Oltre alle cellule endocrine da pochi anni si è scoperto un nuovo tipo cellulare: le cellule follicolo-stellate.Sono cellule epiteliali caratterizzate da lunghi processi citoplasmatici, nuclei piccoli, numerosi po-liribosomi, scarso RER, piccolo apparato di Golgi e non hanno granuli. Proprio il fatto di non averegranuli le distingue dalle cellule endocrine.Hanno un marker: la proteina S-100beta, che di solito agisce con il sistema nervoso centrale. Producono peptidi, citochine e fattori di crescita. L' ipotesi è che si tratti di cellule staminali ipofisa-rie, infatti si pensa che abbiano un'attività paracrina con una cellula vicina; ad esempio nellacoordinazione o regolazione delle cellule endocrine dell'ipofisi.
Data: 11 novembre Editori: Alessandra Rai, Giulia RicciAutori: Giada Giumbini, Carolina Goffredo, Arianna Guiducci, Roberta Ientile, Chiara Barone,Cristina Di Lecce
A destra sono rappresentate in blu le cellule endocrine e in giallo si osserva l'anticorpo specifico S-100 beta che identifica le cellule follicolostellate, che si vanno a mettere proprio tra le cellule endo-crine, vicino ai capillari. Si tratta comunque di tre immagini a scansione. Le cellule follicolostellate occupano una posizione centrale tra i cordoni di cellule endocrine ipofisa-
rie e molto vicino ai capillari; si tratta quindi di una posizione molto strategica per l'attivita paracri-na.
Un esempio di alterazione: l'ipotalamo produce un fattore di rilascio della GH verso l'ipofisi, chequindi rilascia l'ormone della crescita in vari tessuti tra cui fegato, muscoli e ossa. Se il suo equili-brio non va escono alcune patologie:
1) si creano delle sindromi di sottoproduzione del GH o di insensibilit à , perché da unaparte può prodursi poco GH nel momento della crescita portando così al nanismo, dall'altrapuò essere che, pur producendo GH, la ghiandola non risponde ai recettori specifici perqualche mutazione di questi ultimi; la conseguenza è la stessa, l'origine però può variare.
Quindi, il nanismo può essere è proporzionato oppure ipofisario (che può comportare anchedelle alterazioni come per esempio le fontanelle aperte oppure la picnodisostosi, alterazione dellacrescita delle ossa e delle cartilagini).
2)Nella situazione opposta avviene la sindrome di sovrapproduzione o ipersensibilit à.Quando si produce troppo ormone GH o c'è qualcosa che lo blocca o si va incontro ad un
Data: 11 novembre Editori: Alessandra Rai, Giulia RicciAutori: Giada Giumbini, Carolina Goffredo, Arianna Guiducci, Roberta Ientile, Chiara Barone,Cristina Di Lecce
anomalia: il gigantismo o acromegalia. I sintomi di queste anomalie sono: l'aumento delleestremità, la diastasi dentaria (ovvero denti separati l'uno dall'altro), ipertensione arteriosa,obesità, diabete, restringimento del campo visivo e altri.
L'ipofisi intermedia è poco sviluppata nella specie umana e ed invece è molto sviluppata nei retti-li e negli anfibi cioè in quegli animali che per sopravvivere devono mimetizzarsi con l'ambiente cir-costante; questi animali hanno una produzione di pigmenti tali da regolare la colorazione dellacute. Nell'uomo questo meccanismo non avviene, quindi è rimasto solo un residuo della tasca diRatkhe tra l'adenoipofisi a destra e la neuroipofisi a sinistra. La pars intermedia può avere caratte-ristiche diverse, ma di solito presenta una struttura cistica cioè possiede cavità rivestite da epiteliocon un liquido interno; oltre a queste strutture cistiche sono presenti le cellule neuro-endocrine cheproducono l'MSH ormone melatonina stimolante. Un esempio di mutazione della produzione diMSH può essere l'albinismo parziale, cioè essere albini solo per metà corpo.La neuroipofisi o pars-nervosa contiene gli assoni di neuroni il cui corpo sta sopra nell'ipotalamo(non ci sono corpi di neuroni nella neuroipofisi), inoltre contiene pituiciti (cellule della glia).
Ipofisi e ghiandola pinealeNella specie umana l'ipofisi intermedia è meno sviluppata a differenza degli anfibi e dei rettili chene hanno bisogno per mimetizzarsi. Essi infatti hanno una produzione di pigmento tale da regolarela colorazione della cute e non essere identificati dal predatore.Nell'uomo vi è un residuo dell'ipofisi intermedia nella tasca di Rathke, tra l'adenoipofisi a destra ela neuroipofisi a sinistra (l'asterisco nella foto indica l'ipofisi intermedia). L'ipofisi intermedia puòavere caratteristiche diverse, ma di solito ha una struttura cistica, ovvero ha delle cavità rivestite daepitelio, con un liquido interno. Oltre a queste cisti sono presenti ovviemente le celluleneuroendocrine che producono MSH (ormone melatinostimolante o melanostimolante). Un casoraro è fornito da un disegno raffigurante una bambina in Tazmania affetta da un'anomalia, unalbinismo parziale: la metà centrale della testa è bianca, mentre il resto del corpo è a macchia dileopardo. Questo ovviamente è dovuto ad un problema di pigmentazione.
Data: 11 novembre Editori: Alessandra Rai, Giulia RicciAutori: Giada Giumbini, Carolina Goffredo, Arianna Guiducci, Roberta Ientile, Chiara Barone,Cristina Di Lecce
La neuroipofisi o pars nervosa,invece, contiene assoni dineuroni dei quali però il corpo si trova nell'ipotalamo (non ci sono corpi di neuroni nellaneuroipofisi) insieme a cellule della glia, che prendono il nome di pituiciti (che serve a manteneretroficamente il tessuto), e poi c’è uno stroma seppur minimo.Nell'immagine a destra è possibile notare sulla sinistra l'ipofisi anteriore con la sua neuroipofisi e lapars intermedia; a destra invece il colore è molto diverso perché la neuroipofisi non prende bene icoloranti e gli assoni si colorano poco a differenza dei nuclei dei pituiciti (che si colorano molto).
L'ipofisi nervosa è facilmente riconoscibile in quanto vi sono assoni quasi trasparenti chetrasportano ormoni prodotti nell'ipotalamo, e nuclei di pituiciti. La neuroipofisi accumula gli ormoni(non li produce! Li produce il nucleo ipotalamico rispettivo, paraventricolare e sopraottico) e poi lilibera. Questi accumuli di granuli neurosecretori che contengono ADH e ossitocina, in istologia,vengono chiamati corpi di Herring, in quanto sono in grado di captare più colorante in questi“bozzi” presenti nell'assone lungo la traiettoria attraverso la neuroipofisi.Sulla destra con la freccia si può vedere un corpo di Herring.
Alcuni nuclei ipotalamici producono ossitocina, che scende dagli assoni, arriva alla neuroipofisi, siaccumula nei corpi di Hering e viene rilasciata in vari modi, come con il riflesso della suzione,grazie anche alla secrezione di altri ormoni, tra cui la prolattina.
Data: 11 novembre Editori: Alessandra Rai, Giulia RicciAutori: Giada Giumbini, Carolina Goffredo, Arianna Guiducci, Roberta Ientile, Chiara Barone,Cristina Di Lecce
Ghiandola pineale
Per quanto riguarda la ghiandola pineale, chiamata così perchè ha la forma di un pinolo, o di unapigna, produce l'ormone melatonina. Viene identificata come organo cerebrale già dal III-IV secoloa.C. Nel corso dei secoli si è sempre ritenuto che la questa fosse sede dell'anima. Galeno fu ilprimo a descriverla intorno al 200 a.C come “ghiandola conarium”, perché dalla forma conica. Nel 1958 fu isolato l'ormone prodotto da essa, la melatonina.
In alto in questa sezione particolare si possono vedere i collicoli superiori e inferiori e fa capolinosuperiormente la ghiandola pineale; nell'altra sezione in basso a sinistra la pineale forma partedegli organi circumventricolari, che sporgono, per qualche ragione ancora ignota nel III ventricolo.Gli studiosi si interrogano ad oggi sul perché una ghiandola endocrina abbia rapporti con un liquidobiologico, al di là del sangue; in alto a destra vediamo gli organi circumventricolari, la pineal bodyda una diversa angolazione e l'importanza del suo rapporto con il III ventricolo.
La ghiandola pineale ha rapporti con il III ventricolo e si sviluppa dal suo tetto, alla 7 settimana digestazione, da una evaginazione ependimale.
Ha una lunghezza di 7-10 mm, larghezza di 6 mm, altezza di 2,5 mm,
Data: 11 novembre Editori: Alessandra Rai, Giulia RicciAutori: Giada Giumbini, Carolina Goffredo, Arianna Guiducci, Roberta Ientile, Chiara Barone,Cristina Di Lecce
peso di 100-180 mg e un volume in aumento dalla nascita fino ai due anni (le misure sonoimprecise perché sono state ancora poco studiate sulla specie umana).
In alto si può vedere la posizione centrale della pineale e un pinealoma (adenoma, tumore disolito benigno della ghiandola endocrina), che la rende molto più grande di quella che dovrebbeessere; se si osserva una risonanza magnetica normale la ghiandola pende sul III ventricolo.
I rami anteriori e posterioridelle arterie cerebrali che vascolarizzano ghiandola pineale si possono dividere in tre gruppi:
uno che viene dalla circolazione posteriore, e che va quindi a ramificarsi in un'arteriapineale laterale e un 'arteria pineale mediale;
poi dalla circolazione anteriore e posteriore esce un ramo dell'arteria pineale detta rostrale(posteriore),
infine c'è un ramo dell'arteria coroidale posteromediale.In basso a sinistra si può vedere l'arteria posteromediale, le arterie laterali, l'arteria mediale e lapineale si trova al centro.
Data: 11 novembre Editori: Alessandra Rai, Giulia RicciAutori: Giada Giumbini, Carolina Goffredo, Arianna Guiducci, Roberta Ientile, Chiara Barone,Cristina Di Lecce
NB: negli anni, nei secoli, ci si son resi conto che nelle 24 ore del giorno alcune patologie sipresentavano in un orario piuttosto che in un altro; per esempio l'infarto insorge nelle prime ore delmattino, l'asma verso le 4-5, il valore più basso dell'insulina si rileva alle 5, le sintomatologie diartrite reumatoide alle 8, al contrario di notte maggiori flussi urinari verso le 18:00, rischio diemorragia cerebrale alle 21:00 ecc..
Questo ha fatto studiare questa ghiandola nella specie umana (più studiata negli animali chehanno una riproduzione stagionale); quindi vari stati fisiologici ed eventi patologici avvengonofrequentemente in certi orario del giorno dimostrando una ritmicità biologica.La melatonina è il principale ormone che regola il ciclo circadiano, ed è anche un ottimoantiossidante; da una parte quindi regola il ciclo luce-buio, sonno-veglia, e da un’altra agisce daprotettore dei vasi sanguigni, ecc... Questo meccanismo origina dalla retina e porta alla sintesidella melatonina: sono presenti però recettori per la melatonina non solo nella ghiandola pineale,ma anche in altre parti del corpo, come ad esempio nei testicoli e nelle ovaie (legata a fenomeniriproduttivi).
In basso a sinistra la luce filtra attraverso l'occhio, le vie retino-ipotalamiche e va a stimolare lamelatonina durante le ore notturne.I nuclei ipotalamici, la retina, i nuclei sopraottico e paraventricolare e l'ipofisi sono integrati in unaltro asse che si sta scoprendo adesso, il quale comprende anche l'intestino.
Data: 11 novembre Editori: Alessandra Rai, Giulia RicciAutori: Giada Giumbini, Carolina Goffredo, Arianna Guiducci, Roberta Ientile, Chiara Barone,Cristina Di Lecce
La ghiandola pineale ha una struttura nodulata altamente cellulare con setti di tessuto connettivoche portano vasi sanguigni all'infundibolo pineale del III ventricolo. All' interno del parenchima si trovano: i pinealociti, cioè le cellule endocrine, le cellule gliali e isinusoidi che si trovano nello stroma.In un preparato solido si notano nuclei sia dei pinealociti che delle cellule gliali.Nella specie umana si trovano inoltre, progredendo nell' età, delle granulazioni chiamate “sabbiacerebrale”, grandi accumuli calcificati che assorbono molto colorante. Su questo argomento visono due lavori al mondo, in queste ghiandole pineali si presentano due colorazioni, una chiara(quella normale) e una scura, che è dovuta a depositi di fluoruri.Queste sono immagini con il microscopio elettronico a scansione, i pinealociti, visti dall'alto, presentano delle ciglia (cosa molto curiosa, una cellula endocrina con delle ciglia sopra?)
I pinealociti varianomoltissimo nella scalazoogenetica: nei pesci e negli anfibi la loro immagine è identica ai fotorecettori che troviamo nella retina, ossia ai coni e i bastoncelli. Si pensa che la ghiandola pineale durante l'evoluzione abbia avuto una funzione diversa che si è andata progressivamente a perdere, ma ne sono rimaste delle ciglia.
Data: 11 novembre Editori: Alessandra Rai, Giulia RicciAutori: Giada Giumbini, Carolina Goffredo, Arianna Guiducci, Roberta Ientile, Chiara Barone,Cristina Di Lecce
L’unico organo nel cranio capace di sviluppare calcificazione, quindi pietre, è appunto la ghiandola pineale. Quindi l’asportazione della “pietra della follia” era pratica comune nel medioevo. Si parla, quindi, di “corpora arenacea” o “sabbia cerebrale” o “acervuli”:
Calcificazioni del parenchima associate con l’età; Rappresentano punti di riferimento nella radiografia dopo 3°-4° decade di vita;
quindi dopo i 30 anni si identificheranno dei puntini bianchi in rx; Due o tre lavori nel mondo si sono occupati di cosa sono fatti e ci sono opinioni
diverse: c’è chi dice che sono corpi di apatite e chi di calcite, ma comunque contengono calcio e fosforo (sono molto simili a calcificazioni che ritroveremo anche nell’orecchio interno);
Sono cristalli con dimensione variabile tra 47 e 28 micrometri (sono abbastanza grandi considerando che una cellula medialmente ha una dimensione di 20 micron).
Quindi in una rx la pineale apparirà molto più bianca, per la presenza di nuclei di calcificazione dovuti a questa “sabbia cerebrale”. Nel 2010 si è scoperto che in questa calcificazione sarebbero coinvolti i mastociti, trovati in gran numero attorno a queste calcificazioni, ma non è ben chiaro ancora la dinamica della situazione. Teniamo, poi, presente che la ghiandola pineale si trova inserita nel contesto dell’asse ipotalamo-ipofisi-ghiandola pineale- intestino. L’intestino ha un vero e proprio orologio biologico, pertanto se per ragioni ambientali – non si dorme bene, turni notturni, luce artificiale, temperature costanti, aria condizionata – si altera questo ciclo biologico si ha una conseguente “cronodistruzione”, quindi alterazione di questo ciclo/orologio
Data: 11 novembre Editori: Alessandra Rai, Giulia RicciAutori: Giada Giumbini, Carolina Goffredo, Arianna Guiducci, Roberta Ientile, Chiara Barone,Cristina Di Lecce
biologico. Addirittura è stato confermato come molti tumori vengano in seguito a rottura del ciclo sonno-veglia, quindi è consigliato dormire almeno 4 h di seguito. Anche le alterazioni gastrointestinali, ulcera peptica, reflusso, cirrosi epatica non alcolica, depressioni, parkinson sono conseguenze confermate di questo orologio. Nei paesi scandinavi si fornisce già, a fronte di queste problematiche, la “fototerapia” per la scarsa presenza di sole e quindi tale luce andrà ad agire sulla ghiandola pineale, limitando il problema SAD (disordini affettivi stagionali) causati da mancata esposizione solare.
SISTEMA NEUROENDOCRINO DIFFUSO (DNES)Dall’inglese “Diffuse NeuroEndocrine System”, comprende non un tipo cellulare riscontrabile nel solo apparato digerente ma include tantissimi tipi cellulari in quasi tutti gli apparati del corpo. Vediamone qualche caratteristica:
Racchiude cellule ad azione neuroendocrina ed endocrina con un fenotipo comune,quindi già dalla forma, disposizione e altre caratteristiche del citoplasma si può capire se una cellula appartiene o meno al DNES;
Forma parte di una rete di organi discreti, cellule sparse, aggregati cellulari del sistema nervoso; non sono quindi ghiandole a sé, sono cellule singole;
Come espressione di markers, secernono neuropeptidi (tra cui ci sono anche degli ormoni), cromogranine di vario genere enzimi;
Contengono nel citoplasma, come per le cellule endocrine dell’ipofisi, granuli di secrezione elettrondensi;
Hanno eterogeneità cellulari: è un sistema presente sia in cellule normali che tumorali. Quindi tra i vari tumori si identificano anche “tumori neuroendocrini”, che non si riconoscono ovviamente subito perché hanno una serie di sintomi non associati e che si ricollegano a queste cellule sparse con granuli di secrezione identificativi.
Ci sono, quindi, degli elementi che ci fanno sospettare che una cellula sia effettivamente una cellula neuroendocrina appartenente a questo sistema: considerando l’apparato digerente (il primo ad essere scoperto) e le cellule epiteliali dell’epitelio intestinali, notiamo come tra di esse si trovano qua e là nello sfondo ghiandolare, quindi per es nel fondo dellecripte del Lieberkuhn, delle cellule che hanno granuli piccoli elettrondensi che non c’entrano nulla con pepsina, gastrina etc. Quindi questa presenza di granuli in una cellula nel contesto di organi o apparati, come digerente, respiratorio etc. può far pensare ad una probabile origine neuroendocrina. Questo si può verificare con l’uso di anticorpi.
Data: 11 novembre Editori: Alessandra Rai, Giulia RicciAutori: Giada Giumbini, Carolina Goffredo, Arianna Guiducci, Roberta Ientile, Chiara Barone,Cristina Di Lecce
Nell’immagine di dx notiamo proprio l’esempio appena menzionato: cripta intestinali in cui si trovano cellule con granuli tipici dell’intestino (arancioni in basso, indicate col numero 9) accompagnate poi da celllule che presentano granuli sopra al nucleo che non sono celluledi Paneth e probabilmente sono cellule neuroendocrine (granuli rossi, indicati col n. 8). Queste cellule neuroendocrine, secondo una classificazione (che non piace alla prof.), possono essere:
CHIUSE: quando non arriva al lume (intestinale, del follicolo tiroideo etc.) (nella figura a sn è la cellula che si trova subito al di sopra del vaso indicato col n.5);
APERTE: quando vanno dalla membrana basale fino al lume (nella figura di dx, è indicata sempre col n.8).
Comunque, come si può notare dalla figura di sn, la cellula neuroendocrina si deve posizionare sempre nelle zone più profonde in modo tale da mettersi in contatto con i capillari sinusoidi, per poter rilasciare i propri ormoni nel circolo sanguigno.
In alto a sn notiamo ancora le cellule neuroendocrine sempre nelle cripte duodenali, visualizzate con anticorpi (non si trovano in gruppo, bensì sono qua e là); nel colon anche si possono evidenziare con immunoistochimica utilizzando anticorpi specifici ed
Data: 11 novembre Editori: Alessandra Rai, Giulia RicciAutori: Giada Giumbini, Carolina Goffredo, Arianna Guiducci, Roberta Ientile, Chiara Barone,Cristina Di Lecce
evidenziamo nella figura una tripla positività; nei bronchi anche abbiamo isolato cellule di questo tipo; nel villo intestinale sono evidenziate in giallo e producono serotonina.
Dalla tabella si evidenzia come in realtà cellule di questo tipo si possono individuare in un gran numero di organi e presentano granuli tutti diversi (granuli chiari, granuli non rotondi etc.) e produrranno cose differenti (glucagone, secretina, colecistochinina etc.)
Data: 11 novembre Editori: Alessandra Rai, Giulia RicciAutori: Giada Giumbini, Carolina Goffredo, Arianna Guiducci, Roberta Ientile, Chiara Barone,Cristina Di Lecce
In questa immagine si evidenzia come le cellule neuroendocrine possono essere individuate al microscopio elettronico a trasmissione: nel pancreas ad esempio troviamo cellule dell’adenomero che presentano nucleo centrale, RER in basso e al di sopra del nucleo i granuli di zimogeno che sono elettrondensi ma non sono confondibili con i tanti piccoli granuli elettrondensi che caratterizzano la cellula neuroendocrina ( si veda l’immagine in alto a sn in cui i grandi granuli di zimogeno molto scuri si differenziano dai piccolissimi granuli più in basso).
TIROIDELa tiroide è una ghiandola che si trova nella regione sottoioidea e può essere palpata mettendo:
1. Indice sulla cartilagine tiroide (visibile nel maschio – pomo d’Adamo);
Medio sulla cartilagine cricoide; Con il 4° dito si palpa l’istmo della tiroide (
in chi ha noduli non si può palpare); Con il 5° dito si palpa il margine superiore
del manubrio sternale (incisura giugulare);
E’ questo un metodo molto semplice per palpareil volume della tiroide, operando questa manovraponendosi alle spalle del paziente, mentre
quest’ultimo ingoia la saliva facendo così prominenza sui lobi tiroidei.La ghiandola tiroide deriva il proprio nome dal greco “thyreos” (scudo, appunto per la prominenza laringea che corrisponde alla cartilagine tiroidea).
Ha origine branchiale, cosa molto importante per capire la patologia perché ciò significa che si forma insieme alle labbra, palato e quindi, una volta formatasi nel contesto dello stomodeo, la tiroide deve migrare altrimenti si ha una condizione patologica.
3. Ha un colorito rosso bruno e una superficie liscia;4. Consistenza molle;5. Si tratta dell’organo più superficiale della loggia del collo. E’ per questo che si può
palpare molto bene, al di là della patologia;6. Si trova a 2-3 cm dall’incisura dello sterno, profondamente ai mm. sternotiroideo e
sternoioideo (quindi più o meno tra C5 e T1);
Data: 11 novembre Editori: Alessandra Rai, Giulia RicciAutori: Giada Giumbini, Carolina Goffredo, Arianna Guiducci, Roberta Ientile, Chiara Barone,Cristina Di Lecce
7. Ha una forma ad H con istmo mediano e anteriore al 2°-3° anello tracheale, importante nelle manovre di rianimazione per non lederla;
8. Polo superiore dei lobi laterali: fino a livello della parte media della cartilagine tiroidea;
9. Polo inferiore scende fino a livello del 5°-6° anello tracheale.
La ghiandola tiroide è una ghiandola il cui nome deriva dal greco e vuol dire scudo per la presenzadella prominenza laringea che corrisponde alla cartilagine tiroidea. E’ una ghiandola endocrina diorigine branchiale. La conoscenza dell’origine embriologica è importante per capire la patologia,perché essendo di origine branchiale vuol dire che si sviluppa insieme alle labbra, al naso e alpalato, tutte parti simmetriche che devono chiudersi, migrare e prendere la loro posizionedefinitiva. Presenta un colorito rosso bruno, superficie liscia e consistenza molle. Questa ghiandolaè l’organo più superficiale della loggia del collo e proprio per questo è possibile palparla moltobene. E’ situata a 2-3 cm dall’incisura dello sterno, profondamente ai muscoli sternotiroideo esternoioideo, tra C5 e T1. Presenta una forma ad H con un istmo mediano e anteriore alsecondo/terzo anello tracheale. Conoscere questa informazione è importante nelle manovre dirianimazione per evitare di danneggiare questa ghiandola essenziale. Presenta un polo superioree un polo inferiore in entrambi i lobi.
Il polo superiore arriva fino alla parte media della cartilagine tiroidea il polo inferiore scende a livello del quinto/sesto anello tracheale.
Queste informazioni riguardanti la posizione risultano importanti come punto di riferimento percapire se il paziente presenta un ingrandimento della tiroide oppure un’atrofia. Ovviamenteesistono dei margini di variazione a seconda della struttura e delle patologie concomitanti.
Ogni lobo è lungo circa 4 cm, largo 2-2,5 cm, un diametro trasversale di circa 6-7 cm compresol’istmo, altezza di 3 cm e uno spessore di 4-6 mm. Il peso alla nascita è di circa 200mg. Nell’adulto può variare tra i 18-35g: nell’uomo il peso dellaghiandola è di circa 18 g, nella donna 14,5 g. In alto a destra nella figura si può vedere la posizione classica alla visita medica: il paziente inposizione retta, il medico dietro di lui che con entrambe le mani, durante la deglutizione, sente ilobi tiroidei, entrambi, e sente vibrare la laringe. In basso a destra nella figura si osservano i rapporti della tiroide con i grandi vasi (vicino passa lacarotide comune). In basso a sinistra la carotide dopo la dissezione con i due lobi e l’istmo.
Data: 11 novembre Editori: Alessandra Rai, Giulia RicciAutori: Giada Giumbini, Carolina Goffredo, Arianna Guiducci, Roberta Ientile, Chiara Barone,Cristina Di Lecce
Nel 30-50% dei casi può essere presente un lobo piramidale (prima di diagnosticare tumoribisogna considerare la possibilità che il paziente presenti invece questo terzo lobo), che si dirige inalto, assume una forma conica e può raggiungere dall’istmo l’osso ioide. La causa dellaformazione del lobo piramidale è embriologica. Durante la formazione della faccia, la tiroide si stasviluppando all’interno della cavità orale (stomodeo), e a un certo punto dello sviluppo embrionaledovrà migrare e scendere fino a occupare la sua posizione anatomica a livello del collo. Se nonfosse così potrebbero rimanere residui della migrazione della tiroide, e bisogna controllare che nonvadano incontro poi ad alterazioni patologiche. Alla quinta settimana di sviluppo, dalla posizioneall’interno della cavità orale vicino la lingua la tiroide deve migrare nella sua posizione definitivaentro la settima settimana di sviluppo, e se ciò avviene correttamente non rimane nessuna tracciase non il foro cieco, all’altezza della “V” linguale, unica rimanenza del dotto tireoglosso, che èdestinato a regredire più o meno completamente.
A sinistra nella figura sono indicate le possibili localizzazioni di tessuto tiroideo accessorio,ectopico o di cisti del dotto tireoglosso. Tessuto tiroideo accessorio se vi è oltre alla tiroide normaleun’altra accessoria che si può trovare in qualsiasi punto lungo la via di migrazione della ghiandola,ectopico se non è nel collo ma in altre parti. Durante la migrazione del dotto tireoglosso possonorimanere parti di tessuto che vanno incontro a cisti, cavità ripiene di liquido che si vedono subitoall’ ecografia non che alla radiografia (di solito si riscontrano in maniera casuale).
CASI CLINICI (The New England Journal of Medicine)
Paziente 1 (a sinistra nella figura): bimba di 4 anni e mezzo. Durante una visita di controllo per lacrescita dal pediatra le viene diagnosticato ipotiroidismo, inusuale per una bimba così piccola.Facendo ulteriori controlli si riscontra una alta captazione del tecnezio (Tc99m), che sta a indicarela presenza di una ghiandola o una struttura che prende attivamente un metabolite da questa
Data: 11 novembre Editori: Alessandra Rai, Giulia RicciAutori: Giada Giumbini, Carolina Goffredo, Arianna Guiducci, Roberta Ientile, Chiara Barone,Cristina Di Lecce
analisi. La bambina presenta la tiroide sul fondo della bocca, mai scesa, e per questo le vieneasportata e rimpiazzata da una terapia sostitutiva.
Paziente 2 (a destra nella figura): donna di 43 anni. Intubazione difficoltosa all’atto chirurgicoriscontrata durante un intervento. Presenta una orofaringe ristretta. Le fanno una ecografia e altreindagini e le trovano un tumore solido alla base linguale, confermato alla scintigrafia con Tc99m.Questo è sempre un caso di tiroide che non è migrata ed asportata, con conseguente terapiasostitutiva.
Al centro della slide altri due esempi. La foto più in alto rappresenta un esempio di non migrazionedella ghiandola tiroide, che rimane attiva a livello del foro cieco (che non si è formato) e disturba lapersona nell’atto di bere, mangiare e parlare. Nella foto al centro in basso all’altezza del foro ciecovi è un ponte con il palato e si parla sempre di una tiroide che non ha migrato.
Data: 11 novembre Editori: Alessandra Rai, Giulia RicciAutori: Giada Giumbini, Carolina Goffredo, Arianna Guiducci, Roberta Ientile, Chiara Barone,Cristina Di Lecce
Nella immagine si vede una scintigrafia con una tecnica di fusione tramite un software di risonanzamagnetica e di una TAC che permette di osservare ancora più dettagli. Caso clinico: pazientefemmina di 53 anni presenta ipotiroidismo. La ghiandola tiroide non funziona e trattiene l’ormone,che non essendo in circolo provoca nella paziente fatica, giramenti di testa, diarrea, mal di pancia,accumulo di peso, e in posizione supina manifesta una sensazione di mancanza d’aria, quasi
Data: 11 novembre Editori: Alessandra Rai, Giulia RicciAutori: Giada Giumbini, Carolina Goffredo, Arianna Guiducci, Roberta Ientile, Chiara Barone,Cristina Di Lecce
sviene. Alla SPECT/CT si osserva che non c’è tiroide. La paziente ha una positività alla baselinguale. Nel caso di assenza di tiroide (aplasia), conoscendone il decorso durante la migrazionebisogna cercare nel collo e nella bocca. Se non si trova, terapia sostitutiva.
La ghiandola tiroide è vascolarizzata da una arteria tiroidea superiore, inferiore e talvolta da unaarteria tiroidea media detta anche ima. Le arterie superiori e inferiori sono sempre presenti. Perquanto riguarda il drenaggio venoso, vi è la vena tiroidea superiore media e inferiore.
La tiroide è una ghiandola endocrina parenchimatosa avvolta da una capsula connettivale.Nella capsula entrano vari vasi che la vascolarizzano. Intorno alla tiroide vi è la guaina peritiroideae uno spazio detto pericoloso, situato dietro lo spazio retrofaringeo e che collega gli spazicervicali profondi al mediastino. Il nome pericoloso è dovuto alla facilità con cui si verificanoemorragie nel corso degli interventi alla tiroide. Un intervento in questa zona mette a rischio la vitadel paziente perché non solo si toccano i vasi tiroidei ma anche altri vasi presenti in questo spazio.Si sta considerando una serie di spazi limitati dalle fasce cervicali superficiale, media e profonda.Tra la fascia cervicale media e profonda vi è quindi la guaina peritiroidea con lo spazio pericoloso(visibile nella radiografia in basso). In questo spazio può andare sangue, pus e qualunque cosa èda considerare.
Data: 11 novembre Editori: Alessandra Rai, Giulia RicciAutori: Giada Giumbini, Carolina Goffredo, Arianna Guiducci, Roberta Ientile, Chiara Barone,Cristina Di Lecce
Posteriormente ai lobi della tiroide sono presenti in media 4 ghiandole paratiroidee postesuperiormente e inferiormente (sono in media 4 ma possono variare tra 2 e 12).Interessante notare che la tiroide è a contatto con molti vasi importanti quali carotide comune e lasucclavia, e durante operazioni di tiroidectomia, cioè asportazione della tiroide, bisogna stareattenti a non danneggiarli. Inoltre vi è un nervo ricorrente di sinistra e di destra. Se si danneggiadurante la tiroidectomia il nervo vago servirà un anno di terapia logopedica per rimparare a parlare.
Data: 11 novembre Editori: Alessandra Rai, Giulia RicciAutori: Giada Giumbini, Carolina Goffredo, Arianna Guiducci, Roberta Ientile, Chiara Barone,Cristina Di Lecce
L’ innervazione della ghiandola tiroide corrisponde a gangli simpatici cervicali superiore, medio einferiore. Un plesso nervoso del ganglio cervicale inferiore accompagna l’arteria tiroidea inferiore esi collega con il nervo laringeo ricorrente e laringeo esterno. Poiché così innervata, si può bencapire il perché dell’alto rischio durante la tiroidectomia di danneggiare qualche nervo, lasciandocosì il paziente non solo senza tiroide, ma anche senza voce.
I linfatici della tiroide comunicano col plesso tracheale e poi passano ai linfonodi prelaringei,pretracheali e paratracheali. La tiroide ha un drenaggio linfatico molto importante per cui ilcarcinoma o un altro tipo di tumore tiroideo ha grandi possibilità di insediarsi. Talvolta i linfaticidrenano sui linfonodi brachiocefalici associati al timo, lateralmente drenano vicino alle venetiroidee superiori verso i linfonodi cervicali profondi e possono drenare in maniera diretta sul dottotoracico senza passare per i linfonodi.
All’ecografia è difficile individuare la tiroide, bisogna avere un buon occhio clinico perché apparetutto di colore molto grigio. Aiuta immaginare una farfalla dove le due ali sono i due lobuli e il corpoè l’istmo.Problemi di tiroide possono insorgere a diversi livelli: ipotalamico e ipofisi. In questo caso ilcretinismo o ipotiroidismo congenito è l’insufficienza di ormoni tiroidei verificatesi durante l’infanzia.Il gozzo, problema di ipotiroidismo, è già presente nella storia dal Seicento.Noduli si possono formare come accumulo di tessuto adiposo causata da una ipofunzionalitàtiroidea. Importante quando vi sono noduli tanto grandi è che non devi la trachea, perché se ciòavvenisse di respirerebbe male e bisognerebbe assolutamente togliere la tiroide.