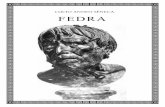Seneca lezione in classe Ancina V A linguistico
-
Upload
marcello-meinero -
Category
Education
-
view
2.295 -
download
1
description
Transcript of Seneca lezione in classe Ancina V A linguistico

SENECA
FILOSOFIA A ROMA
– Scopo: delineare un ideale di vita. Filosofia come risposta etica e politica ai problemi dell'uomo e della collettività
– Primato della problematica morale: vengono meno logica e gnoseologia. Stoicismo letto in chiave morale è la filosofia dominante a Roma
– dallo stoicismo viene ripresa la figura del saggio: colui che ricerca la sapientia: conoscenza delle cose umane e divine.
CASO EMBLEMATICO DEL PASSAGGIO DELLA FILOSOFIA DA GRECIA A ROMA: CICERONE
– educato sotto la guida di maestri greci: cultura greca era indispensabile per uomo politico della roma repubblicana
– dottrina mediata da divulgatori: lo stesso Cicerone darà spinta alla divulgazione del peniero greco a Roma con traduzioni
– giugono tutte insieme le filosofie greche (aristotelismo, platonismo, stoicismo, probabilismo): i romani ne attuano una combinazione
SENECA FILOSOFO
– situazione politica: senato esautorato e concentrazione del potere:1. retorica non ha più una piazza, si richiude nelle aule e diventa gioco erudito (declamatores)2. filosofia rompe il suo legame con la vita pubblica e politica per diventare “arte del vivere”3. la ricerca di nuove risposte per i nuovi tempi porta alla diffusione di culti magici ed esoterici
– Seneca vive sulla propria pelle questa contraddizione:1. primo tempo: De Clementia: accetta il principato, il filosofo deve essere pedagogo del principe2. secondo tempo: De ozio: filosofo si ritira alla ricerca del buon vivere per sé stesso
– capisaldi della sua filosofia sono stoici:1. unica ragione universale che si identifica con la natura e con Dio2. corrispondenza tra virtù e felicità3. saggio come figura normativa4. visione pessimistica della vita dominata da follia, avidità, violenza5. saggio che si erge di fronte moltitudine di stolti
– concezione filosofica personale:1. filosofia come ricerca della propria salvezza2. filosofia come continua riflessione e autoeducazione3. generi coltivati da seneca: consolationes, dialoghi, epistole: muovono da un'occasione e sono sempre rivolti ad un interlocutore4. temi: quelli che impone la vita: piacere, dolore, libertà, schiavitù, vecchiaia, morte

STILE SENECA
1. DRAMMATICO - contrappone alla convenzione ciceroniana, che è tutta simmetria, lo stile umano, che è asimmetrico- non è lo stile imperatorio di Cesare, che scrive gelidi e limpidi bollettini - è lo stile drammatico dell'anima umana che è in guerra con se stessa ex. Ferre impetum vitiorum tam magno comitatu venientium potest.(ep. 7)- scrittura composta di frasi brevi, staccate, improvvise, che incalzano spesso una medesima cosa per
colpirla da più lati. ex. et tempus quos adhuc aut auferebatur aut subripiebatur aut excidebat collige et serba (ep. 1)
2. LINGUAGGIO DELLA PREDICAZIONE - cellula stilistica del linguaggio:
a. nell'epoca di Cesare e Cicerone era stato il periodo: la struttura architettonica della prosa letteraria riflette il senso di una realtà ben organizzata; tra l'individuo e il cosmo, c'è la mediazione della società b. per Seneca è la sententia: la realtà politica passa in secondo piano, l'uomo deve cercare soluzioni individuali alla propria solitudine esistenziale. La conseguenza sul piano stilistico è una prosa esasperata, che ha tanti centri e tante pause quante sono le frasi. I rapporti sintattici si semplificano: le parole vuote, usate a puro fine grammaticale, tendono a scomparire. Ogni pensiero è concentrato e coniato nel modo più espressivo possibilec. nell'epoca di Frontone sarà la parola
- tecniche epigrammatiche di seneca:1. Predilezione per l'uso assoluto del participio futuro, che conferisce all'espressione senso di
ineluttabilità. 2. Uso di et nel senso di anche. Diventa in Seneca uno strumento per creare clausole taglienti.
3. Frequente la litote dei pronomi negativi: nemo non, «non c'è nessuno che non», usata per esprimere una legge cosmica che non conosce eccezioni.
4. Molto usata la figura etimologica, che potenzia la parola-chiave della frase e conferisce all'espressione lo stile sentenzioso delle massime proverbiali. Inhumanior redeo, quia inter homines fui Ep. 7,3
5. L'antitesi 6. Uso di immo correttivo. ex. Servi sunt, immo homines. Servi sunt: immo contubernales.
Servi sunt: immo humiles amici. Servi sunt: immo conservi.( ep. 47)7. L'anafora sostituisce la trama sintattica con una trama fonica, legando una frase all'altra
attraverso la ripetizione iniziale. ex. Quem mihi dabis, qui aliquod pretium tempori ponat, qui diem aestimet, qui intellegat se cotidie mori? (ep.1)
3. LINGUAGGIO DELL'INTERIORITA' Se Lucrezio considera l’uomo nei suoi rapporti con il cosmo, Cicerone nei suoi rapporti con la società, toccò a Seneca bandire il messaggio dell’interiorità forgiandone il linguaggio
a. L’interiorità come POSSESSO
1. Termini della sfera giuridica. ex. Vindicare: rivendicare legalmente il possesso di qualcosa, togliendolo al proprietario illegittimo. Implica il concetto di liberazione. Ita fac, mi Lucili, vindica te tibi (Ep. 1) L’autopossesso è un tema dominante.
2. Uso del riflessivo direttoSed quid prodest si non effugit? Sequitur se ipse et urget gravissimus comes.
3. Uso del riflessivo indirettoFrequente è l'uso del dativo riflessivo:

sibi adquiescere, sibi relinqui
4. Coesistenza di due riflessivi Rappresenta il punto culminante di questo uso del dativo, secondo una propensione all'accumulo pronominale che è tipica del latino.
B. L’interiorità come RIFUGIO
Uso di verbi dinamici con l'accusativo riflessivo come termine di movimento: Animus ab omnibus externis in se revocandus est Tranq. An. 14,2
Il ritorno dell'animo dal mondo esterno assume l'aspetto di una fuga; l'interiorità è vista come rifugio: frequente l'espressione in se recedere. Recede in te ipsum quantum potes (ep.7)
Il linguaggio dell’interiorità coniato da Seneca confluirà, soprattutto attraverso Agostino, nell’esperienza cristiana
LA SCANSIONE FILOSOFICA DEI TEMI SECONDO IL LIBRO DI TESTO
1. IMPEGNO: iuvare mortalem: cercare una soluzione pratica
2. RIFONDARE IL RUOLO STORICO E MORALE DELL'INTELLETTUALEclasse dominante deve trovare rifugio e tranquillitas (controllo della propria esistenza)
3. SPINEGERE PRINCIPE ad imperare con:beneficium (filantropia) e clementia (mitezza)
4. ETICA PER CLASSE SOCIALE SQUILIBRATAa. politica esautorata dall'imperatoreb. religiosità privata in crisi
5. ARS VIVENDI: pratica del vivere. Etica mette ordine nella vita
6. ELIMINARE PASSIONI: ostacolano la ragione, la comprensione delle cose
7. CONVERSIONE: cum + verto = cambiamento radicale
8. INDIVIDUALISMO COSTRUTTIVO: prendere coscienza di se stessi
9. CONDIZIONE DEL MALATO E TERAPIA MORALEa. medicina = cura passività del corpo (malattia)b. filosofia = cura passività dell'animo (lasciarsi vivere)
10. ESPANSIONE ORIZZONTALE: lavorare insieme agli altri per il bene comune.Metafora del soldato:a. esercita se stessob. fa parte di un plotone, ovvero un organismo organizzato

Epistolae Morales Ad Lucilium: si tratta di un epistolario, reale o fittizio, scritto a partire dal 62/63, pervenutoci incompleto; S., venuta meno la sua funzione civile, si muove soprattutto nell’orizzonte della coscienza individuale e trova un destinatario ideale nel suo giovane amico Lucilio (campano, di origini modeste, assurto al rango equestre e a varie cariche politiche-amministrative, di buona cultura).
Modello: l’opera costituisce un unicum nella letteratura antica e S. si mostra consapevole di aver introdotto un nuovo genere in quella latina (orgogliosamente evidenzia la diversità rispetto all’epistolario ciceroniano).
Lo spunto sarà pervenuto a S. da Platone e soprattutto da Epicuro, nelle cui lettere si riconosce il rapporto di amichevole paternalismo che si istaura con Lucilio. Seneca riprende un topos dell’epistolografia antica, nell’affermare che lo scambio epistolare, permettendo di istituire un colloquium con l’amico, è più efficace sul piano pedagogico dell’insegnamento dottrinale.
Il tono pacato e cordiale è quello di un amico che ricerca egli stesso la via della saggezza.
Funzione: la funzione dell’epistola è pedagogica: la lettera, vicina alla realtà della vita vissuta, si presta alla pratica quotidiana della filosofia; oltretutto una corrispondenza permette, molto meglio di un trattato, di compiere un cammino per gradi verso la sapientia (NB: le lettere dei primi tre libri si concludono con un’aforisma che imprima meglio il messaggio e che sia spunto di meditazione; le epistole, procedendo, diventano sempre più lunghe fino a raggiungere l’ampiezza di veri trattati). Accanto alla funzione teoretica, di dimostrazione di una verità, è importante anche la funzione parenetica, l’esortazione a compiere il bene.

Ideologia: il genere epistolare si rivela appropriato anche per il tipo di filosofia di S., priva di sistematicità ed incline alla trattazione di singoli temi etici. I temi si possono spesso ricondurre alla tradizione diatribica e vi sono anche delle affinità con la satira, soprattutto quella oraziana.
Le norme più importanti sono: l’autarkeìa (indipendenza ed autosufficienza), l’indifferenza nei confronti delle seduzioni mondane, un raccoglimento e una meditazione in vista di un perfezionamento interiore, la riflessione sulle debolezze e i vizi propri ed altrui.
L’obiettivo è la conquista della libertà interiore e la quotidiana meditazione sulla morte a cui il sapiens guarda con animo sereno, simbolo della sua indipendenza dal mondo.
L’etica senecana rimane profondamente aristocratica (si riferisce al volgo con termini sprezzanti) anche se la consapevolezza della comune sorte di tutta l’umanità lo porta ad una condanna del trattamento comunemente riservato agli schiavi.
Stile: S. dichiara di utilizzare uno stile inlaboratus et facilis; il filosofo, infatti, deve badare alle res, non all’abbellimento della forma, che è giustificabile solo se funzionale all’apprendimento (le sententiae o la citazioni di versi poetici hanno una funzione psicagogica, di aiutare a fissare in mente un concetto). In realtà, la prosa filosofica senecana è elaborata e complessa, tesa alla ricerca dell’effetto o dell’espressione epigrammatica.
Sintassi: S. rifiuta l’architettura del periodo classico e ciceroniano, predilige invece uno stile paratattico in cui frantuma il pensiero in un susseguirsi di frasette nervose e sentenziose (“minutissimae sententiae”, Quintiliano) collegate soprattutto dalle antitesi, dalle ripetizioni e dai parallelismi; una tecnica <<puntillistica>> che produce l’effetto di sfacciattare l’idea in tutte le angolazioni possibili, fornendo una formulazione sempre più concisa fino ad arrivare all’epigramma. Si percepisce anche il tentativo di riprodurre l’andamento della lingua parlata (sermo).
Modelli: S. riprende lo stile della retorica asiana e della predicazione dei filosofi cinici.
Drammaticità: lo stile riflette la polarità della predicazione senecana, teoretica e parenetica: si alternano i toni sommessi della meditazione interiore e quelli vibranti dell’esortazione. Lo stile è antitetico e conflittuale (è stato definito “drammatico”) perchè deve esplorare l’animo umano, pieno di contraddizioni. Non sa evitare una certa teatralità nella ricerca dell’effetto.