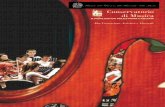sab_11_ore_21...conservatorio
-
Upload
mito-settembremusica -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
description
Transcript of sab_11_ore_21...conservatorio
TorinoConservatorioGiuseppe Verdi
Sabato 11.IX.2010ore 21
Orchestra degli Studentidel ConservatorioGiuseppe Verdi di TorinoAmiram Ganzdirettore e violino
tramite il rimboschimento di aree verdi cittadine a Torino e attraverso progetti di riduzione dei gas serra realizzati in paesi in via di sviluppo.
Il Festival MITO compensa le emissioni di CO2
con la creazione e tutela di foreste in crescita nel Parco Rio Vallone in Provincia di Milano,e in Madagascar.
MITO SettembreMusica Quarta edizione
I Partner del Festival
Con il sostegno di
Realizzato da
È un progetto di
Sponsor
Media partner
Sponsor tecnici
partner istituzionale
Wolfgang Amadeus Mozart(1756-1791)
Concerto n. 3 in sol maggiore per violino e orchestra KV 216AllegroAdagioRondò. Allegro
Pëtr Il’ic Cajkovskij(1840-1893)
Serenata per orchestra d’archi op. 48 Pezzo in forma di sonatina (Andante non troppo. Allegro moderato)Valse (Moderato. Tempo di Valse)Elegia (Larghetto elegiaco)Finale. Tema russo (Andante. Allegro con spirito)
Orchestra degli Studenti del Conservatorio“Giuseppe Verdi” di TorinoAmiram Ganz, direttore e violino
In collaborazione conConservatorio Giuseppe Verdi
Era l’anno 1775, e il diciannovenne Mozart si trovava suo malgrado stanziale a Sali-sburgo, con il pensiero rivolto a Vienna e, ancor più, all’opera, sospirando di poter
scrivere per il teatro da poco inaugurato nella sua città natale. Per il momento, tutta-via, l’unica commissione era arrivata da Monaco, con La finta giardiniera, rappresen-tata nelle prime settimane dell’anno; mentre per il teatro locale nient’altro s’era potu-to fare oltre a una serenata, Il re pastore, in scena ad aprile. Questa la cornice psicolo-gica e lavorativa che vede nascere il Concerto KV 216, terzo di cinque concerti per vio-lino composti nel medesimo 1775 ed eseguiti, molto probabilmente, per l’arcivescovo,con Mozart stesso in veste di solista. Attentissimo a non urtare gli umori dei colleghi,e al tempo stesso sicuro di poter ottenere da loro quel che voleva, Mozart non permetteal solista di spaziare con la libertà assoluta e l’estro inventivo che sarà più avanti deiconcerti per pianoforte; ma abilmente lo mescola all’orchestra, in modo che solleciti,incoraggi, proponga, più che accentrare su di sé l’attenzione. Non dimentichiamo,inoltre, che Mozart era cresciuto con l’archetto in mano, anche se il suo strumento delcuore era il clavicembalo, anzi, presto il pianoforte; e Leopold Mozart, suo maestro
Videoimpaginazione e stampa • la fotocomposizione - Torino
anche in questo, era altresì l’autore di un metodo violinistico molto importante. Nellagrazia del KV 216 questa scienza si tramuta in gioco e in gioia: fin dal primo Allegro,che riprende un’aria del Re pastore (Aer tranquillo e dì sereni) e ci immette in quelclima galante che cancella ogni traccia esteriore di “difficoltà”, tecnica o concettuale,privilegiando lirismo e chiarezza. Canto puro è anche l’Adagio, con il violino pensie-roso, che sembra astrarsi in regioni acute e sovracute, mentre gli amici orchestrali loaccompagnano a loro volta interdetti, quasi dimenticandosi di proseguire, timorosi didisturbarlo. Il Rondò finale, invece, è una festa collettiva, che celebra con toni persinorustici il piacere del suonare insieme: qua e là il violino si smarrisce ancora nei suoisogni, ma poi si riprende più scatenato che mai e tutti gli vanno dietro, questa voltacon i fiati ben in evidenza, quasi fosse una serenata all’aperto. Di impronta schietta-mente campestre sono in effetti gli intermezzi che inframmezzano il placido riproporsidel tema-rondò, riprendendo forse qualche danza locale, visto che Wolfgang scrivendoal padre diceva sempre “il salisburghese” per indicare questo preciso concerto: da nota-re soprattutto il momento in minore, con il violino che danza sopra i pizzicati, già pre-correndo il fandango delle Nozze di Figaro: a dirci che il sogno del teatro anima tuttala partitura.
«L’ho composta seguendo uno stimolo interiore; è una cosa sentita, e per questo osopensare che non sia priva di reali pregi». Così Cajkovskij scriveva alla sua confidenteepistolare Nadezda von Meck, poco dopo aver portato a termine la Serenata perarchi op. 48 nell’autunno del 1880. La limpidezza di questo lavoro nasce, al solito,da un processo sofferto di limatura e ripensamenti: concepita in un primo momen-to come sinfonia, poi proseguita pensando a un quintetto d’archi, infine condottaalla formulazione definitiva, che tuttavia non è lontana dal mondo delle Suites,dove Cajkovskij lascia fluire la sua vena di mozartiano e di cultore della purezza set-tecentesca. La grazia di questo lavoro fu sempre premiata con grande calore di pub-blico, sia alla sua prima esecuzione, avvenuta a San Pietroburgo il 31 ottobre 1881,sia in tournée (da Londra ne parla il musicista stesso). Da notare che la limpidezzadella scrittura deve trovare un contrappeso nella pienezza dell’organico di soliarchi: tanto che Cajkovskij annotò sulla partitura: «Maggiore sarà l’organico del-l’orchestra d’archi, più si avvicinerà alle intenzioni dell’autore». La composizione è strutturata in quattro parti, come una sinfonia: ma al tempo stes-so il primo movimento, come dice il titolo, contiene già in sé la scansione di una purbreve sonata. Il tema d’esordio, che poi tornerà a concludere non solo questo movi-mento, ma l’intera Serenata, ha il respiro pacato e l’aspettativa di un’introduzione:un’idea discendente che per tre volte percorre a lenti passi i gradi di un luminoso domaggiore. Poi ecco fiorire, fra vari raccordi, una sezione in minore, inquieta, piena diindugi; ma già qui fermenta un passo danzante, che si libera poi dalla crisalide nel bel-lissimo passaggio sorretto dal pizzicato dei bassi, tutto all’insegna della leggerezza. Il passo di danza prosegue nella Valse successiva, che tiene luogo di Scherzo, diver-tendosi ogni tanto a interrompere il flusso regolare del ritmo, come arrestandosi adaspettare qualcosa o qualcuno. Molto simile tematicamente alla Valse, ma affine percarattere alla Sonatina, è l’Elegia, qui in funzione di parentesi lenta; il tema più appas-sionato, quasi una romanza d’opera, si incunea nella zona centrale, via via intensifi-candosi; ed è singolare avvertire sotto pelle, in questa trasparenza di linee, il fervoredrammatico che sarà delle ultime sinfonie e di tanti squarci delle opere teatrali. IlFinale utilizza due temi popolari russi, ricavati da una celebre raccolta di Balakirev: ilprimo viene trattato a mo’ di introduzione, l’altro invece è mobilissimo e dilaga pertutto il brano; ma prima di presentarcelo per intero, Cajkovskij ne mette bene in evi-denza le prime quattro note, identiche al tema solenne che ha aperto l’intera Serenatae che infatti farà una memorabile, commossa ricomparsa prima della conclusione.
Elisabetta Fava
Composta esclusivamente da studenti dei corsi medio e superiore, l’Orchestradegli Studenti del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino nasce con laprimaria finalità di portare a traguardo le competenze della pratica strumentalespecificamente legate alle peculiarità tecniche e ai repertori orchestrali.L’organico, che in piccola percentuale si rinnova annualmente, compie un percorsoformativo di tre/quattro anni. Sotto la guida di Giuseppe Ratti, l’Orchestra degli Stu-denti del Conservatorio raggiunge così livelli di levatura tecnica e musicale tali da poterrealizzare esecuzioni di grande valore artistico dei più vari repertori. Per questa ragionele pubbliche esibizioni dell’Orchestra hanno una duplice valenza: infatti, se da un latocostituiscono un’opportunità di completamento formativo indispensabile agli studentialle soglie del professionismo, dall’altro generano, a loro volta, prodotti di rilievo cul-turale, occasioni formative di ascolto per il pubblico. L’Orchestra si produce anche neisuoi sottogruppi più specialistici, Orchestra d’Archi e Gruppo di Ottoni che appro-fondiscono i repertori più specifici delle due famiglie strumentali.L’Orchestra degli Studenti del Conservatorio ha collaborato nello scorso anno acca-demico con l’Orchestra del Teatro Regio di Torino, con l’Orchestra Sinfonica Nazio-nale della Rai, con il Miur/Afam (le eccellenze dell’organico fanno parte dell’Or-chestra Nazionale dei Conservatori), con i Salesiani Don Bosco e il Coro Interuni-versitario di Roma, e ha suonato sotto la direzione di Salvatore Accardo.
Nato a Montevideo, Amiram Ganz ha iniziato gli studi di violino a sei anni conIsrael Chorberg e proseguendoli con Ilya Fidlón e Jorge Risi. Ha vinto il primo pre-mio al Concorso Jeunesses Musicales all’età di undici anni e da allora ha preso ilvia la sua carriera solistica in Uruguay e altri paesi dell’America Latina.Una borsa di studio gli ha permesso di studiare al Conservatorio Cajkovskij di Moscacon il grande virtuoso Victor Pikaizen, allievo e successore di David Oistrakh.Nel 1977 si aggiudica il quarto premio al Concorso Internazionale Long-Thibaud diParigi. Nel 1979, dopo avere conseguito il diploma con menzione di “eccellente”presso il Conservatorio di Mosca, vince il concorso per il posto di primo violino soli-sta nell’Orchestra Filarmonica di Strasburgo. Con questa e altre orchestre europeee americane ha suonato come solista i grandi concerti di repertorio, da Beethovena Berg, Sostakovic e Bartók.Dal 1994 fa parte del viennese Trio Altenberg, ensemble in residenza al Musikvereindi Vienna, dove ogni anno esegue un ciclo di concerti nella prestigiosa Brahms Saal.Il Trio Altenberg ha sviluppato un’importante carriera internazionale e ha incisouna dozzina di cd. L’incisione dell’opera integrale di Schumann ha ottenuto il pre-mio del Museo Schumann di Zwickau e il cd Piano trios from America è stato pre-miato con l’Edison Award della critica in Olanda.Nel 2002 Ganz lascia l’orchestra per consacrarsi esclusivamente alla musica dacamera e all’insegnamento, tenendo corsi di alto perfezionamento presso il Con-servatorio di Vienna e l’Accademia di Musica di Pinerolo, oltre a masterclass indiversi paesi europei.
Se desiderate commentare questo concerto, potete farlo su blog.mitosettembremusica.it o sul sito www.sistemamusica.it