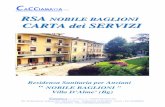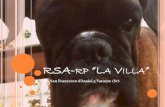RSA 2008
-
Upload
laboratorio-laterra -
Category
Documents
-
view
219 -
download
0
description
Transcript of RSA 2008

sullostatoRapporto
dell’ambientee dellacomunità
Provinciadella
sullostatoRapporto
dell’ambientee dellacomunità
RovigoRovigodidi Provinciadella20082008
A cura di
Francesco MuscoGustavo De FilippoGiorgia Businaro
Provincia di Rovigo
impa rapporto.indd 1impa rapporto.indd 1 8-04-2009 17:24:318-04-2009 17:24:31

INDICE
Governi locali per un ambiente migliore: Ipolitiche e strumenti per lo sviluppo sostenibile
Dall’Agenda 21 Locale agli impegni per il clima: IIIPiano di Azione globale e pratiche locali
1. POPOLAZIONE La popolazione della provincia di Rovigo: brevi cenni La dinamica recente 14 I residenti nei comuni al 31.12.2007 15 La natalità e la mortalità 17 La piramide delle popolazione al 31 dicembre 2007 18 Alcuni indicatori 19 Popolazione straniera 20 Piramide della popolazione straniera 21 Numero componenti per famiglia 22 Sintesi 23
2. ARIA 26 Numero di centraline presenti 28
Particolato PM10 29 Superamenti del valore limite giornaliero di PM10 30 Valore medio annuale di PM10 31
Ripartizione percentuale delle emissioni di PM10 32
Benzene Media annuale concentrazione benzene stazioni 33 di traffi co e di background
Biossido di azoto Medie Annuali di Biossido di Azoto 34 registrato nell’anno nelle stazioni
Ozono Giorni con superamenti soglia informazione 35 oraria di 180 mg/m3
Traffi co ed inquinamento prodotto dai veicoli Età media degli autobus circolanti 36 Numero di veicoli per abitante 37 Autovetture per categoria EURO 38 Autovetture per alimentazione 39 Numero di distributori Metano/GPL 40 Sintesi 41
3. ACQUA Acque superfi ciali Breve quadro idrografi co della Provincia di Rovigo 44
La gestione del sistema idraulico 45
Qualità della acque superfi ciali - Acque interne 45 Indice Biotico Esteso - IBE 48 Concentrazione di nitrati nei corsi d’acqua 49 Stato ambientale dei corsi d’acqua (SACA) 50
impa rapporto.indd 2impa rapporto.indd 2 8-04-2009 17:24:338-04-2009 17:24:33

Acque di balneazione Indice trofi co lungo la costa del Delta del Po 51 Sistema di monitoraggio delle acque di balneazione 53 Idoneità alla balneazione: percentuale di campioni favorevoli 54 Qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi 55 Acque potabili Consumi idrici per uso in alto, medio e basso Polesine 56 Consumo idrico totale della provincia 57 Perdite della rete idrica 58 Consumo pro capite/giorno di acqua rispetto al dato Italiano 59 Qualità dell’acqua erogata per uso potabile 60
Depurazione delle acque refl ue Capacità ed effi cienza depurativa della provincia di Rovigo 61 Sintesi 62
4. RIFIUTI 64 Sistema di raccolta 66 Ecocentri 67 Produzione totale di RSU 68 Produzione di RSU pro-capite giornaliera 69 Percentuale di raccolta differenziata 70 Produzione di rifi uti per comune 71 Composizione della raccolta differenziata 72 Presenza di compostaggio domestico 74 Rifi uti speciali 75 Produzione totale di rifi uti speciali 76 Politiche ed attività di sensibilizzazione ed educazione 77
SINTESI 78
5. CONSERVAZIONE DELLA NATURA E BIODIVERSITÀ 80 Rete Natura 2000
81 Aree naturali minori e ambiti tutelati
83 Estensione degli ambiti naturalistici 84 Fauna
Censimenti della fauna svernante 85 Specie dell’allegato I direttiva uccelli 86
Recupero animali selvatici Numero individui recuperati 88 Cause di incidente
89 Pressione venatoria 90 Numero di cacciatori Cacciatori per ettaro 91 Sintesi 92
6. AMBIENTE URBANO E COMUNITÀ LOCALI 94 Elaborazione questionari inviati ai comuni Comuni che hanno risposto ai questionari di A21 Polesine 96
Risultati dei questionari 98 Piano Urbano del Traffi co 99 Strutture per tempo libero e sport 100 Strutture per attività culturali Associazioni sportive e culturali 102
impa rapporto.indd 3impa rapporto.indd 3 16-04-2009 14:55:2516-04-2009 14:55:25

Piani Zonizzazione Acustica 104
Utilizzo del territorio – Aree produttive e Aziende Rapporto aree produttive abitante 106 Numero di aziende a Rischio Incidente Rilevante (RIR) 109 Aziende con registrazione EMAS 110 Aziende con certifi cazione ISO 14000 111
Infortuni sul lavoro Numero di incidenti sul lavoro Numero incidenti in agricoltura 112
Infrastrutture Sistema infrastrutturale 113 Incidenti stradali Numero complessivo di incidenti Numero complessivo di morti 114 Tasso di lesività Tasso di mortalità Tasso di pericolosità 116 Localizzazione degli incidenti 118 Politiche di sensibilizzazione – Vado Sicuro 119 Radiazioni non ionizzanti
Linee ad alta tensione Estensione delle linee ad alta tensione 120 Popolazione esposta all’induzione magnetica prodotta da elettrodotti di alta tensione 121
Stazioni radiobase Numero di impianti SRB Impianti SRB per comune 122
Istruzione e cultura Popolazione per livello d’istruzione 124 Iscritti nelle scuole per ordine e grado 125 Percentuale di diplomati 126 Offerta scolastica 127
Cinema, teatro, spettacoli Offerta e di spettacoli cinematografi ci 128 Teatro ed attività teatrali 129
Sistema bibliotecario provinciale 130 Indice di prestito 131 Catalogo bibliotecario disponibile 132
Energia e politiche per la protezione del clima 133 Consumi energetici 134 Produzione di energia da fonti rinnovabili 136 Contributi per solare termico e fotovoltaico 138
Politiche per il clima Clima in Polesine 139
Sintesi 142
APPENDICE 144
GLOSSARIO 147
impa rapporto.indd 4impa rapporto.indd 4 8-04-2009 17:24:338-04-2009 17:24:33

I
Governi locali per un ambiente migliore: politiche e strumenti per lo sviluppo sostenibile
Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente e della Comunità nell’edizione 2008 ripercorre l’importanza che ha avuto Agenda 21 Locale per il Polesine. Dalla prima edizione del 2003 sono state attivate numerose iniziative e progetti ma soprattutto sono state messe in atto politiche innovative per la tutela dell’am-biente. Il ruolo dell’amministrazione provinciale si è sviluppato lungo due tipologie di azioni principali:
− l’impegno nazionale e internazionale nel dibattito sullo sviluppo sostenibile e sui cambiamenti climatici;
− l’impegno locale per l’attuazione del Piano d’Azione di Agenda 21 attraverso tutte le politiche messe in atto dall’amministrazione.
Nel primo punto vanno innanzi tutto segnalati l’impegno della Provincia di Rovigo all’interno dell’As-sociazione Coordinamento Nazionale Agende 21 Locali e la sottoscrizione nel 2004 degli Aalborg Com-mittments. Quest’ultimo è stato un passaggio fondamentale per passare dai buoni propositi alla pratica dello sviluppo sostenibile, attraverso anche il monitoraggio periodico delle iniziative avviate in Polesine da parte della Campagna Europea delle Città Sostenibili.
Il terzo elemento che ha portato la Provincia di Rovigo nel dibattito internazionale sui Cambiamenti Climatici è stata la conferenza europea Protezione del clima ed energia rinnovabile: i piccoli e medi co-muni affrontano la sfi da nell’Aprile del 2008 che si inserisce a pieno titolo all’interno della Roadmap del Clima, stabilita nel 2007 durante la Conferenza delle Nazioni Unite di Bali e durante la quale si è cercato di elaborare un quadro di riferimento post Kyoto nell’ambito dei cambiamenti climatici. Elemento chiave della conferenza è stata la sottoscrizione da parte di oltre 250 piccole e medie amministrazioni locali europee della Rovigo Outreach, il documento di intenti e di impegno per le politiche di protezione del clima anche per le amministrazioni locali di dimensioni inferiori ai 100.000 abitanti.
Nell’ambito delle sperimentazioni progettuali va citato il Progetto SIAM (n.LIFE04 ENV/IT000524), fi nanziato attraverso lo strumento comunitario LIFE-Ambiente, che prendendo a riferimento le Direttive Comunitarie specifi camente applicabili, si è posto l’obiettivo di defi nire un nuovo Modello di Area Indu-striale Sostenibile, con il supporto dell’ENEA Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente.
Per quel che riguarda le politiche di protezione dei bacini idrografi ci, la Provincia di Rovigo fa parte della Consulta delle 13 Province del Po costituita per salvaguardare il paesaggio e la cultura locale lungo l’intera asta del grande fi ume e ha promosso il progetto PE.MO.CE. (PErmanent MOnitoring CEnter), una rete transnazionale europea che realizzi sistemi integrati transnazionali per sostenere lo sviluppo soste-nibile e che funga da promotore e coordinatore delle attività di monitoraggio dei bacini fl uviali europei più signifi cativi e degli ambienti naturali a questi connessi.
Nell’ottica della politica di controllo e della certifi cazione impianti, l’area Ambiente dell’Amministra-zione tra il 2007 e il 2008 ha certifi cato oltre 45.000 gli impianti civili; mentre dall’anno 2005 al maggio 2008 oltre 3800 sono stati gli impianti ispezionati sul territorio provinciale.
impa rapporto.indd 5impa rapporto.indd 5 8-04-2009 17:24:338-04-2009 17:24:33

II
Al centro dell’impegno locale si trova il Laboratorio Territoriale Ambientale La.Terr.A., aperto nel 2000 e potenziato negli ultimi anni. La struttura è il centro di educazione allo sviluppo sostenibile per la Pro-vincia di Rovigo e in seguito all’impulso della Regione Veneto per l’attivazione della rete INFEA attraverso ARPAV – Settore per la Prevenzione e la Comunicazione Ambientale, è stato fi rmato nel 2007 un Proto-collo d’Intesa che ha reso possibile la trasformazione del Laboratorio in nodo INFEA per la Provincia di Rovigo.
Vanno segnalate anche le numerose campagne informative di questi ultimi anni, tra queste:
Siamo agli sgoccioli per tema dell’acqua sperimentando, su un campione di 100 famiglie, la riduzione degli sprechi idrici attraverso l’applicazione di riduttori di fl usso nelle abitazioni.
Ecoacquisti fi nalizzata alla riduzione dell’acquisto dei rifi uti, progettata per cercare di ridurre la quantità di rifi uti attraverso una spesa intelligente.
Libera l’aria: giornata provinciale per l’ambiente, legata a tutte le attività del governo locale volte a promuovere la consapevolezza dell’infl uenza diretta che i comportamenti umani hanno sull’ambiente.
Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente (RSA) rappresenta una fotografi a della situazione ambientale e socioeconomica del territorio provinciale analizzandone l’evoluzione e cercando di interpretarne le cau-se. Esso nasce dalla necessità di poter disporre di informazioni qualifi cate e attendibili sui fenomeni che incidono sulla qualità ambientale e sui processi in atto: risposte scientifi camente fondate, aggiornate, puntuali e facilmente interpretabili.
Attraverso l’RSA si evidenziano le caratteristiche e le criticità più signifi cative del territorio cercando di porre in relazione le cause con gli effetti.
Tale documento, oltre ad avere una funzione di diagnosi dello stato di salute dell’ambiente ha anche una funzione informativa ed è dunque rivolto ad amministratori e cittadini integrando l’aspetto descritti-vo dell’ambiente con quello della qualità della vita degli abitanti.
Con l’edizione 2008, l’Amministrazione Provinciale di Rovigo giunge al suo secondo rapporto che si presenta come un aggiornamento di tematiche già affrontate in precedenti documenti. È evidente quan-to sia ardua una rappresentazione sintetica della situazione ambientale vista l’estrema complessità delle interrelazioni tra le matrici ambientali (aria, acqua, suolo…) e quelle relative alle sorgenti di impatto su di esse.
Finalità dello strumento non è solo fornire una fotografi a dello stato attuale dell’ambiente ma essere al contempo uno strumento essenziale per capire l’evoluzione del nostro territorio e poter valutare di con-seguenza le linee gestionali da adottare per garantire uno sviluppo sostenibile anche nei prossimi anni.
L’assessore all’ambiente della Provincia di Rovigo
Giancarlo Chinaglia
impa rapporto.indd 6impa rapporto.indd 6 8-04-2009 17:24:338-04-2009 17:24:33

III
Dall’Agenda 21 Locale agli impegni per il clima: Piano di Azione globale e pratiche locali
La sostenibilità è certamente una di quelle nozioni controverse attorno alla quale numerose sono state le prese di posizione. Nonostante ciò ha assunto un ruolo fondamentale nei più recenti dibattiti inerenti le politiche ambientali, con ricadute pratiche di rilievo nella gestione del territorio da parte delle ammi-nistrazioni locali, a vari livelli di governo.
In questo senso anche una maturazione recente del pensiero ambientale può essere di supporto ad una migliore comprensione della sostenibilità, riferendoci alla città come “capitale realizzato dall’uomo” e al territorio inteso come “risorsa naturale da preservare”.
Ma come saranno le nostre città tra 50 anni? E tra un secolo? I governi locali e nazionali saranno riusciti a renderle compatibili con il nuovo panorama di risorse scarse? Quali misure di adattamento e mitiga-zione alle nuove condizioni ambientali entreranno a fare parte della pianifi cazione e gestione delle aree urbane e del territorio non urbano? Di sostenibilità si parla (e si sparla) dalla fi ne degli anni ottanta del secolo passato, ciononostante le strategie di crescita perseguite nelle nostre città hanno perseverato nell’ignorare la crescente scarsità di fonti energetiche e l’impatto nell’ecosistema delle attività umane.
La consapevolezza che l’ambiente trovi nella città il maggior luogo di confl itto trova giustifi cazione nel fatto che con gli inizi del nuovo millennio oltre il 60% della popolazione mondiale vive nelle città, indi-pendentemente dalla dimensione - ed entro il 2025 saranno oltre 5 i miliardi di abitanti che risiederanno in contesti urbani e che in 135 aree metropolitane il numero dei residenti supererà 4 milioni ciascuno. In ambito europeo la percentuale di cittadini urbani è già più alta, oltre il 70% e comunque la maggior parte degli abitanti ha uno stile di vita di tipo urbano. Si spostano verso un centro o un’area centrale, fan-no acquisti nelle città o nei centri commerciali circostanti, oltre a richiedere un’offerta sociale e culturale creata nelle città. Nonostante il dibattito sul modello di città che è possibile intendere come sostenibile sia ancora controverso, è possibile rilevare una progressiva presa di coscienza collettiva su quali caratte-ristiche debba assumere la vita in ambito urbano nei prossimi decenni e come debba essere preservato il territorio nell’area vasta.
1. La città sostenibile è olistica, va pensata nel suo complesso e non come la sommatoria di parti (quar-tieri, servizi, infrastrutture, reti). Nessun intervento urbano può essere considerato sostenibile se soddisfa solo una delle tre aree di azione della sostenibilità (ambiente, economia, società). Un progetto rispettoso dell’ambiente e tecnologicamente innovativo non è di per sé sostenibile se ad esempio impone costi talmente elevati da impedirne l’accesso ad una parte della popolazione. Molti nuovi quartieri sviluppati, in un’ottica di sostenibilità, risultano essere pienamente rispettosi delle più avanzate tecnologie applicate all’edilizia (condizione necessaria, ma non suffi ciente per la sostenibilità), ma spesso sono inaccessibili ai più. In quest’ottica un approccio intersettoriale alle politiche territoriali è condizione imprescindibile alla sostenibilità.
2. La città sostenibile si rigenera al suo interno, recupera i propri spazi, recupera le parti dismesse dall’industria, riabilita i quartieri degradati ambientalmente e socialmente. Il consumo di suolo, non pre-cedentemente urbanizzato, pone al contempo la questione dei costi vivi diretti e indiretti per l’ambiente, che non possono essere sottovalutati se la prospettiva in cui ci poniamo è quella della sostenibilità. Diluire una città in uno spazio più ampio signifi ca anche espandere il suo potere inquinante, oltre ad
impa rapporto.indd 7impa rapporto.indd 7 8-04-2009 17:24:338-04-2009 17:24:33

IV
accrescere l’impermeabilizzazione dei suoli, mentre un modello di città compatta può portare maggiori benefi ci ecologici ed opportunità sociali se opportunamente pianifi cata. Questo ragionamento vale anche nell’area vasta.
3. La città sostenibile è partecipata, è amministrata da un governo locale che ipotizza scenari di svi-luppo futuro e condivide la loro defi nizione con gli abitanti L’implementazione di una politica sostenibile necessita di strategie permanenti fi nalizzate alla condivisione delle scelte con la comunità locale, da non confondere però con esercizi saltuari di partecipazione che non possono sostituire un’attitudine stabile del governo locale ad attuare processi decisionali aperti rispetto alle scelte strategiche per un determi-nato territorio. È un modo per prevenire le sindromi NIMBY e la conseguente formazione dei movimenti del qui no! In questa prospettiva l’attore pubblico deve ridefi nire il proprio ruolo, poiché tutti gli attori coinvolti nei processi, abitanti inclusi, sono chiamati ad assumersi una responsabilità nei confronti delle generazioni future. Nuovi stili di vita possono essere sviluppati solo in città predisposte per favorirli.
La gran parte delle rifl essioni sulla città e sui territori sostenibili hanno trovato posto negli Aalborg Committments sottoscritti dalla Provincia di Rovigo nel 2004, impegni rilevanti rispetto alle comunità locali, presi in un consesso europeo. In questo la relazione tra globale e locale ha continuato ad essere ampiamente presente nella costruzione di politiche ambientali innovative in Polesine.
In questa prospettiva è andata la Conferenza Europea sul Clima, Protezione del clima ed energia rinno-vabile: i piccoli e medi comuni affrontano la sfi da, tenutasi a Rovigo nell’aprile 2008, inserendo a pieno titolo la Provincia di Rovigo all’interno della Roadmap del Clima, stabilita nel 2007 durante la Conferen-za delle Nazioni Unite di Bali in prospettiva della Conferenza delle Parti di Copenhagen del Dicembre 2009.
Successiva alla Conferenza di Stoccolma (2006), Un futuro con Zero Emissioni di CO2, dalla quale è emerso il ruolo fondamentale delle città e della necessità che queste stesse si pongano obiettivi sempre più ambiziosi ed effi caci in tema di protezione climatica, e posteriore alla Conferenza di Friburgo (2007) sulle Fonti di Energia Rinnovabili Locali, che ha ribadito quanto l’azione locale possa divenire essenziale, la Conferenza di Rovigo si è incentrata sulla stretta relazione che intercorre tra cambiamento climatico ed energie rinnovabili nelle piccole e medie amministrazioni locali, con il supporto dei governi intermedi (provincie, county, département, etc.).
Tra i principali risultati ottenuti, la stesura della Rovigo Outreach, un appello e documento di intenti alle piccole e medie comunità perché assumano nelle loro politiche un forte impegno volto alla protezione del clima e alla messa in opera di azioni concrete a livello locale sull’utilizzo delle energie rinnovabili.
A livello locale il coordinamento tecnico delle politiche per la sostenibilità è affi dato al Laboratorio Territoriale Ambientale La.Terr.A., struttura che nasce nel 2000 e che ospita anche la segreteria tecnica di Agenda 21 Polesine. Il laboratorio nasce con alcuni scopi precisi:
− informativo, dimostrativo e di sensibilizzazione: in quanto strumento operativo per informare i cittadini sulle politiche dello sviluppo sostenibile, seguendo i principi di Agenda 21, crea occasioni che testimonino le opportunità di cambiamento nella direzione di uno sviluppo sostenibile;
− partecipativo: con la funzione di stimolare verso una concreta partecipazione nell’ideare percorsi, promuoverli e attivarli;
− formativo: di crescita culturale ed ambientale della cittadinanza, ma anche crescita di fi gure pro-fessionali, come docenti, tecnici, operatori;
− di collegamento: tra i soggetti coinvolti in queste attività;
impa rapporto.indd 8impa rapporto.indd 8 8-04-2009 17:24:338-04-2009 17:24:33

V
− propositivo: attraverso l’analisi delle problematiche emergenti dal territorio, propone un piano di attività rivolte alla comunità.
Per questo il Laboratorio è stato individuato come strumento capace di rafforzare, attraverso l’educa-zione, l’informazione e la formazione il rapporto tra la società civile e quella politico amministrativa, per-mettendo ai singoli di essere protagonisti attivi, capaci di realizzare una sintesi creativa di saperi teorici, pratiche e rifl essioni sulla propria esperienza quotidiana.
Questo tipo di sistema concorre a promuovere signifi cative sinergie tra il servizio pubblico e la speri-mentazione propria di altri soggetti locali, quali possono essere cooperative, associazioni, consorzi.
Data la complessità delle tematiche ambientali, è stato necessario dotarsi di un polo di coordinamento e stimolo che garantisca la diffusione e il consolidamento delle pratiche di conoscenza e tutela dell’am-biente, in particolar modo attraverso la partecipazione.
Tra le fi nalità che ci si è posti, il potenziamento dei rapporti tra i soggetti che riversano la propria progettualità e le proprie iniziative nel territorio, con l’obiettivo di condividere una strategia comune in tema di Educazione Ambientale, coinvolgendo bambini e ragazzi, adulti cittadini, tecnici, amministratori; i contesti, non solo scuola, ma realtà extrascolastiche a rappresentare luoghi con compiti educativi dif-ferenti; mutando anche i modi, non solo percorsi educativi e formativi tradizionali, ma anche processi di sviluppo territoriale.
L’obiettivo e l’importanza del coinvolgimento del mondo degli adulti, trova conferma già nella Carta di Fiuggi del 1997, dove appare chiaro come l’educazione ambientale sia un’educazione per tutte le età, ricordando che, pur mantenendo alta l’attenzione sulle giovani generazioni, è necessario un impegno ulteriore per quanto riguarda l’apprendimento continuo degli adulti, in particolare per i ruoli che questi possono ricoprire, soprattutto nei confronti di bambini e adolescenti.
I nuovi protagonisti dell’educazione ambientale si muovono in una dimensione territoriale, ovvero quella in cui si rendono più manifesti i problemi connessi con le trasformazioni ecologiche, tecnologiche, economiche e sociali in corso, diventando il luogo in cui meglio si possono tentare azioni e processi volti alla sostenibilità e responsabilizzando istituzioni e soggetti collettivi ad una concezione di sviluppo terri-toriale che consideri il territorio come soggetto vivente.
Esperienze, percorsi, tentativi da parte dei più diversi soggetti e nei più diversi contesti, possono permettere l’avvio di progettazioni partecipate capaci di coinvolgere e far esprimere il protagonismo di scuola, università, associazioni, parchi, enti locali che si muovono sulla scena locale.
Quindi realtà scolastica ed extra-scolastica sono due modi distinti, ma non contrapposti, di realizzare educazione alla sostenibilità. Tra le fi nalità previste è la creazione di un gruppo, a composizione mista, che svolgerà le funzioni di tavolo tecnico a livello provinciale sull’ educazione sostenibile, per defi nire temi e priorità da affrontare nei progetti integrati di Educazione Ambientale, oltre alle risorse disponibili. Il rafforzamento del rapporto con il territorio va concepito anche nella direzione di una progettazione locale di qualità, oltre alla relativa diffusione sul territorio di tali progetti.
Per far ciò sarà necessario individuare le competenze che già esistono a livello provinciale, elaborare processi e metodologie, perché l’educazione ambientale possa supportare l’obiettivo comune del miglio-ramento ambientale, della crescita e della sostenibilità locale.
L’obiettivo è quello di creare un sistema di valori condiviso, fondato su coscienza e mentalità ecolo-giche, dove la natura è percepita come “valore in sé” e in cui si rendono esplicite le connessioni tra i fenomeni e le azioni quotidiane di ogni singolo individuo.
impa rapporto.indd 9impa rapporto.indd 9 8-04-2009 17:24:338-04-2009 17:24:33

VI
Il Laboratorio ha coordinato l’aggiornamento del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente e della Comunità mettendo in rilievo la situazione ambientale attuale, in un’area che ad oggi non ha subito lo sviluppo territoriale dell’area centrale veneta, ma che è ancora luogo di scontro di posizioni di estremo sviluppo e di estrema conservazione.
La provincia è caratterizzata una popolazione apparentemente stabile, che ha all’interno due fattori determinanti: un invecchiamento elevato, superiore alla media regionale e un trend di crescita della po-polazione straniera, crescita in linea con le dinamiche in atto nel resto del paese, ma che sta segnando e determinando le dinamiche della popolazione nel Polesine. Il trend è infatti stabilmente in crescita e non ha subito, come in altre zone della regione, dei picchi o arresti.
Questo determina la presenza di una popolazione complessivamente anziana, venutasi a creare anche in conseguenza di un allontanamento di alcune classi d’età che hanno spostato i loro nuclei familiari nel capoluogo o in altre parti del paese soprattutto per lavoro. A questa si affi anca una popolazione straniera, una forza lavoro (le età presenti sono quelle lavorative) che sta consolidando la propria presenza.
Per quel che riguarda l’aria, i dati evidenziano uno stato che si sta spostando verso un generale miglio-ramento, almeno per alcuni macro fattori. Le caratteristiche morfologiche del territorio (posto alla fi ne della valle padana) non facilitano un continuo e costante ricambio dell’aria, soprattutto in determinati periodi dell’anno. Questo fattore determina uno stato di limitato ricambio e quindi facilita l’accumularsi di determinati inquinanti, prodotti in particolar modo nel periodo autunnale ed invernale, come i parti-colati.
Complessivamente restano preoccupanti gli sforamenti e le concentrazioni di PM10 e le emissioni di NOx, inquinanti che hanno effetti diretti ed indiretti sulla salute dell’uomo e sulla complessiva qualità dell’ambiente.
Esistono inoltre altri fattori che determinano questa pressione, ad esempio il numero eccessivo di veicoli per abitante, alcuni dei quali con una età decisamente avanzata (e quindi con caratteristiche am-bientali superate) e la presenza di attività che possono comportare l’aumento di produzione di inquinanti primari e secondari. Fra questi, in passato, la centrale di Polesine Camerini che a tutt’oggi sta attendendo che il suo progetto di riconversione sia autorizzato o meno da parte del Ministero dell’Ambiente.
Per quanto concerne le acque interne la complessiva qualità risente pesantemente delle attività agri-cole e zootecniche che comunque generano una ricaduta di sostanze inquinanti nei canali di scolo e quindi nelle acque interne. A ricaduta ne risentono le acque sotterranee, anche a causa della limitata profondità di falda, soprattutto nel medio basso Polesine.
A questo si deve aggiungere il fatto che spesso queste acque giungono già in uno stato non soddisfa-cente nel territorio provinciale e risulta quindi diffi cile poter intervenire in maniera adeguata. Per questo l’adozione del Piano Regionale per la Tutela delle Acque dovrebbe agevolare interventi di risanamento e miglioramento del sistema nel suo complesso con interventi volti ad attuare i principi e gli obiettivi di miglioramento della risorsa.
Per quanto concerne le lagune, queste presentano una qualità complessivamente accettabile. Risulta-no avere problemi in siti specifi ci legati alla corretta circolazione delle acqua (necessaria per le attività di pesca) e alla presenza di acqua salata / dolce il cui equilibrio è fondamentale. Durante gli eventi di piena risentono della torbidità e dei carichi inquinanti che arrivano dai principali corsi d’acqua.
Le acque marine hanno invece una discreta qualità. In particolare per quanto concerne l’indice trofi co, i risultati evidenziano che in questi anni non si sono più ricreati quei fattori che hanno portato alla anossia delle alghe. Questo fattore è determinante per rendere l’area del Delta del Po adeguata e turisticamente
impa rapporto.indd 10impa rapporto.indd 10 8-04-2009 17:24:338-04-2009 17:24:33

VIII
appetibile. I dati relativi alla presenza turistica dimostrano appunto questo trend.
Per quanto riguarda l’acqua potabile, prelevata da pozzo nell’alto Polesine e da fi ume nel medio e basso Polesine, si può dire che la qualità sia assolutamente in linea con la qualità delle altre acque da acquedotto distribuite nella regione.
Il consumo, se paragonato ai dati rilevati in altri comuni della regione, non è particolarmente elevato; complessivamente si attesta sul valore medio italiano di 250 l/ab/gg. Nell’Alto Polesine il consumo è addirittura inferiore e si attesta a circa 160 l/ab/gg.
Le perdite di rete, causate soprattutto da perdite dei serbatoi e delle condotte, sono invece elevate e superiori al dato rilevato da ARPA Veneto nella regione Veneto. A parziale giustifi cazione, la complessità e la diffi coltà nella distribuzione che comporta un sistema molto articolato e interconnesso che favorisce perdite di rete.
Capitolo complesso e diffi cile da decifrare è la depurazione delle acque, diffi cile da ottenere nonostan-te la rete di depuratori e vasche presenti. Questo sistema ha molti livelli di ineffi cienza e la sua gestione resta complessa. Il risultato è un sistema depurativo non soddisfacente.
La produzione pro capite di rifi uti continua ad avere una trend in crescita. Il risultato di questa società, basata sull’usa e getta, sarà principalmente la mole di rifi uti che stiamo lasciando alle future generazio-ni.
Tuttavia le politiche messe in atto all’interno del bacino di raccolta hanno portato ad ottenere risultati del tutto soddisfacenti di raccolta differenziata. Ormai stabilmente la provincia si colloca oltre il 60%, risultato soddisfacente ma che ha ancora alcuni margini di miglioramento, in particolare in alcuni comuni della provincia, dove con politiche di maggiore attenzione si potrà raggiungere il 70%. Diffi cile invece l’incremento, oltre certe soglie del comune capoluogo (stabile oltre il 50%), più per la conformazione urbanistica delle aree centrali, che non consente il porta a porta spinto, che per mancanza di sensibilità e di volontà da parte dei cittadini e degli amministratori.
Risultano invece diversi i ragionamenti per Rosolina e Porto Tolle; nel primo comune è il carico legato all’attività turistica estiva a determinare una raccolta differenziata al di sotto del 50%. In questo caso risulta necessario fare campagne di sensibilizzazione mirate e concentrate nel tempo che potrebbero ot-tenere dei risultati molto soddisfacenti, anche se la rotazione costante e continua di clienti non favorisce questo. La certifi cazione EMAS del sistema turistico di Rosapineta si spera che possa aiutare a migliorare questo rapporto.
Nel comune di Porto Tolle, invece, non si è ancora avviata la raccolta porta a porta, unico comune dell’intero bacino nel quale non si effettua un sistema differenziato spinto.
Il Delta del Po rappresenta senza dubbio la maggiore concentrazione di biodiversità e di qualità ambientale dell’intera provincia. Non sono infatti presenti altri nuclei di notevole estensione che racchiu-dano aree che per caratteristiche fi siche e per relazioni ecologiche possano paragonarsi alle zone umide deltizie.
La destinazione a Parco Regionale, in applicazione della LR 36/97, ha permesso a questo territorio di poter preservare e mantenere inalterati alcuni ambiti che oggi rivestono un ruolo fondamentale nella tutela della fl ora, della vegetazione e della fauna. Non a caso le aree che compongono la rete ecologica europea, racchiudono questi ambiti e l’intero corso del fi ume Po.
Alcune golene del Po e dei resti di aree umide (naturali o artifi ciali) racchiudono nel territorio quelli che possono essere defi niti nuclei di una rete ecologica; le connessioni di questa rete sono costituite princi-
impa rapporto.indd 11impa rapporto.indd 11 8-04-2009 17:24:338-04-2009 17:24:33

IX
palmente dai canali, soprattutto dai canali di scolo, che connettono fra loro questi elementi con l’asse del Po, dell’Adige e del Canalbianco che portano verso il basso Polesine.
Restano nel territorio alcuni gorghi, alcune aree umide minori, nuclei alberati rimasti intatti e non completamente inglobati dalle attività agricole. Le oasi di protezione istituite e date in gestione tendono a proteggere appunto queste aree, di notevolissima importanza e determinanti per la salvaguardia e la tutela del patrimonio ecologico provinciale.
La pressione venatoria, visto il calo continuo e costante del numero di cacciatori, è lievemente diminui-ta. Gli atti di bracconaggio che ogni anno vengono segnalati alla Provincia indicano tuttavia una pressione abbastanza elevata, sopratutto nelle aree del Delta.
Complessa è la defi nizione dell’ambiente antropico per eccellenza, l’ambiente urbano, che nell’ottica della sostenibilità riveste un fattore determinante per valutare la complessiva qualità dell’ambiente.
Rispetto al precedente rapporto (2003) si è deciso di riproporre un questionario a tutte le amministra-zioni comunali, per verifi care quali indicazioni fossero variate nel tempo.
Rispetto alle risposte pervenute alcune considerazioni meritano di essere fatte:
- vi è una maggiore consapevolezza del proprio territorio e delle relazioni che su di esso sono state instaurate. In particolar modo molte amministrazioni hanno risposto e prodotto in questi anni delle piste ciclabili, in risposta ad una crescente domanda di mobilità dei propri cittadini. Resta tuttavia il dato nega-tivo degli incidenti che coinvolgono appunto pedoni e soprattutto i ciclisti;
- appaiono vaghi e non defi niti i valori riferiti all’uso del suolo. Superfi cie urbanizzata e destinazioni non sono state indicate da molte amministrazioni;
- rispetto ai dati precedenti risultano complessivamente presenti gli stessi impianti sportivi e le stesse attrezzature per attività culturali. Solo alcune amministrazioni in questi anni hanno prodotto nuove strutture di rilievo (piscine in particolar modo).
Per quanto concerne i piani acustici, la provincia di Rovigo è l’unica nella quale tutte le amministrazioni risultano dotate di piano di classifi cazione. Questo è un ottimo risultato ma adesso devono essere predi-sposti e defi niti eventuali piani di risanamento che vadano a defi nire e indicare azioni correttive rispetto alle problematiche evidenziate con le classifi cazioni.
Resta negativo, come nel rapporto precedente, il rapporto tra aree produttive ed abitanti. Risultano infatti molto diffuse e presenti aree produttive in tutto il territorio provinciale.
Per quanto riguarda le registrazioni EMAS e le certifi cazioni ISO 14.000, che rappresentano la volontà di migliorare (o tenere sotto controllo) le proprie azioni che possano avere delle conseguenze nell’ambien-te nella provincia di Rovigo si segnalano un numero di aziende in continua crescita.
Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente e della Comunità non ha il compito di defi nire le politiche am-bientali, culturali e sociali della Provincia di Rovigo, ma sicuramente è un punto di partenza rilevante da cui gli strumenti in corso di defi nizione (tra questi si segnalano il Programma Energetico e il P.T.C.P.) e le prossime iniziative potranno partire con maggiore consapevolezza e soprattutto di coordinamento inter-settoriale, rispetto ai bisogni del Polesine.
Francesco Musco, Gustavo De Filippo, Giorgia Businaro
impa rapporto.indd 12impa rapporto.indd 12 8-04-2009 17:24:338-04-2009 17:24:33

POPOLAZIONE
impa rapporto.indd 13impa rapporto.indd 13 2-04-2009 19:20:052-04-2009 19:20:05

14POPOLAZIONE 01
La popolazione della provincia di Rovigo: brevi cenniLa dinamica recente
In questo capitolo sono illustrati sinteticamente la composizione della popolazione della provincia di Rovigo e alcuni trend in atto. La popolazione provinciale ammontava a 200.835 unità al censimento del 1871 ed è cresciuta nel corso degli anni raggiungendo, dopo le due guerre mondiali, al censimento del 1951, le 357.963 unità.
Una serie di mutamenti collegati a dinamiche sociali ed economiche e in conseguenza di catastrofi naturali (l’alluvione che ha colpito il Polesine nel 1951, il conseguente abbandono delle campagne, lo spostamento della popolazione verso altri poli urbani) ha causato nella provincia di Rovigo l’inizio di un calo progressivo della popolazione (soprattutto di determinate classi di età), la cui massima variazione negativa si è verifi cata nel decennio dal ’51 al ’61 (-25 0/00 il tasso di variazione annuo).
Negli anni settanta, il calo si è momenta-neamente arrestato segnando una piccola ripresa fi no al Censi-mento del 1981, se-guita da un ulteriore successivo decremen-to che ha portato la popolazione residen-te, nel 2001, ad un to-tale di 242.538 unità.
Nel primo grafi co è rappresentato l’an-damento dei numeri indice della popolazione ai censimenti dal 1871 al 2001. Il calo della popolazione polesana, avvenuto dopo il censimento del 1951, non si è registrato a livello regionale e nazionale.
Dal 2001 al 2007, si è osservata un’in-versione rispetto alla precedente tenden-za della popolazio-ne, che è aumentata dell’1,53%, pari a 3.717 in valore asso-luto.
1 0 0
1 2 0
1 4 0
1 6 0
1 8 0
2 0 0
2 2 0
1 8 7 1 1 8 8 1 1 9 0 1 1 9 1 1 1 9 2 1 1 9 3 1 1 9 3 6 1 9 5 1 1 9 6 1 1 9 7 1 1 9 8 1 1 9 9 1 2 0 0 1
P ro v in c ia d i R o v ig o V e n e to I ta lia
2 4 6 . 2 5 5
2 4 4 . 8 9 4
2 4 4 . 7 5 2
2 4 4 . 6 2 5
2 4 3 . 8 2 9
2 4 2 . 6 0 8
2 4 2 . 5 3 8
2 4 3 . 2 9 2
2 4 3 . 5 2 0
2 4 4 . 0 7 2
2 4 4 . 5 9 4
2 4 4 . 9 9 3
2 4 5 . 3 1 4
2 4 6 . 0 9 2
2 4 6 . 7 9 9
2 4 7 . 3 2 2
2 4 8 . 0 0 4
2 4 0 . 0 0 0
2 4 2 . 0 0 0
2 4 4 . 0 0 0
2 4 6 . 0 0 0
2 4 8 . 0 0 0
2 5 0 . 0 0 0
1 9 9 1 * 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 * 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
p o p o la z io n e re s id e n te TO T A L E
Popolazione residente dal 2001 al 2007 nella Provincia di Rovigo
Fonte: elaborazione Uffi cio Statistica della Provincia di Rovigo su dati ISTAT
Serie storica dei numeri indice della popolazione residente nella provincia di Rovigo dal Censimento del 1871 al Censimento 2001 (base 1871=100)
Fonte: elaborazione Uffi cio Statistica della Provincia di Rovigo su dati ISTAT
impa rapporto.indd 14impa rapporto.indd 14 2-04-2009 19:20:052-04-2009 19:20:05

15 POPOLAZIONE01
I residenti nei comuni al 31.12.2007
La tabella che segue riporta i dati relativi alla popolazione residente nei comuni della provincia di Rovigo alla data del 31 dicembre 2007, suddivisa per genere.
É inoltre riportata la densità abita-tiva comunale. Il comune più densa-mente popolato è Rovigo, mentre il territorio nel quale vi sono meno abi-tanti per chilometro quadrato è Porto Tolle.
tieiaa
--l-o
Maschi Femmine Totale Sup. terr.
Kmq
Densità.
(pop/kmq)
Adria 9.834 10.623 20.457 113,51 180,22
Ariano Polesine 2.341 2.413 4.754 80,91 58,76
Arquà Polesine 1.406 1.497 2.903 20,02 145,00
Badia Polesine 5.316 5.561 10.877 44,52 244,32
Bagnolo di Po 719 706 1.425 21,42 66,53
Bergantino 1.250 1.381 2.631 18,18 144,72
Bosaro 666 710 1.376 6,02 228,57
Calto 396 419 815 10,99 74,16
Canaro 1.386 1.494 2.880 32,7 88,07
Canda 458 466 924 14,39 64,21
Castelguglielmo 857 861 1.718 22,1 77,74
Castelmassa 2.092 2.342 4.434 11,9 372,61
Castelnovo Bariano 1.490 1.549 3.039 37,56 80,91
Ceneselli 927 946 1.873 28,58 65,54
Ceregnano 1.888 1.988 3.876 30,01 129,16
Corbola 1.269 1.360 2.629 18,39 142,96
Costa di Rovigo 1.364 1.473 2.837 16,05 176,76
Crespino 1.013 1.106 2.119 31,92 66,38
Ficarolo 1.328 1.343 2.671 17,85 149,64
Fiesso Umbertiano 2.064 2.155 4.219 27,29 154,60
Frassinelle Polesine 767 772 1.539 21,86 70,40
Fratta Polesine 1.260 1.503 2.763 20,9 132,20
Gaiba 546 575 1.121 12,08 92,80
Gavello 805 813 1.618 24,41 66,28
Giacciano con Baruchella 1.118 1.149 2.267 18,35 123,54
Guarda Veneta 585 616 1.201 17,32 69,34
Lendinara 5.872 6.340 12.212 55,4 220,43
Loreo 1.893 1.897 3.790 39,59 95,73
Lusia 1.750 1.863 3.613 17,72 203,89
Melara 930 995 1.925 17,6 109,38
Occhiobello 5.514 5.685 11.199 32,62 343,32
Papozze 830 896 1.726 21,81 79,14
Pettorazza Grimani 867 825 1.692 21,51 78,66
Pincara 650 639 1.289 17,79 72,46
Polesella 2.064 2.132 4.196 16,57 253,23
Pontecchio Polesine 917 914 1.831 11,47 159,63
Porto Tolle 5.124 5.143 10.267 227,63 45,10
Porto Viro 7.130 7.466 14.596 133,37 109,44
Rosolina 3.182 3.234 6.416 73,07 87,81
Rovigo 24.484 27.120 51.604 108,55 475,39
Salara 581 636 1.217 14,3 85,10
San Bellino 602 594 1.196 15,84 75,51
San Martino di Venezze 1.952 2.062 4.014 31,1 129,07
Stienta 1.600 1.663 3.263 24,13 135,23
Taglio di Po 4.170 4.316 8.486 79,01 107,40
Trecenta 1.440 1.592 3.032 35,06 86,48
Villadose 2.617 2.686 5.303 32,5 163,17
Villamarzana 579 601 1.180 14,08 83,81
Villanova del Ghebbo 1.093 1.096 2.189 11,78 185,82
Villanova Marchesana 515 538 1.053 18,2 57,86
Provincia di Rovigo 119.501 126.754 246.255 1789,93 137,58
Popolazione residente nella provincia di Rovigo per comune di residenza al 31/12/2007Fonte: elaborazione Uffi cio Statistica della Provincia di Rovigo su dati ISTAT
impa rapporto.indd 15impa rapporto.indd 15 2-04-2009 19:20:062-04-2009 19:20:06

16POPOLAZIONE 01
I comuni con la maggiore ampiezza demografi ca, superiore ai 10.000 abitanti, sono Badia Polesine, Lendinara e Occhiobello nell’Alto Polesine, Rovigo nel Medio, mentre nel Basso Polesine sono Adria, Porto Viro e Porto Tolle.
Attualmente, a superare la soglia dei 20.000 abitanti, oltre al capoluogo, è il solo comune di Adria; Porto Viro è il terzo per popolazione e conta 14.596 abitanti al 31 dicembre 2007.
Esistono 19 comuni con meno di 2.000 abitanti.
Le variazioni percentuali di popolazione registrate dal censimento del 2001 al 2007 sono state in alcuni comuni negative (con un conseguente calo di popolazione), come a Porto Tolle e Ariano nel Polesine nel Basso e in alcuni piccoli comuni del Medio e Alto Polesine. Un saldo di poco negativo si registra ad Adria e nei comuni limitrofi (inferiore a -3,4).
Il saldo positivo si è registrato in molti comuni fra cui Occhiobello, Porto Viro e Rosolina e Badia Pole-sine.
Variazione della popolazione oltre 3,6 0,1/3,5 -3,4/0,0 al di sotto di -3,5
Variazione in percentuale della Popolazione residente tra il 2001 ed il 2007Fonte dati: Uffi cio Statistica della Provincia di Rovigo su dati ISTAT , elaborazione: Agenda21Polesine
Comuni per classe dimensionale
fi no a 2.000 ab. 2.000 - 5.000 5.000 - 10.000 oltre 10.000 ab.
Distribuzione dei comuni per classe dimensionaleFonte dati: Uffi cio Statistica della Provincia di Rovigo su dati ISTAT, elaborazione: Agenda21Polesine
impa rapporto.indd 16impa rapporto.indd 16 2-04-2009 19:20:062-04-2009 19:20:06

17 POPOLAZIONE01
La natalità e la mortalità
Il tasso di natalità nella provincia di Ro-vigo è cresciuto dal 2003 al 2007 da 6,9 a 7,6 ‰, il dato è però nettamente infe-riore ai valori regionale e nazionale che si attestato al di sopra del 9,0 ‰.
Il tasso di mortalità, il cui valore è su-periore al valore regionale, è infl uenzato dalla elevata presenza di anziani. I valori registrai nella provincia di Rovigo sono superiori al valore regionale e Nazionale.
-9 -e
2003 2004 2005 2006 2007Rovigo 6,9 7,4 7,5 7,3 7,6
Veneto 9,5 10,1 9,8 9,9 9,9
Italia 9,4 9,7 9,4 9,5 9,5
Tasso di natalità - (Nati/Pop. residente media)* 1.000Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statisti-co Regionale su dati Istat
-o ri o e.
2003 2004 2005 2006 2007
Rovigo 11,6 11,2 11,5 11,6 11,7
Veneto 9,5 8,9 9,1 8,9 9,1
Italia 10,2 9,4 9,7 9,5 9,6
Tasso di mortalità - (Morti/Pop. residente media)* 1.000Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Re-
gionale su dati Istat
6
7
8
9
1 0
1 1
2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
R o v ig o V e n e to I ta lia
7
8
9
1 0
1 1
1 2
2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
R o v ig o V e n e to I ta lia
Tasso di mortalità - (Morti/Pop. residente media)* 1.000
Elaborazioni Agenda21Polesine
Tasso di natalità - (Nati/Pop. residente media)* 1.000
Elaborazioni Agenda21Polesine
impa rapporto.indd 17impa rapporto.indd 17 2-04-2009 19:20:062-04-2009 19:20:06

18POPOLAZIONE 01
La piramide delle popolazione al 31 dicembre 2007
La piramide del grafi co successivo rappresenta la struttura della popolazione residente per classi quin-quennali d’età e per sesso. La sua forma evidenzia, nella punta ingrossata, un peso assai rilevante delle classi d’età più anziane e, nella base ristretta, una bassa incidenza dei residenti più giovani, causata dal calo delle nascite.
Nel grafi co sono rappresentate contemporaneamente la popolazione del 2003 (solo bordi) e quella del 2007 (campitura piena). Le principali differenze sono riscontrabili nella notevole diminuzione della popo-lazione della classe 20-24 e 25-29, sia per i maschi che per le femmine; è visibile anche un aumento, in entrambi i generi, delle classi di età comprese tra i 40 e i 59 anni, oltre che negli ultraottantenni.
Da registrare l’aumento, rispetto al 2003, della classe 0-4 anni, data dall’aumento del tasso di natalità, da attribuire parzialmente al contributo della popolazione straniera.
1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
0 -4
5 -9
1 0 -1 4
1 5 -1 9
2 0 -2 4
2 5 -2 9
3 0 -3 4
3 5 -3 9
4 0 -4 4
4 5 -4 9
5 0 -5 4
5 5 -5 9
6 0 -6 4
6 5 -6 9
7 0 -7 4
7 5 -7 9
8 0 -8 4
8 5 -8 9
9 0 e p iù
Piramidi delle classi quinquennali d’età, confronto 2003-2007
Fonte: elaborazione Uffi cio Statistica della Provincia di Rovigo su dati ISTAT
maschi - 2003
maschi - 2007
femmine - 2003
femmine - 2007
impa rapporto.indd 18impa rapporto.indd 18 2-04-2009 19:20:072-04-2009 19:20:07

19 POPOLAZIONE01
Alcuni indicatori
Gli indicatori considerati forniscono alcuni elementi conoscitivi utili a delineare un quadro demografi co e sociale generale, soprattutto in relazione all’anzianità della popolazione e al “peso” delle classi di età non attive su quelle attive.
La popolazione residente è contraddistinta da un invecchiamento superiore alla media regionale e na-zionale: l’indice di vecchiaia è passato dal 129,9% del 1991 al 195,0% del 2001 fi no al valore di 204,1% al 31 dicembre 2007 .
Indicatori di strutturaCensimento 2001 31 dic. 2007
Rovigo Veneto Italia Rovigo Veneto Italia
Indice di vecchiaia 195,0 134,3 127,1 204,1 139,1 142,8
Pop.65-W/Pop.0-14*100Indice di dipendenza 48,9 45,6 48,4 50,6 50,5 51,7
Pop.(0-14+65-W)/Pop.15-64*100Indice di dipendenza anziani 32,3 26,2 27,1 34,0 29,4 30,4
Pop.65-w/Pop.15-64*100Fonte: elaborazione Uffi cio Statistica della Provincia di Rovigo su dati ISTAT
Anche l’indice di dipendenza, che misura il rapporto tra la popolazione attiva e la popolazione in età non lavorativa, segna un aumento determinato soprattutto dall’incremento della popolazione anziana. Il valore al 2001 era 48,9% ed è salito a 50,6% al 31 dicembre 2007.
impa rapporto.indd 19impa rapporto.indd 19 2-04-2009 19:20:082-04-2009 19:20:08

20POPOLAZIONE 01
Popolazione straniera
La componente straniera nella popolazione residente è in costante aumento e ha assunto una signifi -cativa rilevanza nel territorio polesano a partire dagli anni novanta. È infatti dovuto a tale fattore l’incre-mento della popolazione residente complessiva nel Polesine, iniziato nel 2001.
La registrazione di cittadini stranieri nella provincia di Rovigo ha avuto un rapido incremento negli ul-timi anni passando da 3.804 residenti nel 2001 a 13.245 a fi ne 2007. Questa componente contribuisce a contenere il calo della popolazione autoctona residente nella provincia di Rovigo.
Analizzando il trend di crescita della popolazione straniera nella provincia si nota come il picco sia stato registrato nell’anno 2003 con un incremento del 45,3% e nel corso dell’anno 2007 con un incremento del 23,3%, in concomitanza con l’entrata in vigore di nuove normative sugli ingressi degli stranieri.
L’incidenza della popola-zione straniera sul totale del-la popolazione residente si attesta al 5,4%, dato in linea con la media nazionale che è pari al 5 %, leggermente più basso rispetto a molte altre parti del nord Italia.
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2001* 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
% di popolazione stranierapopolazione straniera
Annopopolazione
stranieravariazione assoluta
risp. anno precedentevariazione % risp. anno precedente
% di popolazione straniera
2001* 3.804 335 9,7 1,6
2002 4.673 869 22,8 1,9
2003 6.791 2.118 45,3 2,8
2004 8.551 1.760 25,9 3,5
2005 9.686 1.135 13,3 4,0
2006 10.746 1.060 10,9 4,4
2007 13.245 2.499 23,3 5,4
Popolazione di cittadinanza straniera residente nella provincia di Rovigo, serie storica dal censimento del 2001 al 31/12/2007 Fonte: elaborazione Uffi cio Statistica della Provincia di Rovigo su dati ISTAT
Popolazione di cittadinanza straniera residente nella provincia di Rovigo, serie storica dal censimento del 2001 al 31/12/2007
Fonte: elaborazione Uffi cio Statistica della Provincia di Rovigo su dati ISTAT
impa rapporto.indd 20impa rapporto.indd 20 2-04-2009 19:20:082-04-2009 19:20:08

21 POPOLAZIONE01
Piramide della popolazione straniera
La piramide per classi quinquennali di età della popolazione straniera assume una forma completamente differente rispetto a quella del-la popolazione presa nel suo insieme e vista precedentemente.
Infatti è evidente come gran parte della po-polazione residente risulti tra i 20 ed i 50 anni (popolazione attiva). Pochi sono gli anziani mentre più consistente risulta l’ammontare dei giovanissimi.
(Questo determina un valore molto basso dell’indice di vecchiaia)
àa-a
-ii
ei
al 31.12.2007
Indice di vecchiaia 7,2
Pop.65-W/Pop.0-14*100Indice di dipendenza 30,6
Pop.(0-14+65-W)/Pop.15-64*100Indice di dipendenza anziani 2,0
Pop.65-w/Pop.15-64*100Indici relativi alla sola popolazione straniera residente nel-la provincia di Rovigo al 31/12/2007Fonte: elaborazione Uffi cio Statistica della Provincia di Rovigo su dati ISTAT
0 - 4
5 - 9
1 0 -1 4
1 5 -1 9
2 0 -2 4
2 5 -2 9
3 0 -3 4
3 5 -3 9
4 0 -4 4
4 5 -4 9
5 0 -5 4
5 5 -5 9
6 0 -6 4
6 5 -6 9
7 0 -7 4
7 5 -7 9
8 0 -8 4
8 5 -8 9
9 0 e p iù
Popolazione di cittadinanza straniera residente nella provincia di Rovigo per classi quinquennali d’età al 31/12/2007
Fonte: elaborazione Uffi cio Statistica della Provincia di Rovigo su dati ISTAT
maschi
femmine
impa rapporto.indd 21impa rapporto.indd 21 2-04-2009 19:20:082-04-2009 19:20:08

22POPOLAZIONE 01
Numero componenti per famiglia
Il numero di famiglie ed il numero di compo-nenti per famiglia è determinante per la valu-tazione del dimensionamento dei servizi e del-le strutture per i cittadini in ambito comunale.
Nel periodo considerato, il numero di fami-glie è aumentato passando da 84.769 nel 1991 a 99.980 al 31 dicembre 2007 ma molto di-versa ne appare la distribuzione per numero di componenti.
Infatti, nel 1991 solo il 16,5% delle famiglie aveva 1 solo componente (singles, anziani soli,…); nel 2007 tale percentuale è salita al 26,9%. Viceversa sono diminuite le famiglie composte da 4, 5, 6 o più persone. Nel 1991 ad esempio, circa una famiglia su cinque era composta da 4 persone, nel 2007 solo una su sette.
Il grafi co rappresenta la distribuzione percentuale del numero di componenti per famiglia negli anni considerati.
Questa variazione ha un notevole effetto sulle scelte urbanistiche e pianifi catorie dei Comuni. Appare chiaro che la diminuzione del numero di componenti e quindi la modifi ca della struttura della famiglia comportino oggettivi mutamenti nelle esigenze dei servizi e delle dimensioni abitative.
---
-1-i
e
Censimento
1991
Censimento
2001
al 31 dic.
2007
1 persona 14010 19.935 26.892
2 persone 21814 25.938 29.034
3 persone 21955 23.581 24.256
4 persone 17620 16.241 14.743
5 persone 6462 4.496 3.749
6 o più persone 2908 1.529 1.306
Totale famiglie 84769 91.720 99.980
Famiglie per numero di componenti al Censimento 1991,
2001 e al 31/12/2007
Fonte: elaborazione Uffi cio Statistica della Provincia di Rovigo su
dati ISTAT (2001) e su dati Uffi ci Anagrafe Comunali (2007)
Famiglie per numero di componenti al Censimento 1991, 2001 e al 31/12/2007
Fonte: elaborazione Uffi cio Statistica della Provincia di Rovigo su dati ISTAT (1991-2001) e su dati Uffi ci Anagrafe Comunali (2007)
0 %
5 %
1 0 %
1 5 %
2 0 %
2 5 %
3 0 %
3 5 %
1 componente
Censimento 1991 Censimento 12001 al 31 dicembre 2007
2 componenti 3 componenti 4 componenti 5 componenti 6 o più
componenti
impa rapporto.indd 22impa rapporto.indd 22 2-04-2009 19:20:092-04-2009 19:20:09

23 POPOLAZIONE01
Sintesi
D Causa determinate P Indicatore di pressione S Indicatore di Stato
I Indicatore di Impatto R Indicatore di Risposta
Condizioni positive Condizioni stazionarie Condizioni negative
Trend in crescita Trend stazionario Trend in diminuzione
a kf
Tipo indicatore Valutazione sintetica Trend
Distribuzione dei comuni per classe dimensionale S
Variazione in percentuali di popolazione tra il 2001 ed il 2007 S
Tasso di natalità S
Tasso di mortalità S
Piramide della popolazione 2007 D
Incidenza della popolazione straniera sul totale D
Piramide della popolazione straniera S
Numeri di componenti per famiglia P
Indici della popolazione S
a
a
k
k
k
k
f
f
f
impa rapporto.indd 23impa rapporto.indd 23 2-04-2009 19:20:092-04-2009 19:20:09

ARIA
impa rapporto.indd 25impa rapporto.indd 25 2-04-2009 19:20:092-04-2009 19:20:09

26ARIA 02
AriaInquinamento atmosferico è un termine che indica tutti gli agenti fi sici (particolati), chimici e biologici
che modifi cano le caratteristiche naturali dell’atmosfera.
È diffi cile defi nire quando si possa parlare di inquinamento atmosferico. Infatti la prima diffi coltà è chiarire il confi ne tra sostanze inquinanti e non inquinanti. Williamson (1973) ha proposto una distinzione tra inquinante e contaminante: un contaminante è “ogni cosa che viene aggiunta all’ambiente che causa una deviazione dalla composizione geochimica media”; l’inquinante, per essere considerato tale, deve essere un contaminante responsabile di causare effetti nocivi all’ambiente, inteso in senso lato come unione delle parti naturale ed antropica.
I fenomeni di inquinamento sono il risultato di una complessa competizione tra fattori che portano ad un accumulo degli inquinanti ed altri che invece determinano la loro rimozione e la loro diluizione in atmosfera. L’entità e le modalità di emissione (sorgenti puntiformi, diffuse, altezza di emissione, ecc.), i tempi di persistenza degli inquinanti, il grado di mescolamento dell’aria, sono alcuni dei principali fattori che producono variazioni spazio-temporali della composizione dell’aria.
Per inquinamento atmosferico si intende “la presenza nell’atmosfera di sostanze che causano un effetto misurabile sull’essere umano, sugli animali, sulla vegetazione o sui diversi materiali”. Queste sostanze, di solito, non sono presenti nella normale composizione dell’aria, oppure lo sono ad un livello di concentrazione inferiore.
Le sostanze responsabili dell’inquinamento atmosferico sono numerose e diversifi cate, in termini di caratteristiche chimico-fi siche e di effetti sulla salute e sull’ambiente; esse normalmente si distinguono in:
• inquinanti primari, che vengono direttamente immessi in atmosfera a causa di attività antropiche o fenomeni naturali (biossido di zolfo, acido solfi drico, monossido di azoto, ammoniaca, monossido di carbonio, anidride carbonica e acido cloridrico;
• inquinanti secondari, che si formano per reazioni chimiche o fi siche dagli inquinanti primari, (ani-dride solforica, acido solforico, biossido di azoto, acido nitrico, chetoni, aldeidi, acidi vari, ozono).
Per la composizione e la valutazione delle pressioni esercitate sull’ambiente sono stati utilizzati i dati registrati dalle centraline di rilevamento di ARPA Veneto presenti nella provincia di Rovigo.
I livelli di concentrazione in aria degli inquinanti sono verifi cati quotidianamente. Per valutare la qualità dell’aria, i dati rilevati nelle centraline ARPAV vengono confrontati con i valori limite e con i livelli d’atten-zione e d’allarme previsti dalla normativa vigente. In particolare, per le valutazioni contenute in questo rapporto, sono stati considerati i seguenti valori legislativi:
- DM 60/02 per quanto riguarda il biossido di zolfo (SO2), il biossido di azoto (NO2), gli ossidi di azoto (NOx), il monossido di carbonio (CO), il particolato (PM10), il piombo (Pb) e il benzene (C6H6);
- D.Lgs. 183/04 per l’ozono (O3); dal D.Lgs. 152/2007 per quanto riguarda il cadmio (Cd), il nichel (Ni), il mercurio (Hg),l’arsenico (As) e il benzo(a)pirene.
impa rapporto.indd 26impa rapporto.indd 26 2-04-2009 19:20:092-04-2009 19:20:09

27 ARIA02
Valori limite per la protezione della salute umana, degli ecosistemi, della vegetazione e valori obiettivo secondo la normati-va vigente.
impa rapporto.indd 27impa rapporto.indd 27 2-04-2009 19:20:092-04-2009 19:20:09

28ARIA 02
Numero di centraline presentiNella Provincia di Rovigo, le stazioni di rilevamento dei parametri considerati in questo rapporto sono
complessivamente 5 e sono classifi cate, come previsto dal DM 25/05/94, a seconda che siano localiz-zate in aree non interessate da sorgenti di emissione urbana, in zone ad elevata densità abitativa, in zone a traffi co intenso o in aree suburbane. A ciascuna tipologia di stazione corrisponde una fi nalità di monitoraggio diversa e quindi anche gli inquinanti rilevati sono differenti.
Le stazioni di rilevamento presenti nella provincia sono 5 fi sse dislocate nel territorio come rappresen-tato nella cartografi a sottostante. La tabella riporta i nomi delle stazioni fi sse e i parametri rilevati (i valori possono essere consultati in continuo sul sito dell’ARPA Veneto nella sezione Aria).
Tra le attività del Dipartimento provinciale, sono inoltre eseguiti dei campionamenti con stazione mobi-le. Le reti indagate nel corso del 2008 sono state Villafora (comune di Badia Polesine), Rosolina, Papozze, Pontecchio Polesine e Porto Viro.
Nome stazione Tipologia Caratteristiche PRG Parametri considerati
Rovigo, Largo Martiri Traffi co-urbano Residenziale - Commerciale NOx, CO, O3, SO2, PM10, Benzeni
Rovigo, Borsea Background- urbano residenziale NOx, CO, O3, SO2, PM10
Adria Background- urbano residenziale NOx, CO, O3, SO2, PM10
Castelnovo Bariano Background-suburbano residenziale NOx, SO2, PM10 , Pb, Cd, Hg, Ni, As
Porto Tolle Background-suburbano Residenziale - Commerciale NOx, SO2, PM10, PM2,5
Stazioni fi sse per il monitoraggio della qualità dell’aria della provincia di Rovigo
Fonte: ARPA Veneto, Dipartimento provinciale di Rovigo – Elaborazione: Agenda21Polesine
Ubicazione delle stazioni di rilevamento dell’atmosfera gestite da ARPAV – anno 2008.
Fonte: ARPA Veneto, Dipartimento provinciale di Rovigo – Elaborazione: Agenda21Polesine
impa rapporto.indd 28impa rapporto.indd 28 2-04-2009 19:20:102-04-2009 19:20:10

29 ARIA02
Particolato PM10La sigla PM10 identifi ca materiale presente nell’atmosfera in forma di particelle microscopiche, il cui
diametro aerodinamico medio è uguale o inferiore a 10 μm, ovvero 10 millesimi di millimetro.
È costituito da polvere, fumo, microgocce di sostanze liquide. Le principali fonti di PM10 sono:
- Sorgenti naturali: l’erosione del suolo, gli incendi boschivi, le eruzioni vulcaniche, la dispersione di pollini, il sale marino;
- Sorgenti legate all’attività dell’uomo: processi di combustione (tra cui quelli che avvengono nei motori a scoppio, negli impianti di riscaldamento, in molte attività industriali, negli inceneritori e nelle centrali termoelettriche), usura di pneumatici, freni ed asfalto.
Inoltre, una parte rilevante del PM10 presente in atmosfera deriva dalla trasformazione in particelle liquide di alcuni gas (composti dell’azoto e dello zolfo) emessi da attività umane.
Nelle aree urbane il traffi co veicolare non è la principale fonte del PM10 (è circa il 29% - fonte: Centro studi sui sistemi di trasporto, riportato sul numero di febbraio 2007 della rivista Quattroruote) che resta il riscaldamento degli edifi ci.
I valori limite sono defi niti in Italia dal DL.n. 60 del 2 aprile 2002; tale decreto fi ssa due limiti accettabili di PM10 in atmosfera. Il primo è un valore limite di 50 μg/Nm³ come valore medio misurato nell’arco di 24 ore da non superare più di 35 volte/anno; il secondo come valore limite di 40 μg/Nm³ come media annuale.
impa rapporto.indd 29impa rapporto.indd 29 2-04-2009 19:20:102-04-2009 19:20:10

30ARIA 02
Superamenti del valore limite giornaliero di PM10Scopo di questo indicatore è evidenziare quale è la qualità dell’aria registrata dalle centraline presenti
nella provincia di Rovigo. In particolare sono stati presi in considerazione il numero di superamenti del valore limite giornaliero fi ssato in 50 μg/Nm³.
La tabella indica per ogni stazione il numero di superamenti dal 2004 al 2008. Per la stazione di Adria sono disponibili solo parziali dati riferiti all’anno 2006 ed i dati del 2007 e 2008. Da aprile 2007 è inoltre presente il dato della stazione di Villafora.
Come evidenziato anche nel grafi co si nota che rispetto al 2004 c’è stato un incremento di superamen-ti che è andato tuttavia diminuendo negli ultimi anni. In particolare nelle stazioni di Castelnuovo Bariano e Porto Tolle il numero di superamenti rispetto al 2005 è notevolmente diminuito.
La normativa prevede che il valore di 50μg/Nm3 non sia superato più di 35 volte l’anno.
2004 2005 2006 2007 2008
Valore limite 55 μg/Nm3 50 μg/Nm3 50 μg/Nm3 50 μg/Nm3 50 μg/Nm3
Rovigo Borsea 125 133 114 107 72
Rovigo Largo Martiri 103 122 119 94 79
Castelnuovo Bariano 89 116 98 91 62
PortoTolle 51 90 72 70 -
Adria - - 21 66 47
Numero di superamenti annui del valore di riferimento limite, anni 2004 - 2008Fonte: ARPA Veneto, Dipartimento provinciale di Rovigo – Elaborazione: Agenda21Polesine
0
2 0
4 0
6 0
8 0
1 0 0
1 2 0
1 4 0
R o v ig o B o rs e a R o v ig o L a rg o M a rtir i C a s te ln u o v o B a ria n o P o rto T o l le A d ria
num
ero
supe
ram
enti
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8
Numero di superamenti annui del valore di riferimento limite Fonte: ARPA Veneto, Dipartimento provinciale di Rovigo – Elaborazione: Agenda21Polesine
impa rapporto.indd 30impa rapporto.indd 30 2-04-2009 19:20:102-04-2009 19:20:10

31 ARIA02
Valore medio annuale di PM10Scopo di questo indicatore è evidenziare quale è la qualità dell’aria registrata dalle centraline presenti
nella provincia di Rovigo. In particolare sono stati presi in considerazione i valori medi annuali di concen-trazione di PM10 registrati nelle centraline, questi valori sono stati confrontati con il valore soglia fi ssato dalla normativa vigente in 40 μg/Nm³.
La tabella ed il grafi co rappresentano l’andamento negli anni di questo valore ed è da evidenziare come nel corso degli anni sia diminuito, presso tutte le stazioni, il numero di superamenti. In particolare nel 2008 tutte le stazioni hanno rispettato il valore limite di 40 μg/Nm³. Nel 2007 solo le stazioni di Rovigo avevano superato tale soglia attestandosi tuttavia a 42 μg/Nm³.
Da notare inoltre che la stazione di Porto Tolle ha sempre avuto valori medi inferiori al valore limite.
2004 2005 2006 2007 2008
Valore limite 40 μg/Nm3 40 μg/Nm3 40 μg/Nm3 40 μg/Nm3 40 μg/Nm3
Rovigo - Borsea. 50,6 50,1 46,9 41,8 35,3
Rovigo Largo Martiri Autom. 46,7 45,9 48,3 41,7 37,4
Cast.Bariano 42,5 44,9 43,1 39,6 34,4
PortoTolle 36,3 37,7 36,9 34,9 -
Adria - - 30,8 29,0
Villafora (fondo) - - - 34,5 35,0
Media annuale dei valori di PM10 Fonte: ARPA Veneto, Dipartimento provinciale di Rovigo – Elaborazione: Agenda21Polesine
0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
B o rs e a R o v ig o C a s te ln o v o P o r to To lle A d ria V illa fo ra (fo n d o )
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8
v a lo re m e d io a n n u o c o n s e n ti to : 4 0 u g / m 3
PM10
(ug/
m3)
Media annuale dei valori di PM10 Fonte: ARPA Veneto, Dipartimento provinciale di Rovigo – Elaborazione: Agenda21Polesine
impa rapporto.indd 31impa rapporto.indd 31 2-04-2009 19:20:112-04-2009 19:20:11

32ARIA 02
Ripartizione percentuale delle emissioni di PM10Grazie ad un lavoro svolto da ARPA Veneto1 risulta che la ripartizione percentuale delle emissioni di
PM10 è data da quanto illustrato nel grafi co a torta che segue, nel quale viene individuato il contributo di ciascun macrosettore alla produzione di polveri PM10.
Come si osserva, i contributi più rilevanti sono da attribuirsi al macrosettore 7 “trasporto su strada” (28%), al macrosettore 3 “combustione nell’industria manifatturiera” (18%), al macrosettore 1 “Com-bustione: energia e industria di trasformazione” (16%) e al macrosettore 8 “altre sorgenti e macchinari mobili (14%).
ARPAV sta collaborando con la regione Veneto al fi ne dell’individuazione delle misure strutturali volte al risanamento della qualità dell’aria.
1 - Combustione: Energia e Industria di Trasformazione 16%
2 - Impianti di combustione non industriale 11%
3 - Combustione nell’industria manifatturiera 18%
4 - Processi produttivi (combustione senza contatto) 10%
5 - Estrazione e distribuzione di combustibili fossili ed energia geotermica 0%
6 - Uso di solventi ed altri prodotti contenenti solventi 0%
7 - Trasporto su strada 28%
8 - Altre sorgenti e macchinari mobili (offroad) 14%
9 - Trattamento e smaltimento rifi uti 3%
10 - Agricoltura 0%
11 - Altre emissioni ed assorbimenti 0%
Ripartizione percentuale delle emissioni di PM10 in Veneto negli 11 macrosettori Corinair.
Fonte: ARPA Veneto, elaborazione Agenda21Polesine (2008)
1. “Primo approccio ad un inventario regionale” – Seminario “Inventari locali di emissioni in atmosfera – strumenti ed espe-rienze” 28-29 ottobre 2004 – Venezia.
impa rapporto.indd 32impa rapporto.indd 32 2-04-2009 19:20:112-04-2009 19:20:11

33 ARIA02
BenzeneIl benzene (o benzolo) è un idrocarburo aromatico. Prima di essere riconosciuto come cancerogeno,
trovava largo impiego come additivo anti-detonante nella cosiddetta “benzina verde” in sostituzione del piombo tetraetile. Ora il suo impiego è fortemente ridotto per le stringenti normative sui carburanti.
Il benzene presente in atmosfera deriva principalmente da sorgenti antropiche: secondo l’Inventario delle emissioni APAT del 2000, per il Veneto queste consistono nel traffi co veicolare per il 75%, in altre modalità di trasporto per il 13% e nell’uso di solventi per il 10%. Le concentrazioni in aria di questo in-quinante sono costantemente diminuite a partire dal 2000, grazie alla Legge n. 413/1997 che ha posto una limitazione al contenuto massimo di questo idrocarburo nelle benzine (pari all’1% in volume).
La soglia di concentrazione in aria del benzene è stabilita dal DM 60/2002 e calcolata su base tempo-rale annuale. L’analisi dei livelli di C6H6 nel Veneto, dal 2002 al 2006, sulle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria della rete regionale ARPAV, si è basata sul numero di superamenti del Valore Limite (VL) annuale per la protezione della salute umana, pari a 5 μg/m3.
Media annuale concentrazione benzene stazioni di traffi co e di backgroundScopo di questo indicatore è verifi care quale sia la
concentrazione di Benzene nelle stazioni ed effettuare un confronto per permettere di valutare l’esposizione a questo inquinante
La stazione di Rovigo Centro ha fatto registrare un valore elevato, ma sempre al di sotto della soglia li-mite, nell’anno 2006 pari a 3,8 μg/m3. I valori sono comunque in linea con gli altri grandi centri urbani della regione.
a e a
n-o a
2005 2006 2007
Padova - Arcella 4,2 3,3 3,4
Padova - Mandria 2,7 2,5 2,8
Verona - Corso Milano 4 4,0 3,1
Rovigo - Centro 1,5 3,8 2,5
Belluno - città 3,1 2,5 1,2
Feltre 3,2 2,7 1,4
Media annuale concentrazione benzene stazioni
di traffi co e di background
Fonte: ARPA Veneto, elaborazione Agenda21Polesine
0
1
2
3
4
5
6
2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
v a lo re lim ite a n n u a le
Pado
va -
Arce
lla
Pado
va -
Man
dria
Feltr
e
Bellu
no -
città
Rov
igo
- Cen
tro
Vero
na -
Cor
soM
ilano
μg/
m3
Media annuale concentrazione benzene stazioni di traffi co e di backgroundFonte: ARPA Veneto, elaborazione Agen-da21Polesine
impa rapporto.indd 33impa rapporto.indd 33 2-04-2009 19:20:122-04-2009 19:20:12

34ARIA 02
Biossidi di azotoGli ossidi di azoto (NOx) più importanti, dal punto di vista dell’inquinamento atmosferico, sono il mo-
nossido e il biossido di azoto (NO e NO2).
La presenza in atmosfera di NO (inquinante primario) e NO2 (inquinante secondario) è dovuta essen-zialmente ai processi di combustione; la formazione di questi ossidi dipende, in particolare, dalla tem-peratura e dal tenore di ossigeno della camera di combustione. Le principali sorgenti di ossidi di azoto sono costituite dal settore dei trasporti (in particolare dai motori diesel) e dagli impianti termici (centrali di potenza e impianti di riscaldamento).
L’esposizione ad alte concentrazioni di ossidi di azoto ha un’azione lesiva nei confronti delle vie respi-ratorie profonde e degli alveoli polmonari (edema polmonare), mentre a basse concentrazioni provoca irritazione alle mucose. Nella vegetazione gli ossidi di azoto diminuiscono la velocità di fotosintesi e causano la formazione di necrosi fogliari.
Gli NOx contribuiscono alla formazione delle cosiddette “piogge acide”, che provocano danni alla vegetazione e accumulo di nitrati al suolo e nelle acque (eutrofi zzazione), nonché alla formazione del cosiddetto “smog fotochimico”, costituendo dei precursori per la formazione di ozono troposferico.
Medie Annuali di Biossido di Azoto registrato nell’anno nelle stazioniScopo di questo indicatore è confrontare il valore medio annuale registrato nelle centraline della pro-
vincia di Rovigo per evidenziare eventuali tendenze in atto.
La centralina posta nel centro di Rovigo è quella che fa registrare i valori più elevati di concentrazioni medie, con valori sempre superiori di 40. Tuttavia deve essere evidenziato che il valore soglia per l’an-no 2007 era pari a 46 e che il dato di questa centra-lina è superiore al valore soglia previsto per l’anno 2010 pari a 40 μg/m3.
Le altre postazioni, Adria e Borsea, non fanno re-gistrare valori elevati ed il dato complessivo si pone al di sotto del valore soglia.
e
a i a --o
2005 2006 2007
Rovigo - centro 43 48 41
Rovigo Borsea 26 23 27
Adria 33 30 23
Medie Annuali di Biossido di Azoto registrato nell'an-no nelle stazioni di riferimento.Fonte: ARPA VenetoElaborazione: Agenda21Polesine
0
10
20
30
40
50
60
Rovigo - centro Rovigo Borsea Adria
2005 2006 2007
valore lim ite al 2010
μg/
m3
Medie Annuali di Biossido di Azoto registrato nell’anno nelle stazioni di riferimento.Fonte: ARPA VenetoElaborazione: Agenda21Polesine
impa rapporto.indd 34impa rapporto.indd 34 2-04-2009 19:20:122-04-2009 19:20:12

35 ARIA02
OzonoL’ozono presente in prossimità del suolo (ozono troposferico) è un inquinante di tipo “secondario”; ciò
signifi ca che la sua presenza in atmosfera non è dovuta ad una emissione diretta ma la sua formazione avviene per effetto dell’azione dei raggi solari sugli ossidi di azoto (NOx) e i Composti Organici Volatili (COV) presenti in atmosfera.
In condizioni di intenso irraggiamento, venti deboli e stagnazione meteorologica, tipicamente d’estate, aumenta la produzione di ozono e di altri gas (quali biossido di azoto, acido nitroso, PAN e aldeidi) che, assieme ad esso, costituiscono il cosiddetto “smog fotochimico”.
Solitamente le concentrazioni di ozono risultano più elevate in zone rurali; nei grandi centri urbani, infatti, la presenza di fonti emissive di monossido di azoto - NO, (quali, ad esempio, il traffi co veicolare) è in grado di contrastare l’accumulo di ozono in atmosfera attraverso l’innesco di reazioni che coinvolgono questo inquinante, dando luogo alla formazione di biossido di azoto e ossigeno.
L’ozono, caratterizzato dall’assenza di colore e dall’odore pungente, è un potente ossidante che pro-voca nell’uomo irritazione ai tessuti delle vie respiratorie, in particolare degli alveoli polmonari, anche per esposizioni a breve termine. Danneggia inoltre le piante, creando sulle foglie delle zone necrotiche bianco/giallastre o favorendone l’invecchiamento precoce e la defogliazione; è in grado, inoltre, di com-promettere la fotosintesi clorofi lliana.
Giorni con superamenti soglia informazione oraria di 180 mg/m3
La soglia di informazione è il livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana, in caso di esposizio-ne di breve durata e per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione. Raggiunta tale soglia è ne-cessario comunicare al pubblico una serie dettagliata di informazioni inerenti al luogo, all’ora del superamento, alle previsioni per la giornata successiva e alle precau-zioni da seguire per minimizzare gli effetti di tale in-quinante.
Dalla tabella e dal grafi co si nota come il numero di superamenti abbia avuto un incremento notevole nel 2006, anno che ha prodotto molte giornate critiche in tutto il veneto. Nel 2007 il trend sembra ritor-nato ai valori del 2005 con valori assolutamente al di sotto nella media regionale.
vi -e -i
o, --
2005 2006 2007
Rovigo 2 9 3
Borsea 7 29 7
Adria 2 39 6
Legnago 14 17 2
Monselice 5 25 8
Giorni con superamenti del VL 180 ug/m3 Fonte: ARPA Veneto, elaborazione Agenda21Polesine
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Rovigo Borsea Adria Legnago M onseliceanno 2005 anno 2006 anno 2007
Giorni con superamenti del VL 180 ug/m3 Fonte: ARPA Veneto, elaborazione Agenda21Polesine
impa rapporto.indd 35impa rapporto.indd 35 2-04-2009 19:20:122-04-2009 19:20:12

36ARIA 02
Traffi co ed inquinamento prodotto dai veicoliSe non la prima causa, una delle principali fonti di inquinamento è da ricercare nella combustione di
idrocarburi nei veicoli. Il traffi co stradale ha grosse responsabilità infatti per l’inquinamento atmosferico: molte sostanze emesse dai motori hanno pesanti ripercussioni sulla salute e sull’ambiente.
La tossicità delle emissioni dei motori ha dato luogo a molti studi da parte di organismi pubblici e uni-versitari. Tutti concordi nel concludere che l’inquinamento dell’aria provoca disturbi gravi specialmente nei bambini, nelle persone anziane e negli asmatici.
Numerose novità tecnologiche sono state già introdotte per ridurre le emissioni di inquinanti (marmit-te catalitiche, benzina senza piombo, carburanti più poveri di zolfo…). Ma i loro effetti non permettono di compensare l’aumento del parco auto e dei chilometri percorsi, che si traducono in un aggravio delle emissioni di gas responsabili di danni alla salute e all’ambiente.
Per valutare il contributo del traffi co sono stati presi in considerazione alcuni indicatori che illustrano ed analizzano questa componente
Età media degli autobus circolantiScopo di questo indicatore è valutare l’età media dei mezzi di trasporto pubblico presenti nella provin-
cia di Rovigo.
Il dato evidenzia una età media di 9,6 anni, dato in linea con il valore medio veneto pari a 9,3.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Rovigo 12,8 10,1 8,0 8,3 8,3 8,6 9,6
Veneto 14,5 12,7 10,4 10,1 8,8 8,7 9,3
Età media del parco autobus di linea, per bacino di traffi coFonte: ACI – Elaborazione: Agenda21Polesine
6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 04 2 00 5 2 00 6 20 0 7
R o v ig o V e n e to
Età media del parco autobus di linea, per bacino di traffi coFonte: ACIElaborazione: Agenda21polesine
impa rapporto.indd 36impa rapporto.indd 36 2-04-2009 19:20:132-04-2009 19:20:13

37 ARIA02
Numero di veicoli per abitanteScopo di questo indicatore è valutare il numero di veicoli presenti per abitante nella provincia per va-
lutare eventuali variazioni e modifi che rispetto alle altre province venete.
La tabella illustra i dati relativi all’anno 2006 e contiene il numero di veicoli immatricolati per provincia distinti per tipologia. Il tasso di motorizzazione regionale è in linea con il valore nazionale che per il 2006 si è attestato a 592 veicoli ogni 1.000 abitanti. I dati provinciali sono invece quasi tutti sopra la media nazionale con la provincia di Rovigo che fa registrare il valore di 602 auto ogni 1.000 abitanti.
Rispetto all’anno precedente nella provincia di Rovigo si è registrato l’incremento maggiore del tasso di auto ogni 1.000 abitanti. Il valore è cresciuto infatti del 1,5%, contro un aumento dello 0,9% fatto registrare a livello regionale.
Il grafi co rappresenta sia il tesso di auto ogni 1.000 abitanti che la variazione rispetto all’anno prece-dente.
Autovetture Autobus Motocicli
Autocarri
trasp.
merci
Altri veicoli
Totale
complessivo
auto ogni
1000
abitanti
variazione
2005-06
Belluno 124.750 425 14.311 16.055 7.024 162.565 587 1,3%
Padova 540.029 1.410 78.542 61.875 34.678 716.534 601 1,0%
Rovigo 147.325 301 16.799 17.569 8.035 190.029 602 1,5%
Treviso 524.374 1.313 55.605 64.595 31.962 677.849 612 0,9%
Venezia 432.154 1.435 56.894 40.323 27.246 558.052 517 0,1%
Vicenza 519.779 1.173 62.786 60.429 31.107 675.274 616 1,1%
Verona 541.101 1.329 77.171 59.832 30.757 710.190 615 1,2%
Veneto 2.829.512 7.386 362.108 320.678 170.809 3.690.493 593 0,9%
Veicoli circolanti per categoria e provincia – 2006Fonte: ACI - elaborazione Agenda21Polesine
4 6 0
4 8 0
5 0 0
5 2 0
5 4 0
5 6 0
5 8 0
6 0 0
6 2 0
B e l lu n o P a d o v a R o v ig o T re v is o V e n e z ia V ic e n z a V e ro n a V e n e to
0 , 0 %
0 , 2 %
0 , 4 %
0 , 6 %
0 , 8 %
1 , 0 %
1 , 2 %
1 , 4 %
1 , 6 %
a u to o g n i 1 0 0 0 a b ita n ti v a r ia z io n e 2 0 0 5 -0 6
Veicoli cir-colanti per categoria e provincia – 2006Fonte: ACI - elaborazione Agenda21Polesine
impa rapporto.indd 37impa rapporto.indd 37 2-04-2009 19:20:142-04-2009 19:20:14

38ARIA 02
Autovetture per categoria EUROA partire dal 1991 l’Unione Europea ha emanato una serie di direttive in materia di inquinamento am-
bientale prodotto dai veicoli, che hanno obbligato le case automobilistiche ad adottare sempre maggiori accorgimenti per ridurre le emissioni inquinanti.
Sulla base di queste direttive sono state individuate diverse categorie di appartenenza per i veicoli: le cosiddette Euro 1-2-3-4-5. I veicoli rientrano, cioè, in una determinata categoria a seconda della norma-tiva europea alla quale adempiono.
• Euro 0: rientrano in questa categoria tutti i veicoli a benzina senza catalizzatore e quelli “non ecodiesel”.• Euro 1: la normativa è in vigore dal 1993 e ha obbligato a montare sui nuovi veicoli la marmitta ca-
talitica e a usare l’alimentazione a iniezione.• Euro 2: la normativa è in vigore dal 1997 e ha imposto modifi che per la riduzione delle emissioni
inquinanti anche per i diesel.• Euro 3: la normativa è in vigore dal 2001 e ha imposto l’adozione di un sistema chiamato Eobd, che
riduce ulteriormente le emissioni.• Euro 4: la normativa è in vigore dal 2006 e impone limiti ancora più severi. Attualmente, i veicoli
Euro 4 sono gli unici veicoli a cui, in genere, è consentita la circolazione nei giorni di blocco del traf-fi co. I motori diesel devono però essere dotati di fi ltro antiparticolato.
• Euro 5: la nuova normativa entrerà in vigore solo nel 2009.
I dati della provincia di Rovigo sono in linea con quelli delle altre provin-ce, anche se deve essere evidenziata una maggiore presenza di veicoli facenti parte delle categorie Euro 1 ed Euro 2 (con il 29,3% degli autoveicoli circolan-ti). Solo il 14,9% delle au-tovetture appartiene alla categoria Euro 4 o supe-riore.
i n -e e ti o
% --a -
euro 0-1 euro 2-3 euro 4 o sup totale
Belluno 30.714 24,6% 74.233 59,5% 19.803 15,9% 124.750
Padova 133.345 24,7% 311.551 57,7% 95.133 17,6% 540.029
Rovigo 43.190 29,3% 82.130 55,7% 22.005 14,9% 147.325
Treviso 135.131 25,8% 303.370 57,9% 85.873 16,4% 524.374
Venezia 101.514 23,5% 250.792 58,0% 79.848 18,5% 432.154
Verona 138.254 25,6% 306.017 56,6% 96.830 17,9% 541.101
Vicenza 139.636 26,9% 297.724 57,3% 82.419 15,9% 519.779
Veneto 721.784 25,5% 1.625.817 57,5% 481.911 17,0% 2.829.512
Autovetture distinte per classe inquinante Euro 1-5. Anno 2006
Fonte: ACI – elaborazione: Agenda21Polesine
0 % 1 0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 7 0 % 8 0 % 9 0 % 1 0 0 %
B e llu n o
P a d o v a
R o v ig o
T re v is o
V e n e z ia
V e ro n a
V ic e n z a
V e n e to
e u ro 0 -1
e u ro 2 -3
e u ro 4 o s u p
Autovetture di-stinte per classe inquinante Euro 1-5. Anno 2006Fonte: ACI – elabora-zione: Agenda21Polesine
impa rapporto.indd 38impa rapporto.indd 38 2-04-2009 19:20:152-04-2009 19:20:15

39 ARIA02
Autovetture per alimentazione
Scopo di questo indicatore è valuta-re come sia composto il parco veicola-re circolante nella provincia di Rovigo valutando il combustibile utilizzato. In questo caso i dati dell’ACI ci permetto-no di valutare il numero di veicoli e il tipo di combustibile utilizzato, dal quale derivano determinati tipi di inquinanti.
Dalla lettura dei dati relativi all’anno 2006 è evidente che nella provincia di Rovigo è molto elevato l’uso di veicoli con combustione mista benzina + GPL e benzina + Metano che occupano il 13% del totale, rispetto al valore veneto che si attesta a meno del 5,5%. I diesel hanno invece lo stesso peso interessan-do circa il 32% dei veicoli.
Il grafi co rappresenta questa tendenza ed evidenzia la percentuale di veicoli a doppia alimentazione.
Interessante notare la elevata presenza di veicoli a doppia alimentazione Benzina + metano, combina-zione che rende i veicoli a benzina molto meno inquinanti. Infatti un veicolo a metano ha, rispetto alle emissioni di CO2 (anidride carbonica) il 22% in meno rispetto alla benzina, 30% in meno rispetto al gasolio e il 12% in meno rispetto al GPL
Un altro dato fondamentale è che il benzene, sostanza dichiarata uffi cialmente cancerogena per l’uo-mo, è assente, mentre è presente nella benzina e, in minima parte, nel gasolio e nel GPL; il metano ha inoltre anche bassissime emissioni degli IPA, elevati invece nel gasolio .
--o n -l
e
Rovigo Veneto
Benzina 80.825 54,9% 1.779.046 62,9%
Benzina + GPL 8.724 5,9% 100.753 3,6%
Benzina + Metano 10.546 7,2% 46.231 1,6%
Diesel + Altro 47.230 32,1% 903.482 31,9%
Totale 147.325 100,0% 2.829.512 100,0%
Autovetture per alimentazione. Anno 2006Fonte: ACI – elaborazione: Agenda21Polesine
R o v i g o
D i s ee l
A l tr o
3 2 , 1 %
+
M e ta n o
7 , 2 %
B e n z i n a
5 4 , 9 %
B e n z i n a
B e n z i n a
+
G P L
5 , 9 %
V e n e to
l +
A l t r o
3 1 , 9 %
+
M e ta n o
1 , 6 %
B e n z i n a
6 2 , 9 %
B e n z i n a
B e n z i n a
+
G P L
3 , 6 %
+D i s ee
Autovetture per alimentazione in provincia di Rovigo. Anno 2006Fonte: ACI – elaborazione: Agenda21Polesine
Autovetture per alimentazione in Veneto. Anno 2006Fonte: ACI – elaborazione: Agenda21Polesine
impa rapporto.indd 39impa rapporto.indd 39 2-04-2009 19:20:152-04-2009 19:20:15

40ARIA 02
Numero di distributori Metano/GPL
Perché l’uso di questi combustibili possa crescere è fondamentale che sia presente una adeguata rete di distribuzione, in particolar modo di metano. Infatti uno dei vincoli che limita la distribuzione di veicoli a doppia alimentazione è la discontinua presenza nel territorio di punti di rifornimento.
I dati relativi al Veneto, ed i dati provinciali, evidenziano che in questa regione c’è una buona presen-za di distributori di GPL, presenti non solo nelle città ma anche nelle aree di servizio autostradali. Nella provincia di Rovigo il tasso di distribuzione è il più elevato attestandosi a 45 distributori ogni 1.000 veicoli alimentati a GPL. Il dato della provincia di Belluno è elevato ma legato ad un numero molto basso di veicoli a doppia alimentazione benzina + GPL (solo il 2,2% di veicoli con questa alimentazione sono nella provincia di Belluno che ha 11 distributori. Complessivamente con il 8,7% dei veicoli a GPL sono presenti il 12,8% dei distributori
Per quanto concerne i distributori di metano molto buona è la presenza di veicoli, pari infatti al 22,8% del totale dei veicoli provinciali, che però possono contare solo su 18 distributori, pari al 16% del totale.
Metano GPL
n. distrib. veicoli % di veicoli
% di
distributori n. distrib. veicoli % di veicoli
% di
distributori
Belluno 2 202 0,4% 1,8% 11 2.183 2,2% 3,6%
Padova 25 9.596 20,8% 22,5% 64 25.873 25,7% 21,0%
Rovigo 18 10.546 22,8% 16,2% 39 8.724 8,7% 12,8%
Treviso 10 4.570 9,9% 9,0% 49 17.297 17,2% 16,1%
Venezia 15 3.643 7,9% 13,5% 36 14.876 14,8% 11,8%
Vicenza 17 14.263 30,9% 15,3% 41 13.927 13,8% 13,4%
Verona 24 3.411 7,4% 21,6% 65 17.873 17,7% 21,3%
Veneto 111 46.231 100,0% 100,0% 305 100.753 100,0% 100,0%
Numero di distributori attrezzati per Metano e GPL e tasso di distributori per 1000 veicoliFonte: ACI (2008) – elaborazione: Agenda21Polesine (2008)
0 %
5 %
1 0 %
1 5 %
2 0 %
2 5 %
3 0 %
3 5 %
B e llu n o P a d o v a R o v ig o T re v is o V e n e z ia V ic e n z a V e ro n a
% d i v e ic o li % d i d is tr ib u to ri
M e ta n o
0 %
5 %
1 0 %
1 5 %
2 0 %
2 5 %
3 0 %
3 5 %
B e llu n o P a d o v a R o v ig o Tre v is o V e n e z ia V ic e n z a V e ro n a
% d i v e ic o li % d i d is tr ib u to ri
G P L
Percentuale di veicoli per alimentazione e percentuale di distributori sul totale per provinciaFonte: ACI (2008) – Elaborazione: Agenda21Polesine (2008)
impa rapporto.indd 40impa rapporto.indd 40 2-04-2009 19:20:162-04-2009 19:20:16

41 ARIA02
Sintesi
Tipo indicatore Valutazione sintetica Trend
Numero di centraline presenti R �
Superamenti del valore limite giornaliero di PM10 S �
Valore medio annuale di PM10 S �
Media annuale concentrazione benzene stazioni di
traffi co e di background
S
Medie annuali registrate nelle stazioni della provincia
di Rovigo
S
Giorni con superamenti soglia informazione oraria di
180 mg/m3
S
Età media degli autobus circolanti I �
Numero di veicoli per abitante D
Autovetture per categoria EURO R
Autovetture per alimentazione R
Numero di distributori Metano/GPL R
D Causa determinate P Indicatore di pressione S Indicatore di Stato
I Indicatore di Impatto R Indicatore di Risposta
Condizioni positive Condizioni stazionarie Condizioni negative
Trend in crescita Trend stazionario Trend in diminuzione
a
a
a
a
a
a
k
k
k
f
f
f
f
f
impa rapporto.indd 41impa rapporto.indd 41 2-04-2009 19:20:172-04-2009 19:20:17

ACQUA
impa rapporto.indd 43impa rapporto.indd 43 2-04-2009 19:20:172-04-2009 19:20:17

44ACQUA 03
Acqua Acque superfi ciali Breve quadro idrografi co della Provincia di RovigoLe acque dolci interne rappresentano uno degli elementi caratteristici del territorio polesano solcato sia
dai grandi fi umi come l’Adige, il Po e il Tartaro - Canalbianco, sia da una fi tta rete di canali di bonifi ca che costituiscono una sorta di sistema linfatico che drena ogni angolo della provincia.
Dal punto di vista dei defl ussi idrici il territorio della Provincia di Rovigo gravita in massima parte sul bacino del Canalbianco. Una fi tta rete di canali e scoli drena capillarmente il Polesine riversando le proprie acque direttamente in questo collettore per la zona posta in sinistra idrografi ca, mentre per le zone in destra idrografi ca le acque defl uiscono dapprima nel Collettore Padano Polesano e quindi, tramite esso in Canalbianco. Fra i più importanti affl uenti che interessano la Provincia di Rovigo, il Naviglio Adigetto scorre sulla sinistra del Canalbianco e rappresenta una derivazione dell’Adige originante in prossimità di Badia Polesine.
Da citare, inoltre, il Canale Ceresolo, che rappresenta un corso d’acqua artifi ciale di circa 50 Km di lun-ghezza utilizzato principalmente a fi ni irrigui.
Infi ne, sebbene in termini di drenaggio dei terreni rivestano un ruolo secondario, il Polesine e la sua storia sono indissolubilmente legati ai due grandi fi umi, l’Adige ed il Po, che ne delimitano a nord e a sud i confi ni con le province limitrofe.
Per quanto concerne la classifi cazione delle acque così come stabilito dal D.lgs 152/2006, il territorio è interessato da:
- corsi d’acqua signifi cativi, come i rami principali del fi ume Po e dall’Adige;
- corsi d’acqua di rilevante interesse ambientale o potenzialmente infl uenti sui corsi d’acqua signifi cativi come i rami secondari del fi ume Po;
- acque di transizione signifi cative, costituite dalle lagune e dalle valli presenti nell’area del Delta del Po;
- acque marine costiere signifi cative, le coste del litorale marino.
Complessivamente la provincia di Rovigo ricade all’interno di tre bacini idrografi ci: il Bacino Nazionale del fi ume Po, quello dell’Adige ed il bacino di rilievo regionale del Fissero Tartaro Canalbianco.
Suddivisione della provincia di Rovigo in base ai bacini idrografi ci in base al Dlgs. 152/2006Elaborazione: Agenda21Polesine
Ambito Nazionale - fi ume POAmbito Nazionale - fi ume AdigeAmbito Regionale - Fissero Tartaro Canalbianco
impa rapporto.indd 44impa rapporto.indd 44 2-04-2009 19:20:172-04-2009 19:20:17

45 ACQUA03
La gestione del sistema idraulicoIl governo idraulico delle reti minori, chiamate anche reti delle acque basse, compete ai Consorzi di
Bonifi ca. Nel territorio provinciale si trovano 4 Consorzi di Bonifi ca:
• il Consorzio Valli Grandi e Medio Veronese con sede a Legnago (VR), il cui comprensorio ricade nelle province di Verona, Mantova e Rovigo. In Provincia di Rovigo interessa un’area complessiva di 1489 ettari suddivisi tra i Comuni di Badia Polesine (per 823 ettari) e di Giacciano con Baruchella (666 ettari).
• il Consorzio Padana Polesana, con sede a Rovigo, interessa il territorio ubicato tra il fi ume Po a sud e il Canalbianco a nord, con una giacitura dei terreni che degrada nella direttrice ovest-est partendo da 12 metri sopra il livello del mare a Melara e arrivando a 2 metri sotto il livello del mare a Cavanella Po. Interessa 34 Comuni della Provincia di Rovigo e 3 della Provincia di Verona. Gli impianti idrovori del comprensorio sono in totale 17.
• il Consorzio Polesine Adige Canal Bianco, con sede a Rovigo, ha un comprensorio della superfi cie di 64.247 ettari, delimitato dai fi umi Adige e Gorzone a nord, dal Canalbianco a sud, dal canale Malo-pera ad ovest e dalla idrovia Po Brondolo ad est. I terreni sono caratterizzati da giaciture notevolmen-te depresse, con quote del piano di campagna degradanti da ovest verso est, da valori di circa 8 m s.m.m a valori di -3,50 m s.m.m. nelle zone bonifi cate delle ex Valli polesane dove si sono osservati notevoli costipamenti dei terreni (anche dell’ordine di 3 metri) e rilevanti effetti di subsidenza: in to-tale 30.000 ha. (47% dell’intero territorio) si trovano a quote inferiori al medio mare. Il regime delle acque è quasi esclusivamente a scolo meccanico continuo.
• il Consorzio Delta Po Adige, con sede a Taglio di Po, occupa una superfi cie di 62.780 ettari, dei quali 60.318 ettari in Provincia di Rovigo (in particolare i 7 comuni di Ariano Polesine, Corbola, parte del Comune di Loreo, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po, e 2.462 ettari in Provincia di Venezia). Sotto l’aspetto altimetrico, il comprensorio consorziale soggiace quasi interamente al medio mare di due, tre metri, con punte, in alcune zone, di quattro metri. Particolare caratteristica del territorio é l’elemento naturalistico costituito dalle valli da pesca, le pinete e tutto l’ambiente naturale delle foci dei fi umi, e in particolare ai lembi estremi del Delta del Po, occupati da lagune, sacche, buse, bonelli, scanni. La vicinanza al mare ha comportato notevoli diffi coltà di derivazione di acqua irrigua a causa della elevata quantità di sale presente nell’acqua.
Suddivisione del territorio polesano in base ai Consorzi di pertinenzaElaborazione: Agenda21Polesine
IdrovoreConsorzio Delta po AdigeConsorzio Padana PolesanaConsorzio Polesine Adige CanalbiancoConsorzio Valli Veronesi
impa rapporto.indd 45impa rapporto.indd 45 2-04-2009 19:20:172-04-2009 19:20:17

46ACQUA 03
Come si vede dalla cartografi a successiva, il sistema delle acque della provincia di Rovigo è molto ar-ticolato e complesso. In particolare, la conformazione del terreno, pianeggiante, e la presenza di grandi fi umi quali l’Adige a nord e il Po a Sud, comportano vasti ambiti soggetti a rischio idraulico. Sono infatti presenti ambiti all’interno dei quali il defl usso delle acque è considerato diffi coltoso, sono quindi ne-cessari impianti di sollevamento (evidenziati nella cartografi a) per permettere il defl usso delle acque, che utilizza principalmente il Canalbianco ed il sistema idroviario del Fissero-Tartaro-Canalbianco per il defl usso delle acque. Nell’area del Basso Polesine, la presenza delle idrovore è essenziale per garantire la sicurezza del territorio.
Il sistema di defl usso delle acque sotterranee segue anch’esso la direzione ovest-est come evidenziato nella cartografi a che segue dove sono riportate anche le isofreatiche.
Aree con defl usso diffi coltoso e aree soggette a inondazione periodiche nella provincia di Rovigo.Fonte: Regione Veneto, Provincia di Rovigo e consorzi di Bonifi ca
IdrovorePozziAree con defl usso diffi coltosoAree soggette a inondazioni periodiche
Direzione di defl usso Isofreatiche
-4,0- -2,0-1,9-0,50,6-3,53,6-6,56,6-9,0
Principali corsi d’acquaCorsi d’acqua secondariLagunaValli da pesca
Acque sotterranee, direzione del defl usso delle acque e isofreaticheFonte: Regione Veneto, Provincia di Rovigo e consorzi di Bonifi ca
Principali corsi d’acquaCorsi d’acqua secondariValli da pescaLaguna
impa rapporto.indd 46impa rapporto.indd 46 2-04-2009 19:20:182-04-2009 19:20:18

47 ACQUA03
Qualità della acque superfi ciali - Acque interne Con l’entrata in vigore del nuovo TU 152/2006 sono state introdotte sostanziali innovazioni in tema
di monitoraggio e classifi cazione delle acque superfi ciali. Il nuovo decreto ha ripreso sostanzialmente le indicazioni e le strategie individuate dal precedente (D.Lgs. 152/99, ora abrogato), riscrivendo però la sezione relativa alla classifi cazione dei corpi idrici e gli obiettivi di qualità ambientale.
Nel 152/2006, pur restando in vigore l’obbligo di attuare il monitoraggio chimico-fi sico e chimico, assume notevole importanza il monitoraggio di alcuni indicatori biologici che non erano considerati nel decreto del 1999. Si tratta per esempio del fi toplancton, di macrofi te e fi tobentos e della fauna ittica, oltre ai macroinvertebrati bentonici per altro già previsti dal decreto 152/1999. Tuttavia a livello nazionale (se si esclude l’IBE), non vi sono attualmente criteri e procedure defi nitive per la classifi cazione in base a tali indicatori biologici.
La defi nizione di qualità ambientale richiede poi, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, una caratteriz-zazione iniziale basata sul concetto di “ecoregione”, di tipizzazione e di individuazione dei corpi idrici di riferimento, analisi complessa ed attualmente in fase di completamento da parte dell’ARPA Veneto.
Attualmente, la classifi cazione delle acque superfi ciali attinge sia dalla nuova che dalla vecchia nor-mativa, laddove quest’ultima non fornisca elementi o criteri suffi cienti per giungere ad una valutazione della qualità delle acque.
Per la stesura del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Rovigo sono state utilizzate le informazioni fornite dal Dipartimento Provinciale dell’ARPAV di Rovigo, quelle ottenute dal “Piano di Monitoraggio 2000” ed i dati che sono stati elaborati da ARPA Veneto e che hanno indagato lo stato di salute delle acque nella regione.
impa rapporto.indd 47impa rapporto.indd 47 2-04-2009 19:20:182-04-2009 19:20:18

48ACQUA 03
Indice Biotico Esteso - IBELa comunità biologica più usata come indicatore è quella dei macroinvertebrati bentonici (larve d’in-
setti, molluschi, crostacei ecc.), che sono comunemente ritenuti i più adatti a rappresentare, con buona sensibilità, le variazioni indotte dall’inquinamento in un corso d’acqua. Quando si presentano fenomeni d’inquinamento, infatti, tali comunità reagiscono con una riduzione del numero totale di taxa, ma anche attraverso la comparsa di specie più tolleranti e la scomparsa di quelle più sensibili.
Il giudizio fi nale viene espresso, sulla base dell’interpolazione del numero di taxa di macroinvertebrati rinvenuti con la presenza/assenza di taxa a diverso grado di sensibi-lità, mediante dei valori numerici convenzionali (Indici Biotici) che sono direttamente traducibili in 5 classi di qualità.
Nella tabella sono sintetizzati i valori per i corsi d’acqua principa-li che attraversano il territorio dei comuni della provincia. In molti casi il risultato sintetico indica un ambiente inquinato o molto inqui-nato con valori di IBE che variano da 5/6 a 4/5. La cartografi a, che illustra la situazione al 2003, evi-denzia questo complessivo stato non positivo.
-ci e 5
i -
ei ti n -o e -o
classe di qualità Valore I.B.E. Giudizio di qualità
I 10-11-12 Ambiente non inquinato
II 8-9 Ambiente leggermente inquinato
II-III 7/8 Condizioni di passaggio fra le classi indicate
III 6-7 Ambiente inquinato
III-IV 5/6 Condizioni di passaggio fra le classi indicate
IV 4-5 Ambiente molto inquinato
V 1-2-3 Ambiente fortemente inquinato
Criteri di conversione dei valori di IBE in classe di qualità
Cod i ce
Stazione
Nome Corso
d’acquaComune
2003 2005
IBE classe IBE classe
205 Adige Rovigo 5 IV 4 IV
210 Canalbianco Bosaro 5 IV 4 IV
193 Po Castelnovo B. - - 4/5 IV
229 Po Villanova M. 5 IV 4/5 IV
Indice Biotico Esteso per alcune stazioni nella provincia di RovigoFonte: Provincia di Rovigo, Area Ambiente
Indice Biotico Esteso per alcune stazioni nella provincia di RovigoFonte: Provincia di Rovigo, Area Ambiente
Stazioni di rilevamentoIBE anno2003
Classe IIIClasse IVClasse V
impa rapporto.indd 48impa rapporto.indd 48 2-04-2009 19:20:182-04-2009 19:20:18

49 ACQUA03
Concentrazione di nitrati nei corsi d’acqua Grazie al lavoro svolto da ARPA Veneto ed aggiornato continuamente con nuovi rilevamenti è possibile
valutare, confrontando fra loro i diversi corsi, la concentrazione di nitrati che rappresentano l’ultimo stadio di ossidazione dei composti azotati provenienti dai processi di decomposizione biologica delle sostanze organiche, e quindi in buona parte dalle attività agricole e dalle attività zootecniche.
La concentrazione dei nitrati è un parametro importante ai fi ni della tutela dei corpi idrici, poiché rap-presenta uno degli inquinamenti più diffusi nel territorio derivando dal comparto agro-zootecnico che ri-sulta essere la fonte prevalente (i nitrati vengono, infatti, utilizzati in grandi quantità sui terreni agricoli in forma di fertilizzanti organici e/o inorganici); vi è anche il contributo dato dall’ossidazione degli scarichi di refl ui civili, da taluni scarichi industriali e dal dilavamento di superfi ci impermeabili urbane. Il contributo atmosferico è invece considerato di secondaria importanza.
Per quanto riguarda i dati rilevati sul territorio veneto, ARPA Veneto rappresenta la concentrazione di nitrati per bacino, espressa come 75° percentile, nel periodo 2002-2007; dove sono evidenziati con aree di diverso colore anche i livelli soglia ricavati dai Macrodescrittori utilizzati per la classifi cazione.
I bacini idrografi ci maggiormente interessati da questo parametro sono i bacini del Fratta-Gorzone e del Sile; in misura minore quelli del Bacchiglione, del Canal Bianco e del bacino scolante nella Laguna di Venezia. Nel complesso la situazione risulta soddisfacente poiché mediamente si attesta al di sotto della soglia di 22,1 mg/l con l’esclusione del bacino del Fratta-Gorzone; per l’asta del fi ume Togna-Fratta-Gor-zone tuttavia il Piano di Tutela delle Acque prevede al 2016 obiettivi meno rigorosi, con il mantenimento dell’obiettivo di qualità Suffi ciente anziché il raggiungimento dello stato di Buono.
Il trend della risorsa è stabile: nei vari bacini idrografi ci i risultati nel periodo 2002-2007 si attestano su livelli costanti (l’unica eccezione è rappresentata dal bacino “Pianura tra Livenza e Piave”, per il quale nel 2006 sono disponibili dati relativi ad una sola stazione di monitoraggio e che quindi nel complesso risulta più sensibile a variazioni anche minime dei dati rilevati).
Concentrazione di nitrati nei corsi d’acquaFonte: ARPA Veneto
Adige Bacchiglione Brenta Lemene Livenza Piave Po Sile TagliamentoPian.tra
Livenza e
Canal
Bianco
Fratta-
Gorzone
Bacino
Scolante - I.
2002 2003 2004 2005 2006 2007Nitrati (75° percentile) andamenti 2002-2007
35
30
25
20
15
10
5
0
mg/
l N03
impa rapporto.indd 49impa rapporto.indd 49 2-04-2009 19:20:192-04-2009 19:20:19

50ACQUA 03
Stato ambientale dei corsi d’acqua (SACA)Secondo il decreto 152/99, la classifi cazione dello Stato Ecologico dei Corsi di Acqua (SECA), espressa
in classi da 1 al 5, viene effettuata incrociando il dato risultante dai 7 parametri macrodescrittori (azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale, percentuale di saturazione dell’ossigeno, BOD5, COD ed Esche-richia coli) con il risultato dell’I.B.E., attribuendo alla sezione in esame o al tratto da essa rappresentato il risultato peggiore tra quelli derivati dalle valutazioni di I.B.E. e macrodescrittori.
Lo Stato Ambientale dei Corsi di Acqua (SACA) è stato calcolato nel periodo 2000 – 2006 confrontando i dati relativi allo stato ecologico con i dati relativi alle concentrazioni dei principali microinquinanti chimici (parametri analizzati) indicati in tabella 1 del D.Lgs. 152/99.
I bacini del Veneto meridionale, fra cui il Canalbianco e il tratto fi nale dell’Adige, sono più compromessi, risultando in stato Suffi ciente o Scadente. La situazione più critica si rileva nel bacino del Fratta-Gorzone, dove lo stato Scadente è determinato prevalentemente a causa del superamento del valore soglia per il parametro addizionale Cromo (20 μg/l per il D.Lgs. 152/99, e 50 μg/l per il D.Lgs. 152/06). Altri casi di stato Scadente si rilevano in alcune stazioni del Bacino Scolante in Laguna di Venezia e nei tratti terminali dei grandi fi umi, e sono dovute non ai parametri chimici, ma ai valori di IBE. Anche nelle stazioni che pre-sentano occasionalmente lo stato Pessimo l’attribuzione della classe di qualità è determinata dai valori di IBE, che denunciano una situazione di sofferenza della comunità biologica che non riesce a svilupparsi pienamente. In generale, prevalgono gli stati Buono, Suffi ciente e Scadente, nell’ordine, per cui si può affermare che la situazione nella Regione sia mediamente suffi ciente. Il Canal Bianco per il 2006 ha fatto registrare tutte le stazioni scadenti.
Stato ambientale dei corsi d’acqua (SACA)Fonte: ARPA Veneto
Adi
ge
N. s
tazi
oni
14
12
10
8
6
4
2
0
elevato buono suffi ciente scadente pessimo
Bacc
higl
ione
Bren
ta
Cana
l Bia
nco
Frat
ta-G
orzo
ne
Gar
da -
Po
Lagu
na d
i Ven
ezia
Lem
ene
Live
nza
Piav
e
Sile
Live
nza
e Pi
ave
Tagl
iam
ento
impa rapporto.indd 50impa rapporto.indd 50 2-04-2009 19:20:192-04-2009 19:20:19

51 ACQUA03
Acque di balneazione Indice trofi co lungo la costa del Delta del PoQuando i fenomeni di eutrofi zzazione si sono manifestati agli inizi degli anni ottanta, con maggiore
frequenza ed intensità anche nelle acque costiere, è stato necessario quantifi care in maniera oggettiva i livelli trofi ci e le loro manifestazioni e scegliere opportuni indici adatti alle acque marine. Nelle acque costiere non è mai stato posto in discussione il processo di eutrofi zzazione, ma il metodo da utilizzare per quantifi care le sue manifestazioni.
L’indice di stato trofi co (TRIX) è individuato dall’ex D.Lgs. 152/99 e s.m.i. per defi nire lo stato di qualità delle acque marino costiere. L’introduzione dell’indice e della relativa scala trofi ca consente di ottenere un sistema di sintesi dei parametri trofi ci fondamentali in un insieme di semplici valori numerici che ren-da le informazioni comparabili su un largo range di condizioni trofi che come queste si presentano lungo tutto il Mediterraneo e nello stesso tempo evitino l’uso soggettivo di denominatori trofi ci. Si è voluto quindi sviluppare una scala numerica di indice trofi co che dovrebbe quantifi care le caratteristiche quali-tative dei livelli di trofi a delle acque in ogni stazione di prelievo.
I parametri principali che concorrono alla defi nizione di un indice trofi co devono:• essere rappresentativi in termini sia di produzione di biomassa fi toplanctonica sia di dinamica della
produzione stessa;• prendere in considerazione i principali fattori
causali ed esprimere la massima variabilità del sistema;
• essere basati su misure e parametri rilevati nella maggior parte delle indagini marine.
Per trovare questi parametri è stato studiato il data set della Regione Emilia-Romagna riferito a diversi programmi di ricerca eseguiti dal 1982 al 1993. Dopo questo studio si è optato sul se-guente set di parametri, divisi in tre categorie:
• Fattori che sono espressione diretta di produttività• clorofi lla “a” mg/m3
• percentuale di ossigeno disciolto• Fattori nutrizionali
• totali:
° fosforo totale
° azoto totale• disponibili:
° DIN azoto minerale disciolto
° DIP fosforo totale disciolto
Numericamente il valore TRIX può variare da 0 a 10, andando dalla oligotrofi a (0; acque scar-samente produttive tipiche del mare aperto) alla ipereutrofi a (10; acque fortemente produtti-ve tipiche di aree costiere eutrofi zzate). Tuttavia quasi nella totalità dei casi i valori TRIX variano da 2 a 8.
ri à
ti
l o 2 -
i
scala trofi ca stato condizioni
2-4 elevatoAcque scarsamente produttive. Livello di trofi a basso. Buona trasparenza. Assenza di anomale colorazione.
4-5 bassoAcque moderatamente produttive. Livello di trofi a medio. Buona trasparenza. Occasionali intorbidimenti
5-6 mediocre
Acque molto produttive. Livello di trofi a elevato. Scarsa trasparenza. Anomale colorazioni. Ipossie e occasionali anossie sul fondo. Stati di sofferenza sul fondo.
6-8 scadente
Acque fortemente produttive. Livello di trofi a molto elevato. Elevata torbidità. Diffuse e persistenti colora-zioni e ipossie/anossie sul fondo. Morie di organismi bentonici. Danni economici.
Scala trofi ca relativa all’indice TRIX
a -)-a o
Comune
Localitàdistanza da costa
(m)
2004 2005 2006 2007
Chioggia - (VE) Isola Verde
500 5,56 5,48 5,51 5,53
926 5,48 5,46 5,58 5,23
3704 5,15 4,95 4,66 4,62
Media 5,40 5,30 5,25 5,12
Rosolina - (RO) Rosolina mare - Punta Caleri
500 5,38 5,18 5,00 5,27
926 5,43 5,35 5,29 5,29
3704 5,60 5,02 5,08 4,90
Media 5,47 5,18 5,12 5,15
Porto Tolle - (RO) Po di Pila
500 5,99 5,72 5,72 5,36
926 6,06 5,59 5,08 5,38
3704 5,75 5,21 4,72 4,69
Media 5,93 5,51 5,17 5,14
Valori medi annui dell’indice di stato trofi co (TRIX) dal 2003 al 2007 per ciascuna stazione e lungo l’intero transetto.Fonte: ARPA Vento
impa rapporto.indd 51impa rapporto.indd 51 2-04-2009 19:20:202-04-2009 19:20:20

52ACQUA 03
Dal 2002 al 2007 si osserva nettamente un’evoluzione positiva delle percentuali di campioni attribu-iti, con il calcolo del TRIX, alle quattro classi di qualità, con un aumento delle percentuali di campioni compresi nelle classi elevato e buono (valori di TRIX inferiori a 5), che raggiunge oltre il 70% dei casi. La graduale riduzione dei valori di indice trofi co è conseguente essenzialmente a un calo dei carichi di azoto e fosforo che arrivano in mare trasportati dai fi umi; si ricorda, inoltre, che nel periodo considerato non si sono mai verifi cate situazioni di eutrofi zzazione, ma solo in sporadiche occasioni si è assistito, in aree prossime alle foci, a eventi limitati di fi oriture algali di breve durata, prive di conseguenze per il biota presente.
Le distribuzioni spaziali dei valori medi annui (rappresentate nella cartografi a sottostante) di TRIX nel 2007 dimostrano come lo stato trofi co nelle aree costiere del Veneto sia mediamente più che soddisfa-cente. Infatti, lo stato è prevalentemente buono a nord, in alcuni punti addirittura elevato, mentre spo-standosi progressivamente verso sud prevale, seppure di poco, lo stato mediocre anche se non mancano punti con stato buono.
Qualità delle acque marino-costiere nel 2007 espressa con i valori di TRIX.Fonte: ARPA Veneto
impa rapporto.indd 52impa rapporto.indd 52 2-04-2009 19:20:202-04-2009 19:20:20

53 ACQUA03
Sistema di monitoraggio delle acque di balneazione Nella provincia di Rovigo le acque destinate alla balneazio-
ne sono quelle del mare Adriatico e dello specchio nautico di Albarella. Su ogni punto di controllo si eseguono rilevazioni chimico-fi siche, ispezioni di natura visiva/olfattiva (PH, colora-zione, trasparenza, oli minerali, sostanze tensioattive, fenoli e ossigeno disciolto) e prelievi di campioni di acqua per l’analisi microbiologica (coliformi, streptococchi, enterovirus)
Le stazioni di campionamento sono complessivamente 18 così ripartite per comune: 10 a Rosolina (di cui 1 nello spec-chio interno di Albarella), 2 a Porto Viro e 6 a Porto Tolle (3 a Boccasette e 3 stazioni a Barricata).
Vengono di seguito riportate le stazioni di prelievo divise per comuni di appartenenza.
-i i -e si
8 -a
r
Denominazione Cod. Litorale
Rosolina
300 metri sud depura-
tore comunale
67
Rosolina Mare
600 metri nord torre
piezometrica
68
torre piezometrica 69
piazza s. Giorgio 70
750 metri sud cam-
peggio vittoria
504
punta Caleri 71
Isola di Albarella - nord
Albarella
72
Isola di Albarella Isola di Albarella - cen-
tro Albarella
76
Isola di Albarella - foce
Po di levante
525
Porto Viro
Scanno Cavallari - nord 77Scanno Cavallari
Scanno Cavallari - sud 78
Porto Tolle
Boccasette - nord 79
BoccasetteBoccasette - centro 73
Boccasette - sud 80
Barricata - nord 81
BarricataBarricata - centro 74
Barricata - sud 82
Denominazione Cod. Specchio
Rosolina
Isola di Albarella -
Mare Vostrum
527 M. Vostrum
Stazioni di monitoraggio delle acque
di balneazione
Fonte: ARPA Veneto
Stazioni di monitoraggio delle acque di balneazioneFonte: ARPA Veneto – Elaborazione: Agenda21Polesine
impa rapporto.indd 53impa rapporto.indd 53 2-04-2009 19:20:202-04-2009 19:20:20

54ACQUA 03
Idoneità alla balneazione: percentuale di campioni favorevoliLa tabella seguente, che riporta la percentuale dei campioni rilevati e favorevoli suddivisi per i comuni
balneari della provincia e per lo specchio nautico di Albarella.
Un indicatore della qualità delle acque di balneazione è dato dalla percentuale dei punti idonei alla balneazione sul totale dei punti monitorati. Dall’analisi dei risultati si evince che le acque costiere del litorale rodigino hanno presentato condizioni di qualità buona per la balneazione (mediamente 91,8% di punti idonei tra il 2003 ed il 2007) con variazioni percentuali di punti idonei solo nel comune di Porto Viro nel corso del 2003 e del 2006 ed in alcune stazioni del comune di Porto Tolle.
Le acque dello spaccio d’acqua di Albarella hanno invece sempre mantenuto il 100% di punti idonei.
Rispetto al valore regionale i dati campionati indi-cano un andamento del tutto simile, con variazioni in positivo della qualità delle acque tra il 2006 ed il 2007
il
% punti idonei
Comuni 2003 2004 2005 2006 2007
Mare Adriatico
Rosolina 100 100 100 100 100
Porto Viro 50 100 100 50 100
Porto Tolle 100 83 100 100 83
Specchio nautico di Albarella
Rosolina 100 100 100 100 100
Percentuale di campioni idonei alla balneazioneFonte: ARPA Veneto
0
2 5
5 0
7 5
1 0 0
R o s o lin a Po r to V iro Po rto T o l le R o s o lin a2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
Raffronto percentuali di campioni favorevoli per comune – anni 2003-2007.Fonte: ARPA Veneto
impa rapporto.indd 54impa rapporto.indd 54 2-04-2009 19:20:212-04-2009 19:20:21

55 ACQUA03
Qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi Nel periodo 2002-2007 ARPAV ha realizzato specifi ci programmi di monitoraggio delle acque destinate
alla vita dei molluschi, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa di settore (D.Lgs. 152/99 e s.m.i. come sostituito dal D.Lgs. 152/06) al fi ne di verifi carne l’idoneità per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura. Attivi-tà di questo tipo sono presenti in tutto il Delta del Po nel quale sono presenti 16 punti di controllo (erano 13 prima del 2006).
I dati ottenuti dai monitoraggi, elaborati se-condo i criteri di legge, hanno portato alla classifi cazione annuale delle acque dei suddetti corpi idrici. Il giudizio di sintesi fi nale è riportato in tabella e nel grafi co sono riportati i valori complessivi delle stazioni conformi e non conformi.
Risulta che rispetto all’anno 2002 la qualità complessiva è andata generalmente migliorando passando da nessun sito conforme a 3 siti conformi su 5. Nello stato attuale si può affermare che a livello regionale la risorsa in questione presenta condizioni intermedie di qualità tra la totale conformità delle acque del mare Adriatico (riportate nel rapporto ARPA Veneto) e la totale non conformità delle acque delle lagune di Caorle e di Caleri/Marinetta.
La non conformità delle acque è risultata essere determinata, prevalentemente, dal superamento del valore limite di legge previsto per il parametro coliformi fecali (molluschi).
9 e a -
el o
-
Dal 2002 al 2005 Dal 2006 al 2007
laguna di Caleri/Marinetta 3 punti 3 punti
laguna la Vallona 2 punti 2 punti
laguna di Barbamarco 2 punti 2 punti
sacca del Canarin 2 punti 4 punti
sacca degli Scardovari 4 punti 5 punti
Punti di campionamento della Provincia di RovigoFonte: ARPA Veneto
Qualità delle acque
Ambiti analizzati 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Laguna di Caleri/Ma-rinetta
Non conforme Non conforme Non conforme Non conforme Non conforme Non conforme
Laguna la Vallona Non conforme Conforme Non conforme Non conforme Non conforme Non conforme
Laguna di Barbamarco Non conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme
Sacca del Canarin Non conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme
Sacca degli Scardovari Non conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme
Qualità delle acque destinate alla vita dei molluschiFonte: ARPA Veneto
Qualità delle acque destinate alla vita dei molluschiFonte: ARPA Veneto
Num
ero
0
1
2
3
4
5
2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
No n c o n fo r m e C o n fo rm e
impa rapporto.indd 55impa rapporto.indd 55 2-04-2009 19:20:212-04-2009 19:20:21

56ACQUA 03
Acque potabiliIn Provincia di Rovigo, l’approvvigionamento di acqua a scopo idropotabile è garantito dalla società
Polesine Acque S.p.A. Prima di essere immesse nella rete acquedottistica, le acque destinate ad uso potabile subiscono una serie di trattamenti atti a garantire un livello di qualità che rispetti i requisiti sanitari stabiliti per legge. Gli impianti in funzione attualmente sono 4 (Boara Polesine, Badia Polesine, Occhiobello, Castelnovo Bariano), dotati di sistemi di potabilizzazione più o meno sofi sticati a seconda delle fonti di prelievo idrico: le acque di falda sono sottoposte a trattamenti meno spinti rispetto a quelle superfi ciali, in quanto le fasi iniziali (chiarifl occulazione e decantazione) non sono svolte tecnologicamen-te, ma naturalmente dal terreno.
La Polesine Acque serve tutti i comuni della Provincia di Rovigo (50) e i comuni di Cavarzere (Ve) e Castagnaro (Vr). Per il comune di Adria interviene invece una diversa società.
Per le redazione del Rapporto sullo stato dell’ambiente sono stati utilizzati i dati forniti dalla società Polesine Acque che si riferiscono agli anni fi no al 2007 compreso.
Consumi idrici per uso in alto, medio e basso PolesineCome si osserva nel grafi co seguente, il consumo più rilevante di acqua è attribuibile all’uso domestico
(76,3%). Segue il consumo dovuto ad altri usi legati comunque ad attività economiche (20,5%), mentre solo il 2,6% è legato ad atti-vità zootecniche-rurali.
Fra i consumi domestici sono inclusi anche i volumi ceduti a sub distributori, pre-senti ad Adria e Cavarzere. Nel grafi co e nella tabella i dati relativi ai sub distributori rientrano nella voce Altro *.
cii-
e.i
ri
Domestici Altri usi Zootec. Altro * Totale
Alto Polesineutenti 24.947 3.599 62 2 28.610
m3 3.488.099 903.143 103.643 60.079 4.554.964
Medio Polesineutenti 38.432 6.412 132 3 44.979
m3 5.495.928 2.024.852 170.710 80.556 7.772.046
Basso Polesineutenti 22.281 4.076 128 15 26.500
m3 2.878.617 1.183.050 245.417 2.500.041 6.807.125
Altri comuni serviti
utenti 5.978 1.239 35 8 7.260
m3 182.944 61.410 649 1.021.921 1.266.924
Totale utenti 91.638 15.326 357 28 107.349
m3 12.045.588 4.172.455 520.419 3.662.597 20.401.059
* Sub distributori, acqua non Potabile, lavaggio verdure, altro
Consumo di acqua per tipo di utenza suddivisa in Alto, medio e basso PolesineFonte: Polesine Acque S.p.A. – Elaborazione : Agenda21Polesine
Consumo di acqua per tipo di utenza suddivisa in alto, medio e basso PolesineFonte: Polesine Acque S.p.A. – Elaborazione : Agenda21Polesine
7 6 , 6 %
4 2 , 3 %
1 9 , 8 %
2 6 , 1 %
1 7 , 4 %
2 , 3 % 2 , 2 % 3 , 6 %1 , 3 % 1 , 0 %
3 6 , 7 %
7 0 , 7 %
0 %
2 0 %
4 0 %
6 0 %
8 0 %
Alto Po le s in e M e d io Po le s in e Ba s s o P o le s in e
Do m e s tic i Al tr i u s i Z o o te c n ic o Al tro *
impa rapporto.indd 56impa rapporto.indd 56 2-04-2009 19:20:222-04-2009 19:20:22

57 ACQUA03
Consumo idrico totale della provinciaI dati messi a disposizione permettono inoltre una valutazione del trend che il consumo idrico ha fatto
registrare dal 2005 al 2007. Nella tabella sono riportati sia i dati relativi agli utenti allacciati alla rete, sia i valori relativi al volume di acqua fatturato da Polesine Acque Spa.
Analizzando i dati re-lativi ai consumi idrici (si prende in considerazione il valore relativo alla sola acqua fatturata) si vede come sia cresciuto pas-sando da 58% al 59% (non viene considerato il dato relativo all’acqua ceduta a sub distributori (Adria e Cavarzere) che rientra invece nella voce altro. Aumentano anche i consumi relativi ad altri usi mentre costante è il consumo per attività zootecniche.
-sieae-
%oariee
2005 2006 2007
descrizione utenti m3 utenti m3 utenti m3
Domestici 84.363 11.443.268 84.651 12.006.637 91.638 12.045.588
Altri usi 12.796 3.748.073 13.073 4.104.338 15.326 4.172.455
Zootecnico 320 486.667 319 524.249 357 520.419
Altro* 23 4.056.117 24 4.123.224 28 3.662.597
Totale utenti 97.502 98.067 107.349
Tot. acqua fatt. 19.734.125 20.758.448 20.401.059
* Subdistributori, Acqua Non Potabile, Lavaggio Verdure, ecc.
Numero utenti e acqua complessivamente fatturata 2005-2007Fonte: Polesine Acque S.p.A. – Elaborazione : La.TerrA.
Consumi idrici totali per tipo di utilizzazione - 2008.Fonte: Polesine Acque SpA
Andamento dell’acqua fatturata e del numero di utenze allacciate 2005 - 2007.Fonte: Polesine Acque SpA
tota
le u
tent
i - n
.
acqu
a fa
ttur
ata
- m
c.
5 8 , 0 %
1 9 , 0 %
2 , 5 %
2 0 , 6 %
5 9 , 0 %
2 0 , 5 %
2 , 6 %
1 7 , 6 %
0 , 0 %
1 0 , 0 %
2 0 , 0 %
3 0 , 0 %
4 0 , 0 %
5 0 , 0 %
6 0 , 0 %
7 0 , 0 %
Do m e st ic i A ltr i u s i Z o o te c n ic o A ltr o *
2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
8 0 . 0 0 0
9 0 . 0 0 0
1 0 0 . 0 0 0
1 1 0 . 0 0 0
1 2 0 . 0 0 0
2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 71 9 . 0 0 0 . 0 0 0
1 9 . 5 0 0 . 0 0 0
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0
2 0 . 5 0 0 . 0 0 0
2 1 . 0 0 0 . 0 0 0
A c q u a fa ttu ra ta T o ta le U te n ti A lla c c ia ti A c q u a
impa rapporto.indd 57impa rapporto.indd 57 2-04-2009 19:20:222-04-2009 19:20:22

58ACQUA 03
Perdite della rete idrica Uno degli indicatori che meglio defi niscono l’effi cienza della rete acquedottistica è la percentuale di
acqua persa dal sistema, valutata come differenza tra la quantità d’acqua prelevata alla fonte e quella fatturata agli utenti, espressa come percentuale della quantità prelevata alla fonte.
L’effi cienza della rete di distribuzione di acqua potabile è tanto più elevata quanto più sono contenute le perdite, in termini percentuali, che si verifi cano dal momento del prelievo alla fonte e dell’immissione in rete, al momento in cui questa preziosissima risorsa raggiunge l’utente fi nale.
Alcune perdite nelle reti di adduzione e in quelle di distribuzione sono da considerarsi tecnicamente accettabili (nella misura non superiore al 20%) anche se, in ogni caso, deve essere perseguita la loro minimizzazione (DPCM 04/03/1996).
Nella tabella è inol-tre riportato il rendi-mento del trattamen-to di potabilizzazione, pari al rapporto tra la quantità di acqua trattata e la quantità di acqua immessa nel sistema di trattamen-to. Il valore è decisa-mente alto, attestan-dosi al di sopra del 90%.
Per quanto concer-ne invece le perdite totali della distribuzione vediamo che il valore è cresciuto dal 2004 al 2007 arrivando al 34,9%. Nelle perdite sono conteggiati i volumi persi per disservizi (accidentali - ad esempio per rotture - per scarico da troppo pieno, etc.), i volumi sottratti (costituito da acqua derivata senza autorizzazione) ed i volumi perduti nella distribuzione (perdite dai serbatoi, dalle condotte, etc.).
---
e, a a à el ---
el
-e
2004 2005 2006 2007
Popolazione residente servita dalla rete di distribuzione
237.837 223.036 225.554 245.109
Popolazione fl uttuante presente nel periodo di osservazione (periodo estivo)
30.000 30.000 30.000 30.000
Volume in ingresso alla distribuzione
espresso in m3 34.405.340 34.419.742 33.148.124 33.948.934
Rendimento al trattamento * 92,40% 92,90% 92,90% 92,80%
Indice delle perdite totali in distribuzione ** 28,80% 35,50% 33,40% 34,90%
* percentuale di acqua che esce depurata dal trattamento di potabilizzazione per essere immessa all’ utilizzazione
** le perdite di rete sono pari al il Volume perso (perso per disservizi accidentali come per rotture, più il volume sottratto ed il volume perso nella distribuzione) / Volume in ingresso alla distribuzione
Indicatori di rendimento del sistema acquedotti stico che serve la provincia.Fonte: Polesine Acque SpA
Indice delle perdite totali in distribuzioneFonte: Polesine Acque SpA – Elaborazione: Agenda21Polesine
0 %
1 0 %
2 0 %
3 0 %
4 0 %
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
I n d ic e d e lle p e rd ite to ta li in d is tr ib u z io n e * * p e rd ite te c n ic a m e n te a c c e tta b ili
impa rapporto.indd 58impa rapporto.indd 58 2-04-2009 19:20:232-04-2009 19:20:23

59 ACQUA03
Consumo pro capite/giorno di acqua rispetto al dato ItalianoLa disponibilità di acqua potabile attualmente non rappresenta nel bacino della provincia di Rovigo
un problema molto grave. A livello internazionale invece è questa una delle principali emergenze, e la situazione non sta migliorando e rischia di degenerare fi no all’insostenibilità. Tuttavia iniziano ad essere necessari interventi volti a migliorare l’uso razionale di questa risorsa esauribile.
Con i dati a disposizione è stato calcolato il consumo per ambito (alto, medio e basso Polesine) ed il consumo giornaliero per abitante, espresso in litri. Il dato è relativo a tutte le tipologie di utenze (produt-tive e civili), pertanto non è possibile la verifi ca dell’effettivo consumo domestico, che rappresenta l’uso principale rispetto alle altre tipologie.
Rispetto alla media italiana, che si attesta sul valore pari a 250 l/abitante/giorno (nel 2005) per utiliz-zo domestico, i risultati evidenziano che complessivamente i consumi dei tre ambiti risultano inferiori. Il bacino che ha un consumo maggiore è il basso Polesine, consumo che risente probabilmente del carico turistico estivo e di alcune attività economiche-agricole. Rispetto al valore di riferimento europeo (pari a 180 l/ab/gg) solo l’alto Polesine registra un consumo pro capite inferiore.
Litri abitante giorno mc
Alto 152,4 4,6
Medio 237,8 7,7
Basso 249,3 6,8
Provincia 212,9 19,1
Consumo pro capite al giorno di acquaFonte: Polesine Acque S.p.A. – Elaborazione: Agenda21Polesine
Consumo pro capite al giorno di acquaFonte: Polesine Acque S.p.A. – Elaborazione: Agenda21Polesine
0
1
2
3
4
5
6
7
8
A lto M e d io B a s s o0
4 0
8 0
1 2 0
1 6 0
2 0 0
2 4 0
2 8 0
3 2 0
m c Litr i a b ita n te g io rn o
litri
/ abi
tant
e / g
iorn
o
met
ri cu
bi
impa rapporto.indd 59impa rapporto.indd 59 2-04-2009 19:20:242-04-2009 19:20:24

60ACQUA 03
Qualità dell’acqua erogata per uso potabilePolesine Servizi esegue periodicamente il controllo della qualità dell’acqua distribuita ai cittadini se-
condo quanto stabilito dalla normativa vigente (il D.Lgs 31/2001 che ha recepito la direttiva CEE n. 98/83/CE).
La potabilità dell’acqua è inoltre assicurata dai controlli dell’Azienda ULSS competente per territorio. L’eventuale superamento dei limiti di legge, anche di un solo parametro, comporta l’adozione di misure cautelative per l’utilizzo dell’acqua da parte dell’ Unità Sanitaria Locale.
Nelle tabelle precedenti è inoltre riportato il rendimento al trattamento, superiore al 90%, che rappre-senta l’effi cienza dei sistemi di potabilizzazio-ne dell’acqua presenti.
Nel territorio sono presenti 10 stazioni di po-tabilizzazione dell’acqua il cui scopo è preleva-re, trattare l’acqua grezza e successivamente la distribuzione dell’ acqua potabile. L’ approv-vigionamento avviene dai fi umi Po ed Adige oppure dalle falde tramite pozzi. A seconda del tipo di prelievo sono previsti differenti sistemi di potabilizzazione; il prelievo da fi ume com-porta la chiarifl occulazione, la decantazione, la fi ltrazione su sabbia e ghiaia e su carboni attivi, l’ accumulo e la clorazione. Il prelievo da poz-zo comporta una fase di fi ltrazione biologica che può eventualmente essere preceduta dal processo di ozonizzazione. I principali centri di captazione dell’acqua da pozzo sono le centrali di Boara Polesine, Occhiobello, Castelnovo Ba-riano e Polesella.
Si riporta in tabella un esempio delle analisi chimico/fi siche eseguite sull’acqua distribuita nell’ acquedotto.
--e -e el i-a , -a l ii-
si a
Descrizione Unità di misura
Valore massimo
assimilabile
Valori medi acqua
distribuita
PH - 7,6
Conducibilità elettrica uS/cm a 20°
300/700
Durezza °F 50 16/30
Ossidabilità mg/l 5 0,2/0,6
Ammoniaca mg/l 0,5 0,05
Nitrati mg/l 50 6
Nitriti mg/l 0,1 <0,005
Magnesio mg/l 50 15/20
Sodio mg/l 175 ago-20
Potassio mg/l - 2
Rame mg/l 1 <0,02
Zinco mg/l 3 0,01/0,06
Alluminio mg/l 0,2 0,05
Fluoro mg/l 1,5 0,01/0,1
Manganese mg/l 0,2 <0,01
Composti Organoalogenati mg/l 0,03
Cloro residuo mg/l almeno 0,2 0,3/0,4
Residuo fi sso a 180° mg/l 1500 250/600
Fosforo mg/l 5 0,1/0,4
calcio mg/l - 50/80
Ferro mg/l 0,2 0,02
Piombo mg/l 0,0005 <0,0001
Antiparassitari e assimilabili mg/l 0,05 <0,01
uS/cm=microsimens/cm
°F=gradi franc.
Esempio di Analisi dell’acqua potabile erogata da Polesine Servizi S.p.A.Fonte: Polesine Acque SpA
impa rapporto.indd 60impa rapporto.indd 60 2-04-2009 19:20:242-04-2009 19:20:24

61 ACQUA03
Depurazione delle acque refl ue Capacità ed effi cienza depurativa della provincia di RovigoDopo essere stata utilizzata, l’acqua inizia il suo viaggio all’interno dei collettori fognari per raggiungere
i depuratori.
Il trattamento delle acque di scarico è un punto di forza del programma di risanamento e tutela am-bientale necessario per salvaguardare il nostro patrimonio idrico.
La capacità di depurazione dei refl ui di un centro urbano dipende sia dalla capacità di raccogliere la maggior parte possibile degli scarichi (civili e produttivi) e convogliarli verso un depuratore, che dall’effi -cienza del trattamento stesso.
I dati a disposizione rappresentano la capacità di depurazione presente nei sistemi della provincia di Rovigo.
I dati forniti da Po-lesine Acque indicano inoltre che, per l’anno 2007, ultimo anno di-sponibile, la popolazio-ne servita dal servizio di raccolta era pari a quasi 224.000 abitanti a cui devono sommarsi i 30.000 fl uttuanti.
Nel corso del 2008 il Dipartimento provinciale dell’ARPA Veneto ha controllato 24 impianti di depura-zione con 165 controlli su prescrizioni e funzionalità. Nel corso dei controlli svolti sono emerse irregolarità nella gestione della depurazione delle acque.
Nel 2009, per lo stesso numero di depuratori, sono previsti 248 controlli.
-oo--oatisi
Numero di impianti per classe di potenzialità
< 2000 AE > 2000 AE fi no 9.999 AE fi no 99.999 AE > 100.000 AE
Provincia 50 29 20 9 0
Totale 79
Numero di impianti per classe di potenzialità – percentuale
< 2000 AE > 2000 AE fi no 9.999 AE fi no 99.999 AE > 100.000 AE
Provincia 63,3% 36,7% 25,3% 11,4% 0,0%
Capacità di depurazione in AE per classe di potenzialità
< 2000 AE > 2000 AE fi no 9.999 AE fi no 99.999 AE > 100.000 AE
Provincia 42.030 342.250 68.650 273.600 0
Totale 384.280
Capacità di depurazione AE per classe di potenzialità – percentuale
< 2000 AE > 2000 AE fi no 9.999 AE fi no 99.999 AE > 100.000 AE
Provincia 10,9% 89,1% 17,9% 71,2% 0,0%
Tipologia di impianti di depurazione presenti nella provincia di RovigoFonte: Area Politiche per l’Ambiente
impa rapporto.indd 61impa rapporto.indd 61 2-04-2009 19:20:242-04-2009 19:20:24

62
Sintesi
Tipo indicatore Valutazione sintetica Trend
Acque interne
Indice Biotico Esteso - IBE S
Concentrazione di nitrati nei corsi d’acqua S
Stato ambientale dei corsi d’acqua (SACA) S
Acque di balneazione
Indice trofi co lungo la costa del Delta del Po S
Sistema di monitoraggio delle acque di balneazione R
Idoneità alla balneazione: percentuale di campioni favorevoli S
Qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi S
Acque potabili
Consumi idrici per uso in alto, medio e basso Polesine S
Consumo idrico totale della provincia P
Perdite della rete idrica P
Consumo pro capite giorno di acqua rispetto a dato Italiano P
Qualità dell’acqua erogata per uso potabile S
Depurazione delle acque refl ue
Capacità ed effi cienza depurativa della provincia di Rovigo R
D Causa determinate P Indicatore di pressione S Indicatore di Stato
I Indicatore di Impatto R Indicatore di Risposta
Condizioni positive Condizioni stazionarie Condizioni negative
Trend in crescita Trend stazionario Trend in diminuzione
a
a
a
a
a
a
k
k
k
k
k
f
f
f
f
f
impa rapporto.indd 62impa rapporto.indd 62 2-04-2009 19:20:252-04-2009 19:20:25

RIFIUTI
impa rapporto.indd 63impa rapporto.indd 63 2-04-2009 19:20:252-04-2009 19:20:25

64RIFIUTI 04
Rifi utiLo smaltimento dei rifi uti è uno dei problemi maggiori per la crescita della società moderna. I rifi uti
continuano ad aumentare, anche a causa degli stili di vita, basati sull’usa e getta, che induce i cittadini ad usare i beni come fossero infi niti, senza preoccuparsi di cosa fare o dove metterli non appena diven-tano inutilizzabili. L’aumento della produzione dei rifi uti è ormai considerato un sintomo del progresso economico e dell’aumento dei consumi.
Nella maggior parte dei Paesi europei la quantità totale di rifi uti prodotta continua ad aumentare, come testimonia il Kiev’s Report (Europe’s environment: the third assessment), il documento della Com-missione Europea che delinea il quadro ambientale a livello degli Stati membri (EU15), dei Paesi dell’Est europeo (Paesi dell’allargamento) e dei Paesi del Caucaso e dell’Asia centrale (EECCA).
La produzione dei rifi uti, interferendo con numerose variabili ambientali quali il suolo, le risorse idri-che, le risorse energetiche e la qualità dell’aria, rappresenta uno dei fattori di pressione ambientali più critici.
D’altro canto esiste anche il problema della mancanza di un numero adeguato di impianti di smalti-mento che siano in grado di ricevere i rifi uti prodotti e di smaltirli correttamente.
Solo una politica del riutilizzo dei materiali, dell’avvio al recupero delle frazioni suscettibili di riutilizzo e, soprattutto, quella della limitazione e prevenzione dei rifi uti prodotti, come del resto auspicato dalla re-cente normativa, è l’unica via perseguibile, e opportunamente accompagnata da una seria informazione-educazione nei confronti dei cittadini.
Il bacino di cui fa parte la provincia di Rovigo ha la stessa dimensione della provincia ed include tutti e 50 i comuni. Il Piano Regionale, adottato con DGR del 15.02.2000 stabilisce che i rifi uti urbani siano smaltiti all’interno del bacino o, al massimo, all’interno della provincia. Nello stesso Piano Regionale sono fi ssati degli obiettivi di raccolta differenziata, molto più ambiziosi di quelli stabiliti dal D.Lgs. 22/97, da raggiungere sull’intero territorio regionale:
• 35% entro il 2001;
• 50% entro il 2003.
La normativa di riferimento a livello nazionale in materia di rifi uti è rappresentata dal Decreto legislati-vo n. 152 del 3 aprile 2006, emanato in attuazione della Legge 308/2004 “delega ambientale” e recante “norme in materia ambientale”. Tale Decreto dedica la parte IV alle “Norme in materia di gestione dei rifi uti e di bonifi ca dei siti inquinati” (articoli 177 – 266) ed ha abrogato una serie di provvedimenti pre-cedenti tra cui il Decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, cosiddetto Decreto “Ronchi”, che fi no alla data di entrata in vigore del D.lgs. 152/06 ha rappresentato la legge quadro di riferimento in materia di rifi uti.
La gerarchia di gestione dei rifi uti è disciplinata dall’art. 179 del D.Lgs. 152/06 “Criteri di priorità nella gestione dei rifi uti” che stabilisce quali misure prioritarie la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifi uti seguite da misure dirette quali il recupero dei rifi uti mediante riciclo, il reimpiego, il riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie, nonché all’uso di rifi uti come fonte di energia.
Il Decreto quindi persegue la linea già defi nita dal Decreto “Ronchi”, ovvero la priorità della prevenzio-ne e della riduzione della produzione e della pericolosità dei rifi uti, a cui seguono solo successivamente
impa rapporto.indd 64impa rapporto.indd 64 2-04-2009 19:20:252-04-2009 19:20:25

65 RIFIUTI04
il recupero (di materia e di energia) e quindi, come fase residuale dell’intera gestione, lo smaltimento (messa in discarica ed incenerimento).
La classi cazione dei ri uti presente nel D.lgs. 152/06 distingue i ri uti
• secondo l’origine in: Ri uti urbani e Ri uti speciali,
• secondo le caratteristiche di pericolosità in: Ri uti pericolosi e non pericolosi.
A livello regionale di riferimento è la Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3, “Nuove norme in materia di gestione dei ri uti”.
I dati utilizzati in questo capitolo sono:
r estratti dalle tabelle pubblicate da ARPA Veneto;
r per il bacino della Provincia di Rovigo sono state utilizzate pubblicazioni speci che pubblicate sul sito internet della Provincia di Rovigo;
r per la popolazione sono stati utilizzati i dati ISTAT o forniti dai comuni della Provincia di Rovigo;

66RIFIUTI 04
Sistema di raccolta
Il servizio di raccolta dei rifi uti urbani ed assimilati viene svolto dalla società Ecogest srl su 49 comuni della provincia, con l’esclusione del Comune capoluogo, servito dalla società ASM Rovigo SpA.
Il comune di Rovigo non è nelle condizioni per poter attuare un sistema di raccolta porta a porta totale (per numero di abitanti e problematiche legate all’urbanizzazione del centro storico). Ha optato quindi per una raccolta tradizionale mediante cassonetti stradali, separando però il rifi uto umido dal rifi uto secco non riciclabile a mezzo di bidoni e l’utilizzo di “isole ecologiche” per la raccolta del vetro/plastica/lattine e della carta.
L’unica raccolta porta a porta attivata è quella della frazione verde, mentre è attivo un servizio di ritiro gratuito a chiamata per gli ingombranti e i beni durevoli.
E’ da anni in funzione inoltre, su richiesta, un servizio di raccolta specifi co per qualsiasi tipologia di rifi uto, riservato alle “grandi utenze”, con sistema a cassoni o biobidoni o cassonetti in comodato e svuo-tamento programmato.
I restanti Comuni della provin-cia da anni hanno implementato l’attivazione del sistema di rac-colta porta a porta totale, adot-tandolo ormai in 47 Comuni sui 49 totali gestiti da Ecogest srl (aggiornato a 2008).
Con tale sistema di raccolta vengono intercettate, diretta-mente da ciascuna utenza dome-stica, tutte le tipologie di rifi uto mediante bidoni di diverso colo-re e sacchetti idonei. La raccolta è programmata in giorni specifi ci comunicati alle utenze mediante un eco-calendario.
o
2002 2003 2004 2005 2006 2007
cassonetti stradali 31 12 9 4 4 2
porta a porta parziale 11 9 2 2 2 1
porta a porta totale 7 28 37 41 41 46
cassonetti stradali con sep. umido
1 1 2 3 3 1
0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
c a s s o n e tti s tra d a li c a s s o n e tti s tr a d a l i c o n s e p . u m id o p o rta a p o r ta p a rz ia le p o rta a p o r ta to ta le
Sistemi di raccolta RSU - 2007 porta a porta parziale
porta a porta totale
cassonetti stradali
raccolta separata dell’umido mediante cassonetti stradali
impa rapporto.indd 66impa rapporto.indd 66 2-04-2009 19:20:252-04-2009 19:20:25

67 RIFIUTI04
Ecocentri
Un ruolo molto importante per la gestione del servizio inte-grato di raccolta dei rifi uti urbani è svolto dagli ECOCENTRI diffusi su tutto il territorio provinciale. Sono centri attrezzati, a benefi -cio di tutti i cittadini e delle ditte del territorio che sottoscrivono un contratto di conferimento.
La funzione di tali strutture è quella di ottimizzare e razionalizzare la raccolta differenziata delle diverse frazioni, raccogliendole in un area idonea in attesa del trasporto all’impianto di recupero o smaltimento. Per ecocentro si intende un’area recintata, presidiata da personale addetto al controllo ed aperta al pub-blico in giorni e ad orari prestabiliti.
Nel caso in cui si adibisca un’area al ricevimento di alcune frazioni di rifi uti da parte delle utenze do-mestiche (come avviene per le campane distribuite sul territorio) senza limitarne la possibilità di accesso, questa è defi nita “isola ecologica” e non necessita di autorizzazione.
Nella provincia di Rovigo, risultano autorizzati in totale n. 18 ecocentri: l’ecocentro del Comune di Me-lara è stato avviato nel corso del 2007, mentre quello del Comune di Rosolina è ancora in fase di realiz-zazione. L’Ecocentro del Comune di Porto Viro è attrezzato per la raccolta di olii e batterie prodotti dalle imbarcazioni in accordo con COOU e COBAT.
Negli ecocentri è possibile portare vari oggetti che non è possibile gettare nei normali contenitori:
• ingombranti;
• rifi uti differenziati (organico, carta e cartone, plastica, vetro e lattine, etc.);
• sfalci e ramaglie;
• rifi uti urbani pericolosi (accumulatori per auto, vernici/solventi/detersivi, neon, pile, farmaci scaduti, olii minerali e vegetali esausti etc.)
Nella fi gura sottostante è riportata la dislocazione sul territorio degli ecocentri autorizzati.
Ecocentri Comuni con Ecocentro autorizzato
Comuni senza Ecocentro
e
e o
n° comuni n° ecocentri
attivi
Percentuale di
comuni
con ecocentro
n°ecocentri
in costruzione
50 18 36% 1
Ecocentri della Provincia di Rovigo – anno 2007.
Fonte: Provincia di Rovigo – Elaborazione: Agenda21Polesine.
impa rapporto.indd 67impa rapporto.indd 67 2-04-2009 19:20:252-04-2009 19:20:25

68RIFIUTI 04
Produzione totale di RSU
Scopo dell’indicatore è valutare l’andamento nel tempo della produzione di rifi uti urbani.
Una buona politica di gestione dei rifi uti dovrebbe tendere a ridurre l’incremento della produzione totale di RSU, arrestandone ed invertendone l’andamento di crescita che tende ad incrementare di anno in anno.
La vigente normativa considera nella categoria dei Rifi uti Solidi Urbani:
• i rifi uti prodotti dai privati cittadini in ambito domestico;
• i rifi uti provenienti da attività lavorative che per caratteristiche qualitative e quantitative possano essere assimilati ai precedenti,
• i resti dello spazzamento stradale;
• i resti risultanti dalla manutenzione delle aree verdi e cimiteriali.
I rifi uti urbani possono essere perciò stimati come somma dei rifi uti solidi urbani destinati allo smalti-mento e quelli oggetto di raccolta differenziata.
Prendendo in considerazione i dati riportati in tabella ed esplicitati nel grafi co si vede come è cresciuta la produzione complessiva di rifi uti dal 1998 al 2007, ultimo anno disponibile. La variazione in percentua-le evidenzia un lieve calo, in questi ultimi anni, nella crescita dei rifi uti con un incremento del 2,0% dal 2005 al 2006 ed un calo del 0,9% nell’ultimo anno.
Tuttavia anche la liena di tendenza complessiva (rappresentata con la linea rossa nel grafcio) evidenzia il complessivo trend di crescita della produzione di rifi uti.
121.108
127.498 127.136 127.136
132.069
125.385
133.193 133.214
135.820134.591
136.687
110.000
120.000
130.000
140.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
P roduzione totali di rifiuti (in tonn) Lineare (P roduzione totali di rifiuti (in tonn))
140 000
anni 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Provincia Rovigo 121.108 127.498 127.136 127.136 132.069 125.385 133.193 133.214 135.820 134.591 136.687
Variazione % - 5,3% -0,3% 0,0% 3,9% -5,1% 6,2% 0,0% 2,0% -0,9% 1,6%
Produzione totale di rifi uti nella provincia di Rovigo – Bacino RO01
Fonte: Provincia di Rovigo e ECOGEST (2008 dati uffi ciosi) – Elaborazione: Agenda21Polesine
ton
n/
ann
o
Produzione totale di rifi uti nella provincia di Rovigo – Bacino RO01Fonte: Provincia di Rovigo e ECOGEST (2008 dati uffi ciosi) – Elaborazione: Agenda21Polesine
impa rapporto.indd 68impa rapporto.indd 68 2-04-2009 19:20:262-04-2009 19:20:26

69 RIFIUTI04
Produzione di RSU pro-capite giornaliera
Scopo dell’indicatore è valutare l’andamento nel tempo della produzione dei rifi uti urbani e la pressio-ne esercitata sull’ambiente.
Obiettivo auspicabile è la riduzione della produzione di rifi uti solidi urbani, ad esempio attraverso:
r campagne di informazione rivolte ai cittadini per promuovere buone pratiche (“spesa intelligen te”, sensibilizzazione dei consumatori).
r Riduzione degli imballaggi, in particolare agendo sulla grande distribuzione.
r Aumento degli imballaggi prodotti con materiali riutilizzabili.
La tabella illustra i valori complessivi fatti registrare dall’intero bacino della provincia di Rovigo; i dati evidenziano un complessivo aumento del quantitativo prodotto per abitante, che è passato da 1,25 kg/abitante/giorno nel 1996 a 1,52 kg/abitante/giorno nel 2006. Tra il 2006 ed il 2007 è da evidenziare il lieve calo del 1,3%.
Nella cartografi a sono invece rappresentati i dati per comune. Sono state fatte 3 classi che rappresenta-no il valore al 2007. La prima classe è fi no a 1,0 kg/abitante/giorno, la seconda fi no a 1,6 kg/abitante/giorno e l’ultima racchiude i comuni dove la quota è addirittura superiore a questo valore. I comuni dove la quota è maggiore sono Rovigo, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina e Gaiba.
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Kg/ab/gg 1,25 1,25 1,36 1,43 1,43 1,43 1,48 1,41 1,49 1,49 1,52 1,50 1,51
variazione 0,0% 8,8% 5,1% 0,0% 0,0% 3,5% -4,7% 5,7% 0,0% 2,0% -1,3% 0,7%
Produzione di rifi uti urbani kg/ab/giorno
Fonte: Provincia di Rovigo e ECOGEST (2008 dati uffi ciosi) – Elaborazione: Agenda21Polesine
Rifi uti pro capite al giorno - 2008kg/abitante/giorno fi no a 1,2 Kg/ab/gg
1,2 - 1,6
oltre 1,6 Kg/ab/gg
RSU pro-capite per Comune - anno 2008Fonte: ECOGEST (2008 dati uffi ciosi) – Elaborazione: Agenda21Polesine
impa rapporto.indd 69impa rapporto.indd 69 2-04-2009 19:20:262-04-2009 19:20:26

70RIFIUTI 04
3 7 , 8 %4 2 , 1 %
4 8 , 6 %5 1 , 3 %
5 5 , 3 %
6 0 , 0 %
2 0 %
3 0 %
4 0 %
5 0 %
6 0 %
2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8
50% Obiettivo D. Lgs 152/2006 per 2009
Percentuale di raccolta differenziata
Analizzando la variazione della parte recuperata di rifi uti, e quindi la percentuale di rifi uti recuperati, si evidenzia come complessivamente il bacino della provincia di Rovigo sia un bacino abbastanza virtuoso che già nel 2006 ha raggiunto e superato la quota del 50%.
Sono quindi già sta-ti raggiunti gli obiet-tivi fi ssati dall’attuale normativa di riferi-mento che pongono il superamento della quota del 45% entro il 31/12/2008.
Il grafi co posto in fondo alla pagina rappresenta invece la composizione dei rifi uti prodotti distinti in recuperati e non recuperati. È evidente quanto sia cresciuta la quota recuperata nell’ar-co degli anni portando la provincia di Rovigo al risultato del 55,2% di rifi uti recuperati al 2007.
e
o
2003 2004 2005 2006 2007 2008
RSU Totale 125.385 133.194 133.053 135.820 134.589 136.687
RSU recuperato 47.342 56.087 64.687 69.617 74.409 82.011
% raccolta differenziata 37,7% 42,1% 48,6% 51,2% 55,3% 60,1%
Percentuale di raccolta differenziata nella provincia di RovigoFonte: Provincia di Rovigo e ECOGEST (2008 dati uffi ciosi) – Elaborazione: Agenda21Polesine
0
2 0 . 0 0 0
4 0 . 0 0 0
6 0 . 0 0 0
8 0 . 0 0 0
1 0 0 . 0 0 0
1 2 0 . 0 0 0
1 4 0 . 0 0 0
1 6 0 . 0 0 0
R S U re c u p e ra to 7 . 8 8 6 1 2 . 7 9 1 1 7 . 7 0 9 2 9 . 0 0 5 3 8 . 3 4 5 4 7 . 3 4 2 5 6 . 0 8 7 6 4 . 6 8 7 6 9 . 6 1 7 7 4 . 4 0 9 8 2 . 0 1 1
R S U re s id u o 1 1 3 . 2 2 2 1 1 4 . 7 0 7 1 0 9 . 4 2 7 9 8 . 1 3 1 9 3 . 7 2 4 7 8 . 0 4 3 7 7 . 1 0 7 6 8 . 3 6 6 6 6 . 2 0 3 6 0 . 1 8 1 5 4 . 6 7 6
1 9 9 8 1 9 9 8 1 9 9 8 1 9 9 8 1 9 9 8 1 9 9 8 1 9 9 8 1 9 9 8 1 9 9 8 1 9 9 8 1 9 9 8
Percentuale di Raccolta differenziata nella Provincia di RovigoFonte: Provincia di Rovigo e ECOGEST (2008 dati uffi ciosi) - Elaborazione: Agenda21Polesine
Andamento della raccolta di rifi uti nella provincia di RovigoFonte: Provincia di Rovigo e ECOGEST (2008 dati uffi ciosi) – Elaborazione: Agenda21Polesine
impa rapporto.indd 70impa rapporto.indd 70 2-04-2009 19:20:272-04-2009 19:20:27

71 RIFIUTI04
Produzione di rifi uti per comune
Nella pagina che segue sono sintetizzati i dati riferiti all’anno 2007 per tutti i comuni della provincia. I dati rappresentati sono la produzione complessiva di rifi uti, la parte di rifi uti separata ed avviata a recu-pero, la percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel comune e il valore pro capite di rifi uti prodotti giornalmente. Sono inoltre nessi in percentuali le variazioni rispetto all’anno precedente.
Analizzando questi dati emergono alcune considerazioni generali:
- solo in due comuni la raccolta differenziata non supera la quota del 40%, mentre complessiva-mente nell’86%dei comuni è stata superata la quota del 55%. Il 30% inoltre separa oltre il 65%;
- Se rapportato alla popolazione, otteniamo che il 63,3% della popolazione separa oltre il 55% e che il 18% supera addirittura il 65%.
Nella cartografi a che segue sono rappresentati i comuni suddivisi in base alla quota di raccolta diffe-renziata. Dalla cartografi a si vede come i comuni più virtuosi sono localizzati nel medio – alto polesine e a quale classe appartengano i comuni più abitati, Rovigo ed Adria.
Percentuale di raccolta differenziata - 2008
fi no al 50%
50% - 60%
60% - 70%
oltre il 70%
Percentuale di raccolta differenziata nei comuni della provincia – anno 2008Fonte: ECOGEST (2008 dati uffi ciosi) – Elaborazione: Agenda21Polesine
impa rapporto.indd 71impa rapporto.indd 71 2-04-2009 19:20:282-04-2009 19:20:28

72RIFIUTI 04
Produzione totali di rifi uti (t.) R.U.R. rifi uti urbani riciclabili (t.) Raccolta differenziata %
Comune 2007 2008 Var 07-08 2007 2008 Var 07-08 2007 2008 Var 07-08Adria 11.501 10.498 -9,55% 6.732 6.762 0,45% 58,5% 64,4% 9,13%Ariano Polesine 2.041 1.940 -5,21% 1.138 1.243 8,46% 55,8% 64,1% 13,00%Arquà Polesine 1.265 1.297 2,45% 876 867 -0,98% 69,2% 66,9% -3,51%Badia Polesine 6.188 5.837 -6,02% 3.757 3.780 0,61% 60,7% 64,8% 6,25%Bagnolo Di Po 490 567 13,59% 300 400 24,96% 61,2% 70,5% 13,16%Bergantino 1.471 1.642 10,44% 901 1.083 16,81% 61,3% 65,9% 7,11%Bosaro 567 596 4,83% 412 445 7,50% 72,7% 74,8% 2,81%Calto 442 513 13,85% 287 379 24,22% 64,9% 73,8% 12,04%Canaro 1.179 1.245 5,30% 824 893 7,72% 69,9% 71,7% 2,56%Canda 428 488 12,36% 274 338 18,91% 64,0% 69,2% 7,48%Castelguglielmo 664 700 5,08% 459 515 10,91% 69,1% 73,6% 6,14%Castelmassa 2.255 2.550 11,57% 1.504 1.736 13,37% 66,7% 68,1% 2,04%Castelnovo B. 1.136 1.249 9,03% 669 755 11,43% 58,9% 60,5% 2,63%Ceneselli 873 957 8,74% 611 667 8,33% 70,0% 69,7% -0,44%Ceregnano 1.676 1.525 -9,92% 1.142 1.054 -8,32% 68,1% 69,1% 1,46%Corbola 1.202 1.373 12,44% 670 841 20,34% 55,7% 61,3% 9,03%Costa di Rovigo 1.201 1.335 10,01% 790 802 1,51% 65,8% 60,1% -9,45%Crespino 770 724 -6,32% 470 451 -4,11% 61,0% 62,3% 2,08%Ficarolo 1.244 1.392 10,60% 645 770 16,20% 51,8% 55,3% 6,26%Fiesso Umbertiano 1.937 1.938 0,05% 1.229 1.265 2,82% 63,4% 65,3% 2,77%Frassinelle Polesine 594 612 2,87% 390 426 8,41% 65,7% 69,6% 5,71%Fratta Polesine 1.322 1.344 1,66% 839 889 5,68% 63,5% 66,2% 4,08%Gaiba 716 674 -6,19% 369 511 27,72% 51,5% 75,7% 31,94%Gavello 571 573 0,40% 363 377 3,72% 63,6% 65,8% 3,34%Giacciano con B. 1.069 1.088 1,78% 605 638 5,10% 56,6% 58,6% 3,38%Guarda Veneta 420 507 17,21% 296 376 21,26% 70,5% 74,1% 4,90%Lendinara 5.926 6.193 4,31% 4.095 4.208 2,69% 69,1% 68,0% -1,70%Loreo 1.530 1.549 1,22% 832 931 10,59% 54,4% 60,1% 9,49%Lusia 1.522 1.736 12,31% 946 1.065 11,14% 62,2% 61,3% -1,34%Melara 850 929 8,46% 497 606 18,05% 58,5% 65,3% 10,48%Occhiobello 6.298 6.368 1,10% 4.049 4.202 3,64% 64,3% 66,0% 2,57%Papozze 804 881 8,78% 513 589 12,84% 63,8% 66,8% 4,45%Pettorazza G. 544 619 12,12% 367 452 18,79% 67,5% 73,0% 7,60%Pincara 527 583 9,59% 351 395 11,07% 66,6% 67,7% 1,65%Polesella 1.814 1.808 -0,31% 1.125 1.149 2,10% 62,0% 63,5% 2,40%Pontecchio Pol. 732 618 -18,53% 423 493 14,17% 57,8% 79,8% 27,59%Porto Tolle 6.500 6.428 -1,11% 1.266 1.291 1,97% 19,5% 20,1% 3,05%Porto Viro 8.514 8.510 -0,05% 3.792 5.848 35,16% 44,5% 68,7% 35,19%Rosolina 5.165 5.394 4,25% 1.789 2.302 22,28% 34,6% 42,7% 18,83%Rovigo 36.748 37.458 1,90% 19.364 20.717 6,53% 52,7% 55,3% 4,72%S.Martino di V. 1.664 539 -208,95% 1.103 380 -189,96% 66,3% 70,6% 6,14%Salara 490 631 22,31% 329 415 20,71% 67,1% 65,8% -2,06%San Bellino 536 1.787 70,00% 330 1.154 71,40% 61,6% 64,6% 4,66%Stienta 1.618 1.672 3,25% 1.014 1.083 6,40% 62,7% 64,8% 3,25%Taglio di Po 3.886 3.899 0,34% 2.158 2.699 20,05% 55,5% 69,2% 19,77%Trecenta 1.431 1.463 2,16% 813 890 8,64% 56,8% 60,8% 6,63%Villadose 2.344 2.234 -4,90% 1.492 1.372 -8,71% 63,7% 61,4% -3,63%Villamarzana 470 640 26,59% 283 416 32,01% 60,2% 65,0% 7,38%Villanova del Ghebbo 1.058 1.096 3,45% 672 726 7,44% 63,5% 66,3% 4,14%Villanova Marchesana 398 488 18,50% 253 364 30,48% 63,6% 74,5% 14,71%Provincia 134.591 136.687 1,53% 74.408 82.011 9,27% 55,3% 60,0% 7,86%Produzione di rifi uti e raccolta differenziata nei comuni della provincia di RovigoFonte: Provincia di Rovigo e ECOGEST (2008 dati uffi ciosi) – Elaborazione: Agenda21Polesine
impa rapporto.indd 72impa rapporto.indd 72 2-04-2009 19:20:282-04-2009 19:20:28

73 RIFIUTI04
Composizione della raccolta differenziata
Valutare la composizione complessiva della racolta differenziata evidenzia in quali settori si sia già raggiunto un buon livello e dove invece si può ancora spingere per incrementare i risultati.
Le frazioni raccolte sepa-ratamente che incidono mag-giormente sulla percentuale di raccolta diffe-renziata della Provincia di Ro-vigo sono il ver-de, l’umido e il multi materiale (Vetro Plastica Lattine - VPL) e la carta, che costitui-scono rispettivamente il 17,4%, il 12,7%, l’11,0% e il 10,6%.
La voce altro che raggiunge il 3,6% racchiude in sé rifi uti recuperabili e rifi uti particolari quali: metalli, le-gno, pneumatici, stracci, pile, accumulatori al piombo, olii vegetali e minerali, T/F, farmaci, vernici, toner.
Negli anni la composizione complessiva si è andata modifi cando ed alcune voci hanno avuto incrementi maggiori di altre. Nel grafi co accanto è rappresentato l’incremento annuale che le diverse classi hanno fat-to registrare dal 2001 al 2007.
L’incremento maggiore è stato le-gato alla Frazione Organica dei Rifi uti Solidi Urbani, costituita dalla frazione organica (scarti di cucina, potature, ecc) nel ciclo della raccolta differen-ziata (col metodo del porta a porta o del contenitore stradale). Un notevole incremento negli anni è stato regi-strato anche dal Verde.
La carta ha un trend costante, un incremento costante negli anni.
e
e
2004 2005 2006 2007
Altro 3.519 2,6% 4.225 3,2% 4.575 3,4% 4.885 3,6%
Residuo 77.107 57,9% 68.465 51,4% 66.203 48,7% 60.181 44,7%
Verde 20.980 15,8% 22.926 17,2% 23.553 17,3% 23.394 17,4%
Umido 9.222 6,9% 13.439 10,1% 15.026 11,1% 17.093 12,7%
V.P .L. 10.637 8,0% 11.424 8,6% 12.759 9,4% 14.739 11,0%
Carta 11.729 8,8% 12.734 9,6% 13.705 10,1% 14.298 10,6%
Totale 133.194 100,0% 133.213 100,0% 135.821 100,0% 134.590 100,0%
Composizione merceologica in ton. dei rifi uti differenziati in tonnellate
Dati: Provincia di Rovigo – Elaborazione: Agenda21Polesine
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
F o rs u V e rd e C a rta M u lti m a te ria le
Composizione merceologica dei rifi uti 2007Dati: Provincia di Rovigo – Elaborazione: Agenda21Polesine
Composizione merceologica dei rifi uti dal 2001 al 2007Dati: Provincia di Rovigo – Elaborazione: Agenda21Polesine
impa rapporto.indd 73impa rapporto.indd 73 2-04-2009 19:20:292-04-2009 19:20:29

74RIFIUTI 04
Presenza di compostaggio domestico
23 comuni della Provincia aderivano nel 2002 al compostaggio domestico. Al 2007 il numero è cre-sciuto arrivando a 38 comuni.
Questa è una forma di gestione molto importante che, sottraendo al rifi uto domestico la parte vegetale e quella alimentare, può determinare una riduzione signifi cativa nella produzione di rifi uto. Questa frazio-ne, infatti, costituisce generalmente circa il 30% del rifi uto totale domestico.
Nel corso degli anni si è assistito ad un aumento progres-sivo delle utenze do-mestiche che hanno aderito alla pratica del compostaggio, incentivati anche dall’applicazione di uno sgravio econo-mico sul calcolo della TARSU e/o T.I.A. che ogni singola realtà comunale ha stabilito in sede di Consiglio.
Il Consorzio Smalti-mento RSU, a sostegno del compostaggio domestico, ha predisposto un volume di facile consultazione sulle buone pratiche e sui consigli per una corretta produzione ed utilizzo del compost nel contesto do-mestico.
e
e
o
e
e
o
Comuni 2006 2007 Variazione Comuni 2006 2007 Variazione
Adria 1.164 1.207 3,7% Lendinara 425 502 18,1%
Ariano Pol. 646 671 3,9% Loreo 255 256 0,4%
Badia Pol. 544 537 -1,3% Lusia 283 285 0,7%
Bergantino 335 342 2,1% Melara 236 236 0,0%
Bosaro 30 31 3,3% Occhiobello 46 160 247,8%
Calto 107 112 4,7% Pettorazza G. 270 276 2,2%
Canaro 19 22 15,8% Pincara 158 154 -2,5%
Castelmassa 219 209 -4,6% Polesella 99 99 0,0%
Castelnovo B. 258 259 0,4% Porto Tolle 195 195 0,0%
Ceneselli 187 186 -0,5% Rosolina 713 705 -1,1%
Ceregnano 314 311 -1,0% Rovigo 1.000 1.200 20,0%
Corbola 190 191 0,5% Salara 216 214 -0,9%
Costa Di Rovigo 343 340 -0,9% S. Bellino 43 43 0,0%
Crespino 198 205 3,5% S. Martino 410 402 -2,0%
Ficarolo 231 232 0,4% Stienta 153 139 -9,2%
Frassinelle 171 170 -0,6% Taglio Di Po 143 148 3,5%
Fratta Pol. 32 34 6,3% Trecenta 229 229 0,0%
Gavello 0 156 - Villadose 388 395 1,8%
Giacciano B. 2 2 0,0% Villamarz. 76 74 -2,6%
Guarda V. 60 60 0,0% Villanova G. 89 97 9,0%
Adesioni al compostaggio domestico
Dati: Provincia di Rovigo – Elaborazione: Agenda21Polesine
Copostaggio domestico Comune che non aderisce
Comune che aderisce
Comuni che aderiscono al compostaggio domesticoFonte dati: Area Politiche dell’Ambiente, Provincia di Rovigo, elaborazione: Agenda21Polesine
impa rapporto.indd 74impa rapporto.indd 74 2-04-2009 19:20:302-04-2009 19:20:30

75 RIFIUTI04
Rifi uti speciali
I rifi uti sono classifi cati, secondo l’origine, in rifi uti urbani e rifi uti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità in rifi uti non pericolosi e rifi uti pericolosi (urbani e speciali), che contengono al loro interno un’elevata dose di sostanze inquinanti pericolose e che quindi devono essere gestiti-raccolti, trasportati e smaltiti con la massima sicurezza.
Nella seguente tabella sono riportati alcuni esempi di rifi uti speciali:
• i rifi uti derivanti da lavorazione industriale; da attività commerciale; da attività sanitarie;
• i rifi uti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifi uti, i fanghi prodotti da trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque refl ue e da abbattimento di fumi;
• i macchinari deteriorati ed obsoleti; i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso.
La base dati utilizzata per popolare gli indicatori relativi alla produzione dei rifi uti speciali è rappresen-tata dalle dichiarazioni MUD effettuate dai soggetti obbligati ai sensi della normativa vigente ed i dati elaborati derivano dalle pubblicazioni che l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente ha fatto in questi anni.
impa rapporto.indd 75impa rapporto.indd 75 2-04-2009 19:20:302-04-2009 19:20:30

76RIFIUTI 04
Produzione totale di rifi uti speciali
L’indicatore misura la quantità totale di rifi uti speciali generati nella provincia di Rovigo. L’informazione viene fornita aggregata ovvero per rifi uti speciali pericolosi, rifi uti speciali non pericolosi. Viene, inoltre, presentato il dato regionale di confronto. La base informativa è costituita dalle dichiarazioni MUD, effet-tuate da parte dei soggetti individuati dall’articolo 189 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e inviate utilizzando il circuito della Camera di Commercio, ai sensi della L 70/94, entro il 30 aprile di ogni anno.
Complessivamente dal 2001 al 2005 è calata la produzione totale di rifi uti non pericolosi nella provincia di Rovigo. L’andamento dei rifi uti speciali pericolosi è calato invece dal 2002 passando da 30.000 t. a 22.377 t nel 2005.
2001 2002 2003 2004 2005
Rovigo t. var. % t. var. % t. var. % t. var. % t. var. %
Speciali non pericolosi
548.471 46,2% 460.198 -16,1% 412.931 -10,3% 221.146 -46,4% 207.817 -6,0%
Pericolosi 18.727 -3,0% 30.346 62,0% 26.819 -11,6% 20.971 -21,8% 22.377 6,7%
Totale 567.198 43,8% 490.544 -13,5% 439.750 -10,4% 242.117 -44,9% 230.193 -4,9%
% sulla prod. regionale 6,65% - 5,87% - 5,23% - 2,86% - 2,85% -
Veneto t. var. % t. var. % t. var. % t. var. % t. var. %
Speciali non pericolosi
7.985.4377,2%
7.694.601-3,6%
7.745.4720,7%
7.777.3470,4%
7.329.502-5,8%
Pericolosi 539.237 4,3% 658.663 22,1% 663.840 0,8% 678.815 2,3% 743.105 9,5%
Totale regione 8.524.674 7,1% 8.353.264 -2,0% 8.409.312 0,7% 8.456.162 0,6% 8.072.607 -4,5%
Produzione annua di rifi uti Speciali non pericolosi e PericolosiDati: ARPA Veneto – Elaborazione:Agenda21Polesine
3 7 5 . 2 0 5
5 4 8 . 4 7 1
4 6 0 . 1 9 84 1 2 . 9 3 1
2 2 1 . 1 4 6 2 0 7 . 8 1 7
2 2 . 3 7 72 0 . 9 7 1
2 6 . 8 1 9
3 0 . 3 4 6
1 8 . 7 2 7
1 9 . 3 0 0
0
1 0 0 . 0 0 0
2 0 0 . 0 0 0
3 0 0 . 0 0 0
4 0 0 . 0 0 0
5 0 0 . 0 0 0
6 0 0 . 0 0 0
A . 2 0 0 0 A . 2 0 0 1 A . 2 0 0 2 A . 2 0 0 3 A . 2 0 0 4 A . 2 0 0 5
S p e c ia li n o n p e ric o lo s i P e r ic o lo s i
Produzione annua di rifi uti Speciali Non pericolosi e PericolosiDati: ARPA Veneto – Elaborazione: Agenda21Polesine
impa rapporto.indd 76impa rapporto.indd 76 2-04-2009 19:20:302-04-2009 19:20:30

77 RIFIUTI04
Politiche ed attività di sensibilizzazione ed educazione
Scopo di questo indicatore è evidenziare le attività messe in atto per aiutare e incrementare la parte-cipazione dei cittadini e la condivisione delle scelte delle amministrazioni nei confronti della gestione dei rifi uti. Per questo motivo, è fondamentale curare al massimo le fasi di avvio delle nuove raccolte, dato che eventuali problematicità e incomprensioni, delle nuove modalità, possono condizionare pesante-mente il successo dell’iniziativa e il risultato della gestione futura dei rifi uti urbani.
Con tali fi nalità il Consorzio smaltimento rifi uti, in stretta collaborazione con Ecogest Polesine progetta e realizza nel territorio polesano serate informative per le utenze, dove vengono fornite opportune spie-gazioni pratiche su quelli che sono i comportamenti quotidiani che il cittadino è chiamato a rispettare, lasciando ampio spazio al dibattito per esaudire dubbi, perplessità e timori. Inoltre realizza incontri infor-mativi sulla corretta pratica del compostaggio e provvede a sviluppare altre attività di sensibilizzazione, con azioni strutturate e mirate ad una specifi ca fascia di utenza, al fi ne di radicare nel Polesine la cultura del rispetto ambientale in tema di separazione dei rifi uti.
Molte informazioni di dettaglio possono essere raccolte sul sito della società Ecogest all’indirizzo www.ecogestsrl.it
Progetti di educazione ambientale per le scuole
• “Gioca con i rifi uti in compagnia di Lello Separello”;
• “Rifi utArt il Riciclo dei Rifi uti un mondo fantastico”;
• “Ricicliamo Fumettando” messaggi ambientali trasmessi attraverso il potere comunicativo delle immagini
Progetti realizzati nel 2007 e nel 2008:
• Colorandia: un eco mondo a colori
• I Rifi uti la nostra storia
• Riciclotto: l’albero del riciclo
Progetti recenti:
• “Oli’ ola’ c’e’ una bella novita’…”; Progetto di sensibilizzazione alla raccolta dell’olio alimentare usato (olio vegetale);
• “Natura riciclona.. Sorriso alla persona”; Progetto di educazione ambientale sull’importanza del riciclaggio dei rifi uti per vivere in armonia con le persone e con la natura (progetto pensato per le Scuole degli Istituti di Istruzione Primaria).
• “Giornata Ecologica 2008”; Giornata ecologica per il fi ume PO
• “L’albero del riciclo”; Progetto di educazione ambientale sul consumo critico, sulla riduzione degli sprechi, sul riutilizzo e sul recupero dei rifi uti
impa rapporto.indd 77impa rapporto.indd 77 2-04-2009 19:20:312-04-2009 19:20:31

78RIFIUTI 04
Sintesi
Tipo indicatore Valutazione sintetica Trend
sistema di raccolta R a
Ecocentri R a
produzione totale di RSU S k
produzione di RSU pro-capite giornaliera S k
percentuale di raccolta differenziata S a
produzione di rifi uti per comune S f
composizione della raccolta differenziata I a
presenza di compostaggio domestico R a
produzione totale di rifi uti speciali S f
Politiche ed attività di sensibilizzazione ed educazione R a
D Causa determinate P Indicatore di pressione S Indicatore di Stato
I Indicatore di Impatto R Indicatore di Risposta
Condizioni positive Condizioni stazionarie Condizioni negative
Trend in crescita Trend stazionario Trend in diminuzione
a kf
impa rapporto.indd 78impa rapporto.indd 78 2-04-2009 19:20:312-04-2009 19:20:31

CONSERVAZIONE DELLA NATURA
E DELLA BIODIVERSITÀ
impa rapporto.indd 79impa rapporto.indd 79 2-04-2009 19:20:312-04-2009 19:20:31

80CONSERVAZIONE 06
Conservazione della natura e biodiversitàLa descrizione di un territorio non può prescindere da una attenta descrizione e illustrazione delle
valenze ambientali e delle aree protette. I parchi, le riserve, le varie oasi di naturalità sono riconosciuti, ormai diffusamente, come elementi fondamentali nella struttura del complesso territoriale. La loro buona gestione, secondo principi di valorizzazione del paesaggio storico, di integrazione delle attività antropiche e, nel contempo, di conservazione delle risorse naturali, è un compito imprescindibile per un uso equili-brato del territorio e delle sue risorse.
La nozione di biodiversità, già da tempo, viene comunemente inserita nei criteri orientativi della pianifi cazione degli interventi connessi alla tutela ambientale ed alla rinaturalizzazione del territorio. Le direttive europee 92/43/CEE, relativa alla protezione di habitat e specie, e 79/409/CEE (Uccelli), relativa alla tutela del patrimonio avifaunistico, sono divenuti riferimenti d’obbligo in questo senso, visto che con esse si è potuta strutturare una prima generale rete ecologica che ha collegato le principali aree protette fra loro.
La provincia di Rovigo, caratterizzata da numerosi piccoli centri e da un diffuso uso agricolo intensivo, non sfugge a queste dinamiche. Il cuore del sistema è nel Delta del Po dal quale, tramite il sistema fl u-viale, si irradia un sistema ecologico complesso e dinamico che si basa sugli equilibri di terre ed acque.
Fanno parte di questo sistema le golene, i gorghi, le aree naturali minori e piccole aree umide localiz-zate nel territorio della provincia.
impa rapporto.indd 80impa rapporto.indd 80 2-04-2009 19:20:312-04-2009 19:20:31

81 CONSERVAZIONE06
Rete Natura 2000Con la Direttiva Habitat 92/42/CEE è stato dato il via all’istituzione della Rete Ecologica Europea “Natu-
ra 2000” composta da un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali che vegetali, di interesse comunitario (indicati negli allegati I e II della Direttiva) la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo. L’insieme di tutti i siti defi nisce un sistema strettamente relazionato da un punto di vista funzionale.
Fanno parte della rete sia i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) previsti dalla Direttiva Europea 43/92/CEE per la protezione degli habitat che le aree destinate alla conservazione delle specie di uccelli deno-minate Zone di Protezione Speciale (ZPS).
I perimetri degli ambiti di Rete Natura 2000 sono stati approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 4003 del 16 dicembre 2008 e sono pubblicati sul sito internet della Regione Veneto.
Estensione di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)Complessivamente in Provincia di Rovigo sono stati individuati otto siti d’importanza comunitaria per
complessivi 25.846 ettari, localizzati quasi esclusivamente nel basso polesine. Rispetto al dato rilevato nel 2000 sono stati raggruppati molti siti di piccole dimensioni e complessivamente è aumentata la su-perfi cie di oltre 2.000 ettari. Nell’alto Polesine un sito interessa parzialmente il comune di Badia Polesine; il sito è IT3210042 Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine.
Per quanto riguarda le Zone di Protezione Speciale nella provincia sono presenti quattro siti che in-teressano un territorio di 25.402 ettari. L’incremento rispetto al 2002 è molto consistente ed è stato necessario al fi ne di rispondere a precise richieste fatte dalla Commissione Europea. La ZPS del Delta del Po interessa marginalmente territorio in Provincia di Venezia ed è contigua ai siti localizzati nella Regione Emilia Romagna.
L’estensione complessiva (territorio complessivamente interessato da SIC, ZPS o da entrambi) è pari a circa 28.500 ettari pari al 16% del territorio provinciale.
Codice Nome del sito Tipo Sup. (ha) Province
IT3270003 Dune di Donada e Contarina SIC 105 RO
IT3270004 Dune di Rosolina e Volto SIC 115 RO
IT3270005 Dune fossili di Ariano nel Polesine SIC 101 RO
IT3270006 Rotta di S. Martino SIC 32 RO
IT3270007 Gorghi di Trecenta SIC 20 RO
IT3270022 Golena di Bergantino ZPS 224 RO
IT3270024 Vallona di Loreo ZPS 64 RO
IT3270017 * Delta del Po: tratto terminale e delta veneto SIC 25.364 RO, VE
IT3270023 * Delta del Po ZPS 25.013 RO, VE
IT3210042 ** Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine SIC 2.090 PD, RO, VR
* parzialmente interessa anche un’altra provincia** parzialmente interessa anche la provincia di Rovigo
I siti di Rete Natura 2000 nella provincia di RovigoFonte: Regione Veneto, Servizio Rete Natura 2000 – Elaborazione: Agenda21Polesine
impa rapporto.indd 81impa rapporto.indd 81 2-04-2009 19:20:312-04-2009 19:20:31

82CONSERVAZIONE 06
IT3210042 œ IT3270003 œ IT3270004 œ œ IT3270005 œ IT3270006 œ IT3270007 œ IT3270017 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ IT3270022 œ œ œ IT3270023 œ œ œ œ œ œ œ œ IT3270024 œ
Comuni interessati dalla presenza di siti facenti parte di Rete Natura 2000Fonte: Regione Veneto, Servizio Rete Natura 2000 – Elaborazione: Agenda21Polesine:
Adr
ia
Gai
ba
Stie
nta
Aria
no P
oles
ine
Gua
rda
Vene
ta
Tagl
io d
i Po
Badi
a Po
lesi
ne
Lore
o
Trec
enta
Berg
antin
o
Mel
ara
Villa
nova
M.
Calto
Occ
hiob
ello
Cana
ro
Papo
zze
Cast
elm
assa
Pole
sella
Cast
elno
vo B
.
Port
o To
lle
Corb
ola
Port
o Vi
ro
Cres
pino
Roso
lina
Fica
rolo
Sala
ra
Sito d’Interesse Comunitario - SICZona di Protezione Speciale - ZPSSovrapposizione tra SIC e ZPS
impa rapporto.indd 82impa rapporto.indd 82 2-04-2009 19:20:312-04-2009 19:20:31

83 CONSERVAZIONE06
Aree naturali minori e ambiti tutelatiOltre alle aree individuate all’interno di rete Natura 2000 sono presenti nella provincia di Rovigo nume-
rose altre aree naturali. Grazie alle pubblicazioni ed ai lavori scientifi ci che hanno indagato il territorio è possibile individuare dei sistemi ecologici di minore dimensione, ma non di minore importanza, presenti nella provincia. Alcuni di questi si sovrappongono alle aree SIC e ZPS o fanno parte di aree tutelate con altri strumenti (aree che ricadono a ridosso del Parco Regionale Veneto del Delta del Po o oasi di prote-zione faunistica).
Esistono quindi differenti ambiti e fra questi meritano di essere evidenziati gli ambiti elencati nella ta-bella sottostante, rappresentati anche cartografi camente. Devono inoltre essere evidenziate le numerose aree umide minori, le golene, gli elementi caratteristici del Delta (valli, lagune, scanni, barene).
Sono inoltre state rappresentate le 13 garzaie individuate nella provincia. Col termine garzaia si inten-de il luogo in cui nidifi cano collettivamente le specie di Aironi con abitudini coloniali.
Località / descrizione Estensione Gestione / Info
Oasi naturalistiche e Riserve naturali
Isola boschina Sul fi ume Po, nel Comune di Bergantino 37 ha. WWF Rovigo
Isola di Tontola Sull’ansa del Po nel tratto tra Ficarolo e Gaiba 25 ha oasi fl oristica e faunistica
Golena della
Madonnina Cà Cornera
Oasi di protezione nel comune di Porto Viro 120 ha Legambiente Veneto
Boj della Feriana situato a Concadirame, frazione di Rovigo. ambiente umido ali-
mentato da falda sopravvissuto lungo l’Adige.
3 ha WWF Rovigo
Oasi golena di Ca’ Pisani si trova lungo la suggestiva “Via delle Valli” un percorso che si
snoda attraverso la laguna dominata dal verde delle tamerici e dei
salici, dal volo degli uccelli e dalla brezza marina.
43 ha Ente Parco Regionale
Veneto del Delta del Po
– Servizi forestali
Oasi golena di Panarella L’Oasi golena di Panarella, istituita nel 1995, è situata nel comune
di Papozze all’interno del Parco Regionale Veneto del Delta del Po
30 ha WWF Rovigo
Oasi di Volta Grimana Nel comune di Porto Viro, L’oasi è stata istituita dalla Provincia di
Rovigo nel 1991
Gruppo Iniziative per
l’ambiente di Porto Viro
Oasi golena Piarda La golena è situata tra Villanova Marchesana e Canalnovo, lungo
l’argine sinistro del Po.
38 ha WWF Rovigo
Giardino Botanico
Litoraneo di Porto Caleri
Il Giardino Botanico si trova a Rosolina Mare a circa 3 km dal
centro, in direzione Sud -Est
23 ha Servizio Forestale Regio-
nale di Padova e Rovigo
Riserva naturale
bocche di Po
Comuni: Porto Tolle, Rosolina, Porto Viro. Comprende 6 differenti
elementi fra cui bonelli, specchi d’acqua, canneti, argini.
424 ha Veneto Agricoltura
Parco Regionale Veneto
del Delta del Po
Istituito con Legge Regionale n. 36 del 8 luglio del 1997 interes-
sa il territorio dei comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Corbola,
Loreo, Papozze, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina , Taglio di Po
12.592 ha Ente Parco
Aree naturali minori
Paleoalveo “La Fossa di
Polesella” di Bresparola
Canale di notevole interesse storico e naturalistico situato tra
Arquà Polesine e Polesella.
8 ha
Golene boscate di Ber-
gantino
Estesa golena posta lungo il corso polesano del Po occupa-
ta da un bosco ripariale, alternato ad aree interessate da
pioppicoltura.
142 ha
impa rapporto.indd 83impa rapporto.indd 83 2-04-2009 19:20:322-04-2009 19:20:32

84CONSERVAZIONE 06
Laguna di Caleri compresa nel territorio di Rosolina ed è separata dal mare da
un ampio cordone dunoso
1.150 ha
Golena di Villanova
Marchesana
Ampia golena comprendente vecchie cave d’argilla 42 ha
Fossa Maestra o Emis-
sario
Canale di bonifi ca di notevole interesse storico e naturalisti-
co, nei comuni di Canda, Giacciano con Baruchella, Trecenta,
Badia Polesine, Bagnolo di Po
49 ha
Gorgo Giare Laghetto d’acqua dolce su paleo alveo, comune di Bergantino 2 ha
Gorgo Magarino Laghetto d’acqua dolce su paleo alveo, nel comune di Tre-
centa
2 ha
Bosco Vecchio (Case
Bovo)
Ambiente umido alimentato da falda lungo l’Adige nel co-
mune di Badia Polesine
11 ha
Canale Malopera Canale di bonifi ca di notevole interesse storico e naturalisti-
co, nei comuni di Giacciano con Baruchella, Trecenta, Badia
Polesine, Canda
38 ha
Cave di Danà Laghetti d’acqua dolce originatisi su antiche cave di argilla
nel comune di Ceneselli
6 ha
Gorgo Dolfi n Laghetto d’acqua dolce di origine naturale su paleo alveo nel
comune di Pincara
1 ha
Le Gorghe Laghetto d’acqua dolce di origine naturale su paleo alveo nel
comune di Fiesso Umbertiano
3 ha
Estensione degli ambiti naturalistici Sono presenti numerosi ambiti con elevata valenza ecologica, identifi cati come oasi di protezione fau-
nistica e tutelati in quanto meritevoli di attenzioni e perché siti meritevoli di tutela. In alcune di queste aree sono inoltre presenti emergenze faunistiche come nel caso del Giardino Botanico Litoraneo di Porto Caleri all’interno del quale è stata individuata la presenza del Pelobate fosco, anfi bio prettamente not-turno ritenuto estinto.
La cartografi a indica geografi camente la localizzazione di queste aree ad elevata naturalità.
Oasi naturalistiche e Riserve Naturali
Aree naturali minori
Garzaie
Altre aree naturali
Parco Regionale Veneto del Delta del Po - LR 36/97
Zone umide minori
Sistema delle dune fossili
Principali corsi d’acqua
impa rapporto.indd 84impa rapporto.indd 84 2-04-2009 19:20:322-04-2009 19:20:32

85 CONSERVAZIONE06
FaunaNell’ambito delle attività connesse con la gestione faunistica, l’aspetto propedeutico della raccolta
e dell’organizzazione di informazioni su popolazioni ornitiche oggetto di intervento, acquista un rilievo particolare.
Il monitoraggio degli uccelli acquatici svernanti è una delle attività di maggior rilievo a livello conti-nentale in quanto, essendo effettuato quasi in contemporanea in tutta Europa, permette di ottenere una fotografi a attendibile dello status e della distribuzione delle varie specie. Nella Provincia di Rovigo tali censimenti interessano particolarmente le valli del Delta del Po.
Censimenti della fauna svernanteIl Censimento Internazionale degli Uccelli Acquatici (International Waterfowl Census) è coordinato
all’International Waterfowl Research Bureau (IWRB), il quale raccoglie i dati e li elabora a livello europeo. In Italia i conteggi sono coordinati dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e nella Provincia di Rovigo a coordinare l’attività è l’area attività produttive.
I dati raccolti mostrano una situazione generale di crescita di individui presenti che sono passati da una presenza compresa tra 60.000 ed 80.000 individui per il periodo 1997-2000, a una popolazione sempre superiore ai 120.000 individui a partire dal 2002 (tranne per il 2004). In particolare proprio il 2008 ha fatto registrare il massimo assoluto di presenze, con oltre 163.000 acquatici censiti.
Tale positivo incremento è da attribuire all’interazione di vari fattori, tra cui:
• generale incremento di determinate specie a livello europeo;
• gestione faunistico-venatoria sempre più effi cace delle aree vallive;
• effetto della creazione di nuove aree di rifugio (Parco del Delta).
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Numero presenze 60.845 78.363 70.297 72.268 93.446 136.885 135.271 105.059 125.769 141.211 123.653 163.257
Variazione - 28,8% -10,3% 2,8% 29,3% 46,5% -1,2% -22,3% 19,7% 12,3% -12,4% 32,0%
Censimento di metà gennaio - provincia di Rovigo, 1997 - 2008
Fonte: Provincia di Rovigo, Area Attività Produttive – Elaborazione: Agenda21Polesine
0
2 0 . 0 0 0
4 0 . 0 0 0
6 0 . 0 0 0
8 0 . 0 0 0
1 0 0 . 0 0 0
1 2 0 . 0 0 0
1 4 0 . 0 0 0
1 6 0 . 0 0 0
1 8 0 . 0 0 0
1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8
Se r ie 1
L in e a re (Se rie 1 )
Censimenti di metà gennaio nella provincia di Rovigo, 1997 - 2008Fonte: Provincia di Rovigo, Area Attività Produttive – Elaborazione: Agenda21Polesine
impa rapporto.indd 85impa rapporto.indd 85 2-04-2009 19:20:332-04-2009 19:20:33

86CONSERVAZIONE 06
Specie dell’allegato I direttiva uccelli Sono state censite 25 specie di uccelli acquatici: 2 specie di Phalacrocoracidae (Cormorano e Maran-
gone minore), 5 di Ardeidae (Airone bianco maggiore, Garzetta, Airone cenerino, Airone guardabuoi, Nitticora), 18 di Anseriformes; per quest’ultimo gruppo è stato rilevato un totale variabile di individui.
Alcune specie sono risultate particolarmente numerose, come ad esempio il Fischione (Anas penelo-pe). In diverse occasioni è stata accertata la presenza di specie particolarmente rare e comprese nell’Al-legato I della Direttiva Uccelli.
Grazie ad analisi approfondite come queste è stato possibile far luce su alcune dinamiche, quali ad esempio la dispersione diurna degli uccelli ittiofagi, gli spostamenti giornalieri degli anatidi tra le valli da pesca e il litorale antistante, ed avere un quadro delle preferenze ambientali delle varie specie.
Ulteriori studi per approfondire le questioni legate alla fauna saranno pubblicati dai faunisti veneti in associazione con l’Ente Veneto Agricoltura e la Provincia di Rovigo.
La tabella che segue evidenzia per ogni specie d’uccello (sono state inserite le specie più signifi canti) la presenza di coppie nidifi canti, svernanti ed il maggior numero rilevato al passo.
UCCELLI – Delta del Po SVERNANTE (97-02) NIDIFICANTE
(Coppie) 2002
n° più al passo
(1999-2000)
Direttive Altro
Airone bianco maggiore 395 (170 - 1000) All. I Dir. Uccellli specie Ramsar
Airone cenerino 557 (400 - 900) 150
Airone rosso 35 - 40 All. I Dir. Uccellli
Albanella minore 10 _ 15 All. I Dir. Uccellli
Albanella reale 12 (8 - 20) All. I Dir. Uccellli
Averla cenerina 2 _ 4 All. I Dir. Uccellli
Avocetta 540 (30 - 1000) 100 All. I Dir. Uccellli
Barbagianni 50 - 80
Canapiglia 123 (20 - 220) 5 _ 15 Lista Rossa it. - All. I Dir. Uccellli
Cavaliere d'Italia 200 All. I Dir. Uccellli
Cicogna bianca 9 All. I Dir. Uccellli
Codone 512 (120 - 1600) All. I Dir. Uccellli
Combattente 1 (0 - 2) 300 All. I Dir. Uccellli
Cormorano 3500 (1600 - 5400)
Falco di palude 48 (40 - 65) 10 _ 20 All. I Dir. Uccellli
Fenicottero 67 (0 - 150) 1200 All. I Dir. Uccellli
Fischione 27800 (8600 - 62400) specie Ramsar
Fistione turco 1 (0 - 3) 1 _ 5 All. I Dir. Uccellli
Folaga 8500 (7000 - 9000) ?
Fraticello 350 All. I Dir. Uccellli
Fratino 48 (20 - 100) 5 _ 10
Gabbiano comune 11300 (7000 - 15000) ?
Gabbiano corallino 1 (0 - 4) 1 All. I Dir. Uccellli
Gabbiano reale 5900 (3500 - 9500) ?
Garzetta 537 (320 - 620) 250 All. I Dir. Uccellli
impa rapporto.indd 86impa rapporto.indd 86 2-04-2009 19:20:342-04-2009 19:20:34

87 CONSERVAZIONE06
Germano reale 8600 (4000 - 16500) ?
Marangone dal ciuffo 1 (0 - 2) All. I Dir. Uccellli
Marangone minore 12 (0 - 73) 150 All. I Dir. Uccellli
Marzaiola 200 All. I Dir. Uccellli
Mignattaio 2 All. I Dir. Uccellli
Mignattino 4000 All. I Dir. Uccellli
Moretta tabaccata 0 - 1 Lista Rossa it. - All. I Dir. Uccellli
Moriglione 900 (400 - 1200) 10
Nitticora 100 (0 - 140) 60 - 80 All. I Dir. Uccellli
Pesciaiola 0 - 5 All. I Dir. Uccellli
Pettegola 28 (7 - 45) 10
Piovanello pancianera 4100 (2400 - 5000)
Pittima reale 7 (0 - 34) 1000
Piviere dorato 34 (0 - 80) All. I Dir. Uccellli
Sgarza ciuffetto 10 _ 15 All. I Dir. Uccellli
Smergo maggiore 1 (0 - 5)
Smergo minore 60 (25 - 100)
Spatola 1 (0 - 7) 8 All. I Dir. Uccellli
Sterna comune 400 All. I Dir. Uccellli
Sterna zampenere 230 All. I Dir. Uccellli
Strolaga mezzana 2 (0 - 7) All. I Dir. Uccellli
Strolaga minore 0 - 1 All. I Dir. Uccellli
Svasso cornuto 0 - 2 All. I Dir. Uccellli
Svasso piccolo 1650 (1000 - 2600) specie Ramsar
Tarabuso 2 (0 - 4) All. I Dir. Uccellli
Tarbusino 30 - 50 All. I Dir. Uccellli
Volpoca 600 (60 - 1950) 50 - 100
Fonte: Faunisti Veneti
impa rapporto.indd 87impa rapporto.indd 87 2-04-2009 19:20:342-04-2009 19:20:34

88CONSERVAZIONE 06
Recupero animali selvatici Il Centro Recupero Animali Selvatici (C.R.A.S.) della Provincia di Rovigo prende vita nel 2003, grazie
all’impegno della Provincia, del veterinario Luciano Tarricone e delle Associazioni fondatrici WWF di Ro-vigo e Lipu di Adria. Lo scopo è di curare e reimmettere in natura quegli individui di specie selvatiche di particolare interesse naturalistico rinvenuti feriti o debilitati all’interno del territorio provinciale. Altra im-portante funzione del Centro, che ha sede a Garofolo di Canaro (RO), è l’educazione ambientale, correlata con le attività di recupero della fauna.
Numero individui recuperatiNel triennio d’attività del C.R.A.S. 2004-06 sono stati ricoverati 219 individui appartenenti alla Fauna
selvatica, tutti provenienti dalla provincia di Rovigo, e costituiti da 206 Uccelli (94 %), 5 Mammiferi e 7 Rettili. Il numero medio d’individui ricoverati all’anno è stato di 73, ovvero 1 o 2 animali alla settimana.
La maggior parte dei recu-peri ha interessato uccelli e fra questi maggiore è la presenza di rapaci notturni e diurni. I primi sono molto spesso ur-tati e quindi feriti durante la notte a causa delle vetture che sfrecciano lungo le strade secondarie. Elevato anche il numero di ardeidi recuperati.
Fra i rettili da segnalare tre testuggine Caretta caretta.
-aaI-aeenumero di ardeidi recuperati
2004 2005 2006 N° totale individui
Uccelli 74 66 67 207
Mammiferi 1 2 2 5
Rettili 4 1 2 7
totale 79 69 71 219
Animali recuperati e curati presso il C.R.A.S. anni 2004 – 2006
Fonte: Il Centro Recupero Animali Selvatici della Provincia Di Rovigo, sintesi attività
Percentuale di animali recuperati e curati presso il C.R.A.S. anni 2004 – 2006 Fonte: Il Centro Recupero Animali Selvatici della Provincia Di Rovigo, sintesi attività
9 3 , 7 %
9 5 , 7 %
9 4 , 4 %
1 , 3 %
2 , 9 %
2 , 8 %
5 , 1 %
1 , 4 %
2 , 8 %
0 % 1 0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 7 0 % 8 0 % 9 0 % 1 0 0 %
2 0 0 4
2 0 0 5
2 0 0 6
Uc c e ll i M a m m ife ri Re ttili
impa rapporto.indd 88impa rapporto.indd 88 2-04-2009 19:20:352-04-2009 19:20:35

89 CONSERVAZIONE06
Cause di incidenteLe principali cause di ricovero presso il centro sono da ricondurre a fratture alle ali, e quindi traumi e
fratture da urti, spesso contro veicoli. Gli altri motivi appaiono meno importanti ma meritano di essere segnalati le intossicazioni e gli avvelenamenti. Le ferite da fuoco, attribuibili ad attività di bracconaggio, risultano poco numerose (3 nel 2004, 2 nel 2005 e 2006).
el 2004 2005 2006 Totale
Ferite e fratture alle ali 19 12 25 56
Altre lesioni e fratture 9 19 14 42
Pullus recuperato 8 2 8 18
Debilitazione 8 5 3 16
Trauma cranico 2 6 7 15
Avv. ed intossicazione 5 3 4 12
Ferite e fratture alle zampe 5 5 2 12
Altro* 15 16 8 39
* Parassitosi ed infezioni, Ferite da arma da fuoco, Shock, Paralisi, Altro
Motivi di ricovero presso il C.R.A.S. anni 2004 – 2006
Fonte: Il Centro Recupero Animali Selvatici della Provincia Di Rovigo, sintesi attività
Motivi di ricovero presso il C.R.A.S. anni 2004 – 2006Fonte: Il Centro Recupero Animali Selvatici della Provincia Di Rovigo, sintesi attività
0
5
1 0
1 5
2 0
2 5
Fe r ite e fr a ttu re
a lle a li
Altre le s io n i e
fratture
Pu llu s
re c u p e ra to
De b il ita z io n e Tra u m a c ra n ic o A v v . e d
in to s s ic a z io n e
Fe r ite e fra ttu re
a lle z a m p e
Altro *
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6
impa rapporto.indd 89impa rapporto.indd 89 2-04-2009 19:20:352-04-2009 19:20:35

90CONSERVAZIONE 06
Pressione venatoriaUna delle pressioni presente nel territorio che infl uisce sulla quantità e qualità della fauna selvatica
presente è senz’altro l’attività venatoria, gestita nella Provincia di Rovigo da apposito Piano Faunistico Venatorio.
Per valutare la pressione esercitata dall’attività venatoria nella Provincia di Rovigo è stato considerato il numero di cacciatori iscritti negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia. La L.157/1992 ha reso obbligatoria l’iscrizione per poter esercitare l’attività venatoria. Ogni cacciatore può iscriversi a più ambiti ma se non è iscritto non può esercitare l’attività.
Complessivamente il territorio sul quale è possibile effettuare attività di caccia è APRI A 89.181 ettari pari a quasi il 50% della superfi cie della provincia.
Nel corso del 2009 la superfi cie disponibile nell’area del Delta del Po potrà variare in base alle indica-zioni del Piano del Parco (o Piano Ambientale) in corso di redazione da parte dell’Ente Regionale Parco Delta del Po Veneto.
Ambiti Territoriali di Caccia ATC
ATC Ro1
ATC Ro2
ATC Ro3
Aziende Agrituristiche Venatorie
Aziende faunistico venatorie di terra
Aziende faunistico venatorie vallive
Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica
Parco Regionale Veneto del Delta del Po - LR 36/97
Oasi di protezione
Oasi di protezione faunistica
impa rapporto.indd 90impa rapporto.indd 90 2-04-2009 19:20:362-04-2009 19:20:36

91 CONSERVAZIONE06
Numero di cacciatoriComplessivamente nel-
la Provincia di Rovigo sono presenti 4259 cacciatori per la stagione venatoria 2008-2009.
Il dato analizzato per Am-bito di caccia vede il maggior numero di cacciatori presenti nell’ambito centrale, seguito dall’ATC Ro2 dell’Alto Polesi-ne e dall’ATC del Basso Pole-sine.
Negli anni il numero di cacciatori è andato calando con una diminuzione netta di 100 unità tra la stagio-ne 2004/2005 alla stagione 2008/2009. Il calo maggio-re è nell’Ambito di caccia dell’Alto Polesine, mentre nel Basso Polesine, nonostante sia evidente il calo numerico, la linea di tendenza è mode-ratamente positiva.
Cacciatori per ettaroIl calo generale di numero di cacciatori ha infl uito nel rapporto tra numero di cacciatori e territorio cac-
ciabile. Se nel 2001 il valore era di 0,051 cacciatori per ettaro nell’ultima stagione il valore è stato 0,047 facendo registrare un discreto calo.
-o r -
-r ti
2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
ATC Ro1 1.538 1.548 1.503 1.478 1.465
ATC Ro2 1.630 1.667 1.671 1.613 1.617
ATC Ro3 1.191 1.159 1.160 1.237 1.177
Totale 4.359 4.374 4.334 4.328 4.259
Numero di cacciatori per ambito dal 2004 al 2008
Fonte: Provincia di Rovigo, Area Attività Produttive – Elaborazione:Agenda21Polesine
A.T.C. ha
n.
cacc.
Cacciatori
per ettaro
Territorio
cacciatore
RO1 37.580 1.465 0,038 25,65
RO2 30.611 1.617 0,052 18,93
RO3 20.990 1.177 0,056 17,83
Provincia 2008 89.181 4.259 0,047 20,94
Provincia 2001 87.533 4.439 0,051 19,71
Cacciatori per ettaro cacciabile
Fonte: Provincia di Rovigo, Area Attività Produttive –
Elaborazione:Agenda21Polesine
Numero di cacciatori per ambito dal 2004 al 2008Fonte: Provincia di Rovigo, Area Attività Produttive – Elaborazione:Agenda21Polesine
1 . 0 0 0
1 . 1 0 0
1 . 2 0 0
1 . 3 0 0
1 . 4 0 0
1 . 5 0 0
1 . 6 0 0
1 . 7 0 0
2 0 0 4 / 2 0 0 5 2 0 0 5 / 2 0 0 6 2 0 0 6 / 2 0 0 7 2 0 0 7 / 2 0 0 8 2 0 0 8 / 2 0 0 9
A T C R o 1 A T C R o 2 A TC R o 3
L in e a re (A TC R o 1 ) L in e a re (A TC R o 2 ) L in e a re (A TC R o 3 )
impa rapporto.indd 91impa rapporto.indd 91 2-04-2009 19:20:362-04-2009 19:20:36

92CONSERVAZIONE 06
Tipo indicatore Valutazione sintetica Trend
Estensione di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) S
Estensione degli ambiti naturalistici S
Censimenti della fauna svernante R
Specie dell’allegato I direttiva uccelli R
Numero individui recuperati R
Cause di incidente S
Numero di cacciatori I
Cacciatori per ettaro I
a
a
k
k
f
f
f
f
a kf
P Indicatore di pressione I Indicatore di Impatto R Indicatore di Risposta
Condizioni positive Condizioni stazionarie Condizioni negative
Trend in crescita Trend stazionario Trend in diminuzione
Sintesi
impa rapporto.indd 92impa rapporto.indd 92 2-04-2009 19:20:372-04-2009 19:20:37

AMBIENTE URBANO
impa rapporto.indd 93impa rapporto.indd 93 2-04-2009 19:20:372-04-2009 19:20:37

94AMBIENTE URBANO 06
Ambiente urbano e comunità locali
Le città rappresentano i luoghi in cui maggiormente si concentrano gli impatti negativi per l’ambiente con conseguenze dirette sulla qualità della vita degli abitanti. Le cause di tali impatti sono da attribuire fondamentalmente al crescente fenomeno della urbanizzazione, all’incremento della densità della po-polazione e all’aumento dell’entità del traffi co veicolare privato,pubblico e commerciale. La possibilità di predisporre interventi effi caci per la risoluzione del problema ambientale, in termini soprattutto di riduzione degli impatti determinati dalle pressioni sull’ambiente, dipende in larga misura dalla possibilità di disporre di informazioni corrette sul fenomeno e sulle correlazioni che lo legano ad altre dinamiche di carattere sociale ed economico. Un’adeguata conoscenza del fenomeno è raggiungibile soltanto con un’informazione ambientale continua ed accurata, che consenta di rappresentare la realtà nel suo evol-versi e, quindi, appurare se effettivamente gli interventi correttivi eventualmente effettuati abbiano prodotto effetti positivi.
Con gli inizi del nuovo millennio oltre il 70 % della popolazione mondiale vive nelle città ed entro il 2025 saranno oltre 5 i miliardi di abitanti che risiederanno in contesti urbani e in 135 aree metropolitane il numero dei residenti supererà 4 milioni ciascuno.
In ambito europeo la percentuale di cittadini urbani è già più alta, indicativamente 80 % (l’oscillazione è più che altro dovuta a cosa intendiamo per “urbano”) e comunque la maggior parte degli abitanti ha uno stile di vita di tipo urbano. Si spostano verso un centro o un’area centrale, fanno acquisti nelle città o nei centri commerciali circostanti, oltre a richiedere “pacchetti” di un’ offerta sociale e culturale creati sempre nelle città. Vivono, lavorano e svolgono le attività più varie all’interno di edifi ci o comunque nell’ambito di un ambiente costruito. Dipendono in larga parte dalle strutture sanitarie e assistenziali e viaggiano costantemente all’interno dell’area urbana per raggiungere tutti i luoghi più o meno necessari al loro mantenimento (Whitelegg, 2001).
La rifl essione sul concetto di ambiente urbano o costruito (built environment) è molto sviluppata nella letteratura anglosassone:
«[…] built Environment, includes roads and other transport corridors, but also housing and residential areas, commercial centers, pipelines and utilities, all of which have particular infl uences on the urban environment. Street trees are an integral feature of many built-up areas in towns and cities. Some urban environmental studies have concerned nature conservation during construction and development. The extent of the built environment in cities has important effects on urban hydrology and climate. Expanding areas of development result in urbanization – either the spread of a city outwards or the encroachment of built-up areas onto existing open spaces» (Kern, 1999).
I recenti processi di rapida urbanizzazione hanno progressivamente acuito una serie di problemi che direttamente incidono sulla qualità della vita quotidiana degli abitanti negli spazi urbani: aumento della disoccupazione, cambiamenti della condizione abitativa (quantitativa e qualitativa), deterioramento delle infrastrutture e dei servizi socio sanitari, diminuzione degli spazi pubblici, crescita delle città per diffusio-ne e dispersione degli insediamenti e conseguenti diffi coltà ad organizzare servizi di trasporto pubblico collettivi e suffi cientemente competitivi rispetto all’automobile.
impa rapporto.indd 94impa rapporto.indd 94 2-04-2009 19:20:372-04-2009 19:20:37

95 AMBIENTE URBANO06
La sezione del rapporto dedicata all’ambiente urbano e alle sue relazioni con i servizi alla comunità raccoglie una serie di dati ed indicatori relativi all’ambiente urbano nella sua accezione più ampia: in quest’ottica si sono fatte rientrare in questo capitolo anche considerazioni sul sistema economico, sui rischi antropici e sulle pressioni esercitate da attività umane.
Fanno parte di questo capitolo anche i dati relativi alle attività culturali, all’istruzione e le informazioni sia del sistema museale che del sistema bibliotecario, intesi come servizi alle città e ai loro abitanti.
Sono presenti dati sul consumo e sulla produzione di energia elettrica, in particolare sulla produzione da fonti rinnovabili. Inoltre è presente anche un capitolo sull’impegno ambientale delle aziende della provincia di Rovigo, impegno testimoniabile con il raggiungimento della certifi cazione ambientale o la registrazione EMAS.
Nella prima parte del capitolo sono sintetizzati i dati raccolti tramite questionari inviati ai comuni della provincia; va segnalato che non tutte le amministrazioni comunali hanno collaborato all’indagine, in ogni caso, qual’ora pervenissero nuovi dati successivamente alla chiusura del rapporto, saranno inseriti nei prossimi aggiornamenti del rapporto.
impa rapporto.indd 95impa rapporto.indd 95 2-04-2009 19:20:372-04-2009 19:20:37

96AMBIENTE URBANO 06
Elaborazione questionari inviati ai comuni
Comuni che hanno risposto ai questionari di A21 Polesine La fase di raccolta dati è stata
compiuta attraverso l’utilizzo di di-verse fonti. Per meglio comprende-re l’uso del suolo a livello comunale, la dotazione di servizi e l’adozione di strumenti urbanistici (Piano acu-stico, Piano Urbano del Traffi co,…) è stato redatto un apposito questio-nario inviato, a metà novembre, ai Sindaci di tutti i Comuni della pro-vincia di Rovigo.
I comuni che hanno risposto costituiscono il 66,4 % del territo-rio provinciale e rappresentano il 79,8% della popolazione.
a--
e,e-è-i-
o-l
Totale Sup. terr. Kmq Completezza
delle risposte
Ricezione
risposte
Adria 20.457 113,5 50% 05-nov-08
Badia Polesine 10.877 44,5 90% 02-mar-09
Bagnolo di Po 1.425 21,4 100% 16-dic-08
Bosaro 1.376 6,0 100% 05-nov-08
Calto 815 11,0 100% 28-nov-08
Canaro 2.880 32,7 50% 26-nov-08
Castelguglielmo 1.718 22,1 100% 12-dic-08
Castelmassa 4.434 11,9 100% 14-nov-08
Castelnovo Bariano 3.039 37,6 100% 25-nov-08
Ceregnano 3.876 30,0 90% 15-dic-08
Corbola 2.629 18,4 20% 04-dic-08
Crespino 2.119 31,9 100% 14-nov-08
Fiesso Umbertiano 4.219 27,3 90% 18-feb-09
Frassinelle Polesine 1.539 21,9 70% 20-nov-08
Fratta Polesine 2.763 20,9 50% 13-feb-09
Gaiba 1.121 12,1 90% 25-nov-08
Gavello 1.618 24,4 90% 14-nov-08
Lendinara 12.212 55,4 70% 28-nov-08
Loreo 3.790 39,6 70% 05-nov-08
Lusia 3.613 17,7 70% Più risposte
Melara 1.925 17,6 100% 14-nov-08
Occhiobello 11.199 32,6 100% 10-feb-09
Pettorazza Grimani 1.692 21,5 70% 05-nov-08
Pincara 1.289 17,8 90% Più risposte
Porto Viro 14.596 133,4 50% 02-mar-09
Rosolina 6.416 73,1 70% 09-dic-08
Rovigo 51.604 108,6 20% Più risposte
Salara 1.217 14,3 100% 10-nov-08
San Bellino 1.196 15,8 100% Più risposte
San Martino di Venezze 4.014 31,1 100% 19-dic-08
Stienta 3.263 24,1 100% 28-nov-08
Trecenta 3.032 35,1 100% 04-dic-08
Villadose 5.303 32,5 90% 24-nov-08
Villanova del Ghebbo 2.189 11,8 90% 09-dic-08
Villanova Marchesana 1.053 18,2 90% 11-dic-08
Totale tra chi ha risposto 196.508 1187,7 (media) 82%
Totale provinciale 2007 246.255 1789,9
Risposte ai questionari di Agenda 21 PolesineFonte: Agenda21Polesine
impa rapporto.indd 96impa rapporto.indd 96 2-04-2009 19:20:372-04-2009 19:20:37

97 AMBIENTE URBANO06
Questionario inviato ai Comuni
della provincia di Rovigo
fonte: Agenda21Polesine (2008)
impa rapporto.indd 97impa rapporto.indd 97 2-04-2009 19:20:372-04-2009 19:20:37

98AMBIENTE URBANO 06
Risultati dei questionariUtilizzando i dati forniti dai Comuni è stato possibile realizzare una serie di analisi e di valutazioni
complessive.
Il Laboratorio Territoriale Ambientale La.Terr.A. continuerà la raccolta delle informazioni per permettere la copertura totale dei comuni della provincia nelle prossime edizioni del rapporto. I dati sono inoltre stati incrociati con i risultati di precedenti questionari e con altre fonti al fi ne di fornire un quadro esaustivo. Una delle fonti con cui è stato effettuato il confronto è il precedente questionario inviato sempre a tutti i comuni per il precedente rapporto del 2003.
Aree pedonali e piste ciclabili Una delle domande riguardava la presenza, all’interno del tessuto urbano, di aree pedonali; per area
pedonale si intende una zona della città interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza e salvo deroghe particolari. Si tratta quindi di aree destinate specifi catamente al movimento dei pedoni.
Diffi cilmente i comuni piccoli hanno la necessità di realizzare delle isole pedonali, ed i dati hanno avva-lorato questa ipotesi. Negli abitati di medio piccole dimensioni la circolazione nelle aree centrali comun-que non compromette la vivibilità dei luoghi e la possibilità, per i residenti e non, di circolare senza essere particolarmente disturbati dalla presenza di veicoli.
Queste aree sono infatti presenti nel comune ca-poluogo e nei centri di Adria (poco oltre 5.000 m2), Loreo (con 2.100 m2), Melara e San Bellino.
Per le piste ciclabili è da evidenziare l’incremento complessivo registrato in provincia dal 2003 ad oggi. Nel 2003 pochi comuni avevano segnalato la pre-senza di piste ciclabili; ad oggi alcuni comuni hanno raddoppiato la dotazione complessiva (Rovigo, Adria, Trecenta) mentre molti altri indicano una consisten-za importante. Ad esempio il Comune di Rosolina dopo la realizzazione della nuova pista ciclabile è arrivato ad avere circa 10 km.
Questa valutazione non permette tuttavia di ra-gionare compiutamente sulla qualità e sulla tipolo-gia di queste piste ciclabili.
Esistono inoltre progetti più ampi e vasti che pre-vedono l’utilizzo degli argini come vie ciclopedona-li.
i-e-aai
-,
o.-o,-aè
--
--
Comunearee pedonali e
ZTL (m²)piste ciclabili (km)
2003 2008 2003 2008
Adria 2.800 5050 3,5 6,4
Badia Polesine 1.500 1.500 1,1 1,8
Corbola - - - 5,3
Crespino - - - 1,1
Frassinelle P. - - - 4,0
Fratta Polesine - - - 0,8
Gaiba - - - 0,4
Lendinara - - - 2,0
Loreo - 2.100 - no
Melara - 1.500 - no
Occhiobello - - - 5,0
Pettorazza G. - - - 0,4
Pincara - - - 1,5
Porto Viro - - - 4,8
Rosolina - 1.200 - 10,0
Rovigo - 56.000 10,0 21,7
S.Martino Di V. - - - 2,5
San Bellino - 500 - 2,0
Stienta - - - 0,2
Trecenta - - 3,4 6,0
Villadose - - 0,5 0,8
Aree pedonali e piste ciclabili nella provincia di RovigoFonte: questionari – Elaborazione Agenda21Polesine
impa rapporto.indd 98impa rapporto.indd 98 2-04-2009 19:20:382-04-2009 19:20:38

99 AMBIENTE URBANO06
Piano Urbano del Traffi coTra gli strumenti di governo urbano, fi nalizzati al contenimento degli inquinanti in ambiente urbano
vanno segnalati i Piani Urbani del Traffi co (PUT) e i Piani di Zonizzazione Acustica.
I PUT sono disciplinati dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285), che ne impone la redazione ai Comuni con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti, nonché ai Comuni comun-que interessati da rilevanti problematiche di circolazione stradale. Il PUT è confi gurato come un insieme coordinato di interventi per il miglioramento delle condizioni della circolazione stradale, nell’area urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati: tali interventi debbono poter essere realizzati nel bre-ve periodo – un biennio – e nell’ipotesi di dotazioni e di mezzi di trasporto sostanzialmente invariate. La fi nalità del PUT è quella di contenere al massimo le criticità della circolazione, in una logica di comple-mentarietà con il Piano dei Trasporti.
Nel comune capoluogo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 328 del 22.12.2005 è stato adottato il Piano Generale del Traffi co Urbano; tale strumento non è ancora stato adottato dal Consiglio Comunale. Gli elaborati, depositati presso la Segreteria Comunale possono essere consultati presso il Settore Mobili-tà, Trasporti, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, e sono inoltre consultabili tramite sito internet del Comune di Rovigo.
Altre amministrazioni dotate di PUT sono Adria e Rosolina. Entrambi sono stati adottati nel 1997 e in questi anni hanno permesso di mettere in atto una serie di interventi che hanno inciso sulla circolazione del traffi co.
ZTL e Aree Pedonali del Comune di Rovigo.Fonte: PUT Tav 16 – Elaborazione: Agenda21Polesine
impa rapporto.indd 99impa rapporto.indd 99 2-04-2009 19:20:382-04-2009 19:20:38

100AMBIENTE URBANO 06
Strutture per tempo libero e sportNell’indagine tra i comuni sono state richieste informazioni relative all’offerta di servizi per lo sport e le
attività all’aria aperta localizzate nel territorio comunale. Alcune di queste strutture sono pubbliche, altre sono invece strutture private che possono essere aperte al pubblico. Non sono elencate strutture private o appartenenti a circoli privati.
Il Comune di Rovigo essendo capoluogo di provincia ed avendo oltre 50.000 abitanti risulta avere la maggior copertura di servizi per il tempo libero e lo sport. Risultano infatti presenti strutture come un centro per la scherma, un bocciodromo, un poligono di tiro, un pattinodromo e numerose palestre private per lo svolgimento di attività fi sica. Non sono stati inseriti questi dati perché la scala dimensionale non permetterebbe un adeguato confronto.
Il risultato complessivo è abbastanza soddisfacente. In tutti i comuni è presente almeno un campo da tennis e sono diffuse anche le palestre (spesso legate a complessi scolastici) e altre strutture come campi da beach volley.
impa rapporto.indd 100impa rapporto.indd 100 2-04-2009 19:20:392-04-2009 19:20:39

101 AMBIENTE URBANO06
Comune
Campo calcio Palestra (basket / volley) Piscina
Altre strutturen.
str
uttu
re
capi
enza
utili
zzaz
ione
gg/
anno
n. s
trut
ture
capi
enza
utili
zzaz
ione
gg/
anno
n. s
trut
ture
capi
enza
utili
zzaz
ione
gg/
anno
Adria
12 2.000 360 14 1.500 360 1 1.000 360
1 autodromo, 1 tiro a segno nazionale,
4 campi di calcio a cinque, 2 campi da
beach volley, 1 pista di atletica leggera
Badia Polesine 5 473 365 6 482 360 1 150 1 campo rugby, con 764 posti
Bagnolo Di Po 1 200 1 1 campo da tennis
Bosaro 1 100 200
Calto 1 200 10
Canaro 2 200 150 1 100
Castelguglielmo 1 300 1 150 1 campo da tennis
Castelmassa 3 1 200 300 1 150 340 3 campi da tennis, 1 beach volley
Castelnovo B. 2 200 150 1 20 200 1 campo da tennis
Ceregnano 1 60 50 2 40 50
Corbola 1 1
Crespino 1 200 360 1 360
Fiesso Umber-tiano
2 2.000 360 2 200 360
Frassinelle P. 1 150 360 1 200 1 c. rugby, 1 campo da tennis
Fratta Polesine 2 200 1 1 pattinaggio rotelle, 1 campo tennis
Gaiba 2 95 200 1 campo da tennis, 1 polifunzio-nale
Gavello 1 500 360 1 360
Lendinara 4 5 1 p. pattinaggio, 2 polivalenti, 4 tennis
Loreo 1 800 1 1 campo da tennis
Lusia 2 99+30 1 99 1 pista polivalente, 1 calcetto
Melara 1 80 100 1 100 100 1 campo da tennis
Occhiobello 2 99 360 3 99 360 1 83 360
Papozze
Pettorazza G. 1 250 300 1 200
Pincara 1 100 100 1 50
Porto Viro 5 3.500 8 1000 1
Rosolina 4 1.500 360 1 250 10 1.000 90 29 c. tennis, 1 equitazione, 1 golf
Salara 1 90 100 1 60 1 campo da tennis
San Bellino 1 200 gen-dic 1 pista polifunzionale
Stienta 1 300 360 1 360 1 area polivalente
Trecenta 1 300 360 1 360 1 campo da tennis, 1 polivalente
Villadose 1 50 180 1 campo da rugby
Villanova Del G. 1 200 1 210 1 bocciodromo, 1 tennis, 2 calcetto
Villanova M. 1 50 120 1 200
Strutture per il tempo libero e lo sportFonte: questionari Agenda21Polesine (2008)
impa rapporto.indd 101impa rapporto.indd 101 2-04-2009 19:20:392-04-2009 19:20:39

102AMBIENTE URBANO 06
Strutture per attività culturali
Associazioni sportive e culturaliRispetto alla dotazione di spazi per attività culturali, per attività teatrali, la presenza di biblioteche pub-
bliche, cinema, teatri presenti nel territorio ed a disposizione dei cittadini, alcuni questionari non sono stati correttamente compilati dalle amministrazioni locali e sicuramente mancano nell’elenco alcune strutture.
Risultano capillarmente presenti le biblioteche (almeno una per comune) molte delle quali danno la possibilità di utilizzare anche strumenti informatici per la navigazione in internet e per l’uso di materiale multimediale. Le biblioteche fanno parte del Sistema Bibliotecario Provinciale (SBP) che permette inoltre l’interscambio di testi e la prenotazione di volumi all’interno di un database condiviso, quindi molto vasto ed interessante.
I cinema sono concentrati nei centri maggiori (Adria, Badia, Porto Viro e Rovigo) mentre le sale teatrali risultano maggiormente distribuite. Più diffi cile è valutare le modalità di utilizzo di queste sale teatrali usate dalle diverse amministrazioni per attività culturali.
Va segnalato che la chiusura del cinema Odeon al 31/12/2008 avrà effetti ambientali negativi per l’incremento della mobilità dal centro di Rovigo all’area commerciale a sud dell’area urbana dove rimane l’unico cinema (multisala) della città. Tali impatti saranno comunque quantifi cabili solo nelle prossime edizioni del rapporto.
Le associazioni culturali e sportive sono più o meno presenti in tutti i Comuni, alcuni dei quali hanno, sul proprio sito, l’elenco aggiornato di tali associazioni.
impa rapporto.indd 102impa rapporto.indd 102 2-04-2009 19:20:392-04-2009 19:20:39

103 AMBIENTE URBANO06
Comune
Biblioteche e mediateche Cinema Teatri
Numero di associazioni culturali e sportive
num
ero
post
i a s
eder
e
acce
ssib
ile
num
ero
post
i a s
eder
e
num
ero
post
i a s
eder
e
Adria 7 122 si 1 400 6 1.700 105
Badia Polesine 1 10 si 1 1.124
Bagnolo Di Po 1 20 si 1 99 4
Bosaro 1 30 si 1 100 3
Calto 1 10 si
Canaro 1 20 si 1 99 10
Castelguglielmo 1 30 si 1 120 1
Castelmassa 1 2 3
Castelnovo B. 1 20 si 1 212
Ceregnano 1 10 1 1 90 14
Corbola 1 48 si 1 4
Crespino 1 50 lun - ven
1 200
Fiesso Umbertiano 1 12 si 1 190 15
Frassinelle P. 1 10 si 1 5
Fratta Polesine 1 70 si
Gaiba 1 25 si 1 150 2
Gavello 1 50 si
Lendinara 1 1 1 59
Loreo 1 30 si
Lusia 1 20 si 1 150 20
Melara 1 10 si 5
Occhiobello 1 si 1 350 cu. 32 + sp. 22
Papozze
Pettorazza G. 1 10 2
Pincara 1 30 si 3
Porto Viro 2 3 550 1 350 60
Rosolina 1 50
Salara 1 6 si 1 50 3
San Bellino 1 100 si
Stienta 1 20 1 200 14
Trecenta 1 100 si 1 300 23
Villadose 1 20 si 36
Villanova Del G. 1 20 si 1 200 7
Villanova M. 1 28 4
Strutture per attività culturali e numero di associazioniFonte: questionari Agenda21Polesine (2008)I comuni non presenti in elenco non hanno risposto al questionario nonostante le sollecitazioni
impa rapporto.indd 103impa rapporto.indd 103 2-04-2009 19:20:392-04-2009 19:20:39

104AMBIENTE URBANO 06
Piani Zonizzazione AcusticaUn ragionamento differente merita la classifi cazione acustica del territorio. In applicazione della recen-
te normativa ed in conseguenza di specifi ci obiettivi, la Provincia di Rovigo, unica nel Veneto, è riuscita a far adottare a tutti i comuni la zonizzazione acustica del territorio.
La classifi cazione acustica avviene in applicazione della Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 con la quale si sono stabiliti i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico. Con il DPCM del 14/11/1997, sulla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, è stabilito l’obbligo per i comuni di adottare la classifi cazione acustica. Tale operazione di “zonizzazione acustica” consiste nell’assegnare, a ciascuna porzione omogenea di ter-ritorio, una delle sei classi individuate dal decreto, sulla base della prevalenza ed effettiva destinazione d’uso del territorio stesso, classi riportate in tabella.
L’ultima amministrazione che ha adotta-to il Piano di Classifi cazione Acustica è stata Porto Tolle (Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 23/02/2009). Il primato assolu-to spetterebbe ad Adria che precorrendo i tempi, deliberò già nel 1991 il controllo del-le emissioni acustiche, adattandosi poi alla normativa nel marzo del 2008.
Nella tabella è riportato l’elenco dei Co-muni e degli atti con cui hanno approvato i loro piani di classifi cazione acustica.
-a e -i -a
-i
Classi di destinazione d’uso del territorioTempi di riferimento
06.00 / 22.00 22.00 / 06.00
Aree particolarmente protette 50 dB 40 dB
Aree prevalentemente residenziali 55 dB 45 dB
Aree di tipo misto 60 dB 50 dB
Aree di intensa attività umana 65 dB 55 dB
Aree prevalentemente industriali 70 dB 60 dB
Aree esclusivamente industriali 70 dB 70 dB
Limiti massimo associati alla zonizzazione acustica del territorio
impa rapporto.indd 104impa rapporto.indd 104 2-04-2009 19:20:402-04-2009 19:20:40

105 AMBIENTE URBANO06
Comune Atto di approvazione della zonizzazione acustica Comune Atto di approvazione della zonizzazione acustica
Adria DCC n. 119 del 18/09/91 e DGC n.77 del 20/03/08 Guarda Veneta DCC n. 23 del 24/08/00
Ariano nel Polesine DCC n. 11 del 28/01/06 Lendinara DCC n. 23 del 02/06/00
Arqua' Polesine DCC n. 39 del 21/12/05 Loreo DCC n. 37 del 06/09/02
Badia Polesine DCC n. 48 del 28/11/00 e DCC n. 17 del 22/06/05 Lusia DGC n. 88 del 29/11/00 e DGC n. 110 del 14/11/01
Bagnolo di Po DCC n. 25 del 06/04/01 Melara DCC n. 73 del 30/03/00
Bergantino DCC n. 122 del 21/12/98 Occhiobello DCC n. 1 del 23/02/05
Bosaro DCC n. 39 del 18/12/00 Papozze DCC n. 51 del 22/12/00
Calto DCC n. 11 del 28/04/00 Pettorazza Grimani DCC n. 47 del 28/12/00
Canaro DCC n. 35 del 30/11/01 Pincara DCC n. 21 del 06/08/01 e nota del 04/11/05
Canda DCC n. 32 del 26/04/99 Polesella DCC n. 51 del 13/10/00
Castelguglielmo DCC n. 42 del 26/04/00 Pontecchio Polesine DCC n. 5 del 02/03/01
Castelmassa DCC n. 32 del 26/04/99 Porto Tolle DCC n. 15 del 23/02/09
Castelnovo Bariano DCC n. 45 del 26/09/00 Porto Viro DCC n. 21 del 05/08/05
Ceneselli DCC n. 2 del 21/02/00 Rosolina DCC n. 61 del 09/06/00 e DGC n.87 del 07/06/05
Ceregnano DCC n. 45 del 05/09/00 Rovigo DCC n. 26 del 27/05/04
Corbola DCC n. 19 del 26/03/02 Salara DCC n. 20 del 28/06/01
Costa di Rovigo DCC n. 40 del 26/08/02 San Bellino DCC n. 33 del 29/09/00
Crespino DCC n. 52 del 30/08/00 San Martino di Venezze DCC n. 84 del 09/10/06
Ficarolo DCC n. 37 del 26/09/00 Stienta DCC n. 2 del 27/01/06
Fiesso Umbertiano DCC n. 2 del 07/02/03 Taglio di Po DCC n. 7 del 22/02/01
Frassinelle Polesine DCC n. 23 del 26/06/01 Trecenta DCC n. 68 del 30/11/00 e nota del 24/07/01
Fratta Polesine DCC n. 8 del 13/03/06 Villadose DCC n. 2 del 15/02/05
Gaiba DCC n. 5 del 29/03/04 Villamarzana DCC n. 49 del 20/12/01 e integrazioni del 03/07/03
Gavello DCC n. 43 del 24/11/00 Villanova del Ghebbo DCC n. 32 del 30/12/02
Giacciano con B. DCC n. 18 del 09/04/01 Villanova Marchesana DCC n. 102 del 13/11/00
Piani di Classifi cazione Acustica approvati nella Provincia di Rovigo
Fonte: Provincia di Rovigo, Area Ambiente (2008)
impa rapporto.indd 105impa rapporto.indd 105 2-04-2009 19:20:402-04-2009 19:20:40

106AMBIENTE URBANO 06
Utilizzo del territorio – Aree produttive e Aziende
Rapporto aree produttive abitanteIn questi ultimi anni è cresciuta notevolmente la disponibilità di aree ad uso produttivo, artigianale,
industriale a disposizione delle imprese nei diversi Comuni della provincia.
Dai dati forniti dal Consorzio per lo Sviluppo del Polesine risulta che in tutti i Comuni ci sono aree in-dustriali, con differenti tassi di saturazione; alcuni Comuni allo stato attuale hanno approvato solo lo stru-mento urbanistico ma manca ancora la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Si tratta comunque di varianti agli strumenti urbanistici già approvate dalle Commissioni Regionali e quindi di usi del suolo già individuati.
Fra i metri quadri disponibili spiccano i 2.645.273 di Porto Viro, legati principalmente alla variante per l’area portuale da realizzare a Cà Cappello, nei pressi dei cantieri navali Vicentini. Rovigo, con oltre 1.300.000 di mq liberi, ha molte aree ancora da utilizzare localizzate soprattutto all’interporto ed in alcu-ne aree di completamento.
Le altre macroaree sorgono nei Comuni lungo la Transpolesana e nel Basso Polesine la localizzazione principale è lungo la Romea e all’AIA. Da evidenziare anche le aree disponibili nei Comuni Calto e Sala-ra.
Complessivamente 8 Comuni hanno una previsione pari a oltre 200 m2 di aree produttive per abitante e solo 9 comuni hanno un valore inferiore a 20 m2/ab.
impa rapporto.indd 106impa rapporto.indd 106 2-04-2009 19:20:402-04-2009 19:20:40

107 AMBIENTE URBANO06
Comune disp
onib
ilità
co
mpl
essi
va
nel t
errit
orio
co
mun
ale
Siti
imm
e-di
atam
ente
ut
ilizz
abili
Siti
con
fabb
ricat
i es
iste
nti
Siti
imm
e-di
atam
ente
pr
evia
ver
i-fi c
a op
ere
di
urba
nizz
a-zi
one
Dis
poni
bilit
à in
m2
di
aree
pro
-du
ttiv
e pe
r ab
itant
e
Adria 716.410 - - - 35,0
Ariano Polesine 312.048 19.000 - - 65,6
Arqua’ Polesine 68.000 20.000 - - 23,4
Badia Polesine 706.806 - 48.000 29.000 65,0
Bagnolo Di Po 35.344 - - - 24,8
Bergantino 110.487 1.604 - - 42,0
Bosaro 272.731 8.721 - - 198,2
Calto 724.589 10.000 - - 889,1
Canaro 21.182 21.182 - - 7,4
Canda 282.233 2.000 - - 305,4
Castelguglielmo 839.408 84.188 - - 488,6
Castelmassa 144.000 26.000 - - 32,5
Castelnovo B. 33.283 26.283 - - 11,0
Ceneselli 97.517 10.662 - - 52,1
Ceregnano 30.300 2.800 - - 7,8
Corbola 37.200 5.800 - - 14,1
Costa Di Rovigo 765.195 2.400 - - 269,7
Crespino 53.105 7.405 - - 25,1
Ficarolo 34.000 43.540 - - 12,7
Fiesso Umbertiano 138.000 18.000 - - 32,7
Frassinelle 103.000 3.000 - - 66,9
Fratta Polesine 134.197 27.404 - - 48,6
Gaiba 59.622 22.622 12.000 - 53,2
Gavello 42.859 - - - 26,5
Giacciano Con B. 129.780 78.480 - - 57,2
Guarda Veneta 20.000 - - - 16,7
Lendinara 427.267 30.000 30.000 - 35,0
Loreo 1.061.000 40.000 160.000 160.000 279,9
Lusia 101.200 12.400 - - 28,0
Melara 79.647 34.795 - - 41,4
Occhiobello 742.859 86.013 - - 66,3
Papozze 101.800 4.500 2.300 - 59,0
Pettorazza G. 86.098 6.098 - - 50,9
Pincara 75.300 - - - 58,4
Polesella 269.265 11.845 - - 64,2
Pontecchio P. 39.000 10.000 - - 21,3
Porto Tolle 140.322 29.240 - - 13,7
Porto Viro 2.645.273 14.855 - 24.424 181,2
Rosolina 229.700 - - 33.700 35,8
Rovigo 1.308.219 358.760 - - 25,4
Salara 671.426 85.905 - - 551,7
San Bellino 604.998 4.736 - - 505,9
S.Martino Di V. 208.777 55.994 - - 52,0
Stienta 128.000 28.000 - - 39,2
Taglio Di Po 365.800 - - 40.800 43,1
Trecenta 15.000 - - - 4,9
Villadose 82.791 - - 13.800 15,6
Villamarzana 92.871 92.871 - - 78,7
Villanova Del G. 77.959 - - - 35,6
Villanova Marc. 74.646 3.509 - - 70,9
Totale 15.540.514 1.350.612 252.300 301.724 63,1
Disponibilità di aree per insediamenti produttivi e/o similari, aggiornamento a settembre 2006
Fonte: ConSviPo – Elaborazione:Agenda21Polesine
impa rapporto.indd 107impa rapporto.indd 107 2-04-2009 19:20:402-04-2009 19:20:40

108AMBIENTE URBANO 06
Aree disponibili per comunedati: Con.Svi.Po - Elaborazione: Agenda21Polesine
Localizzazione delle principali aree produttive della provinciadati: Con.Svi.Po - Elaborazione: Agenda21Polesine
Aree produttive per abitante
Aree residenzialiAree produttive
fi no a 20 mq/ab21 - 50 mq/ab51 - 200 mq/aboltre 200 mq/ab
impa rapporto.indd 108impa rapporto.indd 108 2-04-2009 19:20:412-04-2009 19:20:41

109 AMBIENTE URBANO06
Numero di aziende a Rischio Incidente Rilevante (RIR)Le aziende a Rischio Incidente Rilevante (RIR), dette anche “aziende Seveso”, sono quelle che utilizza-
no, per la loro attività, sostanze classifi cate come pericolose, e che per questo costituiscono un pericolo. I D.Lgs 334/99 (Seveso II) e 238/2005 regolamentano questa categoria di aziende, suddividendole in tre sottogruppi in base al livello di rischio, valutato in base alla quantità di sostanza pericolosa detenuta dall’azienda. Ad ogni gruppo corrispondo-no diversi adempimenti a cui sono sotto-poste le aziende.
Le categorie sono: art. 5 comma 2 (poco signifi cativa), aziende soggette a art. 6 (notifi ca al Ministero ed obbligo di Siste-ma di Gestione per la Sicurezza) e art. 8 (come art. 6 più Rapporto di Sicurezza e valutazione delle azioni per minimizzare il rischio).
ARPA Veneto ha adottato la distribuzio-ne numerica delle aziende soggette agli adempimenti previsti dagli arti-coli 6 e 8 del D.Lgs 334/99 (che sono quelli relativi ai due livelli di rischio più elevati) come un primo indicatore del livello complessivo di rischio pre-sente nel territorio di ciascuna provin-cia. È tuttavia necessario sottolineare come il livello di pericolosità reale associato a ciascuna azienda non di-penda esclusivamente dalle quantità di sostanze pericolose detenute, ma anche dalle misure di prevenzione e sicurezza in essa adottate.
La densità di aziende RIR nel territo-rio della Provincia di Rovigo risulta pari a 3,3x10-3 aziende/km2, valore decisamente inferiore a quello regionale pari a 5,3 x10-3 aziende/km2 ed inferiore a quello nazionale pari a 3,8x10-3 aziende/km2.
--
o 6 -8 e e
-
Aziende soggette a RIR Densità aziende soggette a RIR
ad art. 6 ad art. 8 Totale art. 6 art. 8 Totale
Belluno 1 - 1 0,3 x10-3 - 0,3 x10-3
Padova 9 4 13 4,2 x10-3 1,9 x10-3 6,1 x10-3
Rovigo 2 4 6 1,1 x10-3 2,2 x10-3 3,3 x10-3
Treviso 5 3 8 2,0 x10-3 1,2 x10-3 3,2 x10-3
Venezia 6 24 30 2,4 x10-3 9,7 x10-3 12,1 x10-3
Vicenza 7 11 18 2,6 x10-3 4,0 x10-3 6,6 x10-3
Verona 12 9 21 3,9 x10-3 2,9 x10-3 6,8 x10-3
Veneto 42 55 97 2,3 x10-3 3,0 x10-3 5,3 x10-3
Numero di aziende e densità delle aziende soggette a RIRFonte: ARPA Veneto – Elaborazione: Agenda21Polesine
Densità delle aziende soggette a RIRElaborazione: Agenda21Polesine
Aziende soggette ad art. 6
Aziende soggette ad art. 8
Aziende soggette a RIR
Nella mappa è rappre-sentata la localizzazione per tipologia della azien-de soggette a RIR della Provincia di Rovigo.
impa rapporto.indd 109impa rapporto.indd 109 2-04-2009 19:20:412-04-2009 19:20:41

110AMBIENTE URBANO 06
Aziende con registrazione EMASIl Sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS (Eco-Management and Audit Sche-
me) è un sistema ad adesione volontaria per le imprese e le organizzazioni che desiderano impegnarsi a valutare e migliorare la propria effi cienza ambientale. Il sistema EMAS è stato lanciato nel 1995 ed è stato sottoposto a revisione nel 2001, è principalmente destinato a migliorare l’ambiente e a fornire alle organizzazioni, alle autorità di controllo ed ai cit-tadini uno strumento di valutazione e gestione dell’impatto ambientale di una organizza-zione. Al sistema, defi nito dal Regolamento (CE) n. 761/2001, aderiscono gli Stati membri della Unione Europea e quelli dello spazio economico europeo.
Il sistema di gestione è quindi un impegno nel rispetto dell’ambiente e nell’ottica del continuo miglioramento delle prestazioni ambientali.
Per ottenere la registrazione EMAS un’organiz-zazione deve effettuare una analisi ambientale, dotarsi di un sistema di gestione ambientale, ef-fettuare un audit ambientale e predisporre una dichiarazione ambientale. Successivamente deve ottenere una verifi ca positiva e richiedere la re-gistrazione presso l’organismo competente dello Stato membro.
Nella Provincia di Rovigo positivo è l’incremen-to, dal 2000 ad oggi, del numero di aziende so-prattutto nel campo dei servizi turistici. Manca una adeguata diffusione anche nel resto della provin-cia. Il numero di registrazioni ogni 10.000 imprese è il più elevato del Veneto.
Numero aziende registrate e tasso ogni 10.000 impreseElaborazione: Agenda21Polesine
)a o
el o
-e, -a e
Provincia Registrazioni Imprese (2007)Registrazioni ogni
10.000 imp.
Belluno 6 90.246 0,7
Padova 8 76.904 1,0
Rovigo 4 15.584 2,6
Treviso 5 85.184 0,6
Venezia 13 71.478 1,8
Vicenza 17 94.255 1,8
Verona 4 26.637 1,5
Reg. Veneto 57 460.018 1,2
Aziende registrate EMAS per ProvinciaFonte: EMAS Italia
Organizzazione Alba Invest S.r.l.
Comprensorio turistico dell’isola di Albarella
Ostello AmolaraPalma srl - Villaggio
turistico Rosapineta Sud
Numero registrazione IT-000649 IT-000549 IT-000479 IT-000822
Data prima reg. 23/04/2007 30/08/2006 26/04/2006 14/02/2008
Comune Rosolina Rosolina Adria Rosolina
Codici NACE * 55.10 55.10 | 93.1 | 93.29 55.20 55.20 | 55.90
Verifi catore RINA spa (IT-V-0002)
RINA spa (IT-V-0002)
CSQA Certifi cazioni(IT-V-0005)
RINA spa (IT-V-0002)
* classifi cazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 - Regolamento (CE) n. 1893/2006
Numero Organizzazioni che hanno ottenuto una registrazione EMAS, Provincia di RovigoFonte: sito www.apat.gov.it
Sono inoltre registrati i siti di produzione della Centrale di Castelmassa e della Centrale Edison di Porto Viro.
impa rapporto.indd 110impa rapporto.indd 110 2-04-2009 19:20:422-04-2009 19:20:42

111 AMBIENTE URBANO06
Aziende con certifi cazione ISO 14000La sigla ISO 14000 identifi ca una serie di standard internazionali relativi alla gestione ambientale del-
le organizzazioni. Con la sigla “ISO 14001” si identifi ca uno di questi standard, che fi ssa i requisiti di un sistema di gestione ambientale. Lo standard ISO 14001 è uno certifi cabile, ovvero è possibile ottenere, da un organismo di certifi cazione accreditato che operi entro determinate regole, attestazioni di confor-mità ai requisiti in essa contenuti. Sia chiaro che la certifi cazione ISO 14001 non attesti una particolare prestazione ambientale, né tantomeno dimostri un particolarmente basso impatto, ma piuttosto stia a dimostrare che l’organizzazione certifi cata ha un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività, e ne ricerchi sistematicamente il migliora-mento in modo coerente, effi cace e soprat-tutto sostenibile.
I dati per la provincia di Rovigo sono de-sunti dalle analisi effettuate da ARPA Vene-to. Le organizzazioni con ISO 14001 sono 878, abbastanza ben distribuite nel terri-torio regionale. Si tratta soprattutto di at-tività commerciali (117), di servizi pubblici (111), di aziende che effettuano lavorazio-ni di metalli (73). Numerose sono anche le certifi cazioni ambientali nelle aziende chi-miche, in ristoranti e alberghi, nel settore delle apparecchiature elettriche/ottiche, nel settore gomma/materie plastiche, nel-le industrie alimentari.
Nella provincia erano presenti (dato dell’aprile del 2007) 69 aziende certifi ca-te ISO 14.000. Con una consistenza di poco superiore alle 15.500 aziende risulta che quasi 5 aziende su mille hanno questa cer-tifi cazione, valore secondo solo a Verona (6,8).
Numero aziende certifi cate e tasso ogni 1.000 impreseElaborazione: Agenda21Polesine
--
--o --
ci -e -e
Provincia Certifi cazioni Imprese (2007)Certifi cazioni
ogni 1.000 imp.
Belluno 43 90.246 0,5
Padova 132 76.904 1,7
Rovigo 69 15.584 4,4
Treviso 137 85.184 1,6
Venezia 182 71.478 2,5
Vicenza 134 94.255 1,4
Verona 181 26.637 6,8
Reg. Veneto 878 460.018 1,9
Aziende certifi cate ISO 14001 per provinciaFonte: ARPAV. Dati Aggiornati al 30 aprile 2007
impa rapporto.indd 111impa rapporto.indd 111 2-04-2009 19:20:422-04-2009 19:20:42

112AMBIENTE URBANO 06
Infortuni sul lavoro
Numero di incidenti sul lavoro
Numero incidenti in agricolturaTra il 2003 e il 2007 si è assistito ad una
generale e progressiva diminuzione del nu-mero di incidenti sul lavoro, diminuzione nel quale ha pesato soprattutto il settore dell’industria, passata da 4.197 a 3.808 in-cidenti (valore che raggruppa tutti gli inci-denti denunciati all’INAIL nell’anno).
In calo anche il numero di incidenti nel settore agricolo che sono passati da 489 a meno di 400 incidenti denunciati.
Se si prende inoltre come riferimento il solo settore manifatturiero, si nota come siano calati gli incidenti passando da 1.361 a pochi oltre i 1.000.
Sia le politiche di sensibilità nei confronti degli infortuni sul lavoro, sia l’aumento della sensibilità dei lavoratori nei confronti dei rischi legati all’attività lavorativa devono aver contribuito a far diminuire il numero di incidenti.
Infortuni sul lavoro nel periodo 1997 – 2001fonte dati: INAIL, sito internet
a -e e --
el a
l e 1
ti degli infortuni sul lavoro sia l’aumento della sensibilità de
2003 2004 2005 2006 2007
Industria Commercio Servizi
Artigiane 663 674 736 866 946
Non artigiane 1.968 2.096 2.183 2.222 2.244
Non determinate 1.177 953 918 1.161 1.007
Totale 3.808 3.723 3.837 4.249 4.197
di cui nel manifatturiero 1.361 1.294 1.163 1.165 1.069
Agricoltura
Autonomi 329 328 324 296 254
Dipendenti 160 171 132 123 138
Totale 489 499 456 419 392
Conto stato
Totale 64 104 72 73 91
Totale 4.750 4.852 4.365 4.215 4.291
Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2003 - 2007Fonte: INAIL, sito internet
489
64
3.837
456
72
3.808
39291
1.361
4.197
1.163 1.069
0
5 0 0
1 . 0 0 0
1 . 5 0 0
2 . 0 0 0
2 . 5 0 0
3 . 0 0 0
3 . 5 0 0
4 . 0 0 0
4 . 5 0 0
I n d u s tria C o m m e rc io Se rv iz i d i c u i n e l m a n i fa ttu rie ro A g ric o ltu ra Co n to s ta to
2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
impa rapporto.indd 112impa rapporto.indd 112 2-04-2009 19:20:432-04-2009 19:20:43

113 AMBIENTE URBANO06
Infrastrutture
Sistema infrastrutturaleIl sistema viario del Polesine è rappresentato da una
serie di assi viari gerarchicamente organizzati i cui prin-cipali sono:
• Autostrada A 13 Bologna – Padova, che attraversa tutto il territorio in direzione Nord – Sud, con tre ca-selli di cui uno a Rovigo, uno a Boara ed il recente terzo casello di Villamarzana, che facilita i collega-menti tra le dorsali ovest-est e nord-sud;
• la SS 434 Transpolesana Verona – Rovigo, unica arte-ria stradale orientata in senso Est – Ovest, importan-tissima perché facilita l’accesso al Corridoio I e V;
• SS 16 Adriatica Padova-Otranto, che passa per Rovi-go e la collega con Ferrara verso Sud e Padova verso Nord ;
• SS 309 Romea, storica direttrice per i collegamenti con il basso ferrarese e Ravenna in direzione Sud e con le province di Padova e Venezia verso Nord,
• SR Eridania, ex SP 6, che si estende in direzione Ovest-Est partendo da Mantova e arrivando fi no all’au-tostrada A 13.
Su questo sistema, sintetizzato nella cartografi a alla pagina successiva, sono in fase di progettazione delle nuove arterie stradali che permetteranno di aumentare l’offerta e la complessiva accessibilità del territorio.
In particolare è in fase di ultimazione l’Autostrada Valdastico Sud che si collegherà alla Transpolesana all’altezza di Badia Polesine. La stessa Transpolesana è in progetto di essere trasformata in autostrada (circa 32 km. di viabilità di tipo SS diventeranno autostradali) e verrà prolungata oltre Adria, dove incro-cerà la futura autostrada Venezia-Ravenna.
A queste sostanziali modifi che dell’assetto viario si affi ancheranno nuovi svincoli ed accessi della via-bilità secondaria. Nella tabella sono indicati i dati esistenti e di progetto delle infrastrutture presenti nella Provincia di Rovigo.
I principali collegamenti ferroviari sono rappresentati dalla linea Padova – Bologna che permette i col-legamenti verso Venezia a nord e verso Firenze – Ravenna a Sud. L’altro asse ferroviario è costituito dalla linea Verona – Chioggia, in direzione Est–Ovest, che attraversa tutta la provincia di Rovigo, connettendo l’interporto di Verona, polo logistico di livello nazionale, con le principali aree produttive dislocate su tutto il territorio polesano. Da Adria partono due distinte linee ferroviarie in direzione Nord; la prima raggiunge Chioggia mentre la seconda raggiunge la città di Venezia.
Questi secondi assi, a differenza del primo, non sono elettrifi cati, inoltre il sistema Chioggia – Adria - Verona non è a tutt’oggi inserito nel sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) che si ferma a Rovigo (tratta PD – BO) e ad Adria (tratta Adria - Venezia).
Nella cartografi a che segue è indicato l’attuale sistema ferroviario e sono riportate anche le fermate ferroviarie esistenti.
a-
a-e-
--
-
Lunghezza (km.)
Tipo esistente progetto totale
Autostrada 27 75 102
Strada Statale 87 87
Strada Regionale 131 18 149
Strada Provinciale * 546 76 622
Viabilità comunale * 908 16 924
Altro (svincoli,…) 89 89
Totale complessivo 1.699 274 1.974
* dato non comprensivo dei molti progetti in fase di studio
Estensione della rete stradale Provinciale
Fonte: Regione Veneto – Elaborazione: Agenda21Polesine
impa rapporto.indd 113impa rapporto.indd 113 2-04-2009 19:20:432-04-2009 19:20:43

114AMBIENTE URBANO 06
Sistema viario principale della provincia di Rovigo – 2008Fonte: Regione Veneto – Elaborazione: Agenda21Polesine
Rete stradaleAutostradaStrada Statale SSStrada Regionale SR
Sistema ferroviario della provincia di Rovigo – 2008Fonte: Regione Veneto – Elaborazione: Agenda21Polesine
Stazioni ferroviarieNuova ferrovia Mestre/RiminiFerrovia esistenteSistema Ferroviario Metropolitano
Strada Provinciale SP In ProgettoStrada Provinciale SP AutostradaViabilità comunale Strada Regionale Strada Provinciale
impa rapporto.indd 114impa rapporto.indd 114 2-04-2009 19:20:442-04-2009 19:20:44

115 AMBIENTE URBANO06
Incidenti stradali
Numero complessivo di incidenti
Numero complessivo di mortiLa fonte dei dati presentati è la “Rilevazione sugli incidenti stradali” in Italia, compresa nel Programma
Statistico Nazionale, la cui titolarità è dell’ISTAT. La tabella seguente riporta il numero complessivo degli incidenti, degli infortunati e dei morti.
Il numero elevato di incidenti ed in particolare di incidenti mortali, registrato negli anni passati (si veda il precedente rapporto per i dati precedenti al 2000), ha portato le Amministrazioni Provinciali, e tra queste Rovigo, a intraprendere politiche ed azioni di sensibilizzazione nei confronti del problema. Na-sce quindi il progetto “Strade Sicure” dell’Assessorato alla Sicurezza Stradale della Pro-vincia di Rovigo, che si pone l’obiettivo di sensibilizzare ed informare i giovani dei rischi e dei pericoli legati ad uso non ragionato dei veicoli.
Dal 2000 al 2007 si registra una tendenza al calo dell’in-cidentalità e del numero di morti, anche se non lineare nel tempo. Complessivamen-te diminuiscono anche i feri-ti.
Nel grafi co sono rappre-sentati i numeri indice degli incidenti mortali e dei morti (base anno 2000 =100), che evidenziano chia-ramente il trend in atto.
Numero indice degli incidenti mortali e del numero di morti in provincia di Rovigo ed in VenetoFonte dati: vedi tabella – Elaborazione: Agenda21Po-lesine
e a -e d i
o
a -i
e --
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Totali incidenti
Rovigo 1.276 1.174 1.198 1.040 972 937 1.014 980
Veneto 21.219 21.790 20.745 19.213 18.895 18.378 19.261 18.378
Incidenti mortali
Rovigo 70 46 40 47 27 33 48 30
Veneto 674 646 596 631 511 513 511 493
Totale feriti
Rovigo 1.731 1.693 1.743 1.549 1.412 1.311 1.416 1.387
Veneto 29.846 30.535 29.229 26.938 26.309 25.348 26.611 25.327
Totale morti
Rovigo 81 47 43 56 29 37 50 39
Veneto 732 693 650 711 554 555 553 538
Incidenti, feriti e morti a causa di incidente nella provincia di Rovigo ed in VenetoFonte: 2000-2006: Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT-ACI; 2007 dati ISTAT-ACI
2 0
4 0
6 0
8 0
1 0 0
2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
in c id e n ti m o rta li - R o v ig o in c id e n ti m o r ta l i - V e n e to
to ta le m o r ti - R o v ig o to ta le m o rti - V e n e to
impa rapporto.indd 115impa rapporto.indd 115 2-04-2009 19:20:442-04-2009 19:20:44

116AMBIENTE URBANO 06
Tasso di lesività
Tasso di mortalità
Tasso di pericolositàL’Osservatorio Statistico Provinciale sull’incidentalità stradale ha inoltre realizzato, a livello provinciale e
regionale, uno studio dei tassi di lesività, di mortalità e di gravità, secondo le seguenti formule:
- tasso di mortalità = (totale morti / totale incidenti) * 100 indica il numero di morti ogni cento in-cidenti (considerando i morti fi no a 30 giorni dall’incidente)
- tasso di lesività = (totale feriti / totale incidenti) * 100 esprime il numero medio di persone coin-volte ferite per cento incidenti
- tasso di gravità = (totale morti / totale morti + totale feriti) * 100 è un indicatore che a parità di persone infortunate aumenta all’aumentare dell’esito letale degli incidenti.
I valori dei tassi evidenziano che, nonostante la complessiva e positiva diminuzione del numero asso-luto di incidenti, di feriti e morti, il tasso di mortalità della provincia di Rovigo resta comunque superiore a quello regionale.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
indice di mortalità
Veneto 3,5 3,2 3,1 3,7 2,9 3,0 2,9 2,9
Rovigo 6,3 4,0 3,6 5,4 3,0 3,9 4,9 4,0
indice di lesività
Veneto 140,7 140,1 140,9 140,2 139,2 137,9 138,2 137,8
Rovigo 135,7 144,2 145,5 148,9 145,3 139,9 139,6 141,5
indice di pericolosità
Veneto 2,4 2,2 2,2 2,6 2,1 2,1 2,0 2,1
Rovigo 4,5 2,7 2,4 3,5 2,0 2,7 3,4 2,7
Indici di mortalità, lesività e gravità relativi alla provincia di Rovigo ed al VenetoFonte: elaborazione U.S. Provincia di Rovigo su dati ISTAT-ACI
impa rapporto.indd 116impa rapporto.indd 116 2-04-2009 19:20:452-04-2009 19:20:45

117 AMBIENTE URBANO06
0 , 0
1 , 0
2 , 0
3 , 0
4 , 0
5 , 0
2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
V e n e to R o v ig o
Nel periodo considerato, il tasso di mortalità della provincia di Rovigo ha un andamento variabile e registra valori superiori a quelli regionali.
Il tasso di lesività, caratterizzato da un andamento molto differente dal precedente, è in crescita fi no al 2003 e in diminuzione successivamente, con valori superiori a quelli regionali, tranne nell’anno 2000.
Il tasso di gravità – che misura la pericolosità degli incidenti occorsi - ha un andamento del tutto simile a quello del tasso di mortalità, contraddistinto da un alternanza di diminuzioni e di successivi aumenti.
Tasso di mortalità – 2000-2007fonte: elaborazione U.S. Provincia di Rovigo su dati ISTAT-ACI
Tasso di lesività – 2000-2007fonte: elaborazione U.S. Provincia di Rovigo su dati ISTAT-ACI
Tasso di pericolosità – 2000-2007fonte: elaborazione U.S. Provincia di Rovigo su dati ISTAT-ACI
0 , 0
1 , 0
2 , 0
3 , 0
4 , 0
5 , 0
6 , 0
7 , 0
2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
V e n e to R o v ig o
1 2 5 , 0
1 3 0 , 0
1 3 5 , 0
1 4 0 , 0
1 4 5 , 0
1 5 0 , 0
2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
V e n e to R o v ig o
impa rapporto.indd 117impa rapporto.indd 117 2-04-2009 19:20:452-04-2009 19:20:45

118AMBIENTE URBANO 06
Localizzazione degli incidentiI dati regionali sulla localizzazione degli incidenti stradali sono attualmente disponibili per l’anno 2006;
qui sono confrontati con quelli della provincia di Rovigo.
Complessivamente, su un totale di 1.014 incidenti avvenuti nel Polesine, il 46,9 % ha riguardato le Strade Urbane all’interno di centri abitati, dato inferiore a quello registrato a livello regionale. É di con-seguenza ipotizzabile, nella nostra provincia, una minore probabilità di incidente per i cosiddetti “utenti deboli”, generalmente coinvolti in misura maggiore negli incidenti che accadono in questa tipologia di strade.
Decisamente superiore a quella regionale è invece la percentuale degli incidenti avvenuti nella provin-cia su Strade Statali o Regionali fuori dal centro urbano. In questo caso, contro una media regionale del 8,5 % il valore provinciale è 19,4 %.
Complessivamente, gli incidenti per tipologia stradale, fatta eccezione per le Statali e Regionali fuori dal centro urbano, hanno nella provincia di Rovigo una distribuzione analoga a quella regionale.
Nell'abitato Fuori abitato
TotaleStrada urbana
Strada Provinciale
Statale o Regionale Comunale Provinciale
Statale o Regionale Autostrada
Altra strada
Rovigo 476 51 60 86 119 197 22 3 1.014
Veneto 10.484 1.975 1.401 883 1.875 1.644 918 81 19.261
Localizzazione incidenti 2006Fonte: Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT-ACI
Localizzazione degli incidenti stradali – anno 2006Fonte: Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT-ACI
4 6 , 9
5 , 0
5 , 9
8 , 5
1 1 , 7
1 9 , 4
2 , 2
0 , 3
5 4 , 4
1 0 , 3
7 , 3
4 , 6
9 , 7
8 , 5
4 , 8
0 , 4
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0
S tra d a u rb a n a
P ro v in c ia le n e ll 'a b ita to
S ta ta le o R e g io n a le
n e ll' a b ita to
C o m u n a le e x tra u rb a n a
P ro v in c ia le
S ta ta le o R e g io n a le fu o ri
a b ita to
A u to s tra d a
A ltra s tra d a
V e n e to
R o v ig o
impa rapporto.indd 118impa rapporto.indd 118 2-04-2009 19:20:462-04-2009 19:20:46

119 AMBIENTE URBANO06
Politiche di sensibilizzazione – Vado Sicuro“Vado Sicuro” è la campagna di educazione sulla sicurezza stradale arrivata
quest’anno alla sesta edizione, promossa dalla Provincia di Rovigo.
Il progetto coinvolge le scuole in attività didattiche volte a diffondere e a discu-tere di sicurezza stradale. Il progetto si basa sul concetto di “sicurezza partecipata”, cioè sul principio che la sicurezza non è determinata solo da restrizioni, sanzioni e controlli ma anche e soprattutto dalla partecipazione di tutti i cittadini, dalla condi-visione dei valori, delle volontà di tutti di essere parte attiva a favore delle regole necessarie per una corretta convivenza. La scuola è chiamata a svolgere un ruolo primario nella costruzione della “cultura della sicurezza stradale” attraverso la costruzione di percorsi formativi.
Quest’anno le scuole che parteciperanno sono 54, numero in continua crescita se si pensa che l’anno passato le scuole erano 48. Sono 54 le scuole che hanno inviato la loro adesione confermando il valore di questa iniziativa e la volontà forte di insegnanti e ragazzi di dare il proprio contributo ad una nuova cultura della sicurezza
impa rapporto.indd 119impa rapporto.indd 119 2-04-2009 19:20:472-04-2009 19:20:47

120AMBIENTE URBANO 06
Radiazioni non ionizzantiLe principali fonti di radiazioni non ionizzanti presenti nella provincia di Rovigo sono rappresentate da:
• le linee ad alta tensione utilizzate per la distribuzione dell’energia elettrica, sorgenti a bassa frequenza;
• le stazioni radiobase per la telefonia mobile (SRB), sorgenti ad alta frequenza (stazioni di diversi operatori);
• gli impianti per la radiocomunicazione e la telecomunicazione, sorgenti ad alta frequenza (ripe-titori radio e TV).
Le radiazioni non ionizzanti sono comprese nell’intervallo di frequenza 0-300 GHz (microonde, radiofre-quenze e frequenze estremamente basse) che possono dare origine all’inquinamento elettromagnetico.
Linee ad alta tensione
Tra le sorgenti di campi elettromagnetici (CEM) a maggiore intensità e che interessano ambiti territo-riali molto ampi ci sono le linee elettriche ad alta tensione, utilizzate per il trasporto dell’energia. Queste possono essere divise in base al potenziale trasportato in:
• 132 kV, maggiormente diffuse sul territorio provinciale;
• 220 kV che attraversano l’area dell’Alto Polesine;
• 380 kV che partono dalla centrale termoelettrica di Polesine Camerini
Molti degli studi effettuati in questi ultimi anni hanno evidenziato possibili effetti legati alla prolungata esposizione a CEM di bassa frequenza. Gli effetti cronici (insorgenza di cancro) non sono invece ancora stati dimostrati completamente.
La localizzazione e l’estensione delle linee a bassa frequenza diventa utile al fi ne di valutare l’esposi-zione della popolazione ai CEM.
Estensione delle linee ad alta tensione
Rispetto ai dati disponibili per l’anno 2002 risulta che il numero complessivo delle linee alta tensio-ne è diminuito, con un calo che ha interessato le linee elettriche a 132 kW (-21 km.), a 220 kW (lie-ve calo) e a 380 kW (-11 km.). Nella mappa sono riportate le linee elettriche presenti.
a -e -o
Linee elettriche Estensione 2002 Estensione 2008
132 kV 240 km. 219 km.
220 kV 50 km. 47 km.
380 kV 130 km. 119 km.
Totale estensione 420 km. 385 km.
Estensione della Rete ad Alta Tensione
Fonte: Regione Veneto – Elaborazione: Agenda21Polesine (2008)
Estensione della Rete ad Alta TensioneFonte: Regione Veneto – Elaborazione: Agenda21Polesine (2008)
Elettrodi132 kV220 kV380 kV
impa rapporto.indd 120impa rapporto.indd 120 2-04-2009 19:20:472-04-2009 19:20:47

121 AMBIENTE URBANO06
Popolazione esposta all’induzione magnetica prodotta da elettrodotti di alta tensioneGrazie al lavoro svolto da ARPA Veneto è possibile avere un dato relativo alla popolazione potenzialmen-
te esposta ai campi indotti dagli elettrodotti.
In base alle caratteristiche di ogni elettrodotto sono state individuate le aree (fasce di rispetto) inte-ressate da valori di induzione magnetica superiori a determinate soglie: oltre a quella di 0,2 microtesla prevista dalla LR 27/93, sono state considerate anche le soglie di 3 microtesla e 10 microtesla, indicate dal DPCM 8/7/2003 come rispettivamente obiettivo di qualità e valore di attenzione. La stima della po-polazione esposta è stata eseguita sulla base delle sezioni di censimento ISTAT del 2001, considerando per ogni sezione la densità di popolazione e la superfi cie di territorio occupata dalle fasce di rispetto.
Il metodo proposto è caratterizzato da alcune approssimazioni ed i risultati ottenuti vanno intesi come stime di massima e cautelative dell’esposizione della popolazione a diversi livelli di induzione magnetica. L’indicatore è stato elaborato per la prima volta con i dati del 2006 e non è quindi possibile stabilire il suo andamento temporale.
Nella provincia di Rovigo la popolazione potenzialmente esposta a valori di soglia e attenzione è complessivamente inferiore al 2%. Questo grazie alla conformazione dif-fusa della residenza ed alla conformazione degli ambiti urbani, caratterizzati da piccola dimensione e bassa densità. Le principali linee elettriche, inoltre, attraversano princi-palmente ambiti agricoli.
eel-eai-
> 0.2 microtesla > 0.3 microtesla > 10 microtesla
Belluno 9.758 4,6% 3.994 1,9% 2.508 1,2%
Padova 16.735 1,9% 7.226 0,8% 4.537 0,5%
Rovigo 2.592 1,1% 1.054 0,4% 657 0,3%
Treviso 14.948 1,7% 6.153 0,7% 3.756 0,4%
Venezia 24.119 2,9% 10.428 1,2% 6.625 0,8%
Verona 19.155 2,2% 8.448 1,0% 5.464 0,6%
Vicenza 8.780 1,0% 3.562 0,4% 2.216 0,3%
Veneto 96.087 2,0% 40.865 0,9% 25.763 0,5%
Popolazione esposta ai diversi valori di induzione magneticaFonte ed elaborazione: ARPA Veneto
Popolazione esposta ai diversi valori di induzione magneticaFonte ed elaborazione: ARPA Veneto
0 , 0 %
1 , 0 %
2 , 0 %
3 , 0 %
4 , 0 %
5 , 0 %
6 , 0 %
7 , 0 %
8 , 0 %
9 , 0 %
B e llu n o P a d o v a R o v ig o T re v is o V e n e z ia V e ro n a V ic e n z a V e n e to
> 0 . 2 m ic ro te s la > 3 m ic ro te s la > 1 0 m ic ro te s la
impa rapporto.indd 121impa rapporto.indd 121 2-04-2009 19:20:472-04-2009 19:20:47

122AMBIENTE URBANO 06
Stazioni radiobaseLe stazioni radio base (SRB) per la telefonia cellu-
lare sono gli impianti di telecomunicazione che, per la loro capillare diffusione nei centri abitati, generano maggiore preoccupazione tra i cittadini.
Il servizio di telefonia cellulare viene realizzato tra-mite un sistema complesso di tipo broadcasting che è la rete radiomobile. Essa è distribuita sul territorio ed è costituita da un insieme di elementi, ognuno dei quali è in grado di dialogare con gli altri: le centrali di calcolo in grado di localizzare l’utente e di gestirne la mobilità, le centrali che fi sicamente connettono le linee, le Stazioni Radio Base e i telefoni cellulari.
Ciascuna SRB è costituita da antenne, installate su appositi tralicci o su edifi ci, che trasmettono il segnale al telefono cellulare ed antenne che ricevono il se-gnale trasmesso da quest’ultimo.
Le frequenze utilizzate sono comprese tra i 900 MHz e i 1900 MHz. Ogni SRB interessa una porzione limitata di territorio, detta comunemente cella.
Numero di impianti SRBImpianti SRB per comuneI dati sono stati forniti dall’Area Politiche per l’Am-
biente della Provincia di Rovigo ed evidenziano che complessivamente sono presenti 234 SRB nel 2008, e questo dato segna un aumento del 55% rispetto al precedente dato del 2001. In controtendenza solo Ficarolo e Fiesso che hanno fatto registrare un lieve calo.
Nella mappa che segue è illustrata la localizzazio-ne di questi impianti sul territorio. Sono rappresentate anche le stazioni di ripetizione e diffusione del segna-le video TV.
-r o
-e o ei di e e
u e -
0 e
-e 8, o o e
-e -
Comune 2001 2008 var 01-08
Adria 4 17 76%
Ariano Nel Polesine 3 4 25%
Arqua’ Polesine 1 4 75%
Badia Polesine 4 4 0%
Bagnolo Di Po 1 100%
Bergantino 2 3 33%
Canaro 2 100%
Castelguglielmo 1 2 50%
Castelmassa 3 3 0%
Castelnovo Bariano 1 1 0%
Ceregnano 1 3 67%
Corbola 1 1 0%
Costa Di Rovigo 3 100%
Crespino 2 3 33%
Ficarolo 4 3 -33%
Fiesso Umbertiano 3 2 -50%
Frassinelle Polesine 1 100%
Fratta Polesine 3 100%
Gavello 1 100%
Giacciano Con B. 1 100%
Guarda Veneta 1 100%
Lendinara 3 5 40%
Loreo 1 3 67%
Lusia 3 100%
Occhiobello 5 9 44%
Papozze 1 100%
Pettorazza Grimani 1 2 50%
Pincara 1 1 0%
Polesella 3 5 40%
Pontecchio Polesine 2 3 33%
Porto Tolle 6 7 14%
Porto Viro 5 7 29%
Rosolina 11 13 15%
Rovigo 24 80 70%
San Bellino 1 100%
San Martino di V. 2 100%
Stienta 1 100%
Taglio di Po 4 6 33%
Trecenta 3 3 0%
Villadose 3 4 25%
Villamarzana 3 3 0%
Villanova del G. 1 100%
Totale Complessivo 105 234 55%
Numero di SRB per comune 2001-2008Fonte: Area Politiche per l’Ambiente
impa rapporto.indd 122impa rapporto.indd 122 2-04-2009 19:20:482-04-2009 19:20:48

123 AMBIENTE URBANO06
Campagne di misurazione delle emissioniARPA Veneto effettua il monitoraggio in continuo del campo elettromagnetico emesso dagli impianti di
telecomunicazione con particolare riferimento alle Stazioni Radio Base.
Questa attività rientra nell’ambito del progetto rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici a ra-diofrequenza promosso dal Ministero delle Comunicazioni, e integrato da iniziative delle amministrazioni comunali e provinciali.
I dati sono rilevati attraverso centra-line mobili che vengono posizionate nei punti di interesse per durate varia-bili; orientativamente la durata della campagna di monitoraggio varia da una settimana ad un mese o più.
Localizzazione degli impianti per la telefonia cellulare per comunefonte dati: Area politiche per l’Ambiente, Prov. di Rovigo – Elaborazione: Agenda21Polesine
Controllo delle sorgenti di campo elettromagneticoFonte: ARPA Veneto, Dipartimento Provinciale di Rovigo
Attività di controllo 2008
Centraline di monitoraggio campi ad alta frequenza
siti di misura campi generati da elettrodi
132 kV220 kV380 kV
Linee elettriche Alta Tensione
Impianti attiviStazioni Radio BaseRipetitori TV
e -a a
Attività svolta nel 2008Numero Impianti TLC,
linee elettriche AT
Numero Misure,
Monitoraggi
N. giorni di
monitoraggio
Impianti di telecomunicazione 31 15 1137
Elettrodotti 6 35 -
Controllo delle sorgenti di campo elettromagnetico
Fonte: ARPA Veneto, Dipartimento Provinciale di Rovigo
impa rapporto.indd 123impa rapporto.indd 123 2-04-2009 19:20:482-04-2009 19:20:48

124AMBIENTE URBANO 06
Istruzione e cultura
Popolazione per livello d’istruzioneAnalizzando la serie storica tra il 1951 ed il 2001 si vede come in Polesine la distribuzione della compo-
sizione dei residenti per titolo di studio si sia notevolmente modifi cata.
Negli anni sono decisamente diminuite le persone senza titolo di studio, gli analfabeti e quelle in pos-sesso della licenza elementare, mentre sono aumentati i residenti con la licenza di scuola secondaria di primo grado, i diplomati ed i laureati.
Censim.Analfabeti Alfabeti privi di
titolo di studioLicenza
elementareLicenza media
inferioreDiploma Laurea Totale
195137.023 69.234 192.170 9.071 5.537 1.321 314.356
11,8% 22,0% 61,1% 2,9% 1,8% 0,4% 100%
196118.711 42.765 166.751 14.110 7.459 1.743 251.539
7,4% 17,0% 66,3% 5,6% 3,0% 0,7% 100%
19719.829 53.529 125.273 27.432 11.810 2.334 230.207
4,3% 23,3% 54,4% 11,9% 5,1% 1,0% 100%
19816.473 51.195 100.183 52.922 21.813 4.225 236.811
2,7% 21,6% 42,3% 22,3% 9,2% 1,8% 100%
19914.559 33.439 83.864 71.415 37.285 5.827 236.389
1,9% 14,1% 35,5% 30,2% 15,8% 2,5% 100%
20013.061 24.792 67.036 71.124 54.603 11.721 232.337
1,3% 10,7% 28,9% 30,6% 23,5% 5,0% 100%
Popolazione per livelli d’istruzione ai censimentiFonte: Istat
Composizione dei residenti per titolo di studioFonte: ISTAT - Elaborazione: Agenda21Polesine
0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
A n a l fa b e ti A lfa b e ti p r iv i d i tito lo
d i s tu d io
L ic e n z a e le m e n ta re L ic e n z a m e d ia
in fe rio re
D ip lo m a L a u re a
1 9 5 1 1 9 6 1 1 9 7 1 1 9 8 1 1 9 9 1 2 0 0 1
impa rapporto.indd 124impa rapporto.indd 124 2-04-2009 19:20:492-04-2009 19:20:49

125 AMBIENTE URBANO06
Iscritti nelle scuole per ordine e gradoRelativamente alla scelta dell’indirizzo scolastico, si nota un cambiamento dell’orientamento negli ultimi
tre anni.
Osservando le variazioni, registrate nel 2007/2008 rispetto all’anno precedente, le iscrizioni all’indirizzo artistico sono notevolmente diminuite (-8,0%); anche l’indirizzo tecnico ha subito una fl essione (-1,6%).
L’indirizzo magistrale è quello che registra l’aumento più consistente nel 2007/2008 (+2,4%).
Il calo complessivo di iscritti può essere dovuto alla diminuzione della popolazione in età 14-18 anni che, dal 31/12/2005 al 31/12/2007, è stata del 2,5%.
Indirizzo 2005/2006 2006/2007 variazione 2007/2008 variazione
Artistico 158 163 3,2% 150 -8,0%
Liceale 2.255 2.391 6,0% 2.399 0,3%
Magistrale 1.034 994 -3,9% 1.018 2,4%
Professionale 2.481 2.467 -0,6% 2.472 0,2%
Tecnico 3.867 3.841 -0,7% 3.780 -1,6%
Totale 9.795 9.856 0,6% 9.819 -0,4%
Iscritti agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado per indirizzo, aa.ss. 2005/2006-2007/2008
Fonte: Osservatorio Scolastico Provinciale – Elaborazioni: Uffi cio Statistica della Provincia di Rovigo
Iscritti agli istituti di istruzione secondaria di secondo gradoFonte: Osservatorio Scolastico Provinciale
Distribuzione per indirizzo, a.s. 2007/2008 Fonte: Osservatorio Scolastico Provinciale
- 1 . 0 0 0 2 . 0 0 0 3 . 0 0 0 4 . 0 0 0
A rtis tic o
L ic e a le
M a g is tr a le
P ro fe s s io n a le
T e c n ic o
A rtis tic o
2 %
P ro fe s s io n a le
2 5 %
M a g is tr a le
1 0 %
L ic e a le
2 4 %
T e c n ic o
3 9 %
impa rapporto.indd 125impa rapporto.indd 125 2-04-2009 19:20:492-04-2009 19:20:49

126AMBIENTE URBANO 06
Diplomati ogni 100 diciannovenniFonte: Osservatorio Scolastico Provinciale
Percentuale di diplomatiIl tasso di scolarizzazione è elevato nella
provincia di Rovigo.
Anche i risultati scolastici – misurati dalla percentuale di giovani diplomati - assumono nella provincia di Rovigo valori più positivi ri-spetto a quelli regionali e nazionali.
Infatti, su 100 diciannovenni, circa 80 in Po-lesine hanno ottenuto il diploma di scuola me-dia superiore; nella regione Veneto il dato è di 73 giovani su 100 e, a livello nazionale, è poco più di 77 giovani su 100 (dati anno scolastico 2006/2007).
Il dato differenziato per genere evidenzia una netta prevalenza di diplomate (si raggiunge il 92,6%) rispetto ai diplomati (inferiore a 70 diplomati su 100 ragazzi).
a
a o -
--
di o
Territorio Diplomati per 100 diciannovenni
Provincia di Rovigo
(a.s. 2006-2007)
Maschi 68,9%
Femmine 92,6%
Totale 79,8%
Veneto
(a.s. 2004-2005)
Maschi 67,8%
Femmine 78,7%
Totale 73,2%
Italia
(a.s. 2004-2005)
Maschi 73,5%
Femmine 81,3%
Totale 77,3%
Diplomati per 100 diciannovenni, confronto provincia di Rovigo
a.s. 2006-2007, Veneto e Italia a.s. 2004-2005, valori percentuali
Fonte: Osservatorio Scolastico Provinciale
7 9 , 8 % 7 7 , 3 %7 3 , 2 %
0 %
2 0 %
4 0 %
6 0 %
8 0 %
1 0 0 %
P ro v . d i R o v ig o R e g . V e n e to I ta lia
m a s c h i fe m m in e to ta le
impa rapporto.indd 126impa rapporto.indd 126 2-04-2009 19:20:502-04-2009 19:20:50

127 AMBIENTE URBANO06
Tipo d’Istituto indirizzo
LICEO SCIENTIFICO “P. PALEOCAPA” Via De Gasperi, 19 Rovigo
ISTITUTO MAGISTRALE “C. ROCCATI” Via Carducci, 8 Rovigo
(con annessa sezione classica e linguistica sperim. “Celio”) Via Badaloni, 2 Rovigo
LICEO CLASSICO “C. BOCCHI” Via Dante Alighieri, 4 Adria
(con annessa sezione magistrale “G. Badini”) Adria
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LIC. SCIENT. “GALILEI”
- Liceo Scientifi co “G. Galilei” V.le U. Maddalena, 24 Adria
- Istituto Tecnico Industriale “F. Viola” Via Aldo Moro, 3 Adria
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LIC. SC. “BALZAN”
- Liceo Scientifi co sperim. scient. tecn. ling. mod. Via Manzoni Badia Polesine
- Ist. Tecnico Industriale “F. Viola” Via Manzoni, 191/1 Badia Polesine
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.A. “O. MUNERATI”
- Ist.Tecn. Agrario “O. Munerati” Via Cappello, 10 S. Apollinare
- Ist.Tecn. Geometri “A. Bernini” Corso del Popolo, 274 Rovigo
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “DE AMICIS” Via Parenzo, 16 Rovigo
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “F. VIOLA” Via De Gasperi, 21 Rovigo
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI”
- Ist. Tecn. Att. Soc. “L. Einaudi” Via S. Nicolò, 31 Badia Polesine
- Ist. Tec. Comm. “G. B. Conti” Via Montegrappa, 31 Lendinara
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE IST. D’ARTE
- Istituto d’Arte Via Matteotti, 34 Castelmassa
- I.P.S.I.A. “E. Bari” Viale Stazione, 45 Badia Polesine
- I.P.A. “M. e T. Bellini” Via Mazzini, 5 Trecenta
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. COLOMBO”
- Ist. Prof. Stat. Serv. Comm. e Tur. “C. Colombo” Via S. Francesco, 33 Adria
- I.P.S.I.A. Via U. Giordano, 4 Porto Tolle
- Istituto Tecnico Commerciale Via Marconi, 2/11 Porto Viro
ISTITUTO PROF. PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE Via A. Moro Adria
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E GEOM. “G. MADDALENA” Via Alighieri, 17 Adria
IST. PROFESS. INDUSTRIA E ARTIGIANATO Viale V. Alfi eri, 43 Rovigo
IPSSCT “MARCO POLO” Via De Gasperi, 17 Rovigo
CONSERVATORIO DI MUSICA “F. VENEZZE” C.so del Popolo, 245 Rovigo
CONSERVATORIO DI MUSICA “A. BUZZOLLA” V.le Maddalena, 2 Adria
Istituti scolastici secondari presenti nella provicnai di Rovigo
Fonte: Osservatorio Scolastico Provinciale
Offerta scolastica Complessivamente nella provincia sono presenti 26 istituti scolastici secondari, concentrati maggior-
mente a Rovigo, Adria e Badia che fungono da poli scolastici per l’intera provincia. In questi tre poli sono presenti licei scientifi ci ed istituti tecnici commerciali, per geometri ed industriali che garantiscono quindi una ampia offerta formativa disponibile nell’intero territorio provinciale.
Alcuni istituiti, per caratteristiche formative particolari e per via della poca richiesta, sono localizzati solo all’interno di alcuni poli. Come nel caso del comune di Rovigo che nella frazione di S. Apollinare ha loca-lizzato l’Istituto Tecnico Agrario. Mentre ad Adria ha sede l’Istituto Professionale Alberghiero, eccellenza sia per il grado di formazio-ne offerta sia per l’alta richiesta di diplomati da questo istituto nel com-prensorio del Delta.
All’offerta professio-ne si affi anca l’offerta data dai due conserva-tori di musica presenti nel territorio provincia-le; il Venezze a Rovigo ed il Buzzolla ad Adria.
impa rapporto.indd 127impa rapporto.indd 127 2-04-2009 19:20:502-04-2009 19:20:50

128AMBIENTE URBANO 06
Cinema, teatro, spettacoliOfferta e di spettacoli cinematografi ciLe informazioni a disposizione permettono di effettuare una analisi che si ferma al 31 dicembre 2007,
prima quindi che nella provincia, ed in particolare nel capoluogo, si registrasse la chiusura di alcune sale cinematografi che.
I dati dal 2001 al 2007 evidenziano una crescita, superiore alla media regionale, del numero di spet-tacoli offerti in provincia, ed una crescita notevole anche della spesa pro capite. La spesa per spettatore per spettacolo è anch’essa superiore al valore regionale, sintomo di un interesse della popolazione nei confronti dell’offerta cinema-tografi ca.
Questo trend si è arrestato nel 2006, anno in cui la spe-sa per spettacolo è diminuita così come il numero comples-sivo di spettacoli offerti. Tra il 2006 ed il 2007 si è registra-ta una seconda crescita.
Andamento del numero di spettacoli e spesa per spettacolo, anni 2001 – 2007Fonte dati: SIAE – Elabora-zione: Agenda21Polesine
o-a-il-
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Numero di spettacoli cinematografi ci
Rovigo 3.971 4.149 4.206 5.316 6.721 6.438 7.329
su 1.000 abitanti 16,38 17,10 17,25 21,73 27,46 26,29 29,76
Veneto 78.353 85.541 87.669 94.399 95.814 100.204 102.830
su 1.000 abitanti 17,30 18,69 18,88 20,09 20,22 20,99 21,28
Spesa pro capite
Rovigo 7,80 7,59 7,14 9,19 9,87 8,89 11,33
Veneto 11,45 11,45 10,80 11,53 10,27 10,29 10,88
Spesa per spettatore per spettacolo
Rovigo 5,44 5,77 6,16 6,19 6,28 6,03 6,19
Veneto 5,43 5,50 5,78 5,71 5,75 5,80 5,90
Numero spettacoli e spesa per spettacoli cinematografi ci
Fonte dati: SIAE – Elaborazione: Agenda21Polesine
0
5
1 0
1 5
2 0
2 5
3 0
3 5
2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
5 , 0 0
5 , 2 0
5 , 4 0
5 , 6 0
5 , 8 0
6 , 0 0
6 , 2 0
6 , 4 0
N u m e ro s p e tta c o l i o g n i 1 . 0 0 0 a b ita n ti R o v ig o N u m e ro s p e tta c o li o g n i 1 . 0 0 0 a b ita n ti V e n e to
S p e s a p e r s p e tta to re p e r s p e tta c o lo R o v ig o S p e s a p e r s p e tta to re p e r s p e tta c o lo V e n e to
impa rapporto.indd 128impa rapporto.indd 128 2-04-2009 19:20:512-04-2009 19:20:51

129 AMBIENTE URBANO06
Teatro ed attività teatraliComplessivamente in provincia di Rovigo vengono allestiti un numero di eventi teatrali inferiore, per
numero di abitante, alla media regionale e italiana. Questo è dovuto principalmente al fatto che il numero e la dimensione dei teatri è minore rispetto al resto del Veneto e che molti spettacoli vengono realizzati nelle vicine province di Padova, Ferrara e Verona, che hanno bacini di pubblico molto più ampi. Basti pen-sare all’ offerta che da sola offre l’Arena di Verona o il Teatro La Fenice di Venezia ed al bacino che queste strutture hanno a disposizione.
Tuttavia i dati a disposizione evidenziano un’ offerta consistente con un numero di spettacoli di circa 3-4 eventi a settimana, considerando complessivamente tutta l’offerta teatrale. Da evidenziare il peso delle opere teatrali nel complesso dell’offerta, secondaria importanza lo rivestono i balletti (in particolare il car-tellone con l’offerta di Rovigo).
Tra il 2006 ed il 2007 nonostante il calo di numero di spettacoli (-9,3%) ed il numero di ingressi (-14,4%) si registra un aumento della spesa al botteghino, segno che le attività teatrali hanno comunque riscosso una forte risposta nel pubblico.
Nel grafi co è riportata la spesa per ingresso nel 2006 e nel 2007.
Spesa per singolo ingresso per i diversi tipi di spettacolo teatrale nella provincia di Rovigo.Fonte: ISTAT statistiche culturali – Elaborazione: Agenda21Polesine
Numero spettacoli Ingressi Spesa al botteghino
tipo di attività 2006 2007 Var. % 2006 2007 Var. % 2006 2007 Var. %
Teatro 114 150 31,6% 22.884 19.216 -16,0% 222.949 238.452 6,95%
Lirica 30 19 -36,7% 10.271 6.354 -38,1% 118.206 140.824 19,13%
Rivista e Commedia musicale 4 5 25,0% 560 1.914 241,7% 2.643 16.765 534,34%
Balletto 26 21 -19,2% 5.437 5.647 3,8% 58.882 60.081 2,04%
Altro * 72 28 -61,11% 1.136 1.348 18,66% 10.415,00 14.579,00 39,98%
Totale attività teatrali 246 223 -9,3% 40.288 34.479 -14,4% 413.096 470.702 13,94%
Spettacoli teatrali nella provincia di Rovigo
Fonte: ISTAT statistiche culturali – Elaborazione: Agenda21Polesine
¤ -
¤ 5 , 0 0
¤ 1 0 , 0 0
¤ 1 5 , 0 0
¤ 2 0 , 0 0
¤ 2 5 , 0 0
2 0 0 6 ¤ 9 , 7 4 ¤ 1 1 , 5 1 ¤ 4 , 7 2 ¤ 1 0 , 8 3 ¤ 9 , 1 7 ¤ 1 0 , 2 5
2 0 0 7 ¤ 1 2 , 4 1 ¤ 2 2 , 1 6 ¤ 8 , 7 6 ¤ 1 0 , 6 4 ¤ 1 0 , 8 2 ¤ 1 3 , 6 5
Te a tro L i r ic aR iv is ta -
C o m m . m u s ic .B a lle tto A ltro T o ta le a ttiv ità te a tra li
impa rapporto.indd 129impa rapporto.indd 129 2-04-2009 19:20:522-04-2009 19:20:52

130AMBIENTE URBANO 06
Sistema bibliotecario provincialeIl Servizio Bibliotecario Provinciale (S.B.P.) è una rete che collega le bi-
blioteche del territorio della provincia di Rovigo. E’ stato istituito nel 1997 ed è un progetto della Provincia di Rovigo, attuato dall’Area Servizi alla Persona.
La gestione tecnica del servizio è affi data all’Accademia dei Concordi di Rovigo, secondo i termini sta-biliti da una convenzione sottoscritta con la Provincia. L’S.B.P. si avvale dei fi nanziamenti della Regione Veneto (L.R. 50), dei contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Rovigo e della Fondazione Banca del Monte di Rovigo. Aderiscono al sistema i comuni della provincia di Rovigo, alcuni istituti scolastici superiori, l’Accademia dei Concordi e la Biblioteca Provinciale.
Scopo del S.B.P. è di realizzare una rete che favorisca la cooperazione bibliotecaria nel territorio provin-ciale, aumentando l’offerta e la qualità dei servizi al cittadino.
A questo fi ne è attivo on line il Catalogo Collettivo S.B.P. che, previo il completamento del trasferimento dei dati catalografi ci dei patrimoni librari delle biblioteche aderenti, consente il libero accesso per la ri-cerca dei testi e, tramite password, l’accesso al software per la catalo-gazione via internet.
I servizi offerti da S.B.P. sono i seguenti: catalogo on line, servizio di prestito interbibliotecario, cata-logazione centralizzata dei nuovi acquisti (Centro di Catalogazione), catalo
gazione partecipata (anche attra-verso personale messo a disposi-zione, in loco, da S.B.P.), assistenza tecnica, sviluppo software, comuni-cazione e promozione della rete e delle biblioteche aderenti.
Distribuzione del servizioSolo 6 comuni non fanno parte
della rete del SBP fra cui Salara, Canda e Papozze. Il capoluogo oltre ad avere l’Accademia dei Concordi ha anche biblioteche scolastiche.
Il servizio è stato incrementato rispetto al precedente rapporto del 2002.
ni , -, -
i o -
vi ,
--a -e
oe , e di
o el
BIBLIOTECHE CIVICHE Pettorazza Grimani - Umberto Maddalena
Adria Polesella
Ariano Polesine Pontecchio Polesine
Badia Polesine - Giangirolamo Bronziero Porto Tolle
Bagnolo di Po Porto Viro
Bergantino - Fermo e Giuseppe Bellini Rosolina
Bosaro San Bellino
Calto San Martino di Venezze
Canaro Salara
Castelguglielmo - Mattia Bortoloni Stienta - Leonino Vinicio Gabaldi
Castelmassa Taglio di Po
Castelnovo Bariano Trecenta
Ceneselli - Felice Chilanti Villadose - Guerrino Rizzo
Ceregnano Villamarzana
Corbola - Rosetta Pampanini Villanova Marchesana
Costa di Rovigo BIBLIOTECHE SCOLASTICHE
Crespino Conservatorio di Musica A Buzzolla - Adria
Ficarolo IPSSCT Marco Polo - Rovigo
Fiesso Umbertiano ITC Edmondo De Amicis - Rovigo
Frassinelle Polesine Liceo Scientifi co Eugenio Balzan - Badia Polesine
Fratta Polesine - Giovanni Maria Bonardo Liceo Scientifi co Galileo Galilei - Adria
Gaiba Liceo Scientifi co Paleocapa - Rovigo
Gavello BIBLIOTECHE RAGAZZI
Giacciano con Baruchella - Ugo Grisetti Accademia dei Concordi - Multispazio Ragazzi
Guarda Veneta Adria - Biblioteca dei Ragazzi
Lendinara - Gaetano Baccari Porto Viro - La Bottega di Pinocchio
Loreo - Piergiorgio Bassan ALTRE BIBLIOTECHEAccademia dei Concordi
Centro Francescano di Ascolto
Provincia di Rovigo
Lusia
Melara - Dino Tinti
Occhiobello
Distribuzione delle biblioteche del Servizio BibliotecarioFonte: Servizio Bibliotecario Provinciale SBP
impa rapporto.indd 130impa rapporto.indd 130 2-04-2009 19:20:522-04-2009 19:20:52

131 AMBIENTE URBANO06
Indice di prestitoLa tabella, che utilizza i dati disponibili sul sito del Si-
stema Bibliotecario Provinciale SBP, mette in evidenza il numero di prestiti effettuati dal sistema nell’anno 2007 e 2008.
Nelle due colonne fi nali viene invece rappresentato il rapporto tra i prestiti registrati per ciascuna biblioteca e la popolazione residente di quel comune. Tale rapporto (pre-stiti/popolazione) è detto “Indice di prestito” ed è consi-derato dall’AIB (Associazione Italiana Biblioteche) uno dei più signifi cativi per misurare e valutare la vitalità di una biblioteca (coinvolgimento degli utenti potenziali, qualità delle collezioni).
Il grafi co rappresenta l’indice di prestito delle varie bi-blioteche in ordine decrescente a partire dal valore regi-strato nel comune di Lendinara. Non sono rappresentati le biblioteche che hanno fatto registrare un valore inferiore a 25 prestiti ogni 100 residenti (pari a 0,25). Nel grafi co sono inoltre presenti due linee rosse che rappresentano gli indici di prestito medi regionali calcolati per la stessa fascia di popolazione. Per i comuni con più di 5.000 residenti il valore è 0,91, mentre per i comuni con meno popolazione il valore di riferimento regionale è 0,77.
Prestiti e indice di prestito del Sistema BibliotecarioFonte: Sistema Bibliotecario Provinciale SBP – Elaborazione: Agenda21Polesine
-ile
ila--
eiaà
--eeoiaile
Prestiti Indice di prestito
Comune 2007 2008 2007 2008
Castelmassa 9.013 10.942 2,04 2,47
Bergantino 3.686 4.316 1,41 1,64
Villadose 4.279 6.539 0,81 1,23
Calto 935 849 1,16 1,04
Occhiobello 4.644 10.748 0,43 0,96
Melara 1.078 1.346 0,55 0,70
Ceregnano 2.206 2.512 0,56 0,65
Porto Tolle 7.241 6.247 0,70 0,61
Rovigo (totale) 20.655 28.393 0,40 0,55
di cui Accademia 19.726 27.014 0,39 0,52
Trecenta 1.288 1633 0,42 0,54
Gavello 598 830 0,37 0,51
Porto Viro 5.776 7.459 0,40 0,51
Taglio di Po 2.529 4.011 0,30 0,47
Crespino 724 979 0,34 0,46
Costa di Rovigo 1.018 1.057 0,36 0,37
Loreo 1.152 1.202 0,30 0,32
Pontecchio Polesine 407 502 0,23 0,27
Guarda Veneta 189 318 0,16 0,26
Fiesso Umbertiano 680 1.092 0,16 0,26
Lendinara 2.983 3.086 0,24 0,25
Adria 4.144 4.912 0,20 0,24
Ceneselli 450 426 0,24 0,23
Castelnovo Bariano 337 656 0,11 0,22
Polesella 338 696 0,08 0,17
Corsola 18 426 0,01 0,16
Ficarolo 374 314 0,14 0,12
Badia Polesine 1.781 1.249 0,17 0,11
Bosaro 28 64 0,02 0,05
Canaro 29 121 0,01 0,04
Pettorazza Grimani 17 35 0,01 0,02
Villanova Marchesana 21 11 0,02 0,01
Lusia - 18 0,00
Prestiti e indice di prestito del Sistema BibliotecarioFonte: Sistema Bibliotecario Provinciale SBP
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
indice di prestito anno 2007 indice di presti to anno 2008
Cast
elm
assa
Berg
antin
o
Villa
dose
Calto
Occ
hiob
ello
Mel
ara
Cere
gnan
o
Porto
Tol
le
Rovig
o
Trec
enta
Gav
ello
Porto
Viro
Tagl
io d
i Po
Cres
pino
Cost
a di
Rov
igo
Lore
o
Pont
ecch
io P
oles
ine
Gua
rda
Vene
ta
Fies
so U
mbe
rtian
o
Lend
inar
a
impa rapporto.indd 131impa rapporto.indd 131 2-04-2009 19:20:522-04-2009 19:20:52

132AMBIENTE URBANO 06
Catalogo bibliotecario disponibile La tabella mostra l’andamento dell’informatizzazione dei patrimoni delle biblioteche dal secondo se-
mestre del 2006 fi no al secondo semestre del 2008 e relativi incrementi annui del Catalogo Collettivo OPAC_SBP rilevato dal Centro Servizi S.B.P.
L’incremento sia delle unità sia dei titoli è continuo e questo permette al servizio di offrire una vasta opportunità di scelta agli utenti dell’intero sistema bibliotecario. Il sistema permette infatti l’interscambio di titoli tra le biblioteche grazia al bibliobus, ovvero grazie al sistema di collegamento fra i vari cataloghi offerto dalla Provincia.
Andamento dell’informatizzazione dei patrimoni delle bibliotecheFonte: Sistema Bibliotecario Provinciale – Elaborazione: Agenda21Polesine
Periodo di rilevazione
unità docu.
singole * titoli inseriti **
variazione delle unità
doc. singole
variazione dei
titoli inseriti
II semestre 2006 181.601 91.843 - -
I semestre 2007 196.346 100.019 8,12% 8,90%
II semestre 2007 219.533 111.861 11,81% 11,84%
I semestre 2008 232.150 122.473 5,75% 9,49%
II semestre 2008 249.930 131.339 7,66% 7,24%
* Unità = sono le unità documentarie singole ovvero le collocazioni, il numero quindi di volumi (es. due copie dello stesso libro vale 2, in quanto sono 2 volumi) **Titoli = sono i titoli inseriti ovvero i record catalografi ci, ovvero i titoli fra cui è possibile scegliere (es. due copie dello stesso libro vale 1, in quanto stesso titolo)
Andamento dell’informatizzazione dei patrimoni delle biblioteche
Fonte: Sistema Bibliotecario Provinciale
0
5 0 . 0 0 0
1 0 0 . 0 0 0
1 5 0 . 0 0 0
2 0 0 . 0 0 0
2 5 0 . 0 0 0
3 0 0 . 0 0 0
I I s e m e s tre 2 0 0 6 I s e m e s tre 2 0 0 7 I I s e m e s tre 2 0 0 7 I s e m e s tre 2 0 0 8 I I s e m e s tre 2 0 0 8
0 %
2 %
4 %
6 %
8 %
1 0 %
1 2 %
u n ità d o c u m e n ta r ie s in g o le ti to l i in s e ri ti
v a ria z io n e d e lle u n i tà d o c u m e n ta rie s in g o le v a r ia z io n e d e i ti to l i in s e r iti
impa rapporto.indd 132impa rapporto.indd 132 2-04-2009 19:20:532-04-2009 19:20:53

133 AMBIENTE URBANO06
Energia e politiche per la protezione del climaIl Piano d’Azione “Una politica energetica per l’Europa” promosso dell’Ue nel marzo 2007 prevede le
seguenti politiche da attuare nei diversi Stati membri:
1- La riduzione del 20% grazie all’effi cienza energetica sui consumi di energia previsti per il 2020;
2- Incrementare fi no al 20% la percentuale di produzione di energia da fonti rinnovabili nel 2020 (17% per l’Italia);
3- Ridurre del 20% le emissioni di gas serra sempre nell’orizzonte temporale di riferimento (13% per l’Italia).
La Provincia di Rovigo ha avviato la defi nizione di un Programma energetico improntato seguendo le direttive promosse dal legislatore europeo. La necessità di fare delle previsioni attendibili sui consumi energetici della provincia di Rovigo ha rappresentato, quindi, il primo e fondamentale passo per poter sviluppare concretamente uno scenario verso il sopra citato “20 - 20 – 20”.
Grazie al lavoro di costruzione degli scenari energetici futuri per il territorio polesano, è stato possibile ipotizzare le azioni necessarie per soddisfare il primo obiettivo stabilito dall’Ue e cioè la riduzione dei con-sumi grazie ad un uso energetico effi ciente. Il passo da compiere, quindi, va verso un deciso cambiamento di mentalità in modo tale da abbattere l’attuale uso, sovrabbondante e non giustifi cato, delle diverse fonti energetiche.
La stessa Unione stabilisce, a questo proposito, la necessità di tagliere di un 1/5 i consumi energetici previsti per l’anno 2020, grazie ad un utilizzo energetico effi ciente. Per raggiungere questo scopo, occorre pianifi care una serie di interventi che abbiano il fi ne di agire su tutti i settori socio-economici, con la pre-rogativa di eliminarne gli eventuali sprechi energetici presenti. Le operazioni che si possono svolgere sono molteplici e hanno, naturalmente, pesi specifi ci molto differenti: dalla semplice sostituzione di una lam-padina ad incandescenza con una fl uorescente compatta, all’utilizzo di complessi e costosi motori elettrici industriali ad alta effi cienza. Le possibilità di risparmio sono evidenti e non richiedono necessariamente elevati costi d’investimento e tempi troppo dilatati.
Infi ne, grazie all’effi cienza energetica, è possibile raggiungere due diversi obiettivi.
In primo luogo, tagliare gli sprechi signifi ca ridurre effi cacemente le emissioni atmosferiche dannose per l’uomo e per il Pianeta Terra. In secondo luogo, effi cienza energetica signifi ca ottime possibilità di rispar-mio economico per le famiglie e le imprese.
Il secondo obiettivo fi ssato dall’Ue riguarda, come detto, la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il risultato da raggiungere per l’Italia è quello di arrivare ad avere una quota non inferiore al 17% di energia da fonti alternative, calcolate sui consumi di energia fi nale rimanente dalla riduzione del 20% ottenuta dal risparmio energetico. Equivale a dire che bisogna produrre il 17% di energia da fonte rinnovabile sull’80% rimanente dal risparmio energetico e quindi un 13,6% sul totale. Anche in questo caso, gli interventi che possono essere promossi per il territorio rodigino sono molteplici e devono necessariamente essere cali-brati in base alle peculiarità specifi che che offre il contesto locale di riferimento (privilegiando, in questo senso, la produzione di energia dal Sole e dalle biomasse di origine vegetale).
Per quanto riguarda, infi ne, le emissioni di gas climalteranti, sempre in base alla direttiva 20-20-20 la percentuale che deve essere ridotta per l’Italia è del 13% rispetto alle emissioni del 2005. In questa quota, in base alla direttiva, non rientrano le quote ETS che hanno già una loro regolamentazione a partire dalla direttiva del 2003 recentemente modifi cata con la conferenza di Poznan.
Nella contabilizzazione del programma energetico, comunque, rientrano anche le quote ETS (quindi la CO2 totale). Questo, non solo per semplicità di calcolo, ma anche perché tale somma rappresenta una sorta di sicurezza in quanto se si escludono le quote ETS la percentuale di riduzione sarà più elevata.
impa rapporto.indd 133impa rapporto.indd 133 2-04-2009 19:20:542-04-2009 19:20:54

134AMBIENTE URBANO 06
Grazie ai dati raccolti dall’Area Ambiente, meglio dettagliati nel Programma Energetico cui si rimanda - è possibile sviluppare alcune considerazioni ed illustrare i dati relativi al consumo ed alla produzione di energia nella provincia di Rovigo. L’analisi ha come dato base l’anno 2006 in quanto molti dati non sono ancora disponibili per gli anni successivi.
Consumi energetici Le vendite com-
plessive di prodot-ti petroliferi (Ben-zina, GPL,Gasolio e Olio Combustibi-le) ammontavano nel 2006, ad oltre 186.000 TEP1, fa-cendo registrare una diminuzione rispetto al 1990 del 5,69%. Tra i derivati del petrolio, la quota prevalente spetta al gasolio, in particolare quello destinato all’autotrazione.
E’ interessante far notare che i consumi di gasolio sono aumentati soprattutto nel periodo ‘02 –‘06 (dal 42% al 63%), mentre la vendita di benzina è diminuita soprattutto nel periodo 2003 - 2006 (dal 35% al 29%).
In termini generali, l’andamen-to dei consumi dell’olio combusti-bile e dell’olio lubrifi cante è stato soggetto, nel periodo temporale considerato, ad un andamento al-talenante. Negli ultimi anni, però, il suo peso all’interno dei consumi di prodotti petroliferi è nettamen-te diminuito passando dal 27,16% del 2001 (valore massimo rag-giunto nel periodo) all’1,29% del 2006 (valore minimo nella mede-sima scala temporale).
Limitato è il contributo del Gas di Petrolio Liquefatto, che ha regi-strato un lieve aumento nell’intervallo temporale 1990 - 2003 (dal 6,78% nel 1990 all’8,07% nel 2003). Nell’ultimo quadriennio (2003 – 2006), però, le vendite di G.P.L. hanno subito una moderata fl essione (dal 6,78% del 2003 al 6,28% del 2006).
Consumi energetici nella Provincia di RovigoFonte: GRTN, ditte distributrici di Gas Naturale e Ministero dell’Industria
---o-oe-eedel 5 69% Tra i derivati del petrolio la quota prevalente spetta al gasolio in particolare
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Energia elettrica 98.925 102.804 111.386 113.209 116.262 117.122 120.201 128.431 127.485
Gas Naturale 164.457 178.424 161.572 154.745 157.053 161.041 178.512 186.776 198.909
Benzina 76.166 75.248 70.416 68.435 66.732 65.123 61.512 57.849 54.749
Gasolio 61.293 81.371 79.648 81.541 98.134 93.852 99.133 101.581 117.541
GPL 22.488 19.699 18.621 18.416 15.843 14.808 13.074 12.288 11.706
Olio comb. e lubri. 8.792 5.293 19.533 62.781 48.683 9.603 6.262 5.604 2.404
Totale 432.121 462.839 461.176 499.127 502.707 461.549 478.694 492.529 512.794
Consumi energetici nella provincia di Rovigo espressi in TEP Fonte: GRTN, ditte distributrici di Gas Naturale e Ministero dell’Industria
1. TEP: è un'unità di misura usata per rendere più maneggevoli le cifre relative a grandi valori di energia. L'energia liberata dalla combustione di una tonnellata di petrolio è più intuitiva dell'equivalente valore di 42 miliardi di joule. Rappresenta la quantità di energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo e vale circa 42 GJ.
0
1 0 0 . 0 0 0
2 0 0 . 0 0 0
3 0 0 . 0 0 0
4 0 0 . 0 0 0
5 0 0 . 0 0 0
6 0 0 . 0 0 0
1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6
E n e rg ia e le ttr ic a G a s n a tu ra le B e n z in a G a s o l io G p l O lio c o m b u s tib ile e lu b ri fic a n te
impa rapporto.indd 134impa rapporto.indd 134 2-04-2009 19:20:542-04-2009 19:20:54

135 AMBIENTE URBANO06
Se i consumi vengono valutati in base ai principali settori di utilizzo si vede come la ripartizione sia quasi equamente suddivisa tra i tre macro settori: usi civili, trasporti e attività produttive.
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Usi civili 141.194 146.918 132.813 127.637 133.836 139.810 153.164 158.587 166.380
Trasporti 137.327 144.011 143.376 143.915 154.429 157.759 158.868 156.499 167.279
Attività produttive 153.600 171.910 184.987 227.575 214.442 163.980 166.662 177.443 179.135
TOTALE 432.121 462.839 461.176 499.127 502.707 461.549 478.694 492.529 512.794
Evoluzione dei consumi energetici per attività
consumi di energia elettrica (forniti da GRTN), di gas metano (forniti dalle ditte distributrici) e delle vendite dei prodotti petroliferi
(fornite dal Ministero dell’Industria)
Evoluzione dei consumi energetici per attivitàconsumi di energia elettrica (forniti da GRTN), di gas metano (forniti dalle ditte distributrici) e delle vendite dei prodotti petroliferi (fornite dal Ministero dell’Industria)
0
1 0 0 . 0 0 0
2 0 0 . 0 0 0
3 0 0 . 0 0 0
4 0 0 . 0 0 0
5 0 0 . 0 0 0
6 0 0 . 0 0 0
1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6
Attiv i tà p ro d u ttive Tra s p o r ti Us i c iv ili
impa rapporto.indd 135impa rapporto.indd 135 2-04-2009 19:20:542-04-2009 19:20:54

136AMBIENTE URBANO 06
Produzione di energia da fonti rinnovabili Nella provincia di Rovigo numerose iniziative hanno portato alla crescita della produzione di energia
elettrica attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili.
Fra le varie iniziative quella messa in atto dall’Amministrazione Provinciale è sicuramente una delle più consistenti ed interessanti, sia perché ha interessato tutto il territorio della provincia, sia perché ha dato la possibilità anche a privati di utilizzare i fondi messi a disposizione con il Conto Energia.
Grazie a questi interventi ogni anno viene evitata l’immissione in atmosfera di 235 tonnellate di CO2, gas che concorre insieme ad altri al surriscaldamento del pianeta.
La potenza complessivamente installata è pari a 419 kW e complessivamente in un anno questi impianti producono oltre 400.000 kW di potenza.
Questi, sintetizzati, sono gli interventi pubblici promossi dall’Amministrazione Provinciale. A questi de-vono sommarsi gli interventi dei privati e delle aziende che in questi anni sono stati realizzato e che si andranno a realizzare.
Pote
nza
Prod
uzio
ne
CO2
eq e
vita
ta
Cost
o
Rica
vi d
a Co
nto
Ener
gia
Rica
vi d
a Co
nto
Ener
gia
per
20 a
nni
Risp
arm
i su
bolle
tta
ENEL
Risp
arm
i su
bolle
tta
ENEL
per
20
anni
kWp kWp/anno ton/anno € €/anno € €/anno €
Impianti in conto energia in funzione
Liceo Scientifıco "Paleocapa" - Rovigo 19,80 25.000 14,00 120.000 11.500 230.000 3.750 75.000
Liceo Scientifi co "Balzan" - Badia Polesine 15,12 19.000 10,50 90.000 8.750 175.000 2.850 57.000
Pensilina IPSIA - Porto Tolle 19,80 24.600 13,50 120.000 11.300 226.000 3.700 74.000
Pensilina Centro Operativo 24,32 28.000 16,00 200.000 13.000 260.000 4.000 80.000
Totale A 79,04 96.600 54,00 530.000 44.550 891.000 14.300 286.000
Impianti in conto energia in fase di allacciamento
ITIS " Viola" - Rovigo 9,72 12.000 6,60 60.000 5.500 110.000 1.800 36.000
Facciata sede Provincia di Viale della Pace 18,60 12.300 6,80 195.000 5.600 112.000 1.850 37.000
Totale B 28,32 24.300 13,40 255.000 11.100 222.000 3.650 73.000
Impianti fotovoltaici già in funzione
Impianto ITIS Rovigo 10,00 12.000 6,60 135.000 - - 1.800 36.000
Impianto ITIS Adria 5,00 6.000 3,30 - - - 900 18.000
Impianto ITAS Badia Po1. 5,00 6.400 3,50 - - - 960 19.200
Facciata IPSIA Rovigo 35,00 27.000 14,80 405.000 - - 4.000 80.000
351 lampioni fotovoltaici 58,00 33.000 18,30 864.000 - - - -
Lampioni fotovoltaici Ca' Venier 3,78 2.000 1,10 60.000 - - - -
Bando contributi 195,00 210.000 120,00 140.000 - - - -
Totale C 311,78 296.400 167,60 1.604.000 - - 7.660 153.200
TOTALE A+B+C 419,14 417.300 235,00 2.389.000 55.650 1.113.000 25.610 512.200
Impianti solari in funzione nella provincia di Rovigo
Fonte: Provincia di Rovigo, area Ambiente
impa rapporto.indd 136impa rapporto.indd 136 2-04-2009 19:20:552-04-2009 19:20:55

137 AMBIENTE URBANO06
Esempi di grandi impianti in fase di progettazione e prossima realizzazione sono presenti a Loreo e nella macroarea produttiva tra Castelguglielmo e San Bellino. In questo secondo sito l’impianto fotovoltaico avrà una potenza di circa 80 (79,53) MW e si estenderà su una superfi cie coperta da pannelli solari di circa 850.000 metri quadrati. Questa collocazione è in prossimità della Transpolesana, l’autostrada A13 e il pro-lungamento della Valdastico. L’impatto visivo sarà modesto, in quanto le strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici saranno di altezza non superiore a 3,2 metri.
La producibilità stimata è di 95.500.000 kilowatt ora (kWh) all’anno di energia elettrica, suffi ciente a coprire il fabbisogno elettrico di circa 32.000 famiglie. Le emissioni evitate ogni anno saranno di 47.500 tonnellate di anidride carbonica (CO2). La realizzazione dell’impianto non produrrà emissioni in atmosfera, né inquinamento idrico, del suolo, del sottosuolo od acustico. La durata media dell’impianto sarà di circa 20-25 anni: al termine di questo periodo sarà possibile sostituire i vecchi pannelli, oppure smantellare l’opera e restituire il paesaggio nella medesima conformazione precedente il progetto.
L’impianto di Loreo occuperà invece 35 ettari di terreno che era stato sottoposto a ripristino ambientale negli ultimi dieci anni, dopo un eccessivo sfruttamento nel passato. L’impianto di 12,5 Mwh, che la Piave costruirà in collaborazione con la Edf Italia, realizzato con pannelli di telloruro di cadmio, si stima potrà pro-durre ogni anno 16.500 MW. L’iter burocratico che l’azienda ha dovuto percorrere è in parte inedito proprio per la relativa novità di impianti di questa portata.
L’impianto sarà collegato con un cavidotto alla sottostazione di Adria, dove l’energia prodotta sarà im-messa nella rete nazionale.
Irradiazione globale del suolo (kW/m2) su piano orizzontale, la provincia di Rovigo raggiunge i 1350 kW/m2fonte: Joint Research Centre - JRC - European Commission
impa rapporto.indd 137impa rapporto.indd 137 2-04-2009 19:20:552-04-2009 19:20:55

138AMBIENTE URBANO 06
Contributi per solare termico e fotovoltaico
La provincia di Rovigo ha inoltre emanato appositi Bandi per la concessione di contributi da utilizzare per la realizzazione di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura e/o impianti fotovoltaici per la conversione diretta dell’energia proveniente dalla radiazione solare in energia elettrica.
Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi ai bandi che sono stati emanati dal 2006 ad oggi. Per il 2009 il termine entro cui presentare domanda scade il 29 maggio. Maggiori informazioni sul sito della provincia, www.provincia.rovigo.it
Con la messa a regime degli impianti FTV sovvenzionati con i tre bandi 2006-2007-2008 si avrà un rispar-mio di 188.784 ton CO2 quale contributo per la defi nizione di politiche per la protezione del clima.
1° Bando del 2006:
fondo stanziato 117.000,00 €2.000,00 € per ciascun impianto FTV e 500,00 € per ciascun impianto solare termico;contributi nella misura di
Impianti FTV ammessi a contributo n. 35 pari a 95 kWp 64980 CO2 risparmiata a regime
Impianti SOL. TERM. ammessi a contributo n. 94 pari a 396 mq
2° Bando del 2007:
fondo stanziato 101.500,00 €2.000,00 € per ciascun impianto FTV e 500,00 € per ciascun impianto solare termico;contributi nella misura di
Impianti FTV ammessi a contributo n. 35 pari a 96 kWp 65664 CO2 risparmiata a regime
Impianti SOL. TERM. ammessi a contributo n. 63 pari a 350 mq
3° Bando del 2008 situazione al 18.03.2009; scadenza domande 29.05.2009
fondo stanziato 100.000,00 €2.000,00 € per ciascun impianto FTV e 500,00 € per ciascun impianto solare termicocontributi nella misura di
Impianti FTV ammessi a contributo n. 59 pari a 85 kWp 58140 CO2 risparmiata a regime
Impianti SOL. TERM. ammessi a contributo n. 44 pari a 200 mq
Contributi messi a disposizione dalla provincia di Rovigo per incrementare la diffusione delle fonti rinnovabiliFonte: Provincia di Rovigo, Area Ambiente
impa rapporto.indd 138impa rapporto.indd 138 2-04-2009 19:20:562-04-2009 19:20:56

139 AMBIENTE URBANO06
Politiche per il climaLa “protezione del clima” è un concetto ampiamente (e condivisibilmente) controverso. Il clima non si
può proteggere, per lo meno non con azioni dirette. Non è possibile intervenire rispetto al mutare della circolazione terrestre, non è possibile bloccare un fenomeno atmosferico violento e inatteso, nessuna tec-nologia fornisce alcun aiuto per impedire lo scioglimento dei ghiacciai terrestri o tanto meno per garantire la loro riformazione.
Potremmo defi nire la protezione del clima come l’insieme delle politiche indirette di adattamento e mitigazione fi nalizzate alla riduzione dell’impatto dei cambiamenti climatici su sistemi naturali ed antro-pizzati da un lato e alla riduzione delle esternalità ambientali, che possono favorire le mutazioni climatiche nel medio e lungo periodo. La protezione del clima fa quindi riferimento ad un insieme di politiche già de-fi nite nei sistemi di governo internazionali e locali, con la differenza che prevede l’applicazione congiunta di politiche per l’adattamento e per la mitigazione, con un approccio di valenza strategica, che sia in grado di tenere assieme diversi livelli di gestione, di settori di intervento e di attori (Musco, 2008).
Lo scopo delle politiche di mitigazione consiste nell’evitare impatti non gestibili, secondo un prospet-tiva ex-ante, operando le opportune azioni di calmierazione. L’aumento delle temperature, l’aumento delle precipitazioni o lo scioglimento della banchisa artica non sono eventi gestibili dal momento in cui avvengono. L’unica possibilità è la riduzione delle cause scatenanti di tali fenomeni (l’aumento della CO2 in primis) e una volta che sono avvenuti le sole politiche ipotizzabili sono quelle di adattamento, che comunque non vanno confuse con i piani dell’emergenza e della protezione civile, necessitando di tempi medio-lunghi per essere implementate. Nell’ambiente urbano le politiche di adattamento risultano avere un ruolo di maggior importanza rispetto a quelle di mitigazione, per due ordini di ragioni.
Da un lato, la tendenza al cambiamento climatico non sarà invertita prima dei prossimi 40 anni, pur ipotizzando che potessero essere portate a regime tutte le possibili politiche di mitigazione nell’immedia-to. Dall’altro la mitigazione, in termini di riduzione dei consumi energetici e le riduzioni di emissioni che ne conseguono, richiede alcuni decenni per essere attuata (Steemers, 2003), non foss’altro che quasi la totalità del patrimonio edilizio delle città occidentali non rispetta alcun canone di risparmio energetico, es-sendo le legislazioni in materia molto recenti, praticamente ancora da applicare in Italia, seppur con poche e limitate eccezioni. Nonostante non ci sia un’azione specifi ca di protezione del clima in atto, va segnalato che tutte le azioni di politica energetica attivate dalla Provincia di Rovigo vanno nell’ottica della protezio-ne del clima, con la riduzione delle emissioni di gas clima alteranti, in primo luogo la CO2. Così pure gli obiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) rispecchiano da un lato il tentativo di ridurre l’uso di risorse non rinnovabili (nella pianifi cazione il suolo è la prima risorsa scarsa), allo stesso tempo tengono in considerazione le variazioni al contesto territoriale indotte dai nuovi scenari climatici (ad esempio la saliniazzazione dei suoli dovuta alla risalita del cuneo salino).
Clima in Polesine Nel caso del Polesine il lento trend che fa registrare una calo generale delle precipitazioni ed un aumen-
to delle temperature può portare ad una serie di problemi.
Innanzitutto l’approvvigionamento idrico, legato in alcune aree al pescaggio di acqua da fi ume, è reso diffi cile nel caso di magra. Sono altresì limitate tutte le attività che necessitano di approvvigionamento idrico che sono legate alla portata del fi ume stesso (agricoltura, attività produttive, navigazione,…).
Abbassandosi la spinta idrostatica del fi ume si facilita inoltre la risalita del cuneo salino, sia in superfi cie
impa rapporto.indd 139impa rapporto.indd 139 2-04-2009 19:20:562-04-2009 19:20:56

140AMBIENTE URBANO 06
sia nella profondità della colonna d’acqua. La risalita comporta inoltre l’inquinamento delle acqua di falda, che in conseguenza della pressione idrica esercitata dal fi ume, vengono ricaricate con acqua non dolce.
Il clima del territorio polesano può essere classifi cato come temperato umido, analogamente al resto della pianura padano-veneta, anche se alcune peculiarità rendono questo territorio differente dal resto del Veneto.
Il Polesine è interessato principalmente da venti provenienti da Ovest e Nord Est, come evidenziano le rose dei venti delle stazioni di Rosolina, Villadose e Pradon (Porto Tolle).
Le immagini relative alle rose dei venti sono state fornite dal servizio meteorologico dell’ARPA Veneto e si riferiscono al periodo 1999-2001.
La velocità del vento è molto modesta, e solo in poche occasioni si superano velocità di 4 m/s.
Per quanto riguarda la piovosità e le tempe-rature, i valori fatti registrare e sintetizzati nel precedente rapporto non hanno rilevanti modi-fi che.
La scala provinciale non permette infatti la valutazione di sostanziali variazioni in un lasso temporale così ristretto.
Si è considerato quindi il più vasto sistema regionale Veneto, sistema all’interno del quale possono essere valutati diversi parametri e che permette una complessiva valutazione degli effetti. Per questa analisi si utilizzeranno i dati elaborati da ARPA Veneto, Centro Meteo di Teolo (PD).
Per quanto concerne le precipitazioni il grafi co che segue mostra lo scarto dei valori annuali rispetto alla media per il periodo 1956 – 2004.
In sintesi il trend generale che ARPA Veneto ha registrato è il seguente:
• Tendenza lievemente negativa (signifi cativa);
• Prevalenza di scarti negativi dagli anni ’80;
• Anni più piovosi: 1960,1959, 2002;
• Anni meno piovosi:1983, 2003,1993;
Se la valutazione prende in considerazione il solo periodo invernale i risultati indicano invece:
• Tendenza negativa (signifi cativa), più evidente rispetto alle altre stagioni;
• N° giorni consecutivi senza pioggia in aumento;
• Inverni più “bagnati”: 1978,1977,1960;
• Inverni più “secchi”: 1992,1975, 2000;
Gli inverni più piovosi sono quindi prima del 1980 e i più secchi sono stati il 1992 ed il 2000 (all’epoca della valutazione non è stato preso in considerazione l’inverno 2006).
Rosa dei Venti, stazione di Adria, 10 m. – inv. 2005Fonte: ARPA Veneto
impa rapporto.indd 140impa rapporto.indd 140 2-04-2009 19:20:562-04-2009 19:20:56

141 AMBIENTE URBANO06
Tendono inoltre ad aumentare gli eventi intensivi, con piogge di durata superiore alle 12 ore.
Per quanto concerne le temperature, sempre dagli studi effettuati da ARPA Veneto (centro meteo di Te-olo) è possibile valutare lo scarto rispetto alla media 1956-2004 dei valori rilevati anno per anno. In questo caso si nota un generale aumento delle temperature, con scarti sempre più positivi a partire dal 1990 e temperature massime registrate nel 2003, nel 2000 e nel 1999.
Analisi statistica sulla media annua delle precipitazioni tra il 1956 ed il 2004.Fonte: ARPA Veneto, Centro Meteo di Teolo
MEDIE ANNUE DI TEMPERATURE MINIME IN VENETOScarti rispetto alla media 1956-2004
Anche i giorni consecutivi con temperature massime superiori ai 34°C sono stati registrati in maniera preponderante dal 1990 in poi, con l’estate del 2003 che ha fatto registrare un valore notevolmente ele-vato (oltre 30 giorni consecutivi).
SCARTI PRECIPITAZIONE MEDIA ANNUARISPETTO ALLA MEDIA 1956-2004
mm
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
y= -3.3964x + 116.75R2= 0.0844 p=<0.05
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
anno
°C
3
2
1
0
-1
-2
-3
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
impa rapporto.indd 141impa rapporto.indd 141 2-04-2009 19:20:562-04-2009 19:20:56

142AMBIENTE URBANO 06
Tipo indicatore
Valutazione sintetica
Trend
Elaborazione questionari inviati ai comuni
Comuni che hanno risposto ai questionari di A21 Polesine -
Aree pedonali S
Piste ciclabili S
Piano Urbano del Traffi co R
Strutture per tempo libero e sport S
Strutture per attività culturali S
Associazioni sportive e culturali R
Piani Zonizzazione Acustica R
Utilizzo del territorio
Rapporto aree produttive abitante S
Numero di aziende a Rischio Incidente Rilevante (RIR) D
Aziende con registrazione EMAS R
Aziende con certifi cazione ISO 14000 R
Infortuni sul lavoro
Numero di incidenti sul lavoro S
Numero incidenti in agricoltura S
Infrastrutture
Sistema infrastrutturale viabilità D
Sistema infrastrutturale ferrovia D
Numero complessivo di incidenti /di morti S
Tasso di lesività / taso di mortalità / tasso di pericolosità S
Politiche di sensibilizzazione – Vado Sicuro R
Radiazioni non ionizzanti
Estensione delle linee ad alta tensione I
a
a
a
a
a
a
a
k
k
k
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Sintesi
impa rapporto.indd 142impa rapporto.indd 142 2-04-2009 19:20:562-04-2009 19:20:56

143 AMBIENTE URBANO06
Tipo indicatore Valutazione sintetica
Trend
Popolazione esposta all’induzione magnetica pro-dotta da elettrodotti di alta tensione
I -
Numero di impianti SRB P
Impianti SRB per comune S
Campagne di misurazione delle emissioni R
Istruzione e cultura S
Popolazione per livello d’istruzione S
Iscritti nelle scuole per ordine e grado S
Percentuale di diplomati R
Offerta scolastica R
Cinema, teatro, spettacoli
Offerta e di spettacoli cinematografi ci S
Teatro ed attività teatrali S
Sistema bibliotecario provinciale
Distribuzione del servizio
Indice di prestito R
Catalogo bibliotecario disponibile R
Energia e Politiche per il Clima
Consumi energetici I
Produzione di energia da fonti rinnovabili R
Contributi per solare termico e fotovoltaico R
Clima: piovosità / temperatura S / S / /
Politiche per la protezione del clima R
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
k
k
k
f
f
f
f
f
f f
D Causa determinate P Indicatore di pressione S Indicatore di Stato
I Indicatore di Impatto R Indicatore di Risposta
Condizioni positive Condizioni stazionarie Condizioni negative
Trend in crescita Trend stazionario Trend in diminuzione
a kf
impa rapporto.indd 143impa rapporto.indd 143 2-04-2009 19:20:562-04-2009 19:20:56

144
Appendice
Principale bibliografi a
L. Anglesio, e altri, Rassegna di indicatori e indici per il rumore, le radiazioni non ionizzanti e la radioat-tività ambientale, Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente,
ARPA Veneto, aa.vv., gennaio 2008, Rapporto sugli Indicatori Ambientali del Veneto edizio 2008, Centro-offset Master s.r.l. Mestrino, Padova.
ARPA Veneto, Servizio Osservatorio Suolo e Rifi uti, febbraio 2008, La produzione e la gestione dei rifi uti speciali nella Regione Veneto, ARPA Veneto, Dipartimento Provinciale di Treviso
ARPA Veneto, Dipartimento Provinciale di Rovigo, Osservatorio Acque di Transizione, febbraio 2006, Le lagune del Delta del Po: ecosistemi fragili. Rilevamento in continuo della qualità delle acque Anno (2003-2004), Rovigo
ARPA Veneto, Servizio Comunicazione ed Educazione Ambientale, luglio 2004, Censimento delle aree naturali “minori” della Regione Veneto, Padova
D. Bianchi, E. Zanchini, a cura di, 2001, Ambiente Italia 2001, La salute ambientale delle città, 100 indi-catori sullo stato del paese, Edizioni Ambiente, Milano.
R. Casarin, a cura di, 1998, Ambiente: il Veneto verso il 2000, Giunta Regionale del Veneto, Arcari indu-stria grafi ca.
R. Casarin ed altri, a cura di, 2001, Valutazione d’Impatto Ambientale, Regione del veneto, ARPA Vene-to, Hyper Editore.
M. Cammarrota, a cura di, settembre 2002, L’Ambiente nelle città, indicatori statistici, ISTAT, Poligrafi ca Ruggero, Avellino
R. Drusiani, a cura di, 2000, Tutela delle acque dall’inquinamento, Regione del Veneto, Provincia di Rovigo, Hyper Editore.
ISTAT, ottobre 2007, La popolazione straniera residente in Italia al 1° gennaio 2007, Uffi cio della comu-nicazione, Centro di informazione statistica, Roma .
ISTAT, maggio 2008, Rapporto Annuale La situazione del Paese nel 2007, RTI Poligrafi ca Ruggiero S.r.l., Roma .
C. Loreto, L. Salvatore, P. Cristoforo, 2008, La valutazione Ambientale Strategica (VAS) e gli strumenti di piano e di progetto: Aspetti giuridici, Strumenti e contenuti, Casi ed Esperienze, Paesaggio e aree Protette, Le Penseur.
A. Luchetta, a cura di, Il Delta del Po nel cambiamento climatico, ARPAV - Dipartimento Regionale per la Difesa del Territorio, atti della conferenza Cambiamenti Climatici Conferenza Nazionale 2007.
F. Musco, 2008, Cambiamenti climatici, politiche di adattamento e mitigazione: una prospettiva urbana, Asur, 93
Parco Regionale Veneto del Delta del Po, progetto LIFE 04NAT/IT/000126, Conservation and Breeding of Italian Cobice Endemic Sturgeon, Atti del progetto realizzato con il contributo economico della DG Ambiente della Commissione Europea.
impa rapporto.indd 144impa rapporto.indd 144 2-04-2009 19:20:572-04-2009 19:20:57

145
Provincia di Rovigo, Consorzio Smaltimento Rifi uti, marzo 2008, Rapporto sulla gestione, produzione dei rifi uti urbani e sulla raccolta differenziata.
Provincia di Rovigo, Uffi cio Statistica, Osservatorio Provinciale Statistico Sugli Incidenti Stradali, pubblica-zioni varie
Provincia di Rovigo, Uffi cio Statistica, Osservatorio Provinciale Demografi co, pubblicazioni varie
Provincia di Rovigo, Uffi cio Statistica, Osservatorio Provinciale Scolastico, pubblicazioni varie
S. Schipani, a cura di, Novembre 2008, Statistiche ambientali 2008, Istituto nazionale di statistica, Servi-zio Produzione editoriale, Centro stampa e riproduzione S.r.l., Roma.
K. Steemers, 2003, ‘Cities, energy and comfort’, Introduction to a Special Issue of Energy and Buildings: On urban research, vol. 31, no. 1, pp 1-2
K., Whitelegg, 2001, National Research Activities and Sustainable Development. An ESTO Survey and Assessment of National Research Initiatives in Support of Sustainable Development, Brussels
C. Zerbinati, P. Marzolla, P. Parrozzani, L. Cattozzo, a cura di, dicembre 2003, Atlante dei Vincoli Paesag-gistici e Ambientali della Provincia di Rovigo, Europrint – Rovigo.
C. Zerbinati, P. Marzolla, P. Parrozzani, L. Cattozzo, S. Bedendo, a cura di, dicembre 2004, Analisi dell’atti-vità estrattiva svolta nella provincia di Rovigo.
Piani, strumenti urbanistici, documenti di programmazione e pianifi cazione
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, Documento Preliminare, adottato con DGR n. 2587 del 7 agosto 2007 dalla Giunta Regionale e documenti correlati.
Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, adottato con deliberazione n. 902 del 4 aprile 2003 dalla Giunta Regionale in ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e dal Decreto legislativo 351/99. Riesaminato e modifi cato ed inviato in Con-siglio Regionale per la sua approvazione ha ottenuto il parere favorevole della Settima Commis-sione consiliare, competente per materia, nella seduta del 14 ottobre 2004. Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera è stato infi ne approvato in via defi nitiva dal Consiglio Regio-nale con deliberazione n. 57 dell’11 novembre 2004.
Piano d’Area Delta del Po, adottato con Delibera della Giunta Regionale n.7093 del 23 Dicembre 1986 (Bur n. 5 del 22/1/87), approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n.1000 del 5 Ottobre 1994 (Bur n. 101 del 29/11/94). Adozione Variante 1 Delibera della Giunta Regionale n.582 del 15 Marzo 2002 approvata con Delibera del Consiglio Regionale n.15 del 16 Aprile 2003. Adozione Variante 2 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1123 del 18 marzo 2005 approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n.2354 dell’8/08/08.
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Documento Preliminare approvato in data 4 aprile 2007 con Deliberazione n. 60/18627 dalla Giunta provinciale di Rovigo e i documenti di consulta-zione.
Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Rovigo, depositato e consultabile presso l’Area Attivi-tà Produttive della provincia di Rovigo e scaricabile dal sito internet della provincia
impa rapporto.indd 145impa rapporto.indd 145 2-04-2009 19:20:572-04-2009 19:20:57

146
Si ringrazia
Provincia di Rovigo, Uffi cio Statistica per la collaborazione nella raccolta ed elaborazione dei dati, ed in particolare Cinzia Viale e Claudio Bellato
Provincia di Rovigo, Area Politiche per l’Ambiente, Uffi cio Aria, Uffi cio Energia, Uffi cio Rifi uti
Provincia di Rovigo, Area Attività Produttive, Servizio Caccia
Provincia di Rovigo, Servizio Bibliotecario Provinciale
ARPA Veneto ed in particolare il Dipartimento Provinciale di Rovigo
Polesine Acque SpA
Consorzio Smaltimento Rifi uti
Ecogest s.r.l.
Amministrazioni Comunali che hanno partecipato rispondendo ai questionari.
Note fi nali
Si consente copia o estrazione di parte di questo documento citando la fonte. Per le tabelle ed i grafi ci è necessario citare la fonte riportata nella apposita didascalia.
Dicitura consigliata:F. Musco, G. De Filippo, G. Businaro, 2008, “Rapporto sullo stato dell’ambiente e della comunità della
Provincia di Rovigo 2008”, IUAV Venezia,
impa rapporto.indd 146impa rapporto.indd 146 2-04-2009 19:20:572-04-2009 19:20:57

147
GLOSSARIO
A
Abitante Equivalente (AE): Carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossige-no a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno.
Viene indicato, nel campo dell’ingegneria sanitaria, il carico organico biodegradabile convogliato in fognatura, in un giorno, dovuto alla normale attività di una particolare utenza civile (o similare). La quantità di sostanze organiche biodegradabili viene misurata indirettamente tramite il quantitativo di ossigeno necessario affi nché i batteri possano modifi care le sostanze organiche biodegradabili presenti rendendole innocue nell’arco di 5 gg (BOD5). Il valore di riferimento, secondo il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”,( art. 74), è dato dall’equivalenza 1 abitante equivalente = 60 gr di ossigeno al giorno.
ACI: Automobil Club d’Italia
Acque di transizione: in senso generale si intende indicare con questo termine tutti i corpi idrici salmastri, come lagune, stagni costieri e foci di fi umi. La Direttiva Quadro sulle Acque dell’Unione Europea (Water Framework Directive, 2000) propone una defi nizione riduttiva, riconducendo le A.d.T. ai soli corpi idrici infl uenzati dalle acque dolci, escludendo così gli stagni costieri iperalini. Noi riteniamo che più che ad “acque” di transizione ci si dovrebbe riferire ad “ambienti di transizione” intendendo come transizione le caratteristiche di tali ambienti a cavallo tra terra e mare.
Acque refl ue: residui liquidi – di centri urbani, di lavorazioni industriali o di attività agricole, commer-ciali. Sono spesso fonte di inquinamento.
Alloctona: specie non propria di un determinato territorio, nel quale è giunta a seguito di introduzione volontaria o involontaria; le specie alloctone possono essere invasive ed entrare in competizione con quelle autoctone (proprie del luogo e spontanee).
Antropico: si riferisce ad attività dell’uomo.
APAT: Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici
ARPA: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
Ardeidi: famiglia di uccelli acquatici con becco robusto e zampe generalmente lunghe, a cui apparten-gono aironi, tarabusi e nitticore.
impa rapporto.indd 147impa rapporto.indd 147 2-04-2009 19:20:572-04-2009 19:20:57

148
Aree protette: aree dotate di particolari caratteri ambientali, di cui lo Stato o gli altri organi che hanno poteri di gestione del territorio garantiscono la salvaguardia grazie a specifi ci vincoli legislativi. Tali sono i parchi nazionali e regionali, le foreste demaniali, le riserve integrali, le oasi faunistiche.
Atmosfera: Fluido gassoso che, soggetto alla forza di attrazione della Terra, l’avvolge ed è con essa solidale nei suoi movimenti di rivoluzione e rotazione, per i quali è anche sottoposta alla forza cen-trifuga.
Autoctona: 1: specie spontanea, propria di un determinato territorio; 2: roccia formatasi nel luogo in cui si trova, senza avere subito spostamenti tettonici.
B
Bacino Idrografi co: è la regione geografi ca le cui acque confl uiscono tutte in uno stesso fi ume. Giuri-dicamente è defi nito come segue: «Il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defl uendo in superfi cie, si raccolgono in un determinato corso d’acqua direttamente o a mezzo di affl uenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d’acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente; qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di più corsi di acqua, esso si intende ricaden-te nel bacino idrografi co il cui bacino imbrifero montano ha la superfi cie maggiore» (art. 1 Legge 18 maggio 1989, n. 183).
Barena: struttura fi sica tra le più caratteristiche degli ambienti lagunari. Le barene si presentano come tavolati piatti e bassi, costituiti da sedimenti siltosoargillosi, in generale coperti da vegetazione alo-fi la. Le barene si trovano a quote altimetricamente intermedie tra le isole e le velme, normalmente sono emerse, e vengono sommerse durante le maree di sizigie, ossia di luna piena e di luna nuo-va. La barena è in rapporto funzionale con altre strutture caratteristiche: i ghebi, le velme, i chiari, i canali e i bassi fondali. Il nome Barena secondo Boerio (1856) deriva da “baro”, nome volgare per indicare un fi tto manto di cespugli oppure un terreno paludoso incolto.
Basso fondo/Basso fondale: area della laguna che rimane sotto il livello delle acque anche durante eccezionali basse maree.
Biodisponibilità: proprietà di una sostanza di essere in uno stato chimico o chimico fi sico che può es-sere assorbito e/o metabolizzato da uno o più organismi viventi. Più un inquinante è biodisponibile più può essere assunto dagli organismi.
Biodiversità: varietà delle forme viventi presenti su un territorio. La biodiversità può essere studiata a diversi livelli: genetico, specifi co, biocenotico e paesaggistico. Il numero delle specie viene defi nito con l’espressione “ricchezza di specie”, e costituisce una delle possibili misure della biodiversità di un luogo; esso può essere anche utilizzato come termine di paragone con altre zone. La ricchezza di specie viene considerata la misura generale di biodiversità più semplice e facile da valutare, anche se non può che rappresentare una stima approssimativa e incompleta della variabilità presente tra i viventi.
impa rapporto.indd 148impa rapporto.indd 148 2-04-2009 19:20:572-04-2009 19:20:57

149
Bioindicatore: un bioindicatore è un aspetto facilmente individuabile e misurabile di un processo bio-logico il quale ci fornisce informazioni sul processo stesso senza necessariamente dettagliarne l’ana-lisi. Un bioindicatore può essere costituito dalla struttura della comunità, dalla dinamica demografi ca della popolazione, dalle caratteristiche fi siologiche e comportamentali del singolo organismo, dalla morfologia e fi siologia della cellula ecc. Nell’accezione più comune è considerato come bioindicatore un organismo che con il suo “stato di salute” o la sua presenza o assenza indica una determinata situazione dell’ambiente.
Biomassa: quantità di peso degli organismi presente, in un dato momento, in un dato luogo. È espri-mibile sia come peso fresco, che come peso secco.
Biotopo: Area geografi ca (di superfi cie e di volume variabili) sottomessa a condizioni in cui le domi-nanti ambientali sono omogenee. La componente biologica del biotopo viene defi nita biocenosi.
BOD: richiesta biochimica di ossigeno. Misura la richiesta biologica di ossigeno ovvero la quantità di ossigeno consumato dai microrganismi durante i processi di degradazione aerobica della sostanza organica. Il valore del BOD ottenuto in 5 giorni di misura viene detto BOD5 ed è espresso in milli-grammi di ossigeno per litro, mg/L di O2. L’analisi indica il contenuto di sostanza organica biodegra-dabile, presente nelle acque ed in particolar modo negli scarichi. Un alto valore di BOD in un corpo idrico indica un alto contenuto di sostanza organica biodegradabile ed implica possibili effetti am-bientali negativi dovuti ai processi degradativi.
C
Capacità di carico (carrying capacity): è la capacità di un sistema ambientale di mantenere indefi -nitamente una o più specie. Per l’uomo è la capacità massima del sistema di fornire risorse senza modifi carsi irreversibilmente e la capacità massima del sistema di assimilare rifi uti senza modifi carsi irreversibilmente.
Caradriformi: ordine di uccelli a cui appartengono il gabbiano ed il beccaccino.
Chiavica: apertura praticata attraverso gli argini delle valli e munita di porta a saracinesca, per porre le valli stesse in comunicazione con i canali esterni e permettere la circolazione dell’acqua, la risalita dei pesci dall’esterno, e la pesca.
COD: richiesta chimica di ossigeno (si esprime in mg/L di O2); rappresenta la quantità di ossigeno necessaria per la completa ossidazione chimica dei composti organici ed inorganici presenti in un campione di acqua. È un indicatore che misura la presenza nell’acqua di sostanze ossidabili per via chimica, principalmente organiche, è quindi strettamente correlabile all’inquinamento.
CORINE Land Cover: è un’iniziativa congiunta dell’Agenzia Europea dell’Ambiente e della Commissione Europea, che attualmente interessa 26 paesi; il progetto ha creato mappe di copertura e di cambia-mento del suolo. L’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici (APAT) è l’autorità nazionale incaricata della realizzazione e aggiornamento del progetto e della diffusione dei prodotti.
impa rapporto.indd 149impa rapporto.indd 149 2-04-2009 19:20:572-04-2009 19:20:57

150
Cuneo salino: per opera delle maree l’acqua salata “scivola“ al di sotto dell’acqua dolce meno densa incuneandosi tra essa ed il fondale. Questo fenomeno può verifi carsi alla foce dei fi umi o all’interno della falda.
D
Decibel (dB): Il decibel è un modo di esprimere una determinata misura di rumore. Esso denota la grandezza di una quantità rispetto ad un valore di riferimento stabilito arbitrariamente, in termini di 10 volte il logaritmo (in base 10) del quoziente delle due quantità. In acustica il decibel misura il livello dell’intensità energetica dei suoni.
Direttiva Habitat: vedi Natura 2000
DPSIR: Modello concettuale (Determinante, Pressione, Stato, Impatto, Risposta) elaborato in ambito in-ternazionale in materia di informazione ambientale (OCSE, 1993; Eurostat, 1997; AEA, 1998). Il mo-dello evidenzia l’esistenza a “monte” delle Pressioni sull’ambiente, di forze motrici o Determinanti identifi cati con le attività e i processi antropici che causano le pressioni. A “valle” delle pressioni sta invece lo Stato della natura, che si modifi ca in seguito alle sollecitazioni umane. Il modifi carsi dello Stato comporta Impatti sul sistema antropico e naturale. Gli impatti negativi provocano un effetto di deterioramento delle risorse ambientali. Per contrastare questa situazione la società reagisce for-nendo delle Risposte dirette sia alle cause immediate degli impatti (i cambiamenti dello stato) sia alle cause più profonde, risalendo a “monte” fi no alle pressioni stesse e ai fattori che le generano. Il cerchio così si chiude con la retroazione consapevole della società alle conseguenze negative del suo stesso sviluppo
E
Ecocentro: Area attrezzata al ricevimento di rifi uti urbani o loro frazioni che non prevedono l’installa-zione di strutture tecnologiche o processi di trattamento. Sono destinati al solo ricevimento dei rifi uti urbani e delle loro frazioni, nonché dei rifi uti ad essi assimilati, prodotti da utenze domestiche e non domestiche, provenienti dal territorio di competenza, e conferiti direttamente da privati e/o dagli operatori della raccolta differenziata e gestori del servizio pubblico.
Ecologia: il termine ecologia fu creato da Haeckel (1886) dalla parola greca Oikos: “casa”, ed indica all’origine lo studio degli habitat naturali delle specie viventi. L’habitat di una specie comprende un ambiente fi sico-chimico (“ambiente” o “biotopo”) favorevole alla sua sopravvivenza e alla sua riproduzione, e un ambiente biologico composto da numerose altre specie che popolano lo stesso ambiente (biocenosi). Ciascuna specie interagisce con quelle vicine (debolmente o fortemente, direttamente o indirettamente, con effetti immediati o prolungati nel tempo). L’insieme di queste interazioni costituisce una rete d’interrelazioni generalmente complesse, adattative, spesso evo-lutive. L’ecologia applicata è una disciplina scientifi ca che si occupa delle applicazioni delle teorie ecologiche a difesa dell’ambiente, contro le alterazioni della biosfera e per la razionalizzazione dello sfruttamento delle sue risorse.
impa rapporto.indd 150impa rapporto.indd 150 2-04-2009 19:20:572-04-2009 19:20:57

151
Ecologia del paesaggio: (Landscape Ecology) è una scienza ecologica che integra i diversi livelli ge-rarchici di complessità degli ecosistemi dandone una chiave di lettura omogenea ed originale.
Ecosistema (Ecosistemico): è l’insieme della comunità biologica e dell’ambiente a cui essa è associa-ta nonché dei processi e delle relazioni che intercorrono tra le sue componenti.
Eustatismo: fenomeno di variazione del livello del mare indotto da cambiamenti climatici che infl uen-zano la massa e il volume degli oceani.
Eutrofi a (eutrofi co): stato di un corpo d’acqua caratterizzato da una abbondanza, spesso eccessiva, di nutrienti.
Eutrofi zzazione: arricchimento di nutrienti dell’acqua, che aumenta la Produttività primaria. Può cau-sare lo sviluppo eccessivo delle piante acquatiche, la cui decomposizione innesca una forte attività dei microrganismi decompositori, dapprima aerobici, che a sua volta si rifl ette in una diminuzione dei livelli dell’ossigeno nell’acqua, e poi anaerobici, con rilascio di sostanze tossiche. Questo proces-so può andare avanti sino a causare la morte degli organismi aerobici per anossia ed avvelenamen-to.
F
Falda acquifera: acqua penetrata nel sottosuolo per percolazione in strati di roccia permeabile che si è accumulata e viene trattenuta da terreni impermeabili sottostanti. Si dice artesiana se imprigionata fra due strati impermeabili, freatica se situata al di sopra del primo strato sotterraneo impermeabile.
Fitodepurazione: sistema di trattamento dei refl ui basato principalmente su processi biologici. Gli im-pianti di fi todepurazione sono costituiti da ambienti umidi riprodotti artifi cialmente in bacini imper-meabilizzati, attraversati, con diversi regimi di fl usso, dalle acque refl ue derivanti da un collettore. I sistemi sono caratterizzati dalla presenza di specie vegetali tipiche delle zone umide (igrofi le), radicate ad un substrato di crescita o fl ottanti.
Frazione secca recuperabile: rifi uto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifi uti urbani, avente un elevato contenuto ener-getico, costituita da materiali recuperabili, come carta, vetro e plastica.
Frazione secca residua: detta anche frazione secco non recuperabile è il rifi uto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifi uti urbani, avente un elevato contenuto energetico, costituita dai materiali non recuperabili.
Frazione umida (umido): rifi uto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da rac-colta differenziata o selezione o trattamento dei rifi uti urbani.
Frazione Organica dei Rifi uti Urbani (FORSU): materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidi-tà proveniente dalla raccolta differenziata dei rifi uti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero
impa rapporto.indd 151impa rapporto.indd 151 2-04-2009 19:20:572-04-2009 19:20:57

152
scarti di cucina. La raccolta avviene di norma presso le utenze domestiche e/o selezionate (quali mense, ristoranti, ecc) mediante modelli di gestione riconducibili all’utilizzo di specifi ci contenitori stradali o alla raccolta presso il domicilio dell’utenza interessata (Riferimento normativo: DCR 76/06 e DGR 568/05).
G
Ghebo: piccolo canale con andamento tortuoso che solca le barene e le velme, collegando le aree più interne con i canali più profondi.
H
Habitat: ambiente in cui può essere rinvenuta una data specie o, in senso lato, l’ambiente in cui un organismo vive. Può anche essere riferito a una comunità di organismi viventi.
I
Indice Biotico Esteso (IBE/EBI): è un indice biotico che fornisce una diagnosi di qualità di torrenti e fi umi. Oggetto di indagine dell’indice è la composizione della comunità macrobentonica. Il metodo prevede l’esecuzione di campionamenti su detta comunità, la successiva classifi cazione delle Unità Sistematiche raccolte in “Gruppi faunistici” e la determinazione del numero totale delle stesse. Può essere applicato a interi reticoli idrografi ci.
Isofreatiche: le linee isofreatiche rappresentano l’unione dei punti che hanno la caratteristiche di ave-re uguale quota assoluta (m.s.l.m.m.) della superfi cie della falda freatica.
ISTAT: Istituto nazionale di Statistica
L
Laguna: una laguna è un bacino costiero separato dal mare da un cordone litoraneo e caratterizzato da acqua salmastra e maree. Il nome attuale deriva dal latino lacuna, spazio vuoto. Le lagune tendono a formarsi in territori pianeggianti e solitamente interessati da foci a delta dei fi umi e vengono clas-sifi cate in lagune vive e lagune morte. Le lagune vive hanno uno o più collegamenti o sbocchi con il mare aperto mentre le lagune morte sono completamente circondate da terraferma.
M
Mare Adriatico: è l’articolazione del mar Mediterraneo situata tra la penisola italiana e la peniso-la balcanica. Bagna sei Paesi: Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Montenegro e Albania. Anticamente l’intero mare era chiamato anche Golfo di Venezia, dal momento che la Serenissima vi esercitava un predominio quasi incontrastato.
impa rapporto.indd 152impa rapporto.indd 152 2-04-2009 19:20:572-04-2009 19:20:57

153
N
Natura 2000: è il nome che il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una “rete”) di aree destinate alla conservazione della diversità biologica nel territorio dell’Unione stessa. In particolare si occupa della tutela di un insieme di habitat e di specie animali e vegetali indicati negli All. 1 e 2 della Direttiva Habitat (Direttiva 43/92/CEE).
O
P
Pozzi artesiani: pozzi che pescano in una falda artesiana, in pressione.
Q
R
Raccolta differenziata dei rifi uti: raccolta idonea, secondo i criteri di economicità, effi cacia, traspa-renza ed effi cienza a raggruppare:
- i rifi uti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento (in fase di revisione);
- i rifi uti di imballaggio separatamente dagli altri rifi uti urbani, a condizione che tutti i rifi uti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero.
Per ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifi uti urba-ni pari alle seguenti percentuali minime di rifi uti prodotti (L. del 27 dicembre 2006, n. 296):
a) 40% entro il 31/12/2007; b) 50% entro il 31/12/2009; c) 60% entro il 31/12/2011.
Resilienza degli ecosistemi: la resilienza è la capacità di ritorno alle condizioni iniziali (o a condizioni statisticamente equivalenti) dopo che il sistema è cambiato a seguito di una perturbazione.
Resistenza degli ecosistemi: la resistenza è la proprietà di mantenere condizioni generali del sistema stabili durante e dopo una perturbazione.
Rifi uto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nell’Allegato A alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi. I rifi uti sono classifi cati, secondo l’origine, in rifi uti urbani e rifi uti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifi uti perico-losi e non pericolosi.
Rifi uti Urbani (RU): Sono rifi uti urbani: a) i rifi uti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abita-
zione; b) i rifi uti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto
impa rapporto.indd 153impa rapporto.indd 153 2-04-2009 19:20:572-04-2009 19:20:57

154
precedente, assimilati ai rifi uti urbani per qualità e quantità; c) i rifi uti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifi uti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade
ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifi uti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali; f) i rifi uti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifi uti provenienti da attività
cimiteriale diversi da quelli indicati nei punti b), c) ed e). Rifi uto Urbano Residuo (RUR) o Rifi uto secco non recuperabile: rifi uto urbano misto che residua
dopo aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie, anche la raccolta separata della frazione organica dei rifi uti.
S
Salinità: è la quantità di sali disciolti in un certo volume di acqua. La salinità media dell’Adriatico è di circa il 37 per mille (37 grammi di sale per un litro d’acqua), per il mare in genere si parla di 35 per mille. Un’acqua con un contenuto salino inferiore a quello del mare è detta ipoalina (o iposalina), un’acqua che ne contenga di più è detta iperalina (o ipersalina).
Salmastra: acqua a salinità diversa da quella di mare, generalmente inferiore (in inglese brackish).
SIC: Sito di Importanza Comunitaria introdotti a seguito dell’applicazione della Direttiva Labiata 92/43/CEE
Sostenibilità: vedi Sviluppo sostenibile.
Specie esotica: Termine utilizzato in genere come sinonimo di specie aliena (o alloctona).
Specie protetta: Specie rara o vulnerabile protetta da leggi o convenzioni internazionali che ne impe-discono la cattura o la caccia.
Specie rara: Specie presente con piccole popolazioni che attualmente non è minacciata o vulnerabile, ma che corre rischi a causa della sua rarità naturale.
Specie stanziale: Specie faunistica legata ad un certo ambiente per l’intero ciclo biologico.
Specie svernante: specie migratrice che passa l’inverno in un luogo.
Stazioni Radio Base (SRB): le Stazioni Radio Base (SRB) sono gli impianti di telecomunicazione per la telefonia cellulare. Le SRB sono costituite da antenne che trasmettono il segnale al telefono cellu-lare e da antenne che ricevono il segnale trasmesso da quest’ultimo. Le antenne possono essere installate su appositi tralicci, o su edifi ci in modo che il segnale venga irradiato sulla porzione limita-ta di territorio – cella - interessata dalla copertura.
impa rapporto.indd 154impa rapporto.indd 154 2-04-2009 19:20:572-04-2009 19:20:57

155
Subsidenza: progressivo abbassamento locale del suolo o, più a grande scala, della piattaforma con-tinentale o del fondo marino che tende a cedere a causa del peso dei sedimenti che vi si accumu-lano e del continuo movimento della crosta terrestre. Può essere dovuto a cause naturali quali il compattamento dei suoli alluvionali e la deformazione tettonica degli strati più profondi della crosta terrestre, la compattazione dei sedimenti geologicamente più recenti, il collasso di cavità sotterra-nee, gli assestamenti per eventi sismici. Può essere dovuto anche a cause antropiche quali l’estra-zione di fl uidi dal sottosuolo, in generale agli emungimenti di acqua dalle falde acquifere sotterra-nee e di idrocarburi.
Svernamento: l’azione di fermarsi in un luogo da parte di una specie migratrice.
Sviluppo sostenibile: il concetto di Sviluppo Sostenibile fu coniato essenzialmente nel 1987 dalla Commissione Mondiale per l’Ambiente e Sviluppo (World Commission on Environment and Develop-ment), detta Commissione Bruntland per il nome della sua Presidente. Il concetto fu così defi nito nel rapporto fi nale, “Our Common Future”: «Sviluppo sostenibile è quel modello di sviluppo che soddisfa le necessità presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le sue» (World Commission on Environment and Development, 1987). Il concetto di Sviluppo Sostenibile nasce dal riconoscimento che i problemi di politica ambientale, economica e sociale non possono essere affrontati separatamente. Il concetto dello sviluppo secondo cui si devono affrontare i proble-mi ambientali dopo che è stato raggiunto lo sviluppo economico e sociale non ha funzionato; sono emerse delle necessità di integrazione. Le diverse correnti di pensiero insistono tutte su due punti chiave delle politiche:
- il concetto di gestione ecologica dello spazio ambientale – ovvero dell’insieme di conservazione della natura, mantenimento della qualità degli ecosistemi e dei geosistemi e gestione delle risorse am-bientali sotto il limite della loro capacità di rigenerazione;
– il concetto di giustizia sociale dello spazio ambientale – ovvero la tutela delle generazioni future, che si poggia su principi etici di equità tra tutti gli esseri umani viventi e futuri.
T
V
VAS: Valutazione Ambientale Strategica, introdotta con il T.U. 152/2006 e successive modifi che ed in-tegrazioni a seguito dell’emanazione della Direttiva Europea sulla VAS (2001/42/EC) che imponeva a tutti gli stati membri dell’Unione Europea la ratifi ca della direttiva nelle normative nazionali entro il 21 luglio 2004. Molti degli Stati membri hanno iniziato a implementare la Direttiva a partire dai temi più strettamente connessi alla pianifi cazione territoriale, per poi estendere l’approccio a tutte le politiche con effetti rilevanti per l’ambiente.
Valle da pesca: la valle da pesca è un’area lagunare separata artifi cialmente dalla laguna aperta tra-mite una recinzione fi ssa (costituita da pali) o argini. Sono specchi d’acqua poco profonda utilizzati per l’allevamento dei pesci, che vengono catturati con l’ausilio di dispositivi che ostacolano il loro movimento naturale verso il mare aperto. Rappresentano un patrimonio culturale importante per le attività tradizionali di allevamento ittico.
impa rapporto.indd 155impa rapporto.indd 155 2-04-2009 19:20:572-04-2009 19:20:57

156
Vegetazione ripariale: vegetazione situata in prossimità delle sponde dei corsi d’acqua e dei laghi. La vegetazione ripariale regola il fl usso di nutrienti e la quantità di luce disponibile per la produzione primaria nelle acque.
Velma: porzione di fondale lagunare che resta sommersa in condizioni di marea normale ed emerge solo con le basse maree di sizigie. L’ambiente di velma è un habitat per specie euriecie, resistenti a notevoli variazioni ambientali (di salinità, ossigeno disciolto e temperatura) dovute alle periodiche emersioni. L’associazione vegetale tipica di questi ambienti è lo Zosteretum noltii e con presenza possibile di alghe (ulvacee o del genere Entheromorpha).
VIA: Valutazione di Impatto Ambientale introdotta a seguito dell’emanazione della Direttiva europea 85/337/CEE e attuata attualmente in Italia dal T.U. 152/2006 e successive modifi che ed integrazio-ni.
VINCA: Valutazione di Incidenza Ambientale introdotta a seguito dell’emanazione della Direttiva Habitat (92/43/CEE9 ed in particolare in base a quanto stabilito dall’articolo 6 di tale direttiva. Applicata dal DPR 357/97 attuata in Italia dalle differenti regioni con proprie normative di riferimento.
X
Z
Zero mareografi co: lo zero mareografi co di una località è quel livello usato come zero di riferimento per la misurazione del livello del mare.
ZPS: Zone di Protezione Speciale istituite con l’introduzione dell’applicazione della Direttiva 79/409/CEE detta Direttiva Uccelli
ZSC: Zona Speciale di Conservazione
Fonti principali consultate per l’organizzazione del glossario:
S. Guerzoni, D. Tagliapietre, 2006, Atlante della Laguna: Venezia tra terra e mare, Marsilio Editore, Venezia
ARPA Veneto, aa.vv., 2008, Rapporto sugli indicatori Ambientali 2008, Padova
impa rapporto.indd 156impa rapporto.indd 156 2-04-2009 19:20:572-04-2009 19:20:57

157
impaginazione
MALIN GRAPHIC DESIGN
impa rapporto.indd 157impa rapporto.indd 157 2-04-2009 19:20:572-04-2009 19:20:57