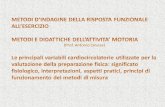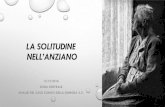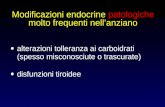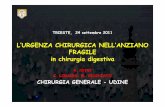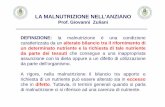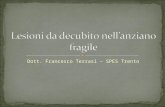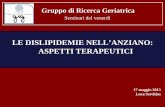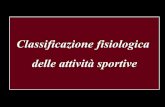Risposta fisiologica all’esercizio acuto nell’anziano
-
Upload
nigel-austin -
Category
Documents
-
view
64 -
download
0
description
Transcript of Risposta fisiologica all’esercizio acuto nell’anziano

Risposta fisiologica all’esercizio acuto nell’anziano
Facoltà di scienze motorie Università degli studi di verona
Corso di laurea speciclistica in scienze dell’attività motoria preventiva ed adattata

• Funzionalità massimale
• Risposta alla transizione metabolica (cinetica)

CONSUMO DI OSSIGENOdeterminanti fisiologici
VOVO22 = Q * (CaO = Q * (CaO22 - CvO - CvO22))
• Q = FC * GpQ = FC * Gp
• CaOCaO2 2 = [Hb] * 1,34 * SaO= [Hb] * 1,34 * SaO22
• CvOCvO2 2 == [Hb] * 1,34 * SvO[Hb] * 1,34 * SvO2 2
.
.
. _
_ _
• Funzionalità massimale

• Funzionalità massimale VO2 = Q * (CaO2 - CvO2)

riserva funzionaleriserva funzionale
• Funzionalità massimale VO2 = Q * (CaO2 - CvO2)

Gp = P / R
Precaricocontrattilità
postcarico
• Funzionalità massimale VO2 = Q * (CaO2 - CvO2)

massimale
• Funzionalità massimale VO2 = Q * (CaO2 - CvO2)

VO2 (l*min-1)
0 1 2 3 4 5 6 7
FC
(b*
min
-1)
60
80
100
120
140
160
180anzianigiovani
• Funzionalità massimale VO2 = Q * (CaO2 - CvO2)

atmosfera mitocondri
capillarialveoli
aria
arterie
tessuti
ventilazione
- Diffusione- VA/Q
shunt
• Funzionalità massimale VO2 = Q * (CaO2 - CvO2)

600 700 800 900 1000 1100
0.5
1.0
1.5
2.0
0
HbO2
Hb
Lunghezza d’onda (nm)
850760
Ass
orb
an
za (
un
ità a
rbit
rari
e)
Spetroscopia nel quasi-infrarosso, NIRS


luce
Percorso della lucerilevata
rilevatoreemettitore emettitore
Sensore NIRSSensore NIRS
cute ecute esottocutesottocute
muscolomuscolo


Test incrementale
Tempo (min)0 5 10 15 20 25 30 35 40
caric
o (W
)
0
50
100
150
200
250
300

-60 0 60 120 300
-0.2
0.0
0.2
Tempo (s)
-60 0 60 120 300
-0.4
-0.2
0.0
0.2
[deoxy(Hb+Mb)]
[oxy(Hb+Mb)]
[oxy(Hb+Mb)+deoxy(Hb+Mb)]
[oxy(Hb+Mb)-deoxy(Hb+Mb)]
Va
ria
zioni di concentrazione (A
.U.)
fase A
fase B
fase C

-0.050
0.000
0.050
0.100
0.150
0 240 480 720 960 1200 1440
tempo (s)
(u.a
.)
delta[deoxyHb]markers A
mpie
zza
ischem
ia

Esercizio incrementale
carico (% Wpicco)
0 20 40 60 80 100
[d
eo
xy(H
b+M
b)]
/
[ de
oxy
(Hb
+Mb
)]isc
he
mia
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

massimale

Andamento della deossigenazione muscolare in funzione dell’intensità dello sforzo in giovani sedentari sani ed in pazienti affetti da miopatia mitocondriale (in alto) e malattia di McArdle (in basso).

ATP ATP ADP + P ADP + P11 + Energia + Energia
1) meccanismo anaerobico
alattacido
2) meccanismo anaerobico
lattacido
3) meccanismo aerobico
•Risposta alla transizione metabolica (cinetica)

tempo (s)
0 60 120 300
Pote
nza
(m
l/Kg/m
in)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180ANAEROBICA ALATTACIDAANAEROBICA LATTACIDAAEROBICA
•Risposta alla transizione metabolica (cinetica)

•Risposta alla transizione metabolica (cinetica)

Test a onda quadra
Tempo (min)0 1 2 3 4 5 6
caric
o (W
)
0
100
200
300
400
50W
100W
150W
200W
250W
300W
•Risposta alla transizione metabolica (cinetica)

0 60 120 180 240 300
VO
2 (L
. min
-1)
0
1
2
3
4
fase
1
fase
2
2
TD2
a2
a1
•Risposta alla transizione metabolica (cinetica)

0 60 120 180 240 300
VO2
(L. m
in-1 )
0
1
2
3
4
Tempo (s)0 60 120 180 240 3000
1
2
3
4
<VT
>VT
a2
a2
a3
VO
2 (L. m
in-1)
fase 1 fase 2 fase 3
fase 1 fase 2
TD2
TD2
2
2
TD3
•Risposta alla transizione metabolica (cinetica)

BIKE <VT
0
20
40
60
80
100
120
-60 0 60 120 180 240 300 360
tempo (s)
VO
2 (%
valo
re d
i equilibrio
)
sogg. giovane
sogg. anziano
BIKE >VT
0
20
40
60
80
100
120
-60 0 60 120 180 240 300 360
tempo (s)VO
2 (%
valo
re d
i equili
brio
)
sogg. giovane
sogg. anziano
•Risposta alla transizione metabolica (cinetica)

•Risposta alla transizione metabolica (cinetica)

tempo (s)
-60 0 60 120 180 240 300
FC (b/m
in)
60
80
100
120
140
160
180
150 W
180 W
270 W
•Risposta alla transizione metabolica (cinetica)

Sogg. 1Sogg.2 Sogg. 1Sogg.2W VO2 VO2 FC FC
0 0.129 0.118 70 6050 0.800 0.970 90 75
100 1.500 1.429 110 90150 2.200 2.104 130 105200 2.800 3.100 150 120250 3.560 3.458 170 135300 4.300 4.500 190 150350 4.700 165

carico (W)
0 50 100150200250300350400
VO
2 (l/m
in)
0
1
2
3
4
5
6
soggetto 1soggetto 2

carico (W)
0 50 100150200250300350400
FC
(b/m
in)
60
80
100
120
140
160
180
200soggetto 1
soggetto 2

VO2 (l/min)
0 1 2 3 4 5
FC (b/m
in)
60
80
100
120
140
160
180
200soggetto 1
soggetto 2

Nota la relazione individuale FC/VO2 è possibile:
stimare VO2max con dati
sottomassimali
calcolare la FC per carichi non testati
calcolare costo energetico nota la FC

carico (W)
0 50 100150200250300350400
FC
(b/m
in)
60
80
100
120
140
160
180
200 soggetto 1
FC=a+b(x)
FCmax=220-età
Wmax=(FCmax-a)/b

FC
(b/m
in)
VO 2 (l/min)
• composizione dell’aria• ora del giorno • idratazione• composizione della dieta• distanza dal pasto
• temperatura ambiente • umidità relativa• tipo di esercizio• sonno• pressione barometrica
costante relazione individuale FC/VO2

0 60 120 180 240 300
-0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Tempo (s)0 60 120 180 240 300
-0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
<VT
>VT
Ap
Ap
As
[ d
eoxy(H
b+M
b)]
/[ d
eoxy(H
b+M
b)]
isc
hem
ia
TDp
p
p
TDp
TDs


Risposta adattativa all’esercizio fisico cronico nell’anziano
Facoltà di scienze motorie Università degli studi di verona
Corso di laurea speciclistica in scienze dell’attività motoria preventiva ed adattata

L’invecchiamento comporta un aumento di incidenza di malattie cronico-degenerative:
• obesità• diabete• ipertensione arteriosa• cardiopatia ischemica• arteriosclerosi

sedentari
allenati

Mediante:
• aumento del VO2max
• diminuzione della FC
“fitnessmetabolica”
“fitnessaerobica”
L’esercizio aerobico è in grado di: prevenire la comparsa della malattia (prevenzione primaria) ridurre i danni da malattia (prevenzione secondaria)
•contenimento del peso corporeo
• contenimento della % di grasso corporeo
• miglioramento del profilo lipidico ematico
• miglioramento del controllo glicemico
• diminuzione della pressione arteriosa

Quale e quanta attività fisica?
• per migliorare la fitness aerobica• per promuovere la salute
nei soggetti di età avanzata

Quale esercizio?
• tale da consentire una sufficiente intensità (attenzione a sport tecnici)
• a basso impatto articolare (infortuni acuti e sovraccarico)
• da svolgere in compagnia (riduce abbandono e migliora continuità)
• non strutturate, da inserire in routine quotidiana

dose
ben
efici
ben
efici
dose
giovani anziani
Quanto esercizio?

dose
ben
efici
ben
efici
dose
giovani anziani
dan
ni
dan
ni
Quanto esercizio?

Quanto esercizio?
Definiscono il volume dell’allenamento:
• durata della seduta
• frequenza settimanale
• durata dell’allenamento
• intensità della seduta
30 min (continui/discontinui)
3 v (fitness aerobica), 7 v (fitness metabolica)
9-12 settimane
intensa (f. a.), moderata (f. m.)
Come si determina l’intensità di un esercizio?

Come si determina l’intensità di un esercizio?
• misurazione diretta del VO2
• stima indiretta basata sulla FC
• scala di autovalutazione

Stima indiretta basata su FC assume:
misura del VO2 o costo energetico costante
costante relazione individuale FC/VO2
stima accurata della FCmax
5
50
Time (min)5 5
100
75
workload (W)Protocollo schematico del test:
• determinazione della FC ad equilibrio• misura o stima del VO2 (VO2 (l/min)= 0.3 + 0.012*W)

Test incrementale
Tempo (min)0 5 10 15 20 25 30 35 40
caric
o (W
)
0
50
100
150
200
250
300

tempo (s)
-60 0 60 120 180 240 300
VO2
(l/m
in)
0
1
2
3
4
150 W
180 W
270 W
.

tempo (s)
-60 0 60 120 180 240 300
FC (b/m
in)
60
80
100
120
140
160
180
150 W
180 W
270 W

Tempo (s)
0 240 480 720 960 1200 1440
FC (b/m
in)
0
50
100
150
20060 120 150 180 210 24090 stop0
watt

Sogg. 1Sogg.2 Sogg. 1Sogg.2W VO2 VO2 FC FC
0 0.129 0.118 70 6050 0.800 0.970 90 75
100 1.500 1.429 110 90150 2.200 2.104 130 105200 2.800 3.100 150 120250 3.560 3.458 170 135300 4.300 4.500 190 150350 4.700 165

carico (W)
0 50 100150200250300350400
VO
2 (l/m
in)
0
1
2
3
4
5
6
soggetto 1soggetto 2
misura del VO2 o costo energetico costante
VO2 (l*min-1)= 0.300 + 0.012 (W)variabilità tra soggetti: 4-5%

carico (W)
0 50 100150200250300350400
FC
(b/m
in)
60
80
100
120
140
160
180
200soggetto 1
soggetto 2
soggetto 1: y=70+0.4(x) soggetto 2: y=60+0.3(x)
costante relazione individuale FC/VO2

FC
(b/m
in)
VO 2 (l/min)
• composizione dell’aria• ora del giorno • idratazione• composizione della dieta• distanza dal pasto
• temperatura ambiente • umidità relativa• tipo di esercizio• sonno• pressione barometrica
costante relazione individuale FC/VO2

Conoscere la relazione individuale FC/VO2 consente di:
stimare il costo energetico di carichi intermedi stimare il costo energetico di altre attività stimare il VO2max

Stima accurata di FCmax
From: “Age-predicted HRmax revisited” Tanaka et al., J Am Coll Cardiol, 37(1): 153-6, 2001

130
140
150
160
170
180
190
200
20 30 40 50 60 70 80 90
age (yrs)
HRm
ax
(b/m
in)
TraditionalTanaka
age 20 30 40 50 60 70 80 90Traditional 200 190 180 170 160 150 140 130Tanaka 194 187 180 173 166 159 152 145
difference 6 3 0 -3 -6 -9 -12 -15
From: “Age-predicted HRmax revisited” Tanaka et al., J Am Coll Cardiol, 37(1): 153-6, 2001
HRmax (b/min)=220-age (yrs)
HRmax (b/min)=208-(0.8*age)
accurate estimation of
HRmax

Scala di Borg o RPE (rate of perceived exhertion):
6 -7 molto, molto leggero8 -9 molto leggero10 -11 piuttosto leggero12 -13 leggermente faticoso14 -15 faticoso16 -17 molto faticoso18 -19 molto, molto faticoso20 faticosissimo

Linee guida American College of Sports Medicine (ACSM) per la prescrizione dell’attività fisica nell’anziano
scopo
frequenza
intensita
durata
tipo
miglioramento fitness aerobica
3-5 gg/sett
Intensa (14-15
RPE) 60-90% FCmax30-45 min
Attività aerobichecon grandi gruppimuscolari: nuoto, corsa, bici
promozione salute
6-7 gg/sett
Moderata (10-11 RPE)
55-70% FCmax
30 min, anche discontinuo
Qualunque attività di intensità pari a cammino veloce (4 MET)

Effect of two training modalities on exercise tolerance in the elderly
Balestrieri F.1, Pogliaghi S.1, Terziotti P.2, Cevese A.2, Schena F.1
1 CeBiSM, Università degli Studi di Trento, Italy
2 Facoltà di Scienze Motorie, Università degli Studi di Verona, Italy

Methods: Subjects: 24 healthy sedentaries (19 M, 5 F; 66.2± .4 yr; 72.9±8.8 kg) were randomly divided into three groups of equal number:ARM: arm cranking 12-week supervised training (30 min, 3 times/week) CYC: cycloergometry 12-week supervised training (30 min, 3 times/week) C: control groupe, continued their habitual lifestyle for 12 weeks Protocol: Before and after the observation period, all subjects performed two incremental tests to exhaustion: arm cranking ergometer (ARM test) cycle ergometer (CYC test)(5-min warm-up at 40 and 50 W, followed by 5 and 10 W/min increments for ARM and CYC tests respectively)
Measures: respiratory variables were measured breath by breath and heart rate (HR) was continuosly recorded. Wpeak, VO2peak, ventilation (VEpeak), oxygen pulse (O2Ppeak) and HRpeak were calculated as the average of the last 10s of exercise.

90
110
100
90 90
7 10 3 5 5
12-week training, 3 times /week


Training disign:
VT identification during incremental test HR corresponding to VT using steady-state tests, translate HRVT in WVT
calculate W90%VT and W110%VT
every 2 weeks revise the HR/W relationship

inizio allenamento
dopo 4 sett



0
1
2
3
4
VT
(l*m
in-1
)
Pre
Post
CYC ARM C
ARM test
0
1
2
3
4
VT
(l*m
in-1
)
Pre
Post
CYC ARM C
CYC test
*
***
§ §
§ §§ §

0
10
20
30
40
V
T (%
of i
nitia
l va
lue
)
CYC CARM
0
10
20
30
40
V
T (%
of i
nitia
l va
lue
)CYC CARM
ARM test

Conclusions:
Our data suggest that a 12-week CYC (large muscle masses) and ARM (smaller muscle masses) training have a similar potential to increase hetero-ergometer exercise tolerance by 10 % (aspecific effect).Similarly, both ARM and CYC training increase homeo-ergometer exercise capacity by 15-20 % (specific effect).

-20
0
20
40
60
80
100
120
140
-60 0 60 120 180 240 300 360
tempo (s)
[d
eoxy
Hb
] a.u
.
giovani
vecchi