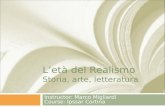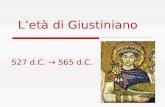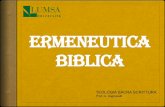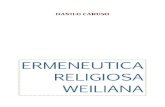Rigobello La Funzione Meta tra il pensiero classico e l’età ermeneutica della Ragione
-
Upload
settemontierma1 -
Category
Documents
-
view
22 -
download
2
description
Transcript of Rigobello La Funzione Meta tra il pensiero classico e l’età ermeneutica della Ragione
-
La funzione meta 651
Giornale di Metafisica - Nuova Serie - XXXII (2010), pp. 651-658.
Armando Rigobello
LA FUNZIONE META TRA IL PENSIERO CLASSICOE LET ERMENEUTICA DELLA RAGIONE
Il presente intervento si riferisce prevalentemente alla relazionedel prof. p. Paul Gilbert, e in parte anche alla relazione del prof.Carlo Sini. Introduco il discorso partendo da lontano nel tempo, ilnucleo speculativo tuttavia si inserisce direttamente nel tema. Ci ri-feriamo al Sofista platonico, al punto in cui il dialogo giunge a pre-cisare la posizione degli amici delle forme. Teeteto sottolinea cheessi ammettono il divenire limitatamente al mondo dellesperienzasensibile ma non per lessere, lessere universale (pantels n), ilvero essere1. A questo punto del dialogo platonico si colloca la cele-bre esclamazione dello Straniero di Elea: E allora per Zeus? Ci fare-mo persuadere cos facilmente che in realt il moto, la vita, lanima,lintelligenza non ineriscono a ci che assolutamente , chesso nvive n pensa, ma invece venerabile e santo, senza intelletto, se ne stafermo, immoto?2.
Limprovvisa perorazione della Straniero di Elea ricca di sugge-stioni anche per i termini del nostro discorso. Loriginario, che infondo indica quel senso dellessere che si precisa in ci che pi tardisar chiamato metafisica, nel dialogo platonico indicato come es-sere universale, e pare alludere ad una realt che ci avvolge ed insie-me ci supera. Questo passo sembra preparare laltra fondamentale
1 Platone, Sofista, 249 a.2 Ibid., 248 e-249 a.
-
652 Armando Rigobello
novit speculativa del Sofista, quella che introduce tra i generi sommiil diverso (t thteron), che rende possibile il movimento, la comuni-cazione e quindi una concezione della realt personale. Lesclamazio-ne della Straniero di Elea non un espediente retorico, ma unaffer-mazione di notevole valore speculativo. Teeteto, il giovane interlocu-tore solitamente piuttosto disponibile ad accogliere lautorevole argo-mentazione, ne avverte la sconvolgente novit: Tutto ci gravissi-mo, esclama. Siamo costretti ad accogliere come necessaria la pre-senza nellAssoluto di una vita consapevole, di unanima.
Il pantels n, lessere universale omniavvolgente, una figuraontica che risente delluso del mito nel pensiero greco. Ma sotto illinguaggio mitico vi una speculazione rigorosa. Gi la nozione diAssoluto si delinea come coscienza vivente. I filosofi greci nel politei-smo antropomorfo del mito trovano uno strumento per tessere inlinguaggio simbolico le loro posizioni speculative. Ci senza incorre-re nelle complessit che sarebbero pi tardi emerse nei rapporti conil messaggio cristiano. Il diascopein (penetrare razionalmente nel sen-so) pot servirsi in forma allusiva del mithologein (tessere miti). Inquesta chiave ci si pu avvicinare alle dottrine speculative con imma-gini mitiche, rifugiarsi nel mito e praticare lallusione, il presenti-mento, la pensosa intenzionalit.
Compiendo un balzo di oltre due millenni, potremmo forse tro-vare in alcune pagine di Merleau-Ponty3, nel rapporto tra visibile einvisibile, una specie di demitizzazione del dialogo platonico, unaproposta di senso sospesa tra lallusione e linquietudine di unaermeneutica sospinta da un desiderio di fruizione pensosa interno adun mondo in cui finzione ed espressione esistenziale, creativa si in-tersecano senza comporsi.
La soglia delloriginario si pu dunque varcare? Lesclamazionedello Straniero di Elea del Sofista platonico gi al di l della soglia,ma nel contesto speculativo contemporaneo possiamo trovare ar-gomenti persuasivi per questo compimento dellitinerario? La posi-zione di Merleau-Ponty indica una articolata via al semplice trascen-dimento ma non emerge dal suo suggestivo discorso una risposta al
3 M. Merleau-Ponty, Le visible et linvisible, Gallimard, Paris 1964; trad. it. e cura diA. Bonomi, Il visibile e linvisibile, Bompiani, Milano 1969.
-
La funzione meta 653
problema del compimento, alluso forse ma non tematizzato. Siamonellet ermeneutica della ragione e il concludere pu apparire comeuna chiusura. Intendiamo comunque giungere ad unaffermazionepositiva e per far ci ritorniamo su di un tema che abbiamo gi af-frontato in un saggio di qualche anno fa su lapriori ermeneutico4.
In quel saggio si esposta largomentazione sul senso di uninter-pretazione dellinterpretazione (interpretazione alla seconda poten-za), non per dare inizio ad una riduplicazione allinfinito dellattoermeneutico, ma per interrompere un continuo rinvio da interpreta-zione a interpretazione. La condizione ermeneutica condizione tra-scendentale. Lapriori di questo trascendentale lirrinunciabile do-manda di senso, la risposta a questa domanda interrompe lindefini-to rinvio. Siamo strutturati nel positivo, e ci precede il dubbio e sti-mola la ricerca. Questo avvertimento pregiudiziale ad ogni ragiona-mento costituisce lapriori ermeneutico, forma trascendentale del con-sistere delluomo. Questo apriori ermeneutico ci costituisce nelless-erci, nellessere in via ed ci che d senso alla vita. Lesclamazio-ne dello Straniero di Elea nel Sofista una testimonianza e lespres-sione dellirrompere di una riflessione recuperatrice (Gabriel Mar-cel), ma non sarebbe possibile il recupero se non ci fosse stata prece-dentemente una intuizione intellettiva, una intuizione del positivo.La risposta ad una domanda trascendentale di senso non pu essereun continuo domandare tra evasione e disperazione. Lessere precedeil non-essere.
Questa argomentazione sulla priorit del positivo sul negativo,questo passaggio dalla domanda trascendentale di senso allafferma-zione del trascendimento ed infine del Trascendente, pu conside-rarsi la via breve relativamente al problema di cui stiamo trattando.Vi per anche una via lunga, che stata percorsa, ed proprioquella dellarticolo Rflexions sur la fonction mta e di alcune pa-gine del volume Potique du sensible di Stanislas Breton5, di cui rife-
4 A. Rigobello, Lapriori ermeneutico. Domanda di senso e condizione umana, Rubbet-tino, Soveria Mannelli 2007.
5 S. Breton, Rflexion sur la fonction mta, Dialogue. Canadian PhilosophicalReview. Revue canadienne de Philosophie 21 (1982), 1, pp. 45-56; Potique du sensible,Editions du Cerf, Paris 1988.
-
654 Armando Rigobello
risce nella sua relazione il p. Gilbert. Il discorso parte dal tema stessodel nostro convegno, ossia dal significato della parola metafisica, efocalizza lattenzione su quel meta che precede il termine fisica. Enoto che la parola deriva dalla posizione dei libri di filosofia prima diAristotele situati dopo quelli riguardanti la fisica. Che funzione puavere dunque lespressione meta nel termine metafisica? Meta allu-de ad unapertura, un andare oltre, unalterit che si precisa in rela-zione a ci che segue, cio fisica. Al di l della genesi storica dellaparola, interessante soffermarci sul senso dellespressione meta.Meta, al di l, indica una funzione dinamica. Essa, nellanalisi diBreton, si specifica in tre figure: metastasi, metafora, metamorfosi. Lametastasi condizione di uno sviluppo non prevedibile, aperto a pipossibilit, la metafora presuppone invece un universo di riferimentoin cui cogliere somiglianze. Pu indicare, nel nostro caso, il passag-gio da un tipo di razionalit ad un diverso tipo di logica e di imma-gini. Pu svolgere una duttile comparazione tra elementi diversi,come pure essere unespressione poetica che viene prima e dopo larazionalit. La metamorfosi, infine, indica il passaggio da una formaallaltra, e presuppone una temporalit, una continuit pur nellin-novazione. Metastasi, metafora, metamorfosi danno luogo ad una pro-gressione.
Tenendo conto dellorientamento di aspetti significativi del pen-siero contemporaneo che alla nozione di sostanza ontologicamenterilevante preferiscono considerare la realt dal punto di vista dinami-co e quindi sottolineare la realt stessa come un plesso di energie, sipu concepire, come Breton, il divenire della realt come un progre-diente sviluppo dalla metastasi alla metamorfosi. Dallincerto orienta-mento della metastasi, allequilibrio allusivo della metafora, ed infinealla accentuata alterit della metamorfosi. Tale processo non pu con-figurarsi come lespressione di una illimitata relativit, di un perennerinvio relativizzante, ma come un processo irreversibile in una con-tinuit analogica. La funzione meta evidenzia la dinamica che investetutta la realt, in un passaggio progrediente verso un compimentosenza ritorno.
A questo compimento situato al vertice dellanalogia si rivolgenecessariamente lesserci di ciascuno, con un atteggiamento che
-
La funzione meta 655
insieme di insufficienza e di sovrabbondanza. Il meta, loltre laphisis esercita una funzione moderatrice ed armonizza litinerario.La funzione meta nel pieno sviluppo della sua opera di mediazione edi collegamento di diverse intenzionalit varca le soglie dellorigina-rio, fino ad attingere lillimitato. Il suo trascendimento giunge a con-figurarsi come trascendenza, tuttavia alla domanda finale di sensonon offre forse una compiuta risposta. La compresenza, al vertice delprocesso, di insufficienza e di sovrabbondanza, richiama la condizio-ne esistenziale, tuttavia lillimitato di questa infinitudine non ancora luogo di intelligenza, di vita, di persona. La domanda finale,radicale di senso, nota trascendentale dellhomo viator (Marcel), nontrova necessariamente risposta nelle dinamiche dellanalogia, la par-te pi intima e pi fragile di noi stessi (Ricoeur) rimane nella suasolitudine. Lautenticit della condizione umana richiede inveceunesperienza di comunione.
Se vogliamo mantenere il discorso su di un piano filosofico, con-sapevoli della rottura metodologica ma senza ricorrere ad esperienzereligiose, ad atteggiamenti mistici, occorre fare riferimento allintui-zione intellettiva. Essa latto noetico con cui perveniamo, in parti-colari esperienze intensamente vissute, a cogliere il senso dellessere,il fondamento della realt appreso in forma atematica, che risvegliain noi lintuizione di un consistere originario, la capacit di svinco-larlo dal volto sensibile dellimmagine 6. Questa intuizione intellet-tiva in fondo lapriori ermeneutico, che ci ricorda lintelletto attivodi Aristotele o quella presenza pi intima a noi di noi stessi di cuiparla Agostino.
Se confrontiamo la dotta e puntuale relazione del p. Gilbert conla relazione del prof. Sini, nonostante le notevoli differenze nella
6 Su questo argomento illuminanti e suggestive sono le parole di Jacques Maritain: a fondamento della conoscenza metafisica egli (S. Tommaso) pone lintuizione in-tellettuale di quella misteriosa realt che si dissimula sotto il termine pi comune e pibanale del nostro linguaggio, la parola essere. Essa si rivela a noi come soggetto non cir-coscrivibile di una scienza che gli dei ci invidiano quando svincoliamo nei suoi proprivalori questo atto di esistere esercitato dalla pi umile cosa, questa spinta vittoriosa me-diante la quale essa trionfa sul nulla (J. Maritain, Court trait de lexistence et de lexis-tant, Hartmann, Paris 1947; trad. it. di L. Vigone, Breve trattato dellesistenza e dellesi-stente, Morcelliana, Brescia 1965, p. 21).
-
656 Armando Rigobello
conclusione possiamo trovare aspetti di significativa convergenza,poich anche la relazione di Sini affronta il tema delineando un iti-nerario che ha qualche notevole affinit con quello esposto dal p.Gilbert. Sini inizia il discorso con una importante definizione kan-tiana che offre un singolare contributo al tema del convegno. Siniinfatti ricorda la distinzione di Kant, nel paragrafo 57 (Dei limitidella ragione pura) dei Prolegomeni ad ogni metafisica futura chevorr presentarsi come scienza (1783), tra confine (Schranke) e limite(Grenze). Il confine delinea un particolare territorio entro il quale sidelineano rapporti e si enunciano procedure tipiche e quindi auto-nome nellambito dei contenuti. Diversa la situazione speculativadel limite, che di per s richiama lillimitato e quindi pone il rappor-to tra enunciazione al di qua del limite e ci che supera il limite edesigna lillimitato. Il meta che nella parola metafisica indica ci cheva oltre, opportunamente precisato in contrapposizione alla chiu-sura territoriale del confine.
Posta in questi termini la questione, il problema centrale diventase sia possibile un rapporto tra limite e confine e quindi se tra questidue ambiti sia possibile un reciproco riconoscimento di rigore cono-scitivo. Certamente a questa ulteriore questione la risposta kantiana, come quella di Sini, negativa. Kant infatti assieme alla legittimitdi guardare oltre il confine e di affermarne una caratteristica impre-scindibile della condizione umana, non ne riconosce tuttavia la vali-dit speculativa. Anche la posizione di Sini, sottolineando la com-piuta autonomia del confine, restringe a questo ambito il rigore spe-culativo, ossia la scientificit. Vi sono tuttavia notevoli differenze traquanto afferma Kant e la posizione di Sini. Sini infatti sembra valu-tare positivamente un rapporto dinamico tra finito e infinito, rap-porto che caratterizza la condizione umana, che rimane in questomodo non rigorosamente definita ma caratterizzata da uno svolgi-mento pragmatico aperto ad una sempre nuova esperienza. Questadifferenza spiega come la posizione di Kant dia luogo ad un dram-matico dualismo mentre in Sini si coglie un positivo sviluppo prag-matico. In qualche modo la posizione di Sini presenta parziali affini-t con quella di un autore gi considerato precedentemente, ossiaMerleau-Ponty. In entrambi gli autori si delinea un ricorrente tra-
-
La funzione meta 657
scendimento che finisce per escludere una trascendenza vera e pro-pria. Il meta contenuto nella parola metafisica non porta ad unarottura metodologica del tipo proposto da Ricoeur ma ad un illi-mitato esperire, che sul piano ermeneutico ricorda pi chiaramenteGadamer.
Nel sottolineare questa differenza va ricordata non solo la rotturametodologica appena citata, ma anche la posizione di Breton. Bre-ton infatti sottolinea la continuit analogica del processo, che inter-rompe una illimitata relativit. Il processo irreversibile. La trascen-denza quindi una possibilit, anzi una necessit logica per inter-rompere un infinito rinvio.
Rimane comunque aperta la questione sulla possibilit che il tra-scendimento possa configurarsi come trascendente. Breton, come si appena detto, fa appello allenergia che investe ed insieme affermache il rinvio analogico e irreversibile non pu ripetersi allinfinito. Ilsuo sviluppo lineare quindi non pu non avere una meta. Tutto cici porta a riconoscere uno sviluppo finalistico per affermare il com-pimento di questa finalit in una meta. A nostro avviso questa situa-zione speculativa richiede un supplemento di argomentazione, unargomentare che non sia pi quello di un metodo unico che spieghilo sviluppo lineare, ma che comporti una rottura metodologica (P.Ricoeur). Dalla constatazione fenomenologica si dovrebbe passare al-laffermazione dialettica che, oltre la dinamica analogica, affermi larealt del compimento. Nel contesto di questo pluralismo metodo-logico, laffermazione dialettica delinea uno spazio speculativo oveconvergono affermazioni che sono tali per limpossibilit del contra-rio (Aristotele), lintuizione intellettuale (Tommaso), la riflessionerecuperatrice (Marcel).
La complessit di queste ultime considerazioni comporterebbeunampia trattazione. Nellambito di questo intervento ci limitiamoa delineare un abbozzo di schema: dalla rottura metodologica al-lintuizione intellettuale nel cui orizzonte situare una riflessionerecuperatrice, in una pluralit di comprensioni colte nellemer-genza della contemporaneit.
La puntuale relazione del p. Paul Gilbert, la sua esposizione evalutazione del pensiero di Breton, ci hanno offerto informazioni e
-
658 Armando Rigobello
utili stimoli speculativi per riesprimere in termini nuovi punti salien-ti della nostra attuale ricerca. La relazione di Carlo Sini, impostandoil suo intervento sulla distinzione kantiana tra limite e confine, hainoltre offerto un singolare ed efficace paradigma su cui misurareconvergenze e diversit.
Armando Rigobello
THE META FUNCTION IN CLASSICAL THOUGHT ANDTHE HERMENEUTIC AGE OF REASON
Abstract
The article starts from Gilberts relationship with and exposition andevaluation of Bretons thought, which offer information and useful specula-tive stimuli for re-expressing in different terms salient points of a researchaiming at understanding a pathway opening up a discourse on transcendingthat is ontological and in the last analysis metaphysical. For this purposereference is made to the well-known affirmations by Plato in the Sophist,both through the conception of pantels n and inclusion of the differentamong the highest genres. As regards the report by Sini, of major interestare the considerations that can be made between the look beyond the confine(Kants Grenze) clearly distinguished from the closing off in the rigor of re-search within the non-transcendable sphere of Schranke.
-
Copyright of Giornale di Metafisica is the property of Tilgher-Genova Publishing and its content may not becopied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express writtenpermission. However, users may print, download, or email articles for individual use.