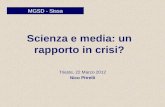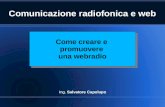Radiofonia in Digitale
-
Upload
federico-pierucci -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
Transcript of Radiofonia in Digitale
-
7/26/2019 Radiofonia in Digitale
1/9
M O N D O D I G I T A L E n . 1 - m a r z o 2 0 0 8
1. PREMESSA
L a grande rivoluzione che le tecnologie di-gitali hanno portato in tanti settori nonpoteva non toccare anche la filiera radiofoni-ca. Larea della produzione radiofonica or-mai digitalizzata da alcuni anni, mentre la-rea della diffusione, almeno in Italia, anco-ra sostanzialmente analogica. Nel seguito,sono brevemente descritte le principali nuo-ve soluzioni proposte per la diffusione e sicerca di valutare quali fra esse siano le piadatte al nostro Paese2.Non vadimenticatochela convergenza deime-
diae deiterminali tende a favorire unaggrega-zione di segmenti di mercatooggi differenziati(radio, TV, telefonia fissa e mobile ecc.) e con-seguentementeuna concentrazionenellemani
deiproviderpi forti. Tale prospettiva pu cer-
tamente costituire unaminaccia perla tuteladelpluralismoe dellocalismoe vannopertanto adot-tate quelle soluzioni di diffusione che garanti-scano iproviderpi deboli, senza peraltro fre-nare lo sviluppo tecnologico e di mercato.Prima di esaminare i nuovi sistemi di diffu-sione, si ritiene utile premettere un brevecommento alle evoluzioni che hanno subitole tradizionali modalit di fruizione della co-municazione radiofonica nel pi generalecontesto del cammino che la Societ stapercorrendo sulla strada sempre pi perva-
siva della multimedialit. Tale quadro par-ticolarmente utile per meglio inquadrare lespecifiche caratteristiche che devono averei moderni sistemi di diffusione.
2. LO SCENARIO DEL MERCATO
DI FRUIZIONE PER I SISTEMI
RADIOFONICI
In sintesi, queste sono le principali conside-razioni che si possono fare relativamente atale tematica:
lascoltostanziale(casalingo) rimarr una
Dopo una breve sintesi sullevoluzione della fruizione radiofonica da parte
degli utenti, larticolo passa in rassegna i nuovi standard dei sistemi per la
diffusione della radiofonia digitale che potranno interessare il nostro Paese.
Questi nuovi sistemi prenderanno progressivamente il posto delle Onde
Medie e della Modulazione di Frequenza nella banda UHF e sono caratte-
rizzati da unalta efficienza di occupazione spettrale e da una forte resi-
stenza a tutti i disturbi di propagazione, prestazione particolarmente im-
portante per lascolto, in continuo aumento, nella condizione di mobilit.
Salvatore MorelloGuido Vannucchi
LA RADIOFONIANELLERA DIGITALE1
39
1 Il presente articolo riprende ed aggiorna un Posi-tion Paper pubblicato nellottobre del 2005 dallaAICT (Associazione per la Tecnologia dellinforma-
zione e delle Comunicazioni), struttura dellAEIT(Federazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica,
Automazione, Informatica e Telecomunicazioni).2 Sipensi, peresempio,allasituazionediaffollamento
dello spettro delle frequenzeradiofoniche in Italia.
-
7/26/2019 Radiofonia in Digitale
2/9
0
realt di notevole rilevanza, anche se conuna duplice ed in un certo senso contraddit-toria tendenza:
ascolto di massima qualit (in modalitmulticanale) in un unico punto concentra-to della casa (spesso coincidente con laposizione del ricevitore TV);ascolto esteso ai vari ambienti allinternodella casa, risolvibile con reti LAN domesti-che, wiredo wireless, oggi molto economi-che e realizzabili con buona qualit di ascol-to per merito delle eccellenti prestazioni de-glialtoparlanti anche di piccoladimensione;
lascolto inmobilit(autoradio o disposi-tivi handheld3) diventer sempre pi ri-chiesto e sar importante scegliere le solu-zioni in grado di assicurare una buona rice-zione dei segnali radiofonici su una percen-tuale molto alta del territorio; lascolto innomadicit(tipico di chi usa ilPC portatile collegato a reti WiFi in alberghi,stazioni, aeroporti ecc.) tender anchessoad aumentare sensibilmente; nuove offerte di programmi, in particola-re tematici o locali, saranno rese possibilidal deciso miglioramento dellefficienzaspettrale conseguente allimpiego delle tec-
nologie digitali; il mixdellutenza radiofonica,semprepiric-codigiovani, propender progressivamente ver-so forme di innovazione radicali, con nuovi pa-radigmi di servizioassociatiallemodalit dellafruizione radiofonica, ci che determiner neltempo lo scostamento dal concetto di radioclassica edinparticolare tender a sviluppare:
integrazione del segnale audio con altrimedia (dati ed immagini);interattivit attraverso opportuni canalidi ritorno;
modelli di comunicazione innovativi,freeopay, quali in particolare il multicast (daunoamolti)elunicast(da uno ad uno,os-sia on demand), che supereranno il classi-co broadcast(da uno a tutti); fruizione, oltre che in real time, anche inshifted timetra cui, in misura sempre piesplosiva, il servizio PODcast(Personal-Option-Digital-cast).
3. LE TECNOLOGIE PER I SISTEMI
DI DIFFUSIONE DI RADIOFONIA
DIGITALE
Per seguire meglio il richiamo nel successivoparagrafo sullecaratteristiche tecnichedei va-ri standard proposti, utile ricordare che ladiffusione in forma digitale dei segnali ra-diofonici avviene attraverso i passaggi classicidelle trasmissioni digitali e pi precisamente:a.Codifica di sorgente: il processo attra-verso cui il segnale audio analogico viene pri-ma convertito in una sequenza numerica (di-gitalizzato) e quindi compresso secondotecniche di riduzione di ridondanza che, pre-servando sostanzialmente la qualit sogget-tiva, riescono a ridurre sostanzialmente il bit-ratedel segnale e ne consentono la trasmis-sione agli utenti con una sensibile efficienzaspettrale, molto superiore a quella ottenibilein analogico (riquadro a p. 41, per qualchemaggior dettaglio sulle tipologie di codifichedi sorgente nel caso dei segnali radiofonici).b.Codifica di canale:loperazioneconlaqua-leilsegnaledigitale,dopolacodificadisorgen-te, viene ulteriormente elaborato (con un mo-derato aumento del bit-rate) per difenderlo almeglio dalle possibilit di errore introdotte dal
particolarecanale di trasmissione impiegato.Laparte pi interessante dellelaborazione consi-stenellintrodurre i cosiddetticodici a correzio-ne di errore (per eliminare cio gli errori nel ri-conoscimento dei bit), sistemi rilevanti in ognicaso, ma indispensabili per i mezzi trasmissiviradio resi critici dai problemi di propagazionequali,in particolare,riflessioni, interferenze,eva-nescenze (fading) di tipo aleatorio e, per le fre-quenze alte, le attenuazioni da pioggia.c.Modulazione:ilbloccocircuitaledellaca-tena trasmissiva in cui il segnale, dopo le due
precedenti elaborazioni, viene impressosuuna portante, rendendone possibile la tra-smissione e/ola diffusione a grande distanza.Le metodologie di modulazione persegnali di-gitalisonosceltesullabasedelleparticolarica-ratteristiche del mezzo trasmissivo impiegato(radio terrestre, satellite,cavo, fibra),dellaspe-cifica banda di frequenzaadottata e delle rela-tive caratteristiche di propagazione.Un metodo di modulazione particolarmenteefficace (in combinazione con i codici corret-tori) per combattere le anomalie di propaga-
zione sopra citate (e perci adottato nella dif-
M O N D O D I G I T A L E n . 1 - m a r z o 2 0 0 8
1
0
0
1
40
3 Con tale denominazione ci si intende riferire a tut-te le classi di terminali portatli (cellulari, radio
portatili, PDA ecc.).
-
7/26/2019 Radiofonia in Digitale
3/9
fusione radio-televisiva terrestre) la tecnicamulticarrierCOFDM(Coded Orthogonal Fre-
quency Division Multiplexing), in cui il flussodigitale dei bitda trasmettere viene distribui-to, nellambito dello spettro a disposizione,su un numero elevatissimo di frequenze por-tanti. Il risultato di tale metodologia - che nel-la sua implementazione pratica realizzataesclusivamente attraverso tecniche di digitalprocessingdel flusso nativo dei bit- unatrasmissione estremamente robusta, in gra-do di resistere a molti tipi di perturbazioni.Gli specifici vantaggi tecnologici conse-guenti alla digitalizzazione si possono cos
riassumere:altosfruttamentodellospettro,concapacitdi moltiplicare da quattro a sei volte il numerodi programmi trasmessi nelle classiche bandeanalogiche della radiofonia (OC, AM, FM) e diutilizzare ad alta efficienza nuove bande di cuisi parler nel seguito;ottima qualit delservizioallutente, anchein situazioni di propagazione perturbata; capacit di offrire servizi multimediali com-plementarial segnale audio (dati, immagini,video lenti ecc.), ciche ha giustificato peral-
cune applicazioni il termine di visual radio;
riduzione della potenza elettricanecessa-ria alla diffusione a parit di area di servizio,
con conseguente diminuzione delle emissio-ni elettromagnetiche.Con tali vantaggi la transizione al digitale sipresenta anche come elemento propulsoredelleconomia dei media, non solo per lo svi-luppo di nuovi apparati, ma per tutti i contenu-ti e servizi innovativi che si potranno creare.
4. GLI STANDARD DI DIFFUSIONE
PROPOSTI PER LA RADIOFONIA
DIGITALE
In questa sede,per brevit,si prenderanno inesame solo i sistemi che possono interessarela realt italiana.
4.1. Sistemi terrestria.I sistemi T-DAB (Terrestrial -Digital AudioBroadcasting) e T-DMB (Terrestrial-DigitalMultimedia Broadcasting)IlT-DAB(Terrestrial-Digital Audio Broadca-sting) un sistema il cui studio iniziato allafine degli anni 80 ed stato il primo stan-dard di radiofonia digitale.
La denominazione originale di questo stan-
M O N D O D I G I T A L E n . 1 - m a r z o 2 0 0 8
1
41
0
0
0
1
La codifica di sorgente
La trasformazione di un segnale audio analogico, prodotto da un trasduttore elettroacustico, in un segnale digitale un processo de-
licato e fondamentale al fine di garantire una qualitsoggettiva di altafedelt.Si agisce su parametri analitici, quali: la modulazione del segnale per trasformarlo in impulsi-campioneper la quale, per i CD, si usa la Pulse Code Modulation(PCM) ad1,4 Mbit/s; la frequenza di campionamento che, tipicamente, sempre peri CD, di 44.100 kHz; la quantizzazione di un campione che neiCD, ha ormai lo standard di riferimentocon un valore di 16 bitper campione; Il ritardo di elaborazione (processing delay) che rappresenta la somma dei tempi impiegati da encodere decoderper eseguire le ri-spettive operazioni di codifica (compressione) e decodifica (decompressione). Un ritardo di elaborazione superiore a qualche decinadi millisecondi (ms) pu creare problemi per la diffusionedella trasmissioni in diretta;e inoltre si agisce su parametripercettivi, che tengono conto cio delle complesse caratteristiche fisiche del sistema di percezione au-ditivo umano.In questo caso, si pu eliminare dal segnaleuna certaquantit dinformazione, sapendoche essa sarebbeininfluente aifinidella sensazione auditiva finale, sfruttando per esempio: la non linearitdella risposta del nostro orecchio medio ed interno; il fenomeno del mascheramento, che nasconde un suono di basso livello, quando presente un altro di livello elevato. Tra laltro,questoprocesso dipendente anche dalle frequenze dei due suoni e si ha anche se i due suoni non sono contemporanei, ma comun-
que molto ravvicinati nel tempo.Poich la banda necessaria a trasmettere o memorizzare un flusso di dati corrispondente ad un segnale audio della durata di 1 s (bitrate) un elemento essenziale dal punto di vistadel costo,negli ultimidecenni i maggiori studi del settoresono statidedicatialla mes-sa a punto di modelli di compressione sempre pielaborati, che quici si limita ad elencare:
MUSICAM: MPEG 1, Layer 2, che il primo ad aver avuto successo, con fattore di compressione di 7,3; MP3: MPEG2, Layer 3, notoin particolare per luso diffusissimo in internete nei modernisistemi distorage (vedi i-Pod) con fattoredi compressione di circa 11;AAC (Advanced Audio Coding): MPEG2e4-AACcon fattore di compressione di 14,7;AAC+ che con un processamento pi evoluto dell AAC raggiunge un fattoredi compressione di 22;AAC+2: ancora pi avanzato, con fattore di compressione di quasi30.
-
7/26/2019 Radiofonia in Digitale
4/9
0
dard e dei successivi non introduceva il pre-fisso T che stato introdotto di recente, perdifferenziarlo dalle soluzioni per satelliti chepermettono la lettera S.La codifica di sorgente adottata il MUSICAM(riquadro a p. 41), codifica di prima genera-zione che richiede 190 kbit/s per programmastereofonico.La modulazione adottata il sistema multi-carrier COFDMgi richiamato. Le caratteristi-che della modulazione consentono la realiz-zazione di reti SFN4 per una copertura nazio-nale o regionale.Il sistema caratterizzato dallimpiego dibande nonappartenenti al normalespettroinuso per la radiofonia AM e FM, quali la BandaVHF-III(cio la banda 174-240 MHz storica-mente allocata per servizi televisivi VHF) e laporzione 1452-1469 MHz, dellaBanda L (sto-ricamente per servizi punto-punto).Le bande di frequenza assegnate vengono poiripartite in canali DAB di circa 1.5 MHz. (nelcasoVHFuncanaletelevisivoda7MHzingra-dodiportare4 canaliDAB).CiascuncanaleDABospita un multiplex di 6 programmi radiofo-nici(dettoancheblocco)conqualitCDlike.Lo standard permette lintegrazione di servizi
dati a banda stretta associati al programmaaudio. Lo standard nato con lobiettivo di ri-coprire essenzialmente la ricezione outdoor,ossia inmobilit, edoffreottime prestazionian-che per velocit elevate di movimento controleffetto Doppler(ricezione garantitafino a 200km/h). Per la ricezione indoor, in assenza diantenne sulla sommit degli edifici, necessa-riounprogettodireteamaggioredensitditra-smettitori e/oconpotenze incrementate, perviadelle ulteriori attenuazioni allinterno di un edi-ficio.Analoga situazione si presenta anche per
gli altri sistemi candidati per la radiofonia digi-tale (DMB e DVB-H) esaminati nel seguito.Il T-DAB, pur adottando una modulazione diconcezione molto valida, mostra tutti gli annipassati dalla sua ideazione. Offre, infatti,uno sfruttamento dello spettro non ottimale
siaper lusodi una codifica di sorgente di pri-ma generazione che richiede, per trasportareun programma, un bit-ratepi che doppiodelle codifiche attuali, sia per le tecnologieimpiegate nella codifica di canale e nella mo-dulazione che non permettono le flessibilitofferte dai sistemi pi moderni5.Per le limitazioni appena dette, tra il 2002edil2003 nasce lostandardT-DMB (Terrestrial-Di-gital Media Broadcasting) per migliorare lecaratteristiche del DAB e con lobiettivo diestenderne le prestazioni anche alla diffusio-ne di Mobile TV. Il sistema DMB totalmenteispirato al DAB ed compatibile con questul-timo in quanto adotta stesse allocazionispettrali ed identico tipo di modulazione. Lacodifica di sorgentedel segnale radiofonicoimpiega invece tecniche di compressione au-diodisecondagenerazione (MPEG4-AAC)6 edunacodifica di canalepi robusta. Aggiungeinoltre la possibilit di una codifica video astandard MPEG4. Se si desidera invece man-tenere la compatibilit radiofonica coni termi-nali DAB esistenti, si perdono i vantaggi dellenuove codifiche audio e si sfrutta esclusiva-mente la potenzialit del sistema per la tra-smissione di Mobile TV.
Per quantodetto,un sistema DMBpuessererealizzato, ove sia preesistente o predispostauna rete DAB, con investimenti minimi e rap-presenta pertanto la sua naturale evoluzione.Tralasciando i problemi di compatibilit, ilDMB certamente uno dei sistemi maggior-mente candidato a fornire servizi radiofonicidigitali di qualit su frequenze terrestri.Per questo si parla oggi disistemi DAB/DMBperch per la radiofonia la prevalenza del pri-mo o del secondo standard dipende dallascelta strategica effettuata sulla base del nu-
merodei ricevitori DABpreesistenti nel Paese.Questo standard ha avuto la prima imple-mentazione completa in Corea con conside-revoli investimenti. Sperimentazioni e primeinstallazioni sono in corso in Germania e inItalia ed altri Paesi europei.
M O N D O D I G I T A L E n . 1 - m a r z o 2 0 0 8
1
0
0
1
42
4 SFN = Single Frequency Network: rete, per copertura nazionale o regionale, costituita da trasmettitori diffusi nel territorio fun-zionanti in modosincrono alla stessa identica frequenza,senza problemi di interferenza.Tale soluzione impensabile con le tec-niche analogiche.
5 Il sistema, nelfrattempo, non ha raggiunto un vero decollo commerciale in nessun Paese ad eccezione di UK e Corea.6
MPEG4-AAC= Moving Picture Experts Group-Layer 4-Advanced Audio Coding.
-
7/26/2019 Radiofonia in Digitale
5/9
b.Il sistema DVB-H (Digital Video Broadca-sting- Handheld) unostandard europeo aperto del consorzioDVB (Digital Video Broadcasting), finalizzatonel Novembre 2004,orientato alla diffusio-ne di Mobile-TV,incuiiltermineHandheldindica che si tratta di un componente dellafamiglia di standard DVB studiato per tra-smissioni verso ricevitori mobili alimentati abatteria (segnatamente cellulari, palmari ePC portatili). Il sistema cura, in particolare, larobustezza della codificadi canaleper la rice-zione da terminali mobili (il cui guadagno diantenna pu anche essere minore dellunit)ed il basso consumo del ricevitore al fine diuna massima durata delle batterie.Il DVB-H integra le funzionalit delle retiDVB-T (ossia lormai diffuso sistema televi-sivo digitale terrestre) cercando di miglio-rarne le prestazioni, dal momento che que-sto standard non stato concepito per la ri-cezione TV in piena mobilit.Il DVB-H, oltre servizi di mobile-TV, per le sueprestazioni a carattere multimediale, per-fettamente adatto alla trasmissione broad-cast di programmi radiofonici e dati, mante-nendo un alto grado di compatibilit con i
servizi della rete DVB-T. Il basso consumo delterminale ricevente ottenuto attraverso lacosiddetta tecnica del timeslicing che con-siste neltenereacceso il terminale solo quan-do riceve i dati di interesse (burst) del pro-gramma TV desiderato. Per i restanti burstdialtri programmi il ricevitore rimane spento,consentendo un notevole risparmio di ener-gia (fino a circa il 90% del consumo).Il sistema non presenta limitazioni sulle codi-fiche di sorgente.In particolare, perla radiofo-nia, sono previste le codifiche audio-video di
seconda generazione (MPEG-AAC) che realiz-zano la massima efficienza spettrale. Comemodulazione, il DVB-H adotta, come il DVB-T,una modulazione multicarrier COFDMe pucoesistere con il DVB-T nellambito dello stes-so multiplex di programmi, come normalmen-te avviene. Allinterno della propria porzionedi multiplex, il sistema DVB-H migliora la co-difica di canale aggiungendo unulteriore co-dice correttore. Ci rende la codifica pi robu-sta nelle condizioni di mobilit con le antennea stilo o integrate dei terminali portatili, in
quanto il sistema DVB-T a cui si appoggia
nato con lobiettivo di una ricezione indoortramite le classiche antenne televisive Yagi.Lo standard DVB-H stato promosso da co-struttori di apparati e da operatori di rete co-me sistema di diffusione per qualunque tipodi programma multimediale.c. Il sistema DRM(Digital RadioMondiale)Il sistema DRM unostandard universale stu-diato espressamenteperla diffusione sulle ban-de di frequenza inferiori ai 30 MHz delle OndeLunghe (LW),Medie (MW) e Corte(SW) edingradodi trasportare unprogrammaa qualitCDconilcorredodeirelatividatiinformativi.Laco-difica di sorgente adottata , al solito, la cosid-detta MPEG4-AAC di seconda generazione,seguitada codifichedi canale molto potenti edil sistema di modulazione ancora una volta ilCOFDM. Particolari combinazioni di codifica disorgente ed enhancers permettono di varia-reil bit-rate audio da 8 a 48 kbit/s, in funzionedellaqualit/ricevibilit delsegnale trasmesso.Possonoessere anche impiegatecodifiche avan-zatesoloperlavoce:lacodificaCELP(CodedEx-citedLinear Prediction) peraudio dialta qualitsenzacontenutimusicalielacodificaHVXC(Har-monic VectorExcitation) peril parlato cheha unbit-rate particolarmente basso.
Lo standard DRM consente anche di diffon-dere contenuti testuali e grafici.Sono in corsogli studi perestendere lapplica-bilit dello standard a bande di frequenza su-perioriai30MHzefinoa120MHz,inmodota-le da poterloutilizzare anche nelle classichebande FM della radiofonia (DRM+).Il DRM non prevede il trasporto di multiplex,ma disingoli programmi, soluzione questamolto apprezzata dalle piccole emittenti lo-cali (mono-programma) che preferiscanomantenere una loro immagine autonoma e
non desiderano essere costrette a consor-ziarsi con altre emittenti per realizzare unmultiplex di programmi come previsto daiprecedenti standard. Dal punto di vista tecni-co, il vantaggio di trasmettere un programmasingolo invece di un multiplex, si paga in ter-mini di prestazioni a radiofrequenza: infatti isistemi a banda stretta non beneficianodelladiversit di frequenza e risentono maggior-mente delle evanescenze del segnale (dovu-te agli echi) che risultano molto selettive infrequenza.
Lalarghezzadibandapropostaperognisingo-
M O N D O D I G I T A L E n . 1 - m a r z o 2 0 0 8
1
43
0
0
0
1
-
7/26/2019 Radiofonia in Digitale
6/9
0
lo canale di questo sistema varia tra i 7 e i 10kHz,con possibilitdi raggruppare picanali.
4.2. Sistemi via satellitea. I sistemi radiofonici da satelliti in corso di sviluppo un sistema satellitarepuramente per radiofonia digitale spinto dallaSociet Worldspace per la copertura dellEu-ropa e dellAfrica operante nella banda 1480-1492 MHz (banda L) che adotta lostandardESDR(ETSI Standard for Digital Radio) di cuisono scarse le informazioni e che sembraorientato a ricevitori proprietari. Il sistemaprevede unarchitettura ibrida di rete terre-stre-satellitare, fondata sullutilizzo della me-desima interfaccia radio, che potrebbe con-sentire in molti casi lottimizzazione tecnico-economica della distribuzione punto-multi-punto perch le frequenze impiegate per i re-lativigap-fillerterrestri siano rigorosamentele stesse di quelle usate nel satellite. Nellat-tualeconfigurazione di questo progetto, la co-pertura prevista per lEuropa consiste in 6 fa-sci linguistici, che permettono la coperturaintegrale dei maggiori Paesi del continente,grazie anche alla componente ausiliaria di ri-petitori terrestri chepermettono di raggiunge-
re i terminali in area urbana ed indoor.b. Il sistema DVB-SH(Digital Video Broadca-sting - Satellite for Handheld receivers)In aggiunta alla soluzione sopra menzionatache nasce per radiofonia da satellite in faseavanzata di studio, per impiego in banda2170-2200 (banda S), il sistema di diffusioneDVB-SH che , in realt, una nuova genera-zione del sistema DVB-H (aperto pertanto adimpieghi anche in altre bande oltre la S) conmaggiore efficienza spettrale e, basato an-che esso, su unarchitettura satellite -gap fil-
lerterrestri. Tale sistema potr svolgereunruolo importante per completare in tempibrevi la copertura DVB-H terrestre, anche inzone a scarsa densit abitativadove i limitidi natura economica impedirebbero verosi-milmente uno sviluppo a breve della coper-tura terrestre. Un sistema di tale natura ov-viamente in grado di trasmettere la radiofo-nia, ma maggiormente concepito per gene-riche applicazioni multimediali e pi in parti-colare per Mobile-TV.In generale le soluzioni satellitari possono
consentire la fornitura di servizi diffusivi su
vaste aree territoriali con investimenti conte-nuti ed immediatezza nella realizzazione del-la copertura. Per quanto riguarda la copertu-ra di popolazioneconcentrata sopratutto nel-le citt, una soluzione satellitare richiede as-solutamente di essere integrata, come gidetto, con piccoli trasmettitori terrestri (gapfillers) tenuto conto delle barriere al debolesegnale satellitare costituito dagli edifici edaltri ostacoli (sottopassi, ponti ecc.).Per le ragioni anzidette, le soluzioni radiofo-niche satellitari vanno seguite con una certaattenzione anche se non ancora chiaro qua-le possa essere il peso deigap-fillerrispettoad una completa copertura da sistemi terre-stri, conpericoli di raddoppio. Non c dubbioche, in ogni caso, i sistemi satellitari potran-no giocare un ruolo complementare sopratut-to per una vasta copertura del territorio.
4.3. Nuove evoluzioni e quadro riassuntivoLa tabella 1 riporta le principali caratteristichee lallocazione in frequenza delle soluzioni perdiffusione radiofonica che, in linea di principio,possono interessare il territorio italiano.Sistacompletando la standardizzazione di duenuove proposte, che sono anche conseguenza
dei conflitti tra costruttori e tra enti di standar-dizzazione,ma che si possono far ricadere perle loroprestazioni nei sistemi della tabella1.La prima proposta il sistema DAB-IPcaratte-rizzatodallintroduzione della codifica televisi-va per Mobile-Tv (come il DMB) e che agli ef-fetti delloccupazionespettrale pertantoequi-valentealDMB,dacuisidistinguesoloperilpimoderno usodelprotocollo IP. La seconda pro-posta (invia di standardizzazione) il sistemaDAB+, esclusivamente radiofonico, con presta-zioni superiori a quelle del DMB nel caso di im-
piego esclusivoperradiofonia.Va notato che luso del termine DAB in questidue sistemi confonde (forse ad arte) le ideeperch essi sono molto pi vicini al DMB ecome tali possono essere considerati e ver-ranno considerati nel seguito: un loro even-tuale successo o meno dipender solo dalladiffusione e politica dei relativi ricevitori. Ciche invece certo che questi ultimi due si-stemi decretanodefinitivamente la mortedel DAB propriamente detto e dei corrispon-denti ricevitori per quei Paesi, come lItalia,
che non hanno una storia pregressa. Non a
M O N D O D I G I T A L E n . 1 - m a r z o 2 0 0 8
1
0
0
1
44
-
7/26/2019 Radiofonia in Digitale
7/9
caso il WorldDAB forum, che ha in carico glistandard della famiglia DAB/DMB, ha assun-to recentemente il nome di WorldDMB.
5. CONSIDERAZIONI
E CONFRONTI TRA I SISTEMI
RADIOFONICI DIGITALI PER
UN UTILIZZO IN ITALIA
Per tutto quanto detto in precedenza, per la
diffusione terrestre, ci si pu limitare allesa-me dei soli tre sistemi DMB/DAB+, DVB-H/DVB-SH e DRM, almeno per le soluzioni didiffusione terrestre, avendo associato le solu-zioni molto simili che possono coesistere.La prima importante osservazione da fare che tali sistemi possono essere consideratinon in concorrenza tra loro, macomplemen-tarie per applicazioni di fascia diversa.IlDMB/DAB+potrebbediventareilsistema prin-cipe con alta qualit (qualit CD o superiore)dei grandi e medi broadcaster radiofonici, in
analogia al ruolo svolto dai sistemi FM nel mo-mento in cui si affiancarono ai programmi ra-diofonicitrasmessi inOndeLunghe,Mediee Cor-te. Inoltre le possibilit del DMB di trasmettereimmagini in movimento (da cui la denomina-zione visual-radio) consentirebbe limpiego diservizi interessanti, per esempio per il traffico,nel caso in cui si volessero trasmettere imma-gini in movimento anzich immagini fisse. Laprestazioneper la trasmissionecontemporaneadi radiofonia e videoe la maggior protezione ri-chiesta, limita peraltro il massimo di capacit
nelluso puramente radiofonico, ci che ha in-
dotto allintroduzione del DAB+ al fine di otte-nere il massimo sfruttamento spettrale e quin-di il massimo di economicit. Sarebbe inveceuna politica sbagliata, usare in Italia tale siste-ma pertrasmissioni di Mobile-TV(come avvie-ne in Corea) in quanto per una tale applicazio-ne lEuropa si sta tutta orientando allimpiegodelDVB-H, persuanaturamolto legatoal siste-ma televisivo DMB-T ed alluso delle relative
gamme di frequenza. Inoltre,non correttoan-dare ad occupare bande destinateallaradiofo-nia con trasmissioni di tipo televisivo.IlDRMha il grande vantaggio di operare latrasformazione in digitale del singolo canaleradiofonico e tale tecnica pu essere impie-gata nelle Onde Corte, Medie ed in FM. Laspecifica tecnica per il DRM in banda FM non tuttavia ancora pronta e cos pure i ricevito-ri devono raggiungere uno stato di matura-zione e di pi vasto consumo di massa, risul-tando ancora costosi ed ingombranti.
Proiettandosi negli anni a venire il sistemaDRM potr rappresentare, in tecnica digitale,il corrispondente dellOnda Media nella storiadellanalogico, mentre il DMB rappresente-rebbe, come gi detto, lequivalente dellin-troduzione della Modulazione di Frequenza(FM). Peraltro ambedue i sistemi sarebberodiqualit superiore ai parallelismi citati in quan-to il DRM pu avere la qualit dellattuale FM,per di pi senza interferenze, mentre il DMBavrebbe qualit notevolmente superiore.IlDRMpertantounsistema adattoai picco-
li gestori radiofonici con stazioni individuali
M O N D O D I G I T A L E n . 1 - m a r z o 2 0 0 8
1
45
0
0
0
1
T-DAB T-DMB/DAB+ DVB-H & DVB-SH DRM
Codifica Sorgente: MUSICAM AAC AAC AAC+Audio efficienza doppia efficienza doppia efficienza tripla
Video Non Prevista MPEG-4 MPEG-4 Non Prevista
Canalizzazione 1,5 MHz 1,5 MHz 8 MHz 1 Canale
per un Multiplo (4 blocchi (4 blocchi OM/AM/FM
da: per canale TV) per canale TV)
6 programmi stereo 10 programmi stereo 120 programmi stereo Singolo canale
con qualit CD per DMB e con qualit CD
20 programmi con
DAB+, con qualit CD
Gamma Frequenza Banda III (200 MHZ); Banda III (200 MHZ); Banda III- IV (500- LW, MW, SW;
terrestre 800 MHZ); Banda II (FM: 88-
Banda L (1,5 GHz) Banda L (1,5 GHz) Banda L (1,5 GHz) 108 MHz)
Satellite Banda L (1,5 GHz) Banda L (1,5 GHz) Banda S (2.2 GHz) -----
TABELLA 1
Quadro riassuntivo
dei vari sistemi
di radiofonia digitale
di interesse italiano
-
7/26/2019 Radiofonia in Digitale
8/9
0
e come qualit in linea con le teche disponi-bili dai piccoli gestori radiofonici.Il processo di trasformazione sartuttavia len-toe dovr avvenireprogressivamenteconla pos-sibilit di coesistenza congliattualicanaliana-logici. In particolaretaletrasformazione riuscira decollareinmodosostanzialesolodopolami-grazionedelletrasmissioni radiofonicheal DMB.Il sistemaDVB-H/DVB-SHha tutte le poten-zialit per trasmettere, oltre il Mobile-TV, an-che radiofonia di alta qualit e con efficienzaspettrale simile a quella del DMB. tuttaviaormai accertato che il tipo di utilizzazione siconcentrer in Europa sul Mobile-TV.Cinonesclude la possibilit di utilizzarlo con suc-cesso negli stessi cellulari per la televisionemobile anche per radiofonia, ma in ogni casoil suo uso si differenzier da quello del DMB,orientandosi pi a considerare i canali musi-cali come Servizi della Societ dellInfor-mazionecon servizi premium (eventual-menteon demand ed a pagamento), ascol-
tabili tramite ricevitori integrati nei cellulari. infine importante ricordare, come interes-sante possibilit applicativa, i
sistemi satelli-tariche hanno il vantaggio di una rapida co-perturadelterritorio ma chetuttavia nelle areecittadine ed in presenza di edifici e altri osta-coli, troverebbero gravi difficolt di funziona-mento,non sisabene quanto facilmentee com-piutamente risolvibili attraverso le reti digapfillerterrestri operanti alle stesse frequenze.Sembra pertanto opportuno concepirli pi inunottica di integrazione delle reti terrestri.Oc-corre inoltre fareattenzione che tali sistemi nonvengano offerti in modalit non compatibilecon la filiera principaleDMB, riducendo le pos-sibilit di efficienza spettrale e operando connumerosigap-fillerun raddoppio delle reti ter-restri a diffusione DMB/DAB+.Unultima considerazione: nel passaggio allaradio digitale, non ha senso parlare di quantiprogrammi attuali possono trovare allocazio-ne in un multiplex quanto piuttosto opportu-
M O N D O D I G I T A L E n . 1 - m a r z o 2 0 0 8
1
0
0
1
46
Quali gli investimenti da affrontare e i costi dei ricevitori per una modernarete radiofonica digitale?
Mentre in passatolinvestimento per una rete radiofonica comportava un impegno economico di una certa consistenza oggi la pre-senza dinfrastrutture gi esistenti a cui appoggiarsi (siti radiofonici e televisivi e rete trasmissiva a grande distanza) nonch la con-tinua diminuzione dei prezzi per gli apparati elettronici anche professionali, rende le corrispondenti cifre abbastanza contenute.Solo allo scopo di dare un grossolano ordine di grandezza degli investimenti sorgenti(escluso cio i siti, le torri, i gruppi di conti-nuit e la rete trasmissiva digitale in cui la capacit impiegata trascurabile rispetto alle necessit della rete televisiva) si pu in-nanzitutto valutare il costo di una rete trasmittente VHF a copertura nazionale in SFN (Single Frequency Network) per realizzare ladiffusione di un blocco di un multiplex radiofonico da 1,5 MHz.In talebanda si ingrado di ospitare10 programmiradiofonici in tecnicaDMB (con possibilitdi associare adogniprogramma radio an-che trasmissioni di servizio in video lento, il cosiddetto visual radio) e 20 programmi puramente radiofonici nel caso DAB+. In un multi-plexpossonocoesisterei due tipidi standardpoich i ricevitoripi moderniprevedono ormai il bi-standard.Il calcolo verr effettuato per una copertura in banda VHF, dal momento che la grande capacit in programmi dei moderni standardradiofonici DMB e DAB+, associata allevoluzionein atto verso loswitch-offdella retetelevisiva analogica, permetter manmano diavere disponibili, almeno per le reti a copertura nazionale, gli slot di banda VHF necessari per la radiofonia. Il pi costoso impiegodella banda L, per il maggior numero di trasmettitori necessari (da 2 a 2,5 volte), sar confinato ad alcune programmazioni a coper-tura regionale o provinciale che potrebbero soffrire di interferenze se realizzatein banda VHF.
Nel caso di una rete nazionale, la codificadi sorgente deisingoli programmi e lapparato di multiplazione degli stessi effettuato a li-vello nazionale e pertanto linvestimento relativo (circa 20 kper ciascun codec di programma e 30 kper il multiplex) incide margi-nalmente sul costo complessivo della reteche sostanzialmente legato ai trasmettitoriper la diffusione.Ciascun trasmettitore (inclusivodei modulatori) di varia potenza,corrisponde ad un costo di investimento da 50 a 150 k a secondadelle necessit di potenza richiesta nella pianificazione dellimpianto.Se,in primabattuta,si intende coprirein outdoor una percentualedellapopolazionepariall80% associata,perla ricezione indoor,ad una coperturaprobabilisticaallinternodella casa (parametro denominato locationprobability) attornoall85%dei locali,il nume-ro mediodi impiantitrasmittentinecessario inbandaVHF risulta attorno ai 70 di cuiil 30% di bassa potenza (200 W) e la restantepartedi altapotenza(2 kW). Coni parametri sopra richiamati,il costo complessivo dinvestimento di talerete risultapertanto attorno agli 8,5M chepuarrotondarsia10M sesihainalcunezonenecessitdigapfiller.Sesitienecontodiuncostodiinstallazioneparial30%e delle parti centrali il costo di investimento complessivo perun multiplex a diffusione nazionale si aggira pertanto attorno ai 14 M.Per quanto riguarda iricevitori, i prezzi tendono ormai ad essere particolarmente contenuti: un ricevitore fisso DMB semi pro-fessionale si aggira attorno ai 250 , mentre un ricevitore portatile DMB/DAB+ ormai sotto i 100 e i prezzi sono ancora desti-nati a scendere quando aumenteranno i volumi.
VVaalluuttaa zzii oonnii eecc oonnoommii cchhee
-
7/26/2019 Radiofonia in Digitale
9/9
no ragionare in termini di bit-rate e valore ag-giunto rispetto al servizio attuale. In altre paro-le importante capire cosa un gestore avr ne-cessit di dare per creare negli utenti un ade-guato appeal. Ci una naturale conse-guenza di come possa essere proficuamentesfruttato il Dividendo Digitaleattraversolintroduzione di servizi innovativi in grado diattirare linteresse e quindi di fare mercato.La risposta a questa domanda consentir dicapire se effettivamente si potr costruireunofferta interessante e quanti nuovi pro-grammi (per esempio, di servizio) serviran-no. Solo in tal modo si sar in grado di creareuna vera pianificazione della transizione.Per concludere, infine, occorre tener presenteche le considerazioni di tipo economico, essen-ziali nelle valutazioni concrete, sono al momen-to di difficile sintesi, perch non sono attual-mente disponibili sufficienti dati certi. Tutta-via, si pu trovare un minimo di elementi di ri-ferimento nellapposito riquadro.
Acronimi
T-DAB: Terrestrial-Digital Audio BroadcastingT-DMB: Terrestrial-Digital Multimedia BroadcastingDAB-IP: Digital Audio Broadcasting - Internet Protocol
DAB+: Digital Audio Broadcasting Plus o Version 2DRM: Digital Radio Mondiale(standard europeoper OC, OM ed OL)
DRM+: Digital Radio Mondiale(standard allo stu-dio per FM)
DVB-H: Digital Video Broadcasting- HandheldDVB-SH:Digital Video Broadcasting - Satellite Handheld
(standard di 2a generazione DVB-H)ESDR: ETSI Standard for Digital Radio(standard
per radiofonia digitale satellitare)
Bibliografia
[1] Approvazione del programma per lo sviluppo in
Italia della radiodiffusione sonora in tecnica di-
gitale. Decreto 14 novembre 2001 del Ministerodelle Comunicazioni, Gazzetta Ufficiale, n. 291,15 dicembre 2001.
[2] DAB: ETSI ETS 300 401 Radio broadcasting sy-stems; Digital Audio Broadcasting (DAB) to mo-bile, portable and fixed receivers(recepita dal-lITU-R nella Raccomandazione BS.1114).REC. ITU-R BS.1114-5 Systems for terrestrial digital
sound broadcasting to vehicular, portable and fixedreceivers in the frequency range 30-3 000 MHz.
[3] DMB: ETSI TS 102 428 Digital Audio Broadca-sting (DAB); DMB video service; User Applica-tion Specification.
S-DMB: ITU-R BO 1130-4 System E Systems for di-gital satellite broadcasting to vehicular, portableand fixed receivers in the bands allocated to BSS
(sound) in the frequency range 1400-2700 MHz.[4] DVB-H: ETSI EN 302 304 (DVB); Transmission
System for Handheld Terminals (DVB-H).
[5] DRM: ETSI ES 201 980 Digital Radio Mondiale(DRM) System Specification.
IEC PAS 62272-1 Digital Radio Mondiale (DRM) -Part 1: System specification (published in 2002).
Rec. ITU-R BS.1514 (04/01) System for digitalsound broadcasting in the bands below 30 MHz.
[6] http://www.drm.org/system/universalstandard.php
[7] Approvazione del regolamento recante la di-sciplina della fase di avvio delle trasmissioniradiofoniche terrestri in tecnica digitale. Auto-
rit per le Garanzie nelle Comunicazioni, Deli-berazione 9 marzo 2005 (Deliberazione n.149/05/CONS). Gazzetta Ufficiale. n.69, 24marzo 2005.
[8] Report to the 61st DVB-TM meeting.(Author:David Crawford, Rapporteur) 29.06.2005.
[9] EBU Tech review: MPEG-4 HE-AAC v2- audio co-ding for todays digital media world (2006)http://www.ebu.ch/en/technical/trev/trev_305-moser.pdf
[10] An MPEGIF White Paper: Understanding MPEG-4: Technologies, Advantages, and Marketshttp://www.m4if.org/public/documents/vault
/MPEG4WhitePaperV2a.zip
M O N D O D I G I T A L E n . 1 - m a r z o 2 0 0 8
1
47
0
0
0
1
SALVATOREMORELLO, laurea in Ingegneria Elettronica allUniversit di Napoli nel 1965. Corsi IRI post-universitari di Management e BusinessAdministration. Vicedirettore ICT RAI fino al 1998, prima Dirigente Impianti e Tecniche di Produzione dellAudio, radiofonico e televisivo, poiDirettore Telecomunicazioni. Dal 1998, Consulente libero professionista su Reti di Telecomunicazioni aziendali e relativi scenari di business.Docente in Corsi di Formazione e di Aggiornamento aziendali e nella P.A. Autore di pubblicazioni per riviste specialistiche e relatore in con-vegni pubblici e privati. stato Vice Presidente dellAES (Audio Engineering Society) per lItalia.E-mail: [email protected]
GUIDO VANNUCCHI, laurea in Ingegneria Industriale allUniversit di Bologna nel 1958, Master Science EE alla Stanford University nel 1963,Libera Docenza in Comunicazioni Elettriche nel 1971. Direttore Generale Telettra dal 1983 al 1990, Senior Consultant di Olivetti Telemedia,Vice Direttore Generale della RAI dal 1996 al 1998. Attualmente Docente al Politecnico di Milano di Architetture per reti e sistemi multi-servizio, membro ordinario del Consiglio Superiore delle Comunicazioni e Consigliere di Amministrazione dellAgenzia Spaziale italiana.Laurea ad honorem in Ingegneria delle Telecomunicazioni, conferita dallUniversit di Padova nel 1998, per i contributi scientifici e mana-geriali nel campo della trasmissione dei segnali.
E-mail: [email protected]