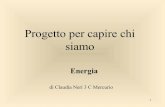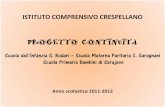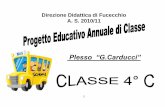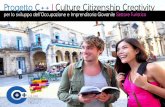ISTITUTO “C. DE TITTA” – LANCIANO Progetto Comenius – Primavera Europea
PROGETTO C ONTAMINACTION
Transcript of PROGETTO C ONTAMINACTION

1
PROGETTO
C ONTAMINACTION Promozione del benessere e prevenzione dei rischi legati all’uso di sostanze
stupefacenti.
RAPPORTO DI RICERCA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
A cura di Marco Giordani e Annie Noro
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 I.C. PALMANOVA – ASS2 BASSA FRIULANA – ISONTINA – COSMO SCS

2
Sommario
1. ContaminAction: la ricerca _____________________________________________________ 3
2. Il benessere _________________________________________________________________ 4
3. Benessere a scuola ___________________________________________________________ 7
4. Benessere nel tempo libero ____________________________________________________ 14
5. Comportamenti a rischio _____________________________________________________ 17
6. Argomenti per l’intervento in classe _____________________________________________ 22
7. Conclusioni ________________________________________________________________ 23
8. Indicazioni di intervento ______________________________________________________ 24

3
1. ContaminAction: la ricerca
La ricerca ContaminAction è stata realizzata per mezzo di un questionario con lo scopo di indagare sui temi
ritenuti importanti per la vita degli studenti delle scuole secondarie di primo grado (SSPG). Il benessere e le
life skills hanno fatto da filo conduttore e sono stati approfonditi in relazione a due contesti significativi per
i ragazzi, quali la scuola e il tempo libero. In particolare le domande hanno riguardato la comunicazione tra
compagni di scuola, l’amicizia, il divertimento, i rischi relativamente all’uso della tecnologia e al consumo di
bevande alcoliche. Le informazioni raccolte sono state elaborate, analizzate ed utilizzate nella fase della
sperimentazione dell’intervento di Peer Education con gli studenti della classe pilota, secondo quanto
definito dalla metodologia della ricerca-intervento e della progettazione partecipata.
Al sondaggio on-line hanno partecipato tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado (SSPG) di
Palmanova che nelle giornate di somministrazione del questionario erano presenti a scuola. La
somministrazione è stata realizzata grazie alla gentile collaborazione degli insegnanti. Gli insegnanti che
hanno somministrato il questionario hanno spiegato agli studenti gli obiettivi del progetto ContaminAction
e hanno dato alcune istruzioni per la compilazione. La compilazione del questionario è durata circa 35
minuti.
Questa sezione di ricerca si pone in continuità con la ricerca rivolta agli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado (SSSG). Con gli studenti della SSPG si è analizzata maggiormente la comunicazione in classe e
la vita a scuola mentre con gli SSSG gli aspetti legati al divertimento e al consumo di alcol e droghe nel
tempo libero.
Il lavoro di coordinamento e coinvolgimento delle classi è stato curato dall’insegnante referente alla salute
su mandato del Dirigente. Senza tale contribuito il lavoro di ricerca non sarebbe stato possibile.
Analisi dati
Il questionario prevedeva domande di tipo chiuso, semi aperte e aperte. Per questo sono stati utilizzati diversi tipi di trattamento e analisi dei dati.
Le domande chiuse che generalmente davano la possibilità di assegnare una preferenza o un valore da 1 a 5 (es. 1 = poco e 5= molto) sono state analizzate tenendo conto della mediana, della media e dei risultati dei test non parametrici utilizzati in base alle esigenze di analisi. Le domande che prevedevano la possibilità di scegliere un’opzione tra più risposte codificate sono state analizzate calcolando le frequenze e il chi quadro.
Le variabili con domane aperte sono state analizzate aggregando le parti di testo con significati simili e tenendo integre quelle frasi rappresentative del fenomeno o di particolare interesse per l’intervento. L’unica variabile “discriminante” utilizzata per confrontare i risultati è stata la variabile di genere. I dati sono stati analizzati utilizzando il programma SPSS Statistic.
Campione
Il questionario ha coinvolto 221 studenti della scuola Secondaria di Primo grado di Palmanova dei quali il 50,2% femmine e il 49,8% maschi, l’età media degli studenti è di 12 anni.

4
2. Il benessere
La tab. 1 mostra come in generale il benessere, sia ritenuto importante e molto importante per il 91,9% dei rispondenti (punteggi 4 e 5).
Tab. 1 Quant'è importante il benessere?
Valore di scala Percentuale
5 73,3
4 18,6
3 5,9
2 ,9
1 1,3
Totale 100
Scale:1 = per niente, 5 = Molto
Qual è il tipo di benessere più importante? La tab. 2 evidenzia che lo stare bene con gli altri (48,4%) prevale sullo stare bene con se stessi (35,3%) e sul benessere fisico (16,3%). La prospettiva sociale, e quindi l’importanza della comunicazione, pare rivesta estrema importanza per i pre-adolescenti. Questo dato è molto interessante perché mette in evidenza quali sono i temi da affrontare con i giovani (le competenze da attivare e sostenere). Il dato sottolinea anche l’im-portanza di affrontare con i ragazzi la relazione esistente tra “star bene con se stessi” e “star bene con gli altri” oltre all’importanza del benessere fisico (in una prospettiva di lungo termine). Tema del futuro.
Tab. 2 Qual è il tipo di benessere più importante?
Percentuale
Benessere relazionale (stare bene con gli altri) 48,4
Benessere psicologico (stare bene con sé stessi) 35,3
Benessere fisico (stare bene fisicamente) 16,3
Totale 100
Benessere e life skills
La tab. 3 riporta come per quasi la totalità dei rispondenti (92,7%) conoscere se stessi sia molto importante per il proprio benessere. Gli stessi ragazzi ritengono di conoscere se stessi piuttosto bene per la maggior parte dei rispondenti anche se, comunque, in una misura inferiore rispetto a quanto lo considerino importante.

5
Tab. 3 Benessere e conoscenza di se stessi
Valore di scala Importanza di
conoscere se stessi (%)
Quanto ritiene di
conoscere se stesso (%)
5 67,4 43,9
4 25,3 37,1
3 5,4 12,7
2 0,5 3,6
1 1,4 2,7
100 100
In misura inferiore rispetto alla tab. 3 ma in misura comunque significativa si ritiene che conoscere le emozioni proprie e quelle degli altri sia importante per stare bene, l’80,5% lo ritiene molto importante anche se, anche in questo caso sono di meno coloro che si sentono competenti nel farlo nella loro vita quotidiana (68,8%) con quasi un quarto dei rispondenti che si colloca in una posizione intermedia (23,5%).
Tab. 4 Benessere e conoscenza emozioni
Valore di scala Importanza conoscenza emozioni Conoscere emozioni
5 51,1 20,8
4 29,4 48,0
3 13,1 23,5
2 3,2 4,1
1 3,2 3,6
Scala:1=per niente 5=Molto 100 100
Saper dialogare è ritenuto molto importante per il benessere per l’84,2% dei rispondenti che anche in questo caso si ritiene in grado di farlo nella vita quotidiana in misura inferiore rispetto alla percezione di importanza ma, comunque, in misura significativa (74,6%) con il 15,4% che si ritiene mediamente competente mentre quasi 1 su 10 non si ritiene in grado di farlo (10% somma val. 1+2).
Tab. 5 Benessere e dialogo
Valore di scala Importanza
di saper dialogare
Competenze
dialogiche
5 55,2 33,0
4 29,0 41,6
3 11,8 15,4
2 1,8 8,2
1 2,2 1,8
Scala:1=per niente 5=Molto 100 100

6
La tab. 6 evidenzia come anche saper dire di no sia ritenuto molto importante dalla maggioranza dei ragazzi (81%) che però in misura significativamente inferiore si ritiene in grado di farlo (52% somma dei punteggi di 4 e 5), poco più di un quarto (28,5%) si ritiene mediamente in grado di dire di no e quasi un quinto (19.5% somma valori 1 e 2) ritiene non esserlo
Tab. 6 Benessere e saper dire di no
Valore di scala Importanza
di saper dire di no
Competenza
nel dire di no
5 50,2 21,7
4 30,8 30,3
3 14,0 28,5
2 3,2 14,5
1 1,8 5,0
Scala:1=per niente 5=Molto 100 100
In sintesi
Il benessere è un argomento importante per i ragazzi che lo associano in misura preponderante alla dimensione della socializzazione. Connessa a ciò l’importanza da loro attribuita alle competenze dialogiche, emotive e relative alla capacità di dire di no, competenze che non sempre ritengono di avere e sulle quali potrebbe essere interessante intervenire, insieme alla connessione esistente tra benessere personale e
relazionale.

7
3. Benessere a scuola
Stare bene a scuola
Divertirsi e imparare cose nuove, è un po' stancante ma ci andiamo per il nostro bene1.
Ai giovani è stato chiesto di esprimere con delle risposte alle domande aperte il significato dello star bene a scuola e dello stare bene con i propri amici nel tempo libero. I risultati sono sorprendenti e la quantità di osservazioni mettono in evidenza come la questione del benessere a scuola si articoli in modo complesso entro quattro direttrici: il contesto fisico e di apprendimento, la relazione con gli insegnanti, la relazione con i compagni, il successo scolastico. Come è possibile vedere dalle risposte degli studenti questi quattro elementi sono tra loro interdipendenti.
Contesto di apprendimento e ambiente fisico
L’ambiente fisico ed il contesto di apprendimento possono influenzare la percezione di benessere.
La dimensione degli spazi e le caratteristiche estetiche possono essere infatti visti da qualcuno come un problema:
“Il benessere è riuscire a stare bene anche in un edificio non molto gradito da me e in certi casi anche odiato, per giunta molto grande”.
Qualcun’altro mette in evidenza la quantità di compiti e di verifiche assegnate dagli insegnanti e collega tutto questo a condizioni di stress personale:
“Avere la cartella leggera, non avere una marea di compiti per casa, non studiare 1000 pagine al giorno, e fare tanta ginnastica, gita e scioperi scolastici”. “Non avere problemi, essere sereno e entrare a scuola senza problemi, senza essere stressato da verifiche e compiti”.
L’aspetto che maggiormente “disturba” il benessere all’interno del contesto di apprendimento è legato però alla mancanza di silenzio durante le attività cioè alla “confusione” che si genera nelle classi durante le lezioni:
“Non litigare con i compagni ed ascoltare la lezione senza continue interruzioni”, “Lavorare bene senza avere il mal di testa ogni lezione per colpa di chi fa caos (…)”. “Poter lavorare tranquillamente cioè lavorare in serenità”.
Confusione che viene solitamente generata da alcune persone che non sono interessate/coinvolte durante l’attività scolastica.
1 Frase tratta dai dati qualitativi del questionario.

8
Insegnanti
Agli insegnanti e alle loro competenze comunicative, relazionali e professionali viene attribuito un certo grado di responsabilità nella generazione di situazioni di benessere ma anche nella produzione di risultati scolastici positivi.
Il benessere in questo caso assume i seguenti significati:
“Stare in un ambiente favorevole alla propria crescita dove puoi imparare cose nuove ed interessanti e dove sei circondato da gente responsabile ed affidabile, che ti spiega e ti aiuta capire le cose più difficili e incomprensibili”. “Trovarsi bene con i professori, trovarsi bene quando i professori spiegano le lezioni (…)”. “Soprattutto stare bene con i professori, perché se non ti piacciono i professori che hai non puoi andare bene a scuola e di conseguenza vieni presa in giro e quindi stai male”.
Infine, all’insegnante viene richiesto un orientamento sia al ruolo che alla persona dello studente, la “giusta severità” deve mescolarsi ad un certo grado di simpatia:
“Avere professori simpatici e giustamente severi”.
Relazione con i compagni Aspettative Per quanto riguarda il benessere in relazione al rapporto con i compagni i temi sono i seguenti: rispetto, amicizia e reciproco aiuto senza prendersi in giro e prevaricare. Riportiamo due frasi significative e rappresentative di quanto emerso dalle risposte:
“Stai bene a scuola quando la mattina si va senza quella preoccupazione di essere preso in giro, di sentirsi escluso...in poche parole senza una sensazione di malessere”. “Anche in classe non ci devono essere prese in giro che tutti si aiutano; che non si ci giudica a vicenda e che ognuno si apprezza”.
La tab. 7 mostra che il “sostegno e il divertimento” sono le scelte più utilizzate per dire cos’è il rapporto con i compagni di classe che, sommate, riguardano quasi metà del campione (47,1%). Il rispetto (18,1%) e la fiducia (10,9%) riguardano il 29% dei rispondenti. Per il 10,4% il rapporto in classe è rappresentato dal volersi bene. Imparare e fare delle cose insieme rappresenta il 10,8%.
Sono più femmine rispetto ai maschi a dire che “è importante il sostegno reciproco” mentre il “confidarsi” è una dimensione esclusivamente maschile (dato a dir il vero inaspettato).
Tab. 7 Cos'è per te soprattutto il rapporto con i compagni di classe?
Percentuale
Sostenersi a vicenda*** 24,0
Divertirsi insieme 23,1
Rispettarsi 18,1
Fidarsi 10,9
Volersi bene 10,4
Imparare delle cose assieme 6,3
Fare attività assieme 4,5
Confidarsi** 2,7
Totale 100
*** Sostegno più femminile - ** Confidarsi più maschile

9
Un aspetto che meriterebbe di essere maggiormente approfondito è il significato del sostenersi a vicenda. Sostenersi significa aiutarsi nel bisogno in modo reciproco oppure aiutarsi giustificando un errore o un’azione scorretta di fronte ad un insegnante o agli altri compagni? Si tratta di un sostegno incondizionato che sostiene quindi il “noi” nei confronti di un “loro” o significa aiuto e rispetto? Sono queste alcune domande di approfondimento che si potrebbero/dovrebbero fare ai giovani per promuovere una riflessione al riguardo.
Ciò che i rispondenti si aspettano dai propri compagni deriva dall’analisi delle risposte ad una domanda aperta. I giovani si aspettano in prevalenza: “rispetto e non essere presi in giro”, “amicizia”, “non litigare”, “gentilezza”, “calma” e “onestà”.
Accanto a questo ci sono le categorie che riguardano il vivere a scuola ed il profitto: “l’aiuto, in caso di difficoltà”, “essere sinceri con i professori”, “impegnarsi di più”, “garantire il silenzio in classe”, “maggior maturità”, “ascolto”, “responsabilità”.
Queste ultime categorie sono state selezionate in modo meno frequente rispetto alle prime. Ciò ad indicare che tra le aspettative degli studenti “l’amicizia e divertimento” da un lato e “il rispetto” dall’altro prevalgono sugli aspetti legati al profitto e a tutti quegli aspetti più legati al percorso formativo.
Gli studenti si aspettano dai compagni soprattutto un orientamento alla persona e quindi il riconoscimento dell’unicità e specificità, piuttosto che un orientamento al ruolo di studente e quindi alla prestazione e al risultato scolastico. Dalla scuola gli alunni si aspettano soprattutto buone relazioni, essere accettati e rispettati mentre si aspettano un po’ meno l’avere dei compagni di “lavoro” con i quali condividere l’apprendimento e la conoscenza. Spicca comunque “l’aiutarsi in caso di bisogno”.
Per i rispondenti andare d’accordo con i propri compagni è mediamente molto importante. In una scala da 1 a 5 la media dei risultati è pari a 4,4 (da ora in poi M 4,4). La tab.8 mostra che, per la quasi totalità dei rispondenti, è molto importante andare d’accordo con i propri compagni In una scala da 1 a 5, l’86,5% dei rispondenti ha assegnato un punteggio compreso tra 4 e 5 (4 = 25,8%; 5= 60,7%). Nessuna differenza significativa tra le risposte dei maschi e quelle delle femmine (Test U di Mann Whitney)2.
Tab. 8 Quanto è importante andare d'accordo tra compagni?
Valore di scala Percentuale
5 60,7
4 25,8
3 9,0
2 2,7
1 1,8
Totale 100
Scale:1 = per niente, 5 = Molto
2 Da ora in poi sarà citato l’esito del Test solo in caso di differenze statisticamente significative tra maschi e
femmine.

10
La situazione in classe
La tab. 9 mette in evidenza che a scuola tra compagni prevale soprattutto il divertimento (41,3%), e la comunicazione su argomenti che non riguardano principalmente la scuola (15,3%). Condividere le opinioni personali e le esperienze, esprimere idee differenti e esprimere punti di vista diversi riguarda rispettivamente il 9,2 il 7,1% dei rispondenti. Per il 4,6% del campione a scuola prevalgono le prese in giro.
Sono pochi gli studenti che indicano quali aspetti prevalenti il “raccontarsi cose che riguardano la scuola” e “condividere i propri sentimenti”. Infine, per il 2%, in classe prevale il conflitto.
Tab. 9 Cosa prevale in classe?
Percentuali
Ci divertiamo a parlare tra noi 41,3
Ci raccontiamo cose che non riguardano la scuola 15,3
Abbiamo idee differenti 9,2
Condividiamo le nostre opinioni ed esperienze 9,2
Esprimiamo punti di vista diversi 7,1
Abbiamo tutti le stesse opportunità di esprimerci 5,1
Le prese in giro 4,6
Ci raccontiamo delle cose che riguardano la scuola 3,6
Condividiamo i nostri sentimenti 2,6
Situazioni di conflitto tra di noi studenti 2,0
Totale 100
Merita una menzione come per alcuni a scuola prevalga il parlare dei rapporti con i partner e il parlare di sesso. Anche se si tratta di pochissimi casi, il tema meriterebbe un approfondimento: si tratta di sparuti casi o di un bisogno che solo alcuni hanno voluto esplicitare?
La tab.10 mostra che poco più della metà dei rispondenti va molto d’accordo con i propri compagni. In una scala da 1 a 5, il 54,3% dei rispondenti ha assegnato un punteggio compreso tra 4 e 5 (4 = 40,7%; 5= 13,6%), la media è di 3,5.
Tab. 10 Nella tua classe quanto andate d'accordo tra compagni?
Valore di scala Percentuale
5 13,6
4 40,7
3 33,5
2 9,0
1 3,2
Totale 100
Scale:1 = per niente, 5 = Molto
Media 3,5

11
Risulta interessante sottolineare la differenza tra l’importanza di andare d’accordo 86,4% (punteggi 4 e 5) e la percezione di quanto realmente gli studenti dichiarino di andare d’accordo tra loro 54,3% (punteggi 4 e 5). Il 33,5% (punteggi 3) degli studenti ha una posizione intermedia e il 12,2% sostiene di andare poco o per nulla d’accordo (punteggi 1 e 2).
Come mostra la tab. 11, più di ¾ dei rispondenti (76,5%) sono interessati a ciò che i propri compagni: dicono (22,7%), fanno (23,5%) e pensano (30,3%). Mentre l’82,4% degli studenti ritiene che i propri compagni siano interessati a ciò che loro: dicono (33%), fanno (30,8%) e pensano (18,6%). Interessante è il confronto tra le due serie di dati: gli altri sembrerebbero più interessati a ciò che i rispondenti dicono e fanno e meno a ciò che pensano. Viceversa i rispondenti sono più interessati a ciò che gli altri pensano rispetto a ciò che dicono o fanno. Si tratta di una percezione diversa dello stesso problema su cui sarebbe interessante far riflettere gli studenti.
Tab. 11 Cosa interessa a me dei miei compagni e cosa interessa ai miei compagni di me
Cosa interessa a ME di LORO* Cosa interessa a LORO di ME**
Quello che dicono/dico 22,7 33,0
Quello che fanno/faccio 23,5 30,8
Quello che pensano/penso 30,3 18,6
NON interessati/o 23,5 17,6
Totale 100 100
A raccontare qualcosa di sé ai propri compagni è l’81,4% degli studenti. La tab. 12 mostra che per il 43,4% di chi ha risposto al questionario è molto importante “raccontare qualcosa di sé agli altri” e per il 37,6% è molto importante (valori 4 e 5) che i compagni raccontino qualcosa di sé al rispondente. Un terzo degli studenti che hanno risposto alle due domande non si sbilancia e fornisce un punteggio intermedio. Infine, è il 25% dei rispondenti a non ritenere importante parlare di sé ai compagni e il 29% a non ritenere importante che i compagni raccontino qualcosa di sé a loro. Sono i maschi che ritengono più importante raccontare qualcosa di sé agli altri rispetto alle femmine.
Tab. 12 Importanza di raccontare qualcosa di sé
Valore di scala Rispondenti* Compagni Compagni** Rispondente
5 14,9 13,6
4 28,5 24,0
3 32,6 33,4
2 14,5 18,1
1 9,5 10,9
Scala:1=per niente 5=Molto 100 100
*Quanto è importante raccontare qualcosa di sé ai compagni **Quanto è importante che i compagni raccontino qualcosa di sé al rispondente
La tab. 13 evidenzia che il 22,6% degli studenti dichiara di avere dei problemi (molti problemi) con i propri compagni (punteggi 4 e 5), il 24% si pone in una situazione intermedia (valore 3) e 53,4% di avere pochi o di non avere problemi con i compagni. Il dato si collega con quello relativo all’andare d’accordo tra compagni ed evidenzia l’opportunità di intervenire in tal senso.

12
Tab 13 Nella tua classe avete dei problemi tra compagni?
Valore di scala Percentuale
5 8,1
4 14,5
3 24,0
2 29,4
1 24,0
Totale 100
Scale:1 = per niente, 5 = Molto
Media 2,5
Suggerimenti
La domanda su “cosa bisogna fare per andare d’accordo” era di tipo aperto. Le risposte non si discostano molto dalle aspettative che i giovani hanno nei confronti dei propri compagni. In primis si trova il tema del rispetto che viene riportato da molti come fondamentale e che nelle risposte spesso si combina ad altri elementi quali: “il non prendersi in giro, non litigare, essere simpatici, conoscere l’altro, parlare e dialogare, giocare insieme all’altro, capirsi, entrare in empatia, accettarsi e farsi accettare per quello che si è, ascoltarsi (…)”.
Di seguito si riportano alcune risposte fornite dagli studenti che evidenziano come l’andare d’accordo sia un aspetto complesso che merita una riflessione all’interno della classe scolastica. Per andare d’accordo bisogna comunicare “(…) i compagni si devono ascoltare, capire, si devono comprendere le loro opinioni; nel contempo non si deve prevaricare “(…) non essere prepotenti”, “(…) non insultarsi e trovare ogni ragione possibile per litigare (…)”, “non credersi superiori (…)”, “perché siamo tutti uguali e non prendersi in giro per sciocchezze come il colore della pelle, la provenienza”, “dando a tutti la stessa possibilità di parlare, (…) a volte i prof. lasciano parlare solo alcuni”. Accanto a questi aspetti comunicativi generali c’è anche chi sostiene l’importanza dell’apertura all’altro in termini emotivi/affettivi: “Avere il coraggio di esprimere i propri sentimenti”.
L’andare d’accordo con i compagni può richiedere un certo sforzo per: conformarsi a loro: “Vado d’accordo con i miei compagni stando alla moda con i giochi di adesso, belli e moderni” ma non completamente e con tutti “(…) e con altri compagni (…) con passioni identiche”; aprirsi all’altro “Stando in banco con tutti e fare nuove esperienze”, rispettando i sui punti di vista: “Rispettarli nonostante abbiano un punto di vista diverso dal nostro” superando i limiti personali dell’altro “e non soffermarsi sui difetti delle persone ma sugli aspetti positivi”. “Se una persona ti sta antipatica semplicemente basta essere educati con lei per mantenere un comportamento civile”.
L’andare d’accordo richiede poi azioni concrete come: “Aiutare quelli in difficoltà (…) controllare che l’altro non abbia problemi”. “Chiedere come sta il compagno, in disparte, e magari capire e aiutarlo il più possibile e magari stare con lui e giocarci, parlarci” e riuscire nell’intento di includerlo “facendolo entrare nel gruppo dove sei tu”. Questo richiede comunque reciprocità: “Bisogna soddisfare le sue esigenze, aiutarlo se ha delle difficolta ma altrettanto deve fare lui”. L’impegno di “dedicarsi all’altro” ha anche dei risvolti interessanti, ad esempio, permette di aprirsi a nuove possibilità. “Bisogna giocare con loro anche quando si preferisce giocare con gli altri perché si potrebbe scoprire che è una persona molto affidabile e se proprio devo dirlo si potrebbe diventare anche migliori amici”. L’andare d’accordo può richiedere un sostegno che va oltre alla semplice convivenza e conoscenza reciproca. In casi di difficoltà nel profitto ma soprattutto di forme estreme di prevaricazione i giovani ritengono sia importante sostenere i propri compagni: “Bisogna appoggiarlo nei casi di un brutto voto o di altre cose spiacevoli che gli sono accadute o nel caso del bullismo aiutarlo e appoggiare le sue idee”.

13
In sintesi
Il benessere a scuola riguarda quindi gli spazi in cui i ragazzi vivono che dovrebbero essere esteticamente gradevoli, il rapporto con gli insegnanti che dovrebbero orientarsi al ruolo ma con attenzione alla persona dello studente e essere in grado di aiutarli in situazioni di difficoltà, e i compagni di classe da cui ci si aspetta sostegno e anche divertimento ma, soprattutto, un atteggiamento non prevaricante che permetta agli studenti di non preoccuparsi di essere presi in giro. Nella realtà nella relazione con i compagni prevale il divertimento e, nonostante l’importanza attribuita all’andare d’accordo con i compagni, questo non sempre accade e crea preoccupazione e in misura non trascurabile sfocia nelle prese in giro che sono vissute come un problema. Si ritiene che ci sia una deflazione dell’intensità comunicativa che sfocia forse in misura eccessiva nel divertimento fine a sé stesso, che non viene sostenuto né dall’abitudine al confronto su idee diverse né da una collaborazione su aspetti scolastici e nemmeno da rapporti di amicizia. Si ritiene che questo sia un dato da tenere in attenta considerazione in quanto potrebbe sfociare in dinamiche di classe disfunzionali al benessere.

14
4. Benessere nel tempo libero
La frequentazione è una forma di comunicazione tipica del mondo giovanile che abbina l’amicizia (comuni-cazione interpersonale) al divertimento (comunicazione distesa). Si tratta di una comunicazione che per-mette ai giovani di aumentare la conoscenza di sé nel confronto con i propri pari, fare scelte autonome e sperimentare i rapporti interpersonali. Ma soprattutto è la forma che permette di identificare e distinguere un gruppo giovanile da altri sistemi sociali (classe scolastica, gruppo parrocchiale, sportivo …).
Amicizia e divertimento Come si può vedere nella tab.14 l’amicizia e il divertimento rappresentano due aspetti estremamente impor-tanti per la quasi totalità degli studenti, tanto che le scelte si concentrano nei punteggi 4 e 5 (93,7%). Nel punteggio più alto, l’amicizia (83,3%) prevale sul divertimento (72,9%).
Tab. 14 Importanza dell’amicizia e del divertimento
Valore di scala Amicizia* Divertimento**
5 83,3 72,9
4 10,4 20,8
3 3,6 3,2
2 ,9 1,4
1 1,8 1,8
Totale 100 100
Scale:1 = per niente, 5 = Molto
Media Amicizia=4,7, Media Divertimento 4,6
Amicizia “Gli amici ti devono aiutare, difendere, farti sempre sorridere e capirti”3. L’amicizia è un sentimento che coniuga diversi aspetti quali il sostegno (29,9%), il divertimento (24,4%), l’af-fetto (16,3%), la fiducia (12,2%), la comunicazione interpersonale (confidarsi 10%). Il rispetto (3,2%), il fare attività insieme (2,7%), e l’imparare delle cose insieme (1,3%) nel complesso non raggiungono il 10%. Si sot-tolinea come l’amicizia sia soprattutto una questione che riguarda la comunicazione e la sua esclusività. L’amicizia richiedendo impegno è selettiva “non si può essere amici di tutti”.
3 Frase tratta dai dati qualitativi del questionario.

15
Tab. 15 Cos'è per te soprattutto l'amicizia? Percentuale
Sostenersi a vicenda 29,9
Divertirsi insieme 24,4
Volersi bene*** 16,3
Fidarsi 12,2
Confidarsi 10,0
Rispettarsi 3,2
Fare attività assieme 2,7
Imparare delle cose assieme 1,3
Totale 100
*** volersi bene > femmine Utilizzando i contributi scritti dai ragazzi l’amicizia si basa su: la fiducia nella relazione: “è importante che l’amico mantenga i segreti”; il rispetto e l’accettazione “che abbia rispetto e non parli alle spalle (…) che non mi prenda in giro per quella che sono (…) che riesca ad accettare i miei difetti”; l’aiuto “che mi aiuti in molte cose (…) e nei momenti di bisogno”, “che mi ascolti nei momenti difficili”; l’esclusività della relazione: “che ci sia sempre per te”, “sia sempre lì per me quando ho bisogno di una mano”, “mi aiuti e che non mi sostituisca con un’altra persona”; la reciprocità: “che mi voglia bene e mi aiuti quando sono in difficoltà così poi farò lo stesso a lei/lui”; la consolazione: “che mi consoli quando sto male”, che “sia sempre vicino a me nel momento del bisogno”; la simpatia/gentilezza e l’affetto: “che sia fiducioso simpatico”, “da un amico io mi aspetto che mi voglia bene”.
Divertimento Il divertimento nel tempo libero per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado consiste nell’abbinare il gioco (es. praticare uno sport, utilizzare i videogiochi, per le ragazze truccarsi) allo stare insieme per parlare (di cose personali, di cosa si è fatto in altri momenti con altre persone) e scherzare. Generalmente il diverti-mento non ha spazi definiti. Sono luoghi di divertimento: la casa propria, la casa di amici, il cinema, fuori casa (…) facendo una passeggiata (…) stando insieme, da qualche parte (…) per dire o fare qualche cavolata. A questa età non è ancora diffusa la frequentazione di pub/bar/discoteca. “Correre per i campi e saltare i fossi”.
La frase riportata poco sopra è uno dei modi in cui si divertono alcuni tra i rispondenti al questionario e ci piace iniziare da qui perché ci sembra una metafora della preadolescenza. In questa fase della vita infatti si inizia a prendere le distanze dalla famiglia e si sperimenta, nella relazione e nell’azione, l’autonomia (fisica e psichica). La ricerca e la sperimentazione di libertà (“correre per i campi”) delimitati da “fossi” che vanno “saltati” assumendosi, consapevolmente e/o inconsapevolmente, dei rischi ben rappresenta questa fase della vita.
Si tratta di una sperimentazione che viene fatta molto spesso in compagnia degli amici abbinando divertimento:
“Divertirsi (…) al massimo (…) senza litigare (…) senza correre dei pericoli (…) giocando e scherzando (…) senza essere giudicati (…) senza annoiarsi (…) senza stare tutto il giorno con il cellulare (…) a fare cose pazze (…)”; ad intensità nella comunicazione:

16
“Significa parlarsi (…) confidarsi (…) dirsi ciò che abbiamo fatto quel giorno (…) sentirsi ascoltati (…) capiti (…) avere un legame forte (…) poter parlare senza timidezza (…) conoscersi meglio (…) condividere le proprie idee e le proprie emozioni (…)”;
anche per vincere quel senso di inadeguatezza e fatica:
“Significa liberarsi dal nervosismo (…) dallo stress (…) liberarsi dai pensieri fastidiosi (…) liberare la mente (…) fare qualcosa che piace”.
Confronto tra il rapporto con gli amici e il rapporto con i compagni di classe Alla fine di questo paragrafo facciamo un confronto tra le aspettative che i giovani hanno relativamente al rapporto con gli amici e a quello con i compagni di scuola. La tab. 16 evidenzia che il “sostenersi a vicenda” e il “divertirsi insieme” sono il denominatore che accomuna i rapporti con gli amici e quelli con i compagni di scuola. Gli aspetti più intimi come il “volersi bene”, il “fidarsi” e soprattutto il “confidarsi” prevalgono invece tra gli amici, mentre il “rispettarsi” prevale tra i compagni di scuola.
Tab. 16 Confronto tra il rapporto con gli amici e il rapporto con i compagni di classe Amici Scuola
Sostenersi a vicenda 29,9 24,4
Divertirsi insieme 24,4 23,1
Volersi bene 16,3 10,4
Fidarsi 12,2 10,9
Confidarsi 10,0 2,6
Rispettarsi 3,2 18,0
Fare attività assieme 2,7 4,4
Imparare delle cose assieme 1,3 6,2
Totale 100 100
Oltre al dato percentuale questi risultati sono interessanti quali spunti per avviare una riflessione sulle differenze e sui significati che gli studenti attribuiscono al “volersi bene” o al “rispettarsi” e quali differenze ci sono tra il “volersi bene” a scuola e il “volersi bene” all’interno di un rapporto di amicizia.
In sintesi
In sintesi l’amicizia è un sentimento che richiede il riconoscimento dell’altro come persona unica e specifica. L’amicizia richiede intimità, esclusività, comprensione dei bisogni dell’altro e aiuto e sostegno nel momento del bisogno. Va comunque sottolineato il primato del sostenersi a vicenda che non è privo di rischi: quando ad esempio sostiene il primato del “noi” (noi amici) in contrapposizione ad un “loro” (compagni, insegnanti, genitori, altri gruppi giovanili, stranieri) dando vita a forme di partecipazione antagoniste. Se il sostenersi implica poi, ad esempio, la richiesta di mantenere segreti indiscriminatamente, ad esempio su un abuso, il consumo di alcol o di sostanze stupefacenti, si capisce che questa forma di comunicazione assume connotati rischiosi per la salute e la sicurezza delle persone. Divertirsi con gli amici significa “frequentarsi” e come abbiamo già avuto modo di dire questa è una forma di comunicazione tipica dei gruppi giovanili che va sostenuta nella sua forma più adeguata (giusto equilibrio tra

17
divertimento sano e amicizia in quanto essa rappresenta fonte di benessere ed elemento protettivo da disagio e dipendenza). Purtroppo la possibilità che i giovani hanno di vivere la propria pre-adolescenza è sempre più limitata e relegata a contesti organizzati che non favoriscono sperimentazione, autonomia e assunzione di rischio consapevole.
Il divertimento ed il sostegno reciproco sono le due dimensioni che accomunano il rapporto amicale e quello coi compagni di classe anche se con una differenza relativamente ad un maggiore coinvolgimento affettivo con i propri amici rispetto ai compagni, con i quali la dimensione del rispetto senza coinvolgimento affettivo è invece dominante. Questo è prevedibile e dal nostro punto di vista anche auspicabile, dal momento che l’amicizia è molto più esigente e quindi non si può pensare che i ragazzi siano contemporaneamente amici con tutti i loro compagni di classe.
5. Comportamenti a rischio
Uso del cellulare
A possedere un cellulare è l’80% degli studenti. Del 20% dei giovani che non lo possiedono il 10% usa quello dei genitori e il 10% generalmente non lo usa, salvo che in momenti di necessità.
La tab. 17 mette in luce il fatto che il 27% dei giovanissimi utilizza il cellulare per “meno di un’ora al giorno” quasi la metà (48,1%) dice di utilizzarlo da 1 a 2 ore, mentre il 15,3% lo usa dalle 3 alle 4 ore. Infine uno su dieci usa il cellulare per più di quattro ore al giorno.
Tab. 17 Se possiedi un cellulare, In media quanto tempo trascorri in un giorno usando il cellulare? Percentuale
Meno di 1 ora 27,0
Da 1 a 2 ore 48,1
Da 3 a 4 ore 15,3
Più di 4 ore 9,6
Totale 100
Dalle domande aperte risulta che il cellulare viene utilizzato innanzitutto per accedere ad internet e collegarsi ai social, ascoltare musica, guardare video e seguire le diverse passioni, parlare con amici e decidere con gli amici dove incontrarsi ma, anche parlare di compiti e per comunicare con i genitori. Infine il cellulare è usato per giocare con i videogiochi.
La fruizione quindi si divide in attività fatte in solitudine (nella maggior parte dei casi) e quella per comunicare con amici e familiari e, quindi, per sostenere una relazione comunicativa.
Sia chi usa poco sia chi usa per molte ore il cellulare è consapevole dei danni che il cellulare può provocare, tanto che la lista su che cosa pensano i giovani dei compagni che usano il cellulare è molto lunga e ricca di osservazioni. Riportiamo le osservazioni dei giovani sui rischi connessi al telefonino perché riteniamo che potrebbero rappresentare degli stimoli di discussione sul tema della frequentazione tra pari. Il primo aspetto è legato ad un uso pervasivo del telefono cellulare sia da parte dei rispondenti ma soprat-tutto dalle persone che stanno loro vicino, soprattutto se hanno un’età maggiore.

18
“Ok, il telefono serve ma non serve utilizzarlo sempre. Per esempio mia sorella che ha 21 anni può telefonare, messaggiare... ma il telefono lo usa veramente sempre io non so come faccia, lo usa anche prima di andare a dormire … ma ovviamente anche a tavola quando mangiamo”.
Nelle frasi riportate di seguito si nota la critica di alcuni che osservano una corruzione della frequentazione a causa del telefonino.
“Sei fisicamente nel gruppo ma comunichi di voler fare altro che non sia comunicare con il gruppo”.
Chi sa di abusare del cellulare ammette di essere come “loro” e ammette i rischi e i danni anche se poi non attiva comportamenti coerenti. In sostanza una consapevolezza del problema ma anche un disinteresse o un’incapacità a trovare soluzioni per limitarne l’uso.
“Io non posso dire niente, viso che sono come loro, ma penso che dovrebbero usarlo di meno e uscire con gli amici di più per giocare all’aperto”.
“Anche io sono un po’ come loro ma secondo me si dovrebbe evitare di stare pomeriggi interi su internet ma incontrarsi e stare insieme. Spesso mi capita di vedere persone che stanno insieme ma usano il telefono stando su social ecc...”.
I rischi connessi all’uso del telefonino sono comunque riconosciuti dalla maggior parte dei rispondenti, i quali sottolineano come uno strumento di diffusione della comunicazione divenga poi un inibitore di contatti faccia a faccia e di attività svolte in contesti aperti e diversi dalla propria abitazione.
“Se lo usano per cose serie mi va bene, ma se lo usano tutto il tempo e se quando gli chiedo se vogliono uscire a fare una camminata sulle mura e loro mi dicono no sto usando il cellulare non posso, un po’ di nervoso e lì non mi va tanto bene”.
“Bisogna cercare di usarlo meno e non parlare con le persone solo tramite il telefono e ritornare un po’ alle vecchie generazioni dopo non c'era il telefono ma cercare di incontrare le persone e non parlare con una persona che è davanti a te con il cellulare.” “Credo che non sia giusto rispetto alle persone che non ce l'hanno perché può darsi che in certi casi si sentano esclusi non avendo un telefono e dato che la vita intera non è dietro un telefono si potrebbe passare più tempo all'aria aperta perché così siamo più attivi e solari”. Per i giovani si tratta di uno strumento che in qualche modo distoglie dalla realtà del mondo che ci circonda che, comunque, ha per i giovani un valore superiore a quello virtuale di internet e del telefonino. Infatti alla domanda su che cosa pensano dei coetanei che usano sempre il cellulare rispondono:
“Dovrebbero tirare su la testa e accorgersi che esistono altre cose oltre al cellulare e che invece di attaccarsi al cellulare gli consiglierei di coltivare le proprie passioni al di fuori dello schermo”.
“Non avranno molta vita per vedere tutte le meraviglie che li circondano”.
“Usare troppo il cellulare non va bene perché ti racchiudi in te stessa e non scopri il mondo reale”.
Il telefonino viene usato anche durante il tempo libero e per alcuni corrompe la comunicazione tra i partecipanti e quindi la frequentazione. La persona è fisicamente presente nel gruppo ma, estraniandosi e distraendosi o comunicando con persone non presenti, non partecipa alla comunicazione. In sostanza una presenza assenza non sempre apprezzata che avrebbe come esito il rifiuto e l’isolamento dell’altro e la sua esclusione dal gruppo.
“Sarebbe meglio fare una chiacchierata anziché stare sempre sullo schermo”.

19
“Sono asociali e soprattutto se ci incontriamo per stare insieme e si usa il cellulare sono irrispettosi. Non va per niente bene, né per chi gli sta vicino, né per chi lo usa”.
“Ogni tanto si può usare il cellulare perché non fa male ma la cosa più brutta è che se lo usi in continuazione gli amici si allontanano sempre di più da te e diventi solitario”.
“Sono dipendenti e se gli togli il cellulare non fanno altro che lamentarsi oppure se gli parli e loro hanno il cellulare in mano non ti ascoltano”.
“Non bisogna "drogarsi" del telefono”.
“Io penso che tutti dovrebbero lasciare a riposo il proprio dispositivo e pensare a giocare con chi ti sta aspet-tando fuori.”
“Io, onestamente, mi preoccupo di quelli che usano sempre il cellulare perché vivono in un mondo tutto loro e maggior parte di questi non riescono a trovarsi con gli altri, e come se non riuscissero più a parlare”.
“Non fa bene e se continuano così diventeranno asociali per poi cadere in un periodo di depressione però io li sostengo non penso niente di loro perché anche io sto col telefono ma non sempre”.
“Penso che le persone che hanno un uso eccessivo del cellulare (più di 4 ore) sono eccessivamente dipendenti e non capisco davvero dove trovino il tempo per utilizzarlo così tanto. Allo stesso tempo cerco di ragionare se anche io ne faccio un uso eccessivo”.
Per gli studenti usare per troppo tempo il cellulare provoca un isolamento che porta all’asocialità. In molti sottolineano i danni alla vista, all’udito e al cervello. Molti suggeriscono di sostituire il cellulare con la vita all’aperto e in compagnia di altre persone. “Usare il cellulare non fa bene sia mentalmente sia fisicamente perché se usi sempre il cellulare ti rovina innanzitutto la vista e stando sempre sul cellulare non ti permette di muoverti ma ti "obbliga" a stare per molto tempo in una sola posizione”.
Poiché tutti sono consapevoli dei rischi e dei danni e sanno come evitare una “dipendenza dal telefono” ma nel contempo dichiarano anche di essere collegati per 1 e più ore al giorno c’è da chiedersi cosa si possa fare per passare dalle intenzioni ai fatti.
Le bevande alcoliche
La tab. 18 ci mostra come tre quarti dei rispondenti (75,1% somma valori 5 e 4) reputino molto pericolose le sostanze alcoliche, il 14,9% si colloca in una posizione intermedia e il 10% (somma valori 1 e2) non le ritiene pericolose.
Tab. 18 Quanto reputi pericoloso per la salute consumare bevande alcoliche?
Valore di scala Percentuale
5 54,7
4 20,4
3 14,9
2 3,2
1 6,8
Totale 100
Scale:1 = per niente, 5 = Molto

20
Per quanto riguarda la percezione di conoscenza relativamente ai rischi causati dall’uso di bevande alcoliche (tab. 19) il 66,5% ritiene di essere informato, il 17,6% pensa di esserlo mediamente e il 15,9% ritiene di non conoscere l’argomento.
Tab. 19 Quanto pensi di essere informata/o sulle conseguenze causate dall'uso di bevande alcoliche?
Valore di scala Percentuale
5 33,0
4 33,5
3 17,6
2 11,8
1 4,1
Totale 100
Scale:1 = per niente, 5 = Molto
Relativamente all’interesse ad approfondire il tema dei rischi connessi all’uso di alcolici un numero significativo di ragazzi (61,5%) si dichiara interessato il 16,7% lo è abbastanza mentre circa un quinto (21,8% somma valori 1 e 2) non lo é.
Tab. 20 Quanto saresti interessata/o ad approfondire in classe il tema dei rischi connessi all'uso di bevande alcoliche?
Valore di scala Percentuale
5 27,1
4 34,4
3 16,7
2 6,8
1 15,0
Totale 100
Scale:1 = per niente, 5 = Molto
Quest’ultimo dato è interessante in quanto mette in evidenza la disponibilità dei ragazzi ad affrontare l’argomento e potrebbe essere davvero un’opportunità dal momento che comunque una percentuale non trascurabile dei rispondenti lo considera non pericoloso e un’altra percentuale non trascurabile ritiene di non essere informata sull’argomento.

21
La richiesta di aiuto
Abbiamo chiesto ai ragazzi a chi si rivolgerebbero per chiedere aiuto nel caso di un problema personale. La tab. 21 evidenzia che la metà (49,3%) dei rispondenti si rivolgerebbe ai genitori e a seguire il 33% agli amici, l’8,6% ad altri parenti, il restante 9,1% si suddivide tra compagni di classe, insegnanti e in ultima analisi (1,3%) esperti.
Tab. 21 A chi chiederesti aiuto per un problema personale
Percentuale
Genitori 49,3
Amici 33,0
Parenti (fratelli, cugini, zii, nonni) 8,6
Compagni di classe 4,1
Insegnanti 2,3
Parroco/allenatore/educatore/capo scout 1,4
Psicologo/esperto 1,3
Totale 100
In sintesi
Relativamente ai comportamenti a rischio indagati possiamo dire che sicuramente l’uso del cellulare, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo individuale legato ai social o ai giochi è da ritenersi un dato da non sottovalutare, soprattutto tenuto conto delle riflessioni dei ragazzi che lo ritengono problematico anche in relazione alle possibilità di corruzione della frequentazione tra pari. Significativa anche il fatto che coloro che ne criticano l’utilizzo eccessivo o improprio ammettano di essere a volte gli stessi ad utilizzarlo nello stesso modo, ma non adottino dei comportamenti alternativi in tal senso.
Relativamente al discorso bevande alcoliche, nonostante la maggioranza le ritenga pericolose e un numero importante ritenga di avere informazioni adeguate al riguardo esiste comunque una parte dei ragazzi che non osservano il rischio legato al loro utilizzo o che non ne sono informati. Questi aspetti richiederebbero degli interventi soprattutto se teniamo conto del dato che più di un terzo del campione, in caso di problemi personali si rivolgerebbe ai propri amici anziché agli adulti.

22
6. Argomenti per l’intervento in classe
Nella tab. 22 si può vedere come i ragazzi sarebbero interessati a trattare insieme ai compagni di classe soprattutto gli argomenti relativi alle emozioni, al dialogo e alle modalità da utilizzare per risolvere i problemi che si presentano durante la vita (tot. 59,8% diviso equamente tra le tre voci). La voce “altro” è stata selezionata dal 13,1% dei rispondenti ma in realtà le risposte sono delle precisazioni rispetto alle altre voci previste in tabella.
Tab. 22 Quali sono i temi che i ragazzi vorrebbero trattare
Percentuale
Conoscere le proprie emozioni e i propri stati d'animo e quelli degli altri 20,4
Saper risolvere i problemi che si presentano durante la vita 20,4
Comunicare con le persone 19,0
Altro 13,1
Prevedere le conseguenze delle proprie azioni 10,9
Saper prendere decisioni in modo autonomo 9,0
Saper gestire eventuali situazioni stressanti 3,6
Sostenere le proprie convinzioni 3,6

23
7. Conclusioni
Gli aspetti più significativi emersi dalla ricerca sono:
1. Il benessere è ritenuto un argomento molto importante e per i ragazzi si riferisce soprattutto alla dimensione relazionale. Coerentemente con ciò le competenze dialogiche, emotive e la capacità di dire di no sono ritenute fondamentali e i giovani si ritengono mediamente competenti in esse anche se in misura decisamente inferiore a quanto le ritengano importanti.
2. A scuola il benessere riguarda sia l’ambiente da un punto di vista estetico che non è ritenuto sempre adeguato, sia l’ambiente da un punto di vista relazionale per quanto concerne il rapporto con gli insegnanti e i compagni. Le buone relazioni con gli insegnanti e i compagni sono fondamentali per star bene a scuola.
3. Agli insegnanti per star bene si richiede uno stile di comunicazione orientato al ruolo con attenzione alla persona dello studente e un atteggiamento di aiuto verso lo studente nei momenti di difficoltà.
4. Con i compagni di classe ci si aspetta soprattutto divertimento, sostegno e mancanza di prevaricazioni.
5. Esiste un’attenzione, forse eccessiva, sull’aspetto del divertimento a scuola che non è bilanciata da un esercizio a esprimere idee e opinioni diverse e non è sostenuta in modo significativo dal rispetto. A conferma di ciò il fatto che una percentuale, non bassa anche se minoritaria, afferma di non andare d’accordo coi compagni e di essere preso in giro.
6. Per quanto riguarda il tempo libero si conferma l’importanza attribuita a questa età all’amicizia e al divertimento. Nei confronti dell’amicizia si nutrono aspettative molto elevate in termini di sostegno, esclusività e reciprocità. Il sostegno prevale sulla dimensione della condivisione e del dialogo, probabilmente poco esercitati, anche in considerazione del fatto che l’aggregazione giovanile oggi è soprattutto di tipo organizzato con la presenza di adulti.
7. Il divertimento e il sostegno sono i due aspetti che accomunano il rapporto con gli amici e quello con i compagni di classe, anche se l’aspetto affettivo è specifico della relazione amicale.
8. Sui rischi indagati si osserva la consapevolezza rispetto a quello di un uso eccessivo del cellulare che può produrre effetti negativi anche sull’interazione e in particolare sulla comunicazione con gli amici. Non sempre però la consapevolezza produce comportamenti adeguati.
9. Rispetto al tema degli alcolici, nonostante la maggioranza li ritenga pericolosi si ritiene non trascurabile la percentuale di coloro che non la pensano in questo modo così come la percentuale di coloro che non si ritengono informati al riguardo, a cui si aggiunge il fatto che non necessariamente coloro che pensano di esserlo posseggono le informazioni giuste.

24
8. Indicazioni di intervento
Alla luce dei dati emersi gli interventi da realizzarsi a scuola possono essere distinti in due macro aree entrambe finalizzate alla promozione del benessere: la prima specifica dedicata al benessere a scuola, orientata a intervenire in modo mirato su quegli aspetti che hanno evidenziato alcune criticità, il cui sostegno favorisce anche il benessere in altri contesti oltre a quello scolastico; la seconda più mirata sui rischi legati alla frequentazione nel tempo libero.
Per quanto riguarda il primo gruppo gli interventi (dedicati al benessere a scuola) dovrebbero riguardare:
1) Il sostegno delle competenze dialogiche e dell’intelligenza emotiva con particolare attenzione al sostegno dell’autonomia personale, della responsabilità individuale e alla disincentivazione di forme di comunicazione antagoniste, prevaricatrici e di dinamiche basate sul senso di appartenenza al gruppo tout court. Questo può essere fatto: a) promuovendo durante le ore di insegnamento degli spazi di dialogo sugli argomenti oggetti di studio che facciano emergere le opinioni personali degli studenti in un momento privo di giudizio e valutazione e b) individuando dei momenti di esercizio a partire da alcuni strumenti scelti appositamente (libri, dvd) in cui si esplicita l’obiettivo dell’allenamento al dialogo, al riconoscimento delle emozioni e della capacità di dire di no. Il tutto dovrebbe essere fatto nel rispetto del contesto scolastico, senza scivolamenti dello stesso in contesti di tipo psicologico/terapeutico e senza trasformare la classe in un gruppo di amici, per cui le riflessioni non dovrebbero trasformarsi in narrazioni di esperienze private. Entrambi i tipi di interventi dovrebbero essere condotti da insegnanti con la supervisione da parte di esperti. I docenti nel momento dell’intervento dovrebbero utilizzare uno stile di conduzione promozionale e facilitante. Questi interventi sono tra l’altro coerenti con i temi che la maggioranza dei ragazzi vorrebbe trattare in classe.
2) Interventi di progettazione partecipata che coinvolgano gli studenti nel miglioramento estetico dell’ambiente scolastico.
Per quanto riguarda la seconda area (dedicata alla frequentazione nel tempo libero) gli interventi dovrebbero essere:
1) Interventi di promozione della consapevolezza sul significato dell’amicizia e del divertimento, con particolare attenzione a problematizzare i rischi collegati al sostegno acritico degli amici.
2) Interventi di riflessione sui rischi di un uso eccessivo della tecnologia e dell’uso di sostanze alcoliche che, in entrambi i casi possono rappresentare un surrogato della comunicazione intima e del divertimento sano. Tali attività dovrebbero favorire la consapevolezza sui rischi e la ricerca di comportamenti alternativi, finalizzati ad aumentare l’interazione e le modalità di divertimento sano centrato sul piacere della comunicazione interpersonale.
Per quanto riguarda la metodologia da adottare, tutti gli interventi sopra riportati prevedono una modalità partecipata che ricorre al dialogo quale forma di comunicazione e in cui l’insegnante è un facilitatore del processo. In tale modalità la partecipazione all’intervento da parte dei ragazzi permette loro di sperimentare quelle forme di comunicazione favorevoli al benessere relazionale sia in classe che nel tempo libero. L’insegnante realizza l’intervento con la supervisione di un esperto su questi temi, sulla metodologia promozionale e la facilitazione, oltre che sulla prevenzione dei comportamenti a rischio. Nel caso della parte specifica sui rischi si può eventualmente prevedere l’intervento diretto di alcuni tecnici nelle classi.