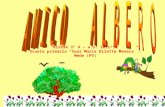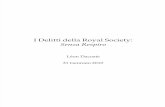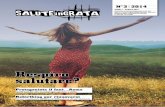Profili di donne, respiro d'ambiente
Click here to load reader
-
Upload
geanina-toma -
Category
Health & Medicine
-
view
225 -
download
2
description
Transcript of Profili di donne, respiro d'ambiente

Quando ancora non sapevo che sarei venuta a vivere in Italia, e studiavo in Romania, il mio primo
contatto con questo Paese è stato la vostra letteratura. Come tutti, ho imparato a conoscere i molti
autori italiani che tutti gli europei sentono come propri. Uno dei ricordi più forti che conservo
riguarda Giacomo Leopardi: mi aveva molto colpito il concetto leopardiano di natura matrigna, una
natura che è ostile agli uomini perché rende impossibile la loro felicità. Una natura che ha leggi
sconosciute che l'uomo non può capire ma solo subire.
Il sentimento e le ragioni di Leopardi e del suo concetto di natura sono molto complessi e sono
oggetto di studio ancora oggi in tutto il mondo. Ma per quanto mi riguarda, ricordo il profondo
effetto che mi fece la prima volta perché questa idea è molto lontana dall'idea di natura con cui sono
cresciuta, e che è più vicina al mio modo di sentire, una natura che è madre, che genera e accoglie.
E allo stesso tempo una Natura che ha bisogno di essere curata, che bisogna trattare con molto
riguardo e che bisogna imparare a conoscere bene, per capirne le leggi e rispettarle.
Questo concetto di natura e di ambiente ha determinato molte scelte importanti della mia vita.
All'Università ho studiato Geologia, prima a Iasi in Romania e poi qui a Torino dove poi mi sono
laureata. La scelta della Geologia non è stata casuale: sono sempre stata affascinata dalle materie
non fini a se stesse, ma che danno degli strumenti per “fare”, per contribuire a migliorare le cose e,
in particolare, da quelle che ti mettono nelle condizioni per intervenire sull'Ambiente a favore
dell'ambiente stesso. Ho sempre avuto il desiderio e l'ambizione di cercare di lasciare qualcosa
dietro di me, qualcosa di positivo e costruttivo a favore degli altri. Per questo la mia prima scelta di
studi è stata, da ragazza, il liceo pedagogico e per questo stesso motivo ho poi scelto la facoltà di
Geologia.
Durante il mio percorso di studi ho affrontato un tema che mi è stato subito particolarmente a cuore,
tanto da diventare poi argomento della mia tesi di laurea. Un tema che dopo la tesi non ho mai
abbandonato del tutto, su cui ho sempre desiderato tornare a lavorare. E forse ora questa mia nuova

esperienza politica me ne darà l'occasione.
Esistono sul territorio piemontese zone più o meno vaste, contaminate da agenti diversi, per ragioni
diverse, che hanno storie differenti, e che devono essere bonificate. Sono circa 300 in Provincia di
Torino, 81 solo nell'area cittadina (dati recenti dell'Anagrafe regionale dei siti contaminati
interessati da un intervento di bonifica).
Ci sono tre esempi eclatanti. Uno riguarda un episodio della storia nazionale e della recente attualità
giudiziaria torinese: i danni provocati, in particolare in questo caso al suolo, dallo stabilimento
Eternit di Casale Monferrato, nell'alessandrino. Basti pensare che lo stabilimento occupava una
superficie di 94 mila metri quadri, dei quali 50 mila erano coperti da lastre di cemento-amianto. Si
stima che i danni al suolo per contaminazione riguardino un'area di circa 740 chilometri quadrati su
cui si trovano 48 comuni. Ma tutto questo è argomento di un processo, proprio qui a Torino, che
riguarda circa 3.000 parti offese e che farà storia.
Un altro caso è quello dell'area dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio, chiusa nel 1990, la
più grande cava d'amianto d'Europa con una produzione 150.000 tonnellate di fibra all'anno, in una
zona vicinissima alla città, e della relativa discarica, con la contaminazione complessiva di un'area
sui due versanti della montagna, per un totale di 310 chilometri quadrati.
E poi c'è la zona di Basse di Stura, a Torino. Si tratta di un'area molto più ristretta delle precedenti,
75 chilometri quadrati lungo la sponda destra del torrente Stura, e di una vicenda con una
dimensione solo cittadina rispetto ai casi di maggiore impatto sull'opinione pubblica citati prima.
Ma che per Torino ha invece un'importanza strategica. Innanzitutto perché racconta del passato
industriale della città: si tratta infatti di un'area usata come discarica di residui siderurgici, di scarti
di fonderia. E questa è la storia di una contaminazione del suolo a cui oggi si cerca di porre rimedio.
E poi perché racconta invece della Torino di oggi, ma non della città delle Olimpiadi o dell'elegante

centro ottocentesco, che i recenti festeggiamenti per l'Unità d'Italia hanno riportato agli antichi
splendori. La Torino di Basse di Stura è la città delle discariche: una zona degradata, dove è difficile
vivere, dove ai rifiuti siderurgici si erano poi sostituiti i rifiuti urbani che confluivano in una
discarica chiusa alla fine del 2009. La sua storia recente racconta di diversi tentativi di recupero: se
ne parla come sede di una centrale per il teleriscaldamento e per il progetto di un vasto parco urbano
di 250.000 metri quadri destinati a verde pubblico.
A proposito di questi casi, nella mia tesi di laurea avevo affrontato la possibilità del recupero e della
bonifica di queste zone tramite il Biorisanamento, una tecnica di bonifica ecologica, con tempi
lunghi ma con - sotto controllo - un bassissimo impatto ambientale. Il Biorisanamento utilizza
microorganismi, batteri o funghi di diversa specie, che si nutrono e quindi metabolizzano sostanze
inquinanti, ad esempio il ferro presente nella fibra d'amianto e direttamente connesso allo sviluppo
di radicali liberi responsabili dell'incidenza dei mesoteliomi, ma anche gli idrocarburi o i materiali
ferrosi dei metalli pesanti.
Il residuo del biorisanamento è composto da anidride carbonica, acqua e biomasse facilmente
riassorbibili dall'ambiente.
E' meglio e preferibile utilizzare microrganismi già presenti sul posto. Per consentire il rispetto
degli equilibri ecologici, l'intervento di biorisanamento dovrebbe essere realizzato utilizzando
microrganismi già presenti nelle stesse zone da bonificare. In questo modo l'impatto dell'intera
operazione sull'ecosistema locale si riduce al minimo. Non sempre però è possibile trovare nel
luogo i batteri adatti a biodegradare gli inquinanti in questione, in questi casi si deve
necessariamente ricorrere ai microrganismi estranei provenienti da altre zone o prodotti tramite
colture in laboratorio.
Il biorisanamento presenta però dei limiti e dei problemi non ancora risolti: i microrganismi
potrebbero svolgere efficacemente il loro lavoro per determinate sostanze inquinanti ma non per
tutte quelle presenti nella zona; Inoltre, i microgranismi presenti in natura non sono sempre in grado

di degradare i composti di sintesi introdotti dall'uomo.
Ho raccontato l'indagine della mia tesi perché condurla è stata appassionante e interessante, come
analisi scientifica ma anche perché mi ha aiutato a conoscere meglio il territorio torinese e
piemontese, con la sua storia e i suoi problemi.
Oggi non faccio la geologa, ma quel percorso di studi mi ha insegnato molto sull'ambiente e i suoi
meccanismi ed è stato molto istruttivo anche per il mio desiderio di prendermi cura della comunità
in cui vivo: così come in natura esistono organismi micro, resistentissimi, che si sono adattati ad
ambienti diversi, sono riusciti a sopravvivere per milioni di anni e che oggi costituiscono una
risorsa per rigenerare l'ambiente naturale, liberandolo da contaminazioni inquinanti, così è anche
per la società i cui individui, ciascuno nel proprio piccolo, può fari grandi cose per la collettività se
si impegna in proprio e fa rete con gli altri, riuscendo forse, domani, addirittura a risolvere problemi
che oggi sembrano senza soluzione.